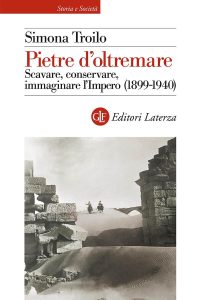Simona Troilo ha studiato e smontato il «discorso» archeologico che serviva a giustificare l’impero coloniale (1899-1940), naufragato con la Guerra
Carlo Franco | Alias | 5 settembre 2021
La ricerca archeologica non è fine a se stessa, semplice ricerca erudita, ma, in colonia, è anche alta opera politica». Non mancavano di consapevolezza le parole dette nel 1929 dal professor Carlo Anti (1889-1961) a proposito degli scavi italiani in Tripolitania e Cirenaica: e il loro senso si lascia facilmente estendere all’azione svolta in altre aree sotto controllate, come le isole italiane dell’Egeo, o per qualche tempo considerate ‘zone di interesse’, come Creta e talune regioni dell’Anatolia. Per il suo carattere politico, anche l’archeologia fu segnata per certo dalle ‘ideologie del classicismo’: aspetto da tempo riconosciuto, e studiato con differente prospettiva (anche ideologica), dagli studiosi di mondo antico, italiani e non. Tale carattere si manifestava anzitutto sul piano interno, come strumento per la costruzione della ‘nazione’ attraverso l’uso del passato e la valorizzazione di reperti e rovine e siti. Importante era anche la proiezione esterna, legata all’esperienza del dominio coloniale. Il senso delle ricerche condotte nell’età dell’imperialismo da missioni europee, in numerose aree del mondo, è ben noto. Oggi queste imprese generano pentimenti post-coloniali, con restituzioni di manufatti a titolo simbolico e risarcitorio.
 Il regno d’Italia s’affacciò tardi e in modi pasticciati al banchetto coloniale, e con una peculiarità: l’occupazione di alcune aree permise di costruire un peculiare ‘discorso’ legato al passato classico e imperiale, del quale l’Italia appunto, come ‘terza’ Roma, si voleva erede. Della nostrana fase coloniale, naufragata con la guerra e chiusa bruscamente dal trattato di pace nel febbraio 1947, poco è rimasto nella coscienza collettiva. Non ha giovato il mito della ‘brava gente’, riproposto a lungo da certa compiacente divulgazione: con scarsa elaborazione consapevole e comune, ma ampia e tacita continuità di uomini e istituzioni. Il Museo Africano, inaugurato a Roma nel 1904, chiuse nel 1971 (!) per rinascere ora con nuovo nome. Ambigua eredità coloniale è anche la pubblicazione di scavi e ricerche prebelliche rimaste giacenti per decenni.
Il regno d’Italia s’affacciò tardi e in modi pasticciati al banchetto coloniale, e con una peculiarità: l’occupazione di alcune aree permise di costruire un peculiare ‘discorso’ legato al passato classico e imperiale, del quale l’Italia appunto, come ‘terza’ Roma, si voleva erede. Della nostrana fase coloniale, naufragata con la guerra e chiusa bruscamente dal trattato di pace nel febbraio 1947, poco è rimasto nella coscienza collettiva. Non ha giovato il mito della ‘brava gente’, riproposto a lungo da certa compiacente divulgazione: con scarsa elaborazione consapevole e comune, ma ampia e tacita continuità di uomini e istituzioni. Il Museo Africano, inaugurato a Roma nel 1904, chiuse nel 1971 (!) per rinascere ora con nuovo nome. Ambigua eredità coloniale è anche la pubblicazione di scavi e ricerche prebelliche rimaste giacenti per decenni.
Nella storia dell’archeologia, il periodo è stato seriamente affrontato: per esempio da Marta Petricioli in Archeologia e Mare nostrum. Le missioni archeologiche nella politica mediterranea dell’Italia 1898/1943 (Valerio Levi Editore, 1990). Un ripensamento alla luce dell’attuale sensibilità post-coloniale e con una specifica attenzione all’ambito mediterraneo, ne propone ora Simona Troilo con Pietre d’oltremare Scavare, conservare, immaginare l’Impero (1899-1940). Lo sguardo della contemporaneista conduce a sottolineare l’attitudine eurocentrica degli attori. Essa determinò i modi in cui fu pensata e realizzata la ricerca archeologica in colonia, pur se essa talora voleva presentarsi invece come scienza ‘pura’. Si indagano con particolare ampiezza la politica e l’amministrazione: emergono così i caratteristici conflitti insorti tra sovrintendenze, governatorati, istituti e scuole archeologiche, variamente impegnati a intestarsi scavi, scoperte, influenze e denari. Così, al centro dell’analisi stanno non rovine e reperti più o meno spettacolari, quanto documenti d’archivio, diari e carteggi, che illustrano l’elemento amministrativo e le logiche politiche sottese.
Spazio è dato ai mezzi cui spettò di valorizzare in patria le intraprese archeologiche: quindi i francobolli, ma anche pittura e scultura, coinvolte nelle mostre di ‘arte coloniale’ degli anni trenta, e soprattutto la stampa. Riviste e pubblicazioni scientifiche erano destinate a circolazione limitata, ma furono prodotte con perizia, per esempio quelle dell’Istituto F.E.R.T. Impegno fu posto pure nella confezione di libri divulgativi e guide per la C.T.I: nel decennio del ‘consenso’ si ebbero promozioni turistiche per i siti di Libia e Egeo. Di più largo impatto erano gli articoli della stampa periodica e quotidiana, dove era largo assai Io spazio dell’archeologia, il volto più spendibile dell’antichità classica (lo mostra l’antologia di Margherita Mangiai, L’antichità classica e il Corriere della Sera. 1870-1945. Fondazione Corriere della Sera, 2017).
Nella ricerca di Troilo, le retoriche alla base dell’archeologia coloniale sono vigorosamente smascherate e denunciate come relazione di potere. Giova evocarle in sintesi. La prima era la missione dell’Italia: si pretendeva che l’eredità culturale e politica dell’impero romano legittimasse la nazione, più che ogni altra, a farsi carico dei resti della civiltà classica. Un discorso già pienamente attivo dal 1911, durante la guerra libica, e poderosamente rilanciato durante il ventennio fascistico (come illustra Massimiliano Munzi, L’epica del ritorno. Archeologia e politica nella Tripolitania italiana. L’Erma di Bretschneider, 2001). In varie occasioni il paradigma fu rafforzato, anche in polemica con parallele iniziative ‘straniere’: si esibiva allora l’impegno a difendere nelle intraprese imperialistiche (e poi, per breve tempo, imperiali) un certo ‘onore nazionale’. Il secondo livello era lo sforzo di tutelare le rovine antiche dall’ignoranza distruttrice dei ‘barbari’: una forma, subdolamente nobilitata, di white man’s burden. Nelle aree delle imprese coloniali nostrane, la barbarie fu identificata (come già ai tempi di Lord EIgin) nel domino ottomano: in particolare, rinfacciando ignavo torpore, colpevole d’aver trascurato o minacciato la conservazione dei manufatti, segni della superiore civiltà greco-romana, estranea e incompresa. Si sa che lo stesso schema era stato usato, in patria, contro le politiche culturali degli stati preunitari, presentate sempre come inadeguate, e che il paradigma classico fu proposto ora in forma unitaria (Grecia e Roma) ora informa isolata (Roma!). Cacciato il neghittoso turco dall’Egeo, dalla Tripolitania e (con più difficoltà) dalla Cirenaica, i resti del passato andavano protetti ora dai nativi, essi pure in vario modo inetti: nomadi cirenaici e pastori ellenici non fornivano adeguate garanzie di preservare quei beni.
Qualche pezzo, contravvenendo a principi altrove asseriti, finì rimosso dal luogo di rinvenimento e trasportato altrove (persino a Roma, come nel caso di famosi spolia). In Libia il pregiudizio, razzistico, religioso e culturale insieme, legittimò l’espropriazione di siti, rovine e reperti, sottratti a indigeni considerati come ‘bambini’, perciò inconsapevoli e vandalici distruttori. A Creta l’archeologia italiana cercò soprattutto le premesse della civiltà greca (senza troppi legami con l’oriente!), ma valorizzò anche la fase veneziana, più problematica nella percezione locale, complicata dalla convivenza di diverse comunità. Anche a Rodi si diede grande peso al Medioevo, cristiano e crociato, liberandogli edifici dalle superfetazioni dei secoli di dominio ottomano, considerate deturpanti. Nell’Egeo agirono i pretesti della “scienza”: gli spazi locali di interesse per le antichità furono accantonati, e si impose la professionalità di archeologi formati alle rigorose pratiche distavo, catalogazione e conservazione, del metodo germanico. Pratiche che si pretendevano impeccabili, ma non sempre lo erano state, giacché nei tempi di guerra erano prevalse su tutto le esigenze militari. Che il punto di vista dei nativi, comunque qualificati, non trovasse spazio, non stupisce, poiché il discorso archeologico oscurava o falsava ampi aspetti della realtà coloniale. Per questo l’indagine sviluppata da Troilo è di grande interesse, e merita ulteriori allargamenti, verso l’Albania o l’Africa Orientale Italiana (che pongono questioni in parte differenti). Il ripensamento di quegli eventi legati a un altro mondo scomparso va condotto con equilibrio, senza i passati eurocentrismi, e senza preconcette condanne politicamente corrette. I limiti, gli errori e gli eventuali ‘meriti’ del colonialismo italiano, anche in archeologia, vanno esaminati e compresi, evitando anacronistici processi al passato.
Poscritto. L’autore si scusa d’aver usato il termine paleoitaliano ‘decennio’, e non l’ormai normale ‘decade’, e confida, contrito, nella clemenza di chi legge.
Il libro: