Giovanni De Luna | La Stampa | 18 ottobre
Un libro come questo è una novità assoluta. Con Storia passionale della guerra partigiana (Laterza) Chiara Colombini ha colmato una lacuna offrendoci una straordinaria storia “dal basso” della Resistenza, un suo racconto corale. I protagonisti non sono i partiti politici, le bande partigiane, gli operai, i contadini, gli intellettuali, i grandi soggetti collettivi che hanno scritto la storia del ‘900, ma gli uomini e le donne che quella storia l’hanno fatta in prima persona nei venti mesi della drammatica guerra civile che sconvolse l’Italia dal 1943 al 1945.
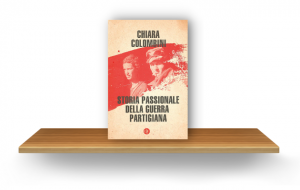 L’obbiettivo dichiarato è quello di indagare su «cosa accade nell’animo e nel comportamento egli essere umani quando vivono circostanze eccezionali» e, quindi, di riflettere sui «sentimenti» di quelli che scelsero di armarsi contro i fascisti e i nazisti, sulla loro capacità di amare e di odiare, sulle loro speranze di futuro e sulla cupa realtà che li avvolgeva nel presente, sui lutti e i dolori che accompagnarono la loro lotta ma anche sulla felicità e le tempeste emotive dalle quali furono attraversate le loro vite, sospese tra l’eccezionalità di quei tempi e una grande voglia di quiete e di normalità. E poi il pensiero della morte, la paura di non essere all’altezza, di poter tradire i compagni sotto tortura, in una dimensione in cui l’eroismo, già noto, di figure come Fanciullacci o Capriolo si intreccia con i dubbi e le incertezze che, oltre che al movimento partigiano, appartenevano alla gente comune.
L’obbiettivo dichiarato è quello di indagare su «cosa accade nell’animo e nel comportamento egli essere umani quando vivono circostanze eccezionali» e, quindi, di riflettere sui «sentimenti» di quelli che scelsero di armarsi contro i fascisti e i nazisti, sulla loro capacità di amare e di odiare, sulle loro speranze di futuro e sulla cupa realtà che li avvolgeva nel presente, sui lutti e i dolori che accompagnarono la loro lotta ma anche sulla felicità e le tempeste emotive dalle quali furono attraversate le loro vite, sospese tra l’eccezionalità di quei tempi e una grande voglia di quiete e di normalità. E poi il pensiero della morte, la paura di non essere all’altezza, di poter tradire i compagni sotto tortura, in una dimensione in cui l’eroismo, già noto, di figure come Fanciullacci o Capriolo si intreccia con i dubbi e le incertezze che, oltre che al movimento partigiano, appartenevano alla gente comune.
Per scriverlo Colombini si è affidata alle testimonianze di chi impugnò le armi, scritte nel corso stesso della lotta, rifiutando le razionalizzazioni offerte dal “senno di poi”: lettere, diari, carteggi confluiscono in un materiale gonfio di passioni, inquieto, turbolento, che l’autrice padroneggia grazie alla solidità delle sue categorie interpretative.
La Resistenza, per lei, scaturì da una scelta individuale di riappropriazione della propria sovranità, dopo vent’anni in cui si poteva soltanto ubbidire, tutti ossequiosi dell’ordine costituito e delle gerarchie. Fu quindi una scelta politica ma fu soprattutto una rifondazione esistenziale: alle certezze del regime si contrapposero i dubbi dei partigiani («Che cosa sei disposto a fare? Fino a dove sei disposto a spingerti? Quale è il limite che sei disposto a superare?») che per la prima volta sperimentarono l’ebbrezza e le difficoltà di essere padroni delle proprie azioni. Proprio per questo fu sempre difficile imporre una disciplina alle bande, evitare quell’alto tasso di conflittualità che caratterizzò i loro rapporti. La Resistenza non fu una “rinascita” o un “risorgimento”, ma una nuova nascita; non una ricostruzione ma la costruzione di una nuova Italia, immaginata come una Patria inclusiva e democratica. L’impegno contro l’attendismo (al quale sono dedicate pagine molto significative) era il risvolto identitario della lotta, il tentativo di combattere tutti i luoghi comuni familistici che si addensavano sugli stereotipi dell’“italianità”. Il “miracolo” della Resistenza si realizzò grazie all’intreccio, ben riuscito, tra la spontaneità, dal basso, e l’organizzazione, dall’alto. Quali fossero gli obbiettivi politici, dei vari partiti, quali fossero le perplessità che serpeggiavano nelle file dei partigiani, il risultato fu l’approdo a una democrazia piena, sorretta dalla comune convinzione (tipicamente novecentesca) «che la politica fosse uno strumento capace di trasformare e di plasmare la realtà».
C’era uno scoglio impervio da affrontare nel percorso di ricerca che ha portato a questo libro. Quando si parla di “sentimenti” si fa riferimento a uno “spirito del tempo” segnato da un’educazione fascista che aveva coinvolto i giovani e i giovanissimi che divennero partigiani, ma anche i loro coetanei che scelsero la Repubblica di Mussolini. Tutti ne avevano introiettato alcuni valori, avevano respirato l’aria mefitica dell’Impero e delle leggi razziali, del maschilismo e della retorica sull’onore. Era uno spirito del tempo in cui era veramente difficile che, come nei versi di Calvino, “tutto il bene” fosse da una parte, “tutto il male” dall’altra.
Partigiani e fascisti avevano fatto insieme un passo irreversibile, impugnando le armi e inoltrandosi in un territorio in cui si entrava solo per uccidere o farsi uccidere.
Un’esperienza estrema, parossistica, inconcepibile in tempi di pace. Ma qui subentravano le prime, radicali differenze: per gli uomini e le donne della resistenza uccidere non era scontato. Certo che c’era l’odio per il nemico, la voglia di vendicare i propri compagni caduti; per il resto, però, non c’era traccia del corteggiamento della “bella morte”, dell’ossessione funebre che affiorava dai teschi grotteschi, dai simboli plumbei che trionfavano sulle divise nere e nelle canzoni “disperate” cantate dai fascisti. A differenza di questi ultimi, per i partigiani uccidere era una necessità, a volte era il solo modo per sopravvivere e quel gesto estremo non era mai scontato: «Se uccidere non mi ripugna sto snaturando le ragioni per cui combatto? Quale differenza resta tra me e gli altri, quelli che voglio sconfiggere», erano gli interrogativi che si affollavano nelle loro teste e che oggi Colombini ripropone. Ed è lei stessa, in conclusione, a indicarci la differenza fondamentale tra gli uni e gli altri, ritrovandosi, i fascisti «in un mondo che stava crollando e gli altri in un mondo che stava nascendo: gli uni guardavano al futuro gli altri si rifiutavano di farlo e guardavano al passato». A un passato che, speriamo, non ritorni mai.
