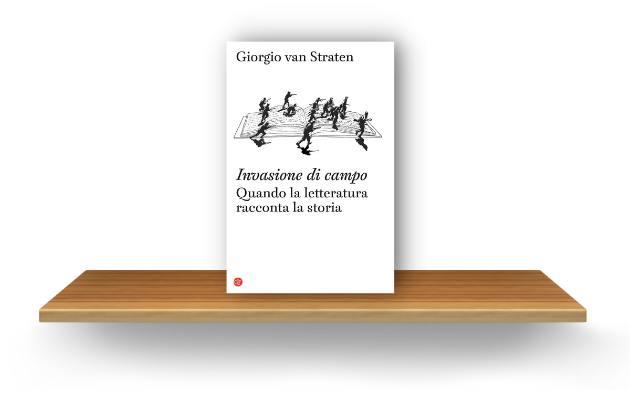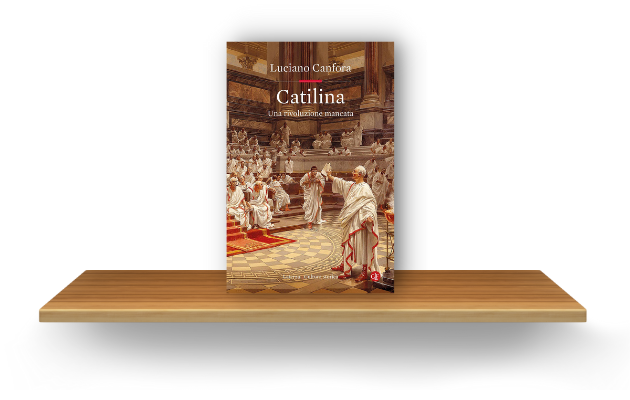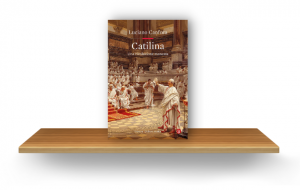La letteratura, con la sua attenzione all’individuo, aiuta a capire meglio il passato
Walter Veltroni | Corriere della Sera | 25 aprile 2023
Uno dei film più belli sul fascismo è il racconto di una storia in cui il fascismo è un’assenza. Una clamorosa assenza. E un gigantesco condominio di Roma che si svuota di ogni essere umano perché Hitler è arrivato nella capitale e tutti, volenti e nolenti, adulti e bambini, vanno a rendere omaggio al dittatore nazista. Le camicie nere di ogni taglia sciamano verso il cancello e in quello spazio enorme, che per lo spettatore diventerà da quel momento il mondo intero, rimangono solo due persone.
Una donna del popolo, Sofia Loren, che vive in modo semplice la suggestione del fascismo al punto da aver provato un mancamento, un giorno, vedendo Mussolini su un cavallo bianco a Villa Borghese.
Nella finestra di fronte abita invece un annunciatore dell’Eiar, Marcello Mastroianni, licenziato dalla radio perché omosessuale e antifascista.
Il fascismo regime invadente, pesante, massificante diventa qui un vuoto tronfio in cui risuona come sovversiva la solitudine di due anime diverse che si incontrano.
Una giornata particolare è storia?
Lo è meno o più di quella organizzata nei manuali e nei saggi, prodotta dal faticoso, insostituibile lavoro sulle carte, sulle date, sui fatti che gli studiosi producono per far conoscere, capire, discutere?
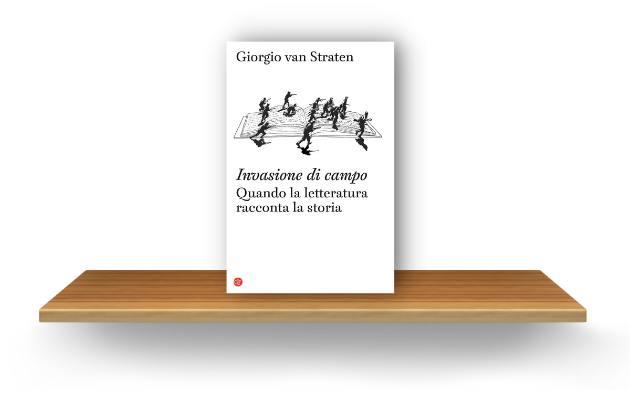 È il tema di Invasione di campo, il bel saggio, pubblicato per i tipi di Laterza, che Giorgio Van Straten ha dedicato al rapporto tra letteratura e storia.
È il tema di Invasione di campo, il bel saggio, pubblicato per i tipi di Laterza, che Giorgio Van Straten ha dedicato al rapporto tra letteratura e storia.
L’autore sostiene, a mio avviso a ragione, fin dall’inizio ciel volume, una tesi chiara: che esse abbiano un’origine comune e dunque «rimandino alla volontà di un confronto con la realtà e la sua memoria, con le esistenze delle donne e degli uomini per come concretamente sono state o si può immaginare che siano state; che entrambe, storia e letteratura, abbiano a che fare con gli individui, e con il desiderio di ricrearli, di rappresentarli e, si potrebbe dire, di riesumarli».
La storia si può non solo scrivere nella sua pura dimensione «fattuale». La si può raccontare assumendo come centro narrativo la condizione umana, individuale o collettiva.
Cioè la storia non ha solo un aspetto «strutturale» al quale l’approccio marxista ha affidato in passato il compito esclusivo di spiegare i fatti, ma essa può filtrare attraverso il vissuto degli umani. Anche solo di un essere umano.
Non aveva in fondo fatto così Omero raccontando di Ettore, Achille, Ulisse? Van Straten analizza, in particolare parlando di Primo Levi e di Beppe Fenoglio, i casi in cui la letteratura si è fatta storia per la capacità di scrittori – in questo caso dei testimoni diretti di portare un po’ più avanti la lettura dei fatti.
Primo Levi capì per primo e raccontò la natura complessa della «zona grigia» con la quale fece i conti nel campo di concentramento e che non è semplificabile nell’indifferenza o nella pura equidistanza.
Fenoglio, in particolare con Una questione privata, raccontò la Resistenza lontano dagli stereotipi riduttivi della letteratura celebrativa e si avventurò nella individuazione dell’esistenza di quella «guerra civile» di cui Claudio Pavone ebbe anni dopo il coraggio, culturale e civile, di parlare da storico di vaglia.
Ha scritto, forzando i termini della questione, Hans Magnus Enzensberger: «Il racconto dello storico è singolarmente privo di umanità. La storia viene esibita senza il suo soggetto: le persone. “I disoccupati”, si dice, “gli imprenditori”». Non per caso, per raccontare la tragedia del Titanic, storia pura, lui stesso adottò la forma del poema epico.
Il concorso della letteratura e della storia può offrire la possibilità di leggere in forma compiuta il succedersi degli eventi, la loro influenza sulla vita individuale e collettiva, persino il loro senso ultimo.
Van Straten cita lo scrittore americano Daniel Mendelsohn che ha indagato il rapporto tra storia e persona: «Da una parte esiste l’infinita gamma di possibilità dovute al caso, al tempo, allo stato d’animo, l’inconoscibile e sterminata massa di eventi che costituiscono la vita di un individuo o di un popolo; dall’altra in questo incredibile e illimitato universo cii fattori e possibilità, si intersecano la personalità e la volontà individuale, le decisioni, la capacità cui operare distinzioni, quindi di creare.».
In fondo la stessa storia degli eventi non è stata condizionata, sovente, dalla influenza delle decisioni umane e non solo dai grandi processi economici, sociali, politici?
Se Rosa Parks nel 1955 non si fosse rifiutata a Montgomery di cedere il suo posto a un bianco, se quello sconosciuto cittadino cinese non si fosse piazzato con due buste della spesa davanti ai carrarmati ciel regime di Pechino, se Libero Grassi non si fosse rifiutato di pagare la mafia, se Mahsa Amini non avesse scelto la sua dignità di ragazza iraniana…
Persone, il cui gesto, magari maturato In un istante, ha segnato la nostra storia.
Scrive Van Straten, in un libro che sviluppa un dibattito aperto proprio sulle pagine de «la Lettura », a proposito della necessità di superare un approccio esclusivamente «scientifico» al racconto storico: «Le donne e gli uomini in carne e ossa chiedevano di tornare a far parte della scena, come singoli e non solo come parte di una classe, di un’etnia o di una generazione, e insieme a questo elemento era riemersa anche la scelta di una nuova generazione di storici di partire da eventi singoli in grado di gettare luce su un intero periodo, sui fenomeni di maggiori dimensioni.».
Su versanti diversi Antonio Scurati e Patrick Modiano, l’uno affrontando letterariamente una attenta ricostruzione del fenomeno Mussolini e l’altro scegliendo di ricostruire la storia di Dora Bruder, una ragazza quindicenne scomparsa negli anni della deportazione degli ebrei dalla Parigi occupata, ci hanno offerto, ma cito solo due tra tanti, la possibilità di leggere la storia attraverso le vite individuali e viceversa.
Cipolla, Ginzburg, Diamond e tanti altri hanno dimostrato anche come sia affascinante il percorso inverso, quando la storia, quella degli specialisti, intreccia le due dimensioni.
Come ha spiegato Giovanni De Luna, a proposito del suo lavoro sulle donne perseguitate durante il fascismo: «La scelta obbligata era quella di coniugare “la storia” con le “storie” ponendo al centro del racconto il nesso individuale collettivo: la contraddittorietà delle vicende individuali veniva assunta consapevolmente come una straordinaria opportunità conoscitiva».
Con una avvertenza, però. Viviamo un tempo nel quale il rischio è opposto a quello del passato.
Siamo infatti costantemente bombardati da storie minute, diffuse per la loro particolarità ed elevate a simbolo esclusivo di problemi e tendenze generali. Un infinito e onnipresente «Strano ma vero» diffuso per indurre facile emotività e disabituarci alla complessità, al dubbio, al legame tra particolare e universale.
Ma proprio storia e letteratura possono servirai, nel loro meraviglioso intreccio, per evitare il rischio di diventare tutti degli isterici, insiemi e ingenui bevitori di frivola e pelosa superficialità.