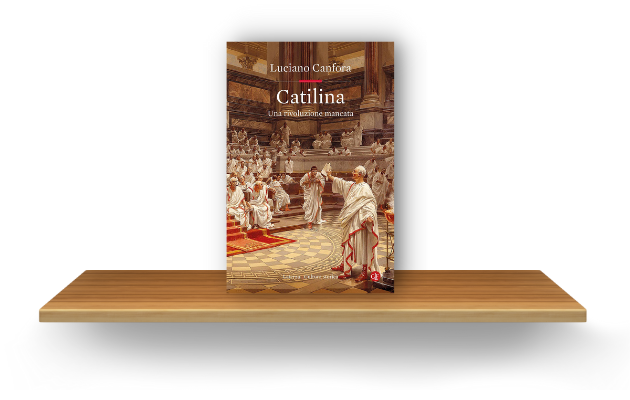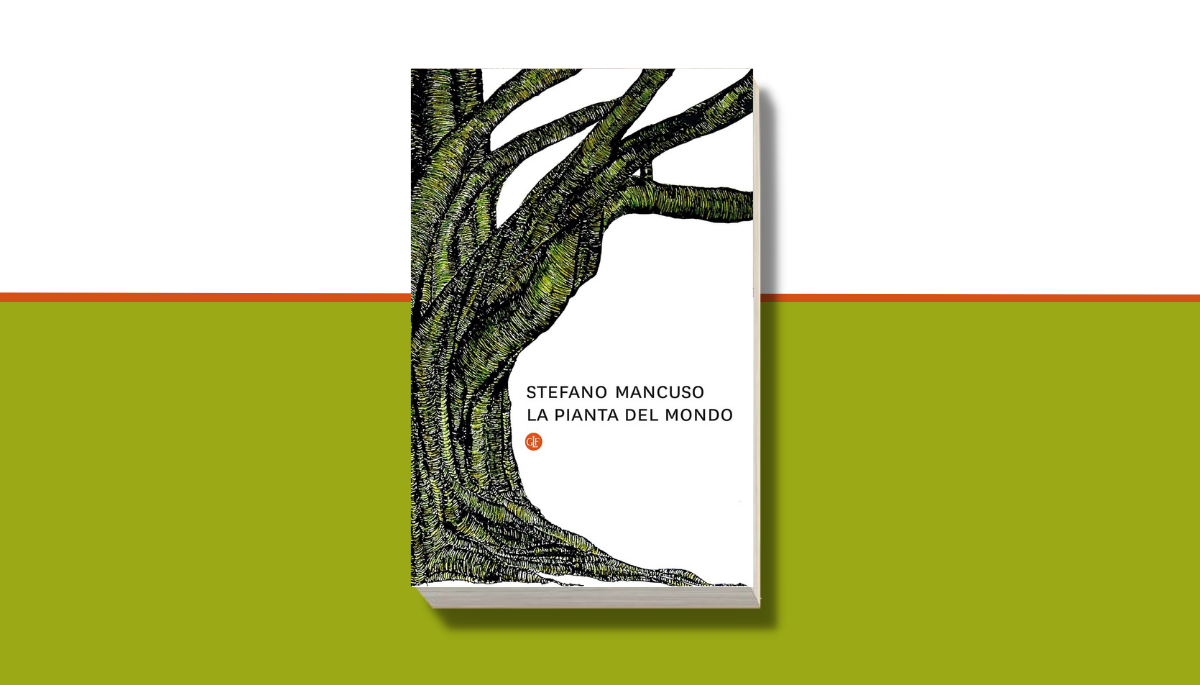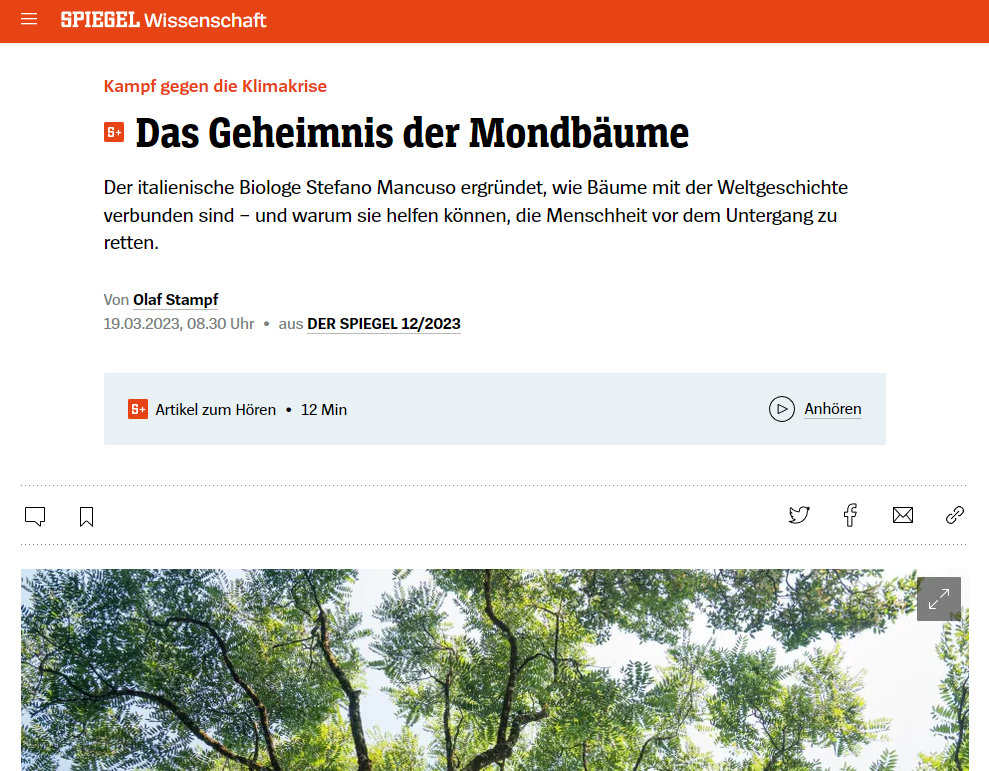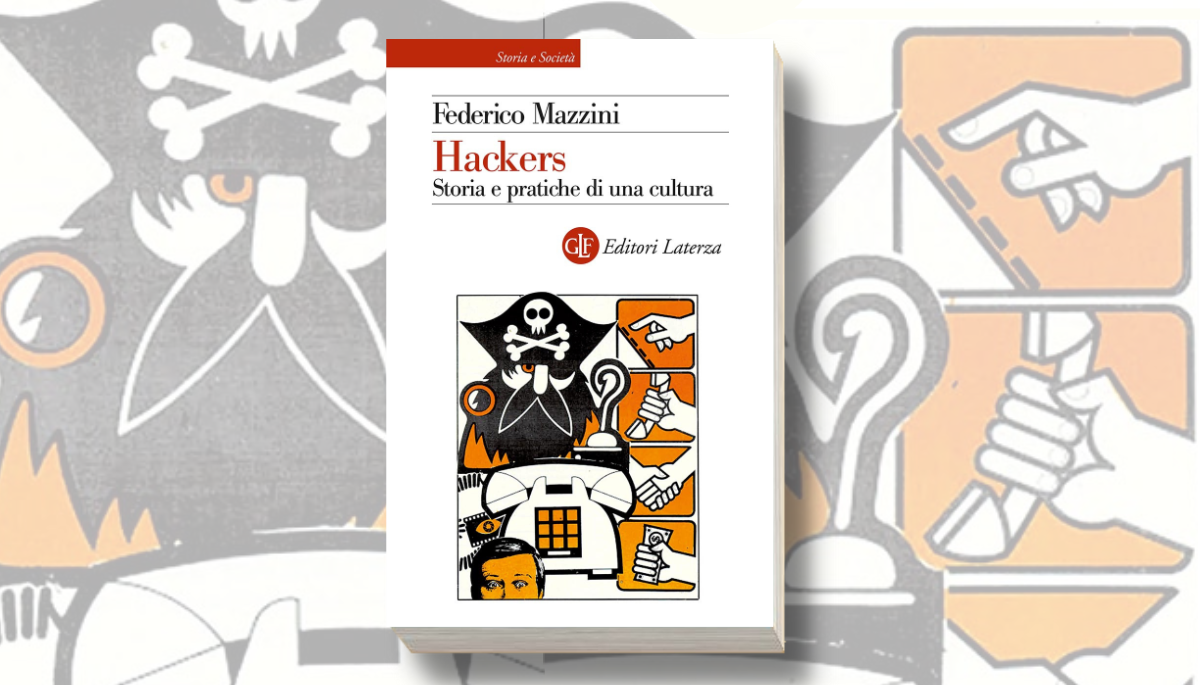Luciano Canfora, in un saggio pubblicato da Laterza, esplora i retroscena della congiura che vide protagonista l’aristocratico romano. L’ombra di Pompeo, la posizione di Cesare, l’autorappresentazione eroica e celebrativa di Cicerone
Paolo Mieli | Corriere della Sera | 6 marzo 2023
La congiura dell’aristocratico Lucio Sergio Catilina – che sconvolse Roma nel 63 avanti Cristo concludendosi nel gennaio dell’anno successivo con la morte del capo dei congiurati nella battaglia di Pistoia – è ancora oggi uno dei casi più intriganti della storia antica. Apparentemente tutto è chiaro: un avventuriero con grandi complicità nel suo ceto di provenienza ordisce e mette in atto un colpo di Stato; Cicerone si erge a difensore dell’ordine repubblicano, convince Roma a reagire con il massimo dispiego della forza e a debellare il sovversivo. La Repubblica sopravvivrà. Ancora per poco. Ma già Sallustio – il primo a scriverne, una ventina d’anni dopo i fatti – lasciò intuire che non tutto era stato così lineare. Tant’è che ancor’oggi «sulle dimensioni e sulla durata della “congiura” né gli antichi né i moderni hanno certezze», scrive Luciano Canfora in Catilina. Una rivoluzione mancata, pubblicato per i tipi di Laterza. Allo stesso modo non è del tutto chiaro quale fosse l’autentico «programma» politico di Catilina. Quanto al fatto che l’aristocratico ribelle tramasse da anni, prima ancora di essere sconfitto alle elezioni del 64, «è soltanto un modo non benevolo di descrivere una circostanza ovvia». Cioè che Catilina come molti altri «capi» della sua epoca — ma anche di altre, perfino della nostra — avesse un «seguito strutturato». Fin dall’inizio della sua avventura politica, anni prima di ordire la celebre «congiura». In ogni caso, prosegue Canfora, possiamo considerare un dato acquisito che Catilina «ha imboccato la strada senza ritorno dell’insurrezione armata, quando ha constatato che per la terza volta consecutiva erano riusciti ad impedirgli di vincere le elezioni».
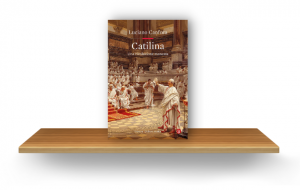 Lo storico dedica grande attenzione a Dione Cassio, che si occupa della congiura tre secoli dopo gli accadimenti. Rione ha scritto la maggiore opera storiografica su Roma dopo quella di Tito Livio e concentra la sua più che benevola attenzione su Pompeo. Pompeo che mentre è in atto l’insurrezione di Catilina tenta, per interposta persona, un autentico colpo di Stato. Durante l’intera vicenda catilinaria, si allunga sulla Repubblica quella che Jérome Carcopino in un libro scritto nel 1936 e ripubblicato più volte anche in Italia, Giulio Cesare (Bompiani) — ha definito l’«ombra di Pompeo». La notizia della morte di Mitridate (63) è giunta a Roma mentre Pompeo era a Gerico e si preparava all’assedio del Tempio di Gerusalemme. L’uomo che aveva sconfitto il re del Ponto e conquistato a Roma l’Asia, impresa davvero grandiosa sotto il profilo politico oltreché militare, era atteso dalla sua città come il più grande dei condottieri. La vicenda politica a quel punto è consistita, scrive Canfora, in «una lotta contro il tempo in vista del prevedibile rientro di Pompeo e del suo esercito». La scomparsa definitiva di Mitridate era un fatto «epocale», il conseguente prestigio di Pompeo «enorme». Secondo Carcopino Catilina e i suoi affrettarono i tempi della loro impresa proprio per prevenire il rientro di Pompeo. A Canfora questa non appare un’ipotesi convincente dal momento che l’atto di insubordinazione dei catilinari «fu, semmai, la reazione alla reiterata sconfitta elettorale». Plausibile gli appare invece che la repressione militare delle truppe catilinarie ammassate in Etruria sia stata affrettata con l’obiettivo — da parte ottimate, tra l’altro di chiudere la partita prima che Pompeo tornasse. O meglio decidesse di «affrettare il rientro in Italia» e di «mantenere in funzione le sue legioni» a motivo di un perdurante stato di guerra nella penisola. Va ricordato che Cesare in quel momento è schierato con Pompeo e lo sarà ancora a lungo.
Lo storico dedica grande attenzione a Dione Cassio, che si occupa della congiura tre secoli dopo gli accadimenti. Rione ha scritto la maggiore opera storiografica su Roma dopo quella di Tito Livio e concentra la sua più che benevola attenzione su Pompeo. Pompeo che mentre è in atto l’insurrezione di Catilina tenta, per interposta persona, un autentico colpo di Stato. Durante l’intera vicenda catilinaria, si allunga sulla Repubblica quella che Jérome Carcopino in un libro scritto nel 1936 e ripubblicato più volte anche in Italia, Giulio Cesare (Bompiani) — ha definito l’«ombra di Pompeo». La notizia della morte di Mitridate (63) è giunta a Roma mentre Pompeo era a Gerico e si preparava all’assedio del Tempio di Gerusalemme. L’uomo che aveva sconfitto il re del Ponto e conquistato a Roma l’Asia, impresa davvero grandiosa sotto il profilo politico oltreché militare, era atteso dalla sua città come il più grande dei condottieri. La vicenda politica a quel punto è consistita, scrive Canfora, in «una lotta contro il tempo in vista del prevedibile rientro di Pompeo e del suo esercito». La scomparsa definitiva di Mitridate era un fatto «epocale», il conseguente prestigio di Pompeo «enorme». Secondo Carcopino Catilina e i suoi affrettarono i tempi della loro impresa proprio per prevenire il rientro di Pompeo. A Canfora questa non appare un’ipotesi convincente dal momento che l’atto di insubordinazione dei catilinari «fu, semmai, la reazione alla reiterata sconfitta elettorale». Plausibile gli appare invece che la repressione militare delle truppe catilinarie ammassate in Etruria sia stata affrettata con l’obiettivo — da parte ottimate, tra l’altro di chiudere la partita prima che Pompeo tornasse. O meglio decidesse di «affrettare il rientro in Italia» e di «mantenere in funzione le sue legioni» a motivo di un perdurante stato di guerra nella penisola. Va ricordato che Cesare in quel momento è schierato con Pompeo e lo sarà ancora a lungo.
Nel gennaio del 62 Metello Nepote, con l’appoggio di Cesare, propone due rogationes (progetti di legge) per affidare a Pompeo poteri eccezionali, cioè un comando straordinario per affrontare l’esercito di Catilina. Plutarco è esplicito nel denunciare la finalità «eversiva» del progetto di Metello Nepote. Concorderà anche Dione Cassio. Per i due storici la motivazione addotta («salvare Roma da Catilina») era pretestuosa, «mentre il vero fine era quello di conferire a Pompeo poteri dittatoriali». Strumento di tale presa del potere sarebbe stata, scrive Canfora, l’elezione al consolato di Pompeo in assenza. Magari «senza collega e comunque con effetto immediato». Il che avrebbe di fatto comportato «la decadenza (o sospensione?) di Silano e Murena, molto faticosamente eletti alla fine del 63 per il 62». All’autore sembra evidente che l’operazione fosse orchestrata da lontano dal medesimo Pompeo. Ed è proprio in contrasto con Pompeo che Catone organizza la resistenza del Senato a questa iniziativa, cercando un compromesso con Metello. II quale Metello reagisce minacciando il ricorso alla violenza nel caso dell’ingresso in città delle legioni pompeiane. Catone lo sostiene e giura che si opporrà al ritorno di Pompeo («in armi») finché sarà in vita. Poi Metello viene costretto alla fuga. Lo stesso Cesare è rimosso dalle funzioni di pretore. Ma ad essere davvero sconfitto è il tentativo di portare Pompeo al potere violando le regole della Roma repubblicana.
Pompeo, nel momento in cui Catilina si ribella, potrebbe prendere il potere con facilità. Ma «se ne astiene». Potrebbe essere «destinatario di onori smisurati». Ma li respinge. Sa bene, scrive Dione Cassio, che «tutti gli onori concessi dal popolo ai potenti fanno nascere il sospetto che siano il risultato di uno sperequato rapporto di forze e dell’azione manipolatrice dei potenti stessi».
Di qui l’ammirazione che Cassio Dione ha per Pompeo. Minor simpatia ha lo storico del terzo secolo d.C. nei confronti di Cesare. Quel Cesare, già raffigurato come «strumentalmente demagogo», viene colto nella sua doppiezza: vuole «abbattere la potenza di Pompeo», malo appoggia perché pensa di «ingraziarsi la massa» mostrandosi devoto del rivale. E conta di «rinsaldare così il proprio potere».
C’è infine Cicerone, al quale Cassio Dione guarda quasi con disprezzo. Quantomeno fastidio per il modo in cui l’arpinate ha costruito il proprio personaggio nell’azione politica e nell’auto-raffigurazione. Il celebre oratore è (agli occhi di chi ne scrive qualche secolo dopo) inadeguato rispetto alla propria pulsione al comando. Le sue sono miserevoli astuzie. Voleva, è chiaro, «un ruolo di comando nella Repubblica perché se ne considerava all’altezza». Per conseguire tale obiettivo, però, aveva scelto «una linea di condotta strumentalmente ambigua». Cicerone in altre parole intendeva «dimostrare sia al popolo sia agli ottimati che quello tra i due schieramenti al quale egli si fosse accostato avrebbe prevalso». Astuto. Anche troppo.
Un intervento «diretto e risolutivo» di Pompeo nella guerra contro l’esercito dei rivoltosi e dunque uno scontro diretto sul campo di battaglia tra Catilina e Pompeo (con la prevedibile vittoria di quest’ultimo) «avrebbe cancellato o quasi la centralità di Cicerone nella vicenda nonché il suo ruolo brutalmente conquistato e disinvoltamente proclamato di salvatore della patria». Ed è appunto Cicerone il temporaneo vincitore di questa partita giocata dietro le quinte della «congiura di Catilina». Pompeo a questo punto decide di restare ad occuparsi del riordino dell’Oriente. Tornerà solo alla fine di dicembre di quel 62. Fa un ultimo tentativo per far occupare da suoi uomini le «poltrone» consolari. Ma Catone stronca anche questo disegno. A questo punto Pompeo scenderà a patti con Cesare per dar vita — insieme a Crasso — al triumvirato. Triumvirato definito da Canfora «una pesante anomalia costituzionale che apertamente esorbitava dal quadro della tradizionale res publica». Un «mostro a tre teste». Vero. Però per ciò che riguarda Cesare quel patto con Pompeo si rivelerà un «colpo di genio». Cicerone e «il suo scomodo estemporaneo alleato Catone», vincitori nell’immediato, alla fine perderanno la partita proprio «in virtù di quel «colpo di genio» di Cesare. Che sarà pagato da Cicerone con l’esilio mentre Catone verrà messo fuori gioco. Il triumvirato porterà «a un vero e proprio mutamento nella prassi di governo: i comandi (militari e non) di lunga durata».
L’impeccabile ricostruzione di Canfora prosegue con storie di spie, lettere anonime, attentati, agguati, strani silenzi, fraintendimenti, ritocchi della cronologia e dei documenti. Cicerone resta un personaggio fondamentale di questa vicenda. Quantomeno finché inizia a maramaldeggiare contro Catilina (ormai in clandestinità) e ad enfatizzare il «rischio corso dalla Repubblica». Cicerone sbaglia i calcoli e prevede una sconfitta di Cesare, insinua che Cesare sia pronto per la tirannide, ma alla fine la prudenza gli impone di «salvare» lo stesso Cesare dalle accuse (da lui stesso avallate) di complicità con Catilina. Fino al giorno in cui, a congiura ormai fallita, nel dicembre del 63 Cicerone ordina l’uccisione immediata degli arrestati ormai condannati. Una mossa sospetta. Pur se, scrive Canfora, «non deve sfuggire quanto radicata fosse in Cicerone la mania omicida verso gli avversari politici». Sarà Publio Clodio Pulcro, entrato in carica come tribuno della plebe quattro anni dopo quei fatti terribili, nel dicembre del 59, a riaprire il dossier delle condanne a morte «eseguite contro le leggi Porcia e Sempronia». Clodio sostenne che Cicerone aveva addirittura falsificato il testo del Senatus consultum che aveva sancito quelle condanne. L’arpinate a quel punto si rassegnò a soccombere e «si autoesiliò prima ancora che l’azione promossa contro di lui giungesse a compimento». Il grande oratore andrà, «malvolentieri», a governare per un anno una provincia romana e al ritorno «troverà la guerra civile già quasi in atto». Cercherà di ritagliarsi ancora un ruolo da protagonista e chiede aiuto a Catone («che lo molla»). Continuerà a considerarsi «parte del “gruppo di testa” della Repubblica». Per mesi tentenna tra Cesare, «che lo corteggia», e Pompeo «dal quale non si sente né fino in fondo apprezzato né tanto meno rassicurato». Prova ad inserirsi nella lotta contro Antonio e dalla parte di Ottaviano. Ma il suo tempo è scaduto. Non «aveva più la percezione della realtà e pagò con la vita».
E Catilina? Nell’orazione Pro Fiacco, Cicerone riferisce, tre anni dopo la morte del sovversivo aristocratico, che sarebbe esistita una sua tomba «ricoperta di fiori» sulla quale «uomini sciagurati, nemici della patria hanno festeggiato con un banchetto». Forse era un’invenzione metaforica finalizzata a risuscitare antichi sentimenti «patriottici». Ma può darsi che nel 59 (quando Cicerone ne parlò) quel sepolcro esistesse davvero. Il valore politico di un monumento funebre, ricorda. Canfora, è grande nell’etica e nella prassi romane. Un esempio per tutti: le ceneri di Cesare da poco assassinato «e prevaleva ancora nell’opinione pubblica l’idea che si fosse trattato di un “tirannicidio” attuato da eroici “liberatori”» — vennero vegliate per notti e notti dalla comunità ebraica di Roma. Comunità memore dell’onta della profanazione del Tempio e del massacro attuato da Pompeo a Gerusalemme vent’anni prima.
Ma questa storia del sepolcro di Catilina è assai strana. A quel che fu tramandato, una volta fallita la congiura, la testa di Catilina venne tagliata e portata a Roma. Forse il corpo fu restituito alla vedova Orestilla (qualcosa del genere, annota Canfora, avvenne sul suolo d’Egitto per il corpo di un altro decapitato illustre: Pompeo). Possibile dal momento che Orestilla fu affidata da Catilina stesso alla protezione di un avversario che gli era stato amico: Quinto Lutazio Catulo. Di figli Catilina non ne ebbe. O meglio all’epoca si diffuse la voce che ne avesse avuto uno e che fosse morto di morte violenta. Quella che Canfora definisce una «leggenda nera». Anche questa usata per far rivivere l’ombra di Catilina destinata a incombere sul tramonto della Repubblica.