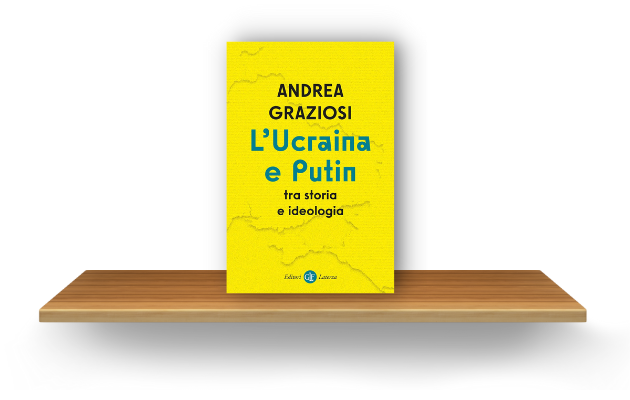Giorgia Antonelli | doppiozero | 17 gennaio 2023
Quando si entra nel cimitero acattolico di Roma si viene sopraffatti dalla bellezza e dalla quiete, e in mezzo ai dedali di percorsi fra tombe di personaggi più o meno celebri, quasi non si fa caso a una piccola pietra miliare posta proprio all’ingresso, per terra, su cui si legge «In memoria di Joyce Salvadori 1912 – 1998 Emilio Lussu 1890 – 1975». È qui che sono custodite, insieme per l’eternità così come insieme avevano vissuto, le ceneri di due dei più importanti protagonisti della Resistenza italiana.
 La storia della loro vita è la geografia di una guerra e al contempo la mappa di un amore, e se per tutta la loro esistenza l’importanza politica e letteraria di Emilio Lussu (scrittore, partigiano, padre costituente e deputato) sembra aver offuscato il ruolo di Joyce nella scrittura e nella Resistenza, lasciando la conoscenza di questa importantissima figura del ‘900 a un pubblico ristretto di intellettuali, adesso la bella biografia scritta da Silvia Ballestra per Laterza, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, restituisce al grande pubblico la consapevolezza di un personaggio storico, culturale e letterario di prim’ordine.
La storia della loro vita è la geografia di una guerra e al contempo la mappa di un amore, e se per tutta la loro esistenza l’importanza politica e letteraria di Emilio Lussu (scrittore, partigiano, padre costituente e deputato) sembra aver offuscato il ruolo di Joyce nella scrittura e nella Resistenza, lasciando la conoscenza di questa importantissima figura del ‘900 a un pubblico ristretto di intellettuali, adesso la bella biografia scritta da Silvia Ballestra per Laterza, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, restituisce al grande pubblico la consapevolezza di un personaggio storico, culturale e letterario di prim’ordine.
Ballestra ha svolto un accuratissimo lavoro di ricostruzione della vita di Lussu, basandosi non solo sui documenti e sui libri, ma anche sulla testimonianza diretta di Joyce, conosciuta quando Ballestra era poco più che ventenne e a cui è rimasta legata per tutta la vita da un intenso rapporto di amicizia e condivisione di intenti letterari, oltre che dalle comuni origini marchigiane.
Ballestra segue dunque le orme di Beatrice Gioconda Salvadori (detta Joyce) fin dalla nascita, avvenuta a Firenze l’8 maggio del 1912, ultima dei tre figli di Guglielmo Salvadori Paleotti (detto Willy), filosofo, professore di filosofia e traduttore italiano di Herbert Spencer, e di Giacinta Galletti di Cadilhac (detta Cynthia), donna coltissima e poliglotta, che trasmette a Joyce il Collier’s pluck, la grinta che proviene dal ramo femminile inglese trapiantato nelle Marche della sua famiglia: entrambi provengono da nobili famiglie di possidenti terrieri marchigiani ed entrambi hanno rinnegato le loro famiglie d’origine, ritenute distanti dagli ideali socialisti che li animano.
È dunque in seno alla famiglia che Joyce inizia a sviluppare la propria coscienza politica, segnata, appena dodicenne, dal pestaggio del padre e del fratello maggiore Max a opera dei fascisti. È dal ’24 dunque che Joyce conosce la fuga: prima in Svizzera, da cui fa la spola con le Marche, al seguito dei genitori, poi in Africa per lavoro e in Germania per studio.
Questo primo episodio di violenza lascia una traccia profondissima nella coscienza della giovanissima Joyce, la stessa consapevolezza che attraverserà in quegli anni altre scrittrici italiane della resistenza come Alba de Céspedes e che porta in sé una domanda che è una rivoluzione epocale: dove sono le donne?
Mentre gli uomini combattono, vanno in guerra, si armano per la Resistenza e subiscono attacchi, le donne restano a casa, al sicuro. Cosa possono fare le donne? Moltissimo, sembra mostrarci Joyce con l’esempio della sua vita, fedele al principio dei suoi dodici anni, quando «giurai a me stessa che mai avrei usato i tradizionali privilegi femminili: se rissa aveva da esserci, nella rissa ci sarei stata anche io».
Ed è proprio questo che viene fuori dalla scrittura di Ballestra, il ritratto di una donna forte, determinata, senza peli sulla lingua tanto da usare liberamente il turpiloquio e capace di raccontare le esperienze umane senza tabù, dalla guerra all’aborto del primo figlio di Emilio – che non poté tenere perché fuggitiva – al parto di suo figlio Giovanni, in grado di arringare le piazze con determinazione e mantenere il sangue freddo nelle situazioni più controverse, capace di lasciare a guerra terminata il figlio piccolissimo alle cure di sua madre Giacinta nelle Marche per girare la Sardegna – terra del suo amato Emilio – a cavallo, per parlare con le donne sarde e smuoverle dal loro torpore, per instillare in loro una coscienza politica.
Joyce non è sempre stata così, racconta Ballestra, è stata timida in giovinezza, ma è stata la vita a forgiarla. Scrive Ballestra: «È il fascismo che l’ha spinta fuori dal suo paese, le ha tolto i documenti, ha punito i suoi familiari. A questo Joyce reagisce con la rivolta. E con non poca rabbia, sentimento indispensabile per la sopravvivenza».
Ci vuole coraggio, determinazione, e anche la forza di sfidare le convenzioni per essere Joyce Salvadori e diventare Joyce Lussu: mettere a tacere un primo matrimonio fallito nelle Marche degli anni ’30, legarsi per la vita e negli intenti a un rivoluzionario e seguirlo e sostenerlo per tutta la vita, sopportare i pettegolezzi che vedevano nella caparbietà del suo carattere e nella scelta di essere una donna libera i tratti di una poco di buono, ma Joyce non è una che si fa piegare dalle convenzioni sociali, né dai ruoli convenzionali e precostituiti. È una donna bellissima, colta e tenace che anche nei momenti più duri – la depressione che segue l’aborto, la lontananza da Emilio, dal fratello Max e dai suoi familiari, che rivedrà solo a guerra finita – non smette di apprezzare le piccole cose belle che la vita può offrire, quelle che restituiscono dignità anche nella disperazione: «i fiori, gli animali, il paesaggio, il buon cibo, le case accoglienti, l’aspetto ordinato di capigliatura e vestiario», sono questi gli elementi che rendono possibile resistere, combattere, perché «la lotta – scrive Ballestra – è un rimedio alla disperazione, l’azione è un richiamo morale ma anche di sopravvivenza alle atrocità della guerra».
Ed è con questo animo che seguiamo Joyce mentre si unisce al gruppo di Giustizia e Libertà, impara a falsificare documenti, assume identità sempre nuove e diverse, porta in salvo ricercati come i coniugi Modigliani, viene addestrata e reclutata a Londra nelle file del SOE (Special Operations Executive, agenzia segreta britannica nata per volere di Churchill) e nel settembre 1943, con il nome in codice di Simonetta, attraversa l’Italia per arrivare nel sud liberato dagli Americani per conto del Comitato di Liberazione Nazionale, perché «una donna può farcela dove tre uomini hanno già fallito». E Joyce riesce, supera difficoltà, mantiene i nervi saldi, e dimostra quello che si era prefissata da ragazzina: che una donna può essere nella lotta allo stesso modo di un uomo, tracciando così, con il suo esempio, un luminoso modello per le sue contemporanee e per le donne a venire.
La Storia di Joyce è dunque prima di tutto la storia di una vita, poi quella di una scrittrice. E a chi volesse obiettare che nel libro trova più spazio la narrazione della attività politica di Joyce piuttosto che di quella letteraria e che la dimensione narrativa possa perdersi tra le pieghe della Storia che inghiotte, sospende, trasforma, si può controbattere che la vita di Joyce fuori dalla scrittura è parte integrante della scrittura di Joyce.
Nelle pagine di Ballestra le doti letterarie di Joyce viene fuori immediatamente, ne sono prova le poesie giovanili tanto lodate da Benedetto Croce, ma lei mette da parte il suo incredibile talento per un’urgenza più grande: la resistenza partigiana e la militanza politica per le quali si spende senza sosta, sia durante la lotta al regime fascista che dopo, quando gira l’Italia e la Sardegna a verificare con mano ciò di cui c’era bisogno per la ricostruzione, per lavorare fianco a fianco delle donne, smuovendo la loro coscienza di partecipazione politica alla vita del Paese.
Gertrude Stein scrisse in Autobiografia di tutti: «E se si è un genio e si è smesso di scrivere si è ancora un genio se si è smesso di scrivere», e questa definizione sembra calzare a pennello per Joyce, la cui scrittura si è nutrita della vita quando per necessità ha smesso di scrivere, per ritornare più forte a guerra finita, quando l’abilità di scrittrice viene messa a servizio della traduzione letteraria e della testimonianza politica della Resistenza. Anche lo stile della sua produzione poetica cambia, si fa scabro, vivo, ricercato nella scelta di parole autentiche, di una precisione nel dire che vuole arrivare a più persone possibili e che la porterà ad autodefinirsi «scrittrice di complemento, non di professione».
Con questa idea di scrittura Joyce torna dunque a scrivere dopo la guerra, con un figlio piccolo da accudire e una carriera politica appena iniziata nelle liste del Partito d’azione in cui mette in atto un modo di fare politica molto diverso da quello del marito, che dopo la guerra lavora alla Costituzione e diventa deputato. A Joyce infatti sta stretto il ruolo di first lady, così prende treni, va nelle piazze a parlare con la gente, punta i piedi se non trova donne in politica con cui interloquire gridando a gran voce quel suo Dove sono le donne?
Joyce Lussu non vuole essere “un caso eccezionale” tra le donne, come le diceva Benedetto Croce, ma vuole che le donne tutte rendano quella che è considerata un’eccezione la norma dell’agire quotidiano, così organizza il primo convegno nazionale delle donne sarde per rappresentare «le aspirazioni della massa femminile, la più oppressa nell’oppresso popolo di Sardegna».
È in questi anni, racconta Ballestra, che germoglia in lei un nuovo modo di fare poesia, e che nasce uno dei suoi libri più celebri: Fronti e frontiere, quello che Joyce rievoca come la sua storia d’amore per Emilio Lussu anche se, o forse soprattutto perché, racconta il loro peregrinare per l’Europa durante la guerra e quella telepatia che li legava anche a distanza e che insieme all’ironia – che Ballestra mai dimentica di sottolineare – e alla comunanza di visione e intenti, aveva reso inossidabile il loro legame.
Nella produzione letteraria di Lussu il talento è quindi medium di un significato più ampio, in cui la letteratura si fa politica. Anche all’interno della sua esperienza come traduttrice, negli anni ’70 (è stata, tra gli altri, traduttrice di Nazim Hikmet, Agostinho Neto, José Craveirinha e Marcelino dos Santos), Joyce sceglie sempre poeti e scrittori che soffrono per una condizione di mancata libertà, che si fanno portavoce di Paesi – e popoli – che non hanno voce, e che proprio per questo vanno divulgati con più attenzione e con più forza, in modo da portare all’attenzione di un pubblico più ampio non solo le loro storie, ma quelle di intere nazioni impegnate in lotte di liberazione, come l’Africa e il Kurdistan.
Gli anni ’70 però, oltre al suo impegno terzomondista, a nuovi libri e alle traduzioni, porteranno anche un immenso dolore nella sua vita: nel marzo del 1975 Emilio muore, lasciandola sola. Ma Joyce continua la sua attività politica e letteraria, e si occupa di storia focalizzandosi sul suo territorio, inizia così a studiare la sibilla appenninica delle sue terre, raccontando di donne sapienti e rivoluzionarie, perseguitate come streghe per le loro conoscenze e la loro libertà, e lo fa per la prima volta dal punto di vista di una donna. Le donne, l’ambiente, la pace (guerra alla guerra, soleva dire), resteranno i suoi campi d’indagine prediletti fino alla fine dei suoi giorni, il 4 novembre 1998, quando si ricongiunge a Emilio nell’eternità degli scrittori di valore e dei combattenti per la libertà.
L’operazione letteraria di Silvia Ballestra nel suo La Sibilla, vita di Joyce Lussu, è dunque una perfetta ricostruzione di uno dei periodi più importanti della storia recente, ma anche la narrazione di un’esistenza particolare che si fa racconto universale, in cui la vita di Joyce Lussu è quella di una scrittrice talentuosa a servizio della vita attiva e di una donna con una personalità unica, fatta di dignità, ardore e sensibile intelligenza, capace di cambiare la Storia.
Dopo aver terminato il libro sono tornata a Testaccio a cercare quella pietra su cui sono incisi i nomi di Joyce ed Emilio Lussu, ho parlato con loro come si fa con qualcuno che ora mi sembra di conoscere da sempre e ho lasciato lì un fiore di gratitudine per la poetessa partigiana, vissuta per la libertà.
 Nella ricerca sul nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei la lente degli storici si è nel tempo, a partire dagli anni ‘80-‘90 sempre più puntata sull’aspetto economico. Di recente Johann Chapotout in Liberi di obbedire (Einaudi 2020) ha messo al centro una figura emblematica di quel sistema che univa efficientismo e sistemi manageriali, mettendoli al servizio della causa di Hitler: Reinhard Höhn, che – fattala franca – nel dopoguerra fu un affermato formatore di dirigenti d’impresa. Ora la storica Anna Veronica Pobbe, utilizzando una vasta mole di documenti, pubblica uno studio che dà conto di come questa «galassia, composta da manager, banchieri, professionisti e dirigenti di grandi gruppi industriali, ebbe un peso non indifferente nelle politiche attuate dal Terzo Reich; come dimostra la grande importanza che venne accordata a questioni quali la contabilità, la ricerca delle più piccole economie e il recupero sistematico di tutti i sottoprodotti; oppure ancora l’efficacia tecnica dei centri di sterminio che si ispirò al modello delle fabbriche». Punto di partenza di Un manager del Terzo Reich è la figura di Hans Biebow, l’amministratore del ghetto di Lodz (Litzmannstadt). Quando nel 1947 le autorità giudiziarie polacche lo portarono alla sbarra, lo considerarono tra i dieci peggiori criminali nazisti in circolazione, alla stregua di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, di ArthurGreiser, Gauleiter della Wartheland (una delle suddivisioni del Paese occupato) e di Hans Prank, governatore generale della Polonia. E, infatti, lo impiccarono. Rispetto al già citato Höhn, che apparteneva alle Ss, Biebow era però un semplice civile, un Kaufmann, un commerciante, come lo definisce l’autrice. Un uomo comune, insomma, che nella foto di copertina appare in giacca e cravatta, ben rasato, mentre in primo piano un uomo dalla barba incolta porta un cappottone con sopra una stella gialla.
Nella ricerca sul nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei la lente degli storici si è nel tempo, a partire dagli anni ‘80-‘90 sempre più puntata sull’aspetto economico. Di recente Johann Chapotout in Liberi di obbedire (Einaudi 2020) ha messo al centro una figura emblematica di quel sistema che univa efficientismo e sistemi manageriali, mettendoli al servizio della causa di Hitler: Reinhard Höhn, che – fattala franca – nel dopoguerra fu un affermato formatore di dirigenti d’impresa. Ora la storica Anna Veronica Pobbe, utilizzando una vasta mole di documenti, pubblica uno studio che dà conto di come questa «galassia, composta da manager, banchieri, professionisti e dirigenti di grandi gruppi industriali, ebbe un peso non indifferente nelle politiche attuate dal Terzo Reich; come dimostra la grande importanza che venne accordata a questioni quali la contabilità, la ricerca delle più piccole economie e il recupero sistematico di tutti i sottoprodotti; oppure ancora l’efficacia tecnica dei centri di sterminio che si ispirò al modello delle fabbriche». Punto di partenza di Un manager del Terzo Reich è la figura di Hans Biebow, l’amministratore del ghetto di Lodz (Litzmannstadt). Quando nel 1947 le autorità giudiziarie polacche lo portarono alla sbarra, lo considerarono tra i dieci peggiori criminali nazisti in circolazione, alla stregua di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, di ArthurGreiser, Gauleiter della Wartheland (una delle suddivisioni del Paese occupato) e di Hans Prank, governatore generale della Polonia. E, infatti, lo impiccarono. Rispetto al già citato Höhn, che apparteneva alle Ss, Biebow era però un semplice civile, un Kaufmann, un commerciante, come lo definisce l’autrice. Un uomo comune, insomma, che nella foto di copertina appare in giacca e cravatta, ben rasato, mentre in primo piano un uomo dalla barba incolta porta un cappottone con sopra una stella gialla.