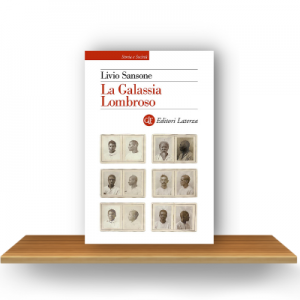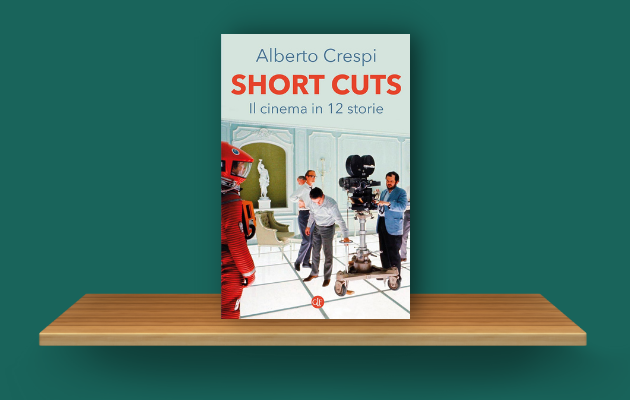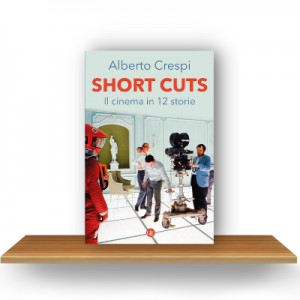Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre si svolgerà la prima edizione di Pianeta Terra Festival, diretto da Stefano Mancuso, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lo scenario sarà la splendida città di Lucca che ospiterà gli incontri in alcuni dei suoi edifici più suggestivi, come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico, solo per citarne alcuni. Nei 4 giorni del festival si indagherà sullo stato di salute del nostro Pianeta, la nostra casa comune, si indicheranno soluzioni, si immagineranno futuri durevoli e soprattutto si proverà a costruire una sensibilità e una coscienza nuove rispetto alle gravi questioni ambientali, le cui conseguenze riguardano il mondo intero. Ma sarà anche “una festa della vita, di ogni singola vita e dell’unico posto dell’universo che conosciamo in grado di ospitarla”: Stefano Mancuso riassume così lo spirito con cui è nato Pianeta Terra.
OLTRE 70 APPUNTAMENTI
Pianeta Terra sarà il luogo giusto per confrontarsi con studiosi d’eccezione, nazionali e internazionali, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa. Negli oltre 70 appuntamenti previsti durante i quattro giorni del festival si parlerà di ecosistemi, di biodiversità, di energia, di agricoltura e alimentazione, di sviluppo urbano, di risorse, di finanza green, ma anche di storia, antropologia, filosofia, arte, letteratura, musica, fotografia, cinema. Lucca sarà la cornice ideale per ascoltare storie straordinarie di donne e uomini impegnati nella difesa dell’ambiente, di chi ha dato un importante contributo scientifico, di chi è ancora alla ricerca di risposte e strategie, di chi sa che la conoscenza deve continuamente tradursi in sapere condiviso. La scienza è ormai da anni unanime nell’affermare che il riscaldamento globale è il problema più grande che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare. Dobbiamo introiettare questa conoscenza e superare la visione antropocentrica che finora ha contraddistinto le nostre scelte impedendoci di dare un peso reale ai dati mondiali di allerta. Pianeta Terra vuole dare il suo contributo alla formazione di un’opinione pubblica responsabile e informata attraverso il patrimonio di competenze trasversali che verranno offerte nei tanti incontri del festival. “È questo il tempo in cui è più che mai necessario leggere il mondo tutto con occhi nuovi – dice l’editore Giuseppe Laterza – operando una vera e propria rivoluzione per la sostenibilità: un banco di prova difficile, ma decisivo per il nostro futuro.”
IL PROGRAMMA
Durante le quattro giornate del festival interverranno personalità di altissimo profilo: scienziati, antropologi, filosofi, economisti, architetti, urbanisti, storici, scrittori, artisti, innovatori, attivisti, policy makers.
Voci dal mondo. Tra i protagonisti di respiro internazionale: Raj Patel, economista, attivista e studioso di politiche alimentari, affronterà una delle grandi domande del nostro secolo: in vista di una crescita della popolazione mondiale che raggiungerà i 10 miliardi, come potremo nutrire tutti in modo sostenibile?; il Premio Nobel per l’Economia Esther Duflo dialogherà con il Ministro Enrico Giovannini sul legame tra crisi climatica e povertà; l’antropologo Eduardo Kohn discuterà di come ricominciare da una nuova ecologia del sé; due biologi di fama internazionale, Merlin Sheldrake e Menno Schilthuizen, a partire dalle loro ricerche, racconteranno rispettivamente il più misterioso dei 5 regni del vivente – l’ordine nascosto dei funghi – , e il modo in cui gli animali e le piante si adattano a un’urbanizzazione sempre più estesa.
Voci dal pianeta Terra. Ci saranno anche alcuni dei massimi esperti di questioni climatiche e ambientali, tra i quali: Riccardo Valentini, studioso di Ecologia forestale e membro dell’IPCC, nel 2007 insignito del Premio Nobel per la Pace insieme ad altri scienziati del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici; Carlo Carraro, economista ambientale, già Presidente della European Association of Environmental and Resource Economists; Valeria Termini, profonda conoscitrice di politica energetica europea e internazionale; Barbara Mazzolai, responsabile del Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia; Roberto Danovaro, biologo marino e Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn; Emanuela Evangelista, biologa e attivista ambientale che vive in un piccolo villaggio nel cuore dell’Amazzonia; Francesca Bria, tra i massimi esperti di innovazione tecnologica. Si discuterà poi di cibo e sovranità alimentare con Stefano Liberti e Carlo Petrini; di emergenza alimentare con Maurizio Martina e Fabio Ciconte; dello scioglimento dei ghiacciai con Elisa Palazzi e Federico Taddia; di moda rigenerativa con Brunello Cucinelli e Federico Marchetti.
Dialoghi sulla natura. A Pianeta Terra Festival i dialoghi sono costruiti come veri e propri innesti tra interlocutori di discipline diverse. Tra i tanti confronti: Vito Mancuso e Gustavo Zagrebelsky sulla necessità di affrontare concretamente il tema dei «diritti delle generazioni future»; Paolo Cognetti e Stefano Mancuso, in un incontro intitolato Alberi Maestri su cosa possiamo imparare dalle piante; Hervé Barmasse e Giovanni Soldini, per guardare da vicino lo stato delle montagne e dei mari; Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà porteranno a Lucca il format di Rai Radio 3 “Tutta l’umanità ne parla”; Massimo Cirri e Andrea Segrè si chiederanno se è ancora possibile vivere a spreco zero; Melania Mazzucco, insieme a Gregorio Botta, rifletterà su come la natura ha nutrito e ispirato le più straordinarie opere d’arte nel corso dei secoli.
Gli assoli. Il programma sarà arricchito da lezioni, monologhi, racconti, performance. Tra i tanti interventi: Vittorio Lingiardi rifletterà sui paesaggi della psiche; Luciano Canfora sulla fine delle utopie; Emanuele Coccia sul legame che tutti i viventi hanno tra di loro e con la terra; Piergiorgio Odifreddi sul De rerum natura di Lucrezio; Mario Cucinella su come costruire edifici e città sostenibili; Barbara Mazzolai sulle nuove tecnologie che le piante possono ispirare; Roberto Battiston sul perché questo è il secolo delle catastrofi annunciate; Michele Serra sull’innalzamento dei mari, la gestione delle acque, lo stravolgimento climatico e l’inquinamento; Tommaso Parrinello su come le osservazioni dallo spazio ci aiutano a studiare i meccanismi che regolano la biosfera; Adrian Fartade terrà un monologo pieno di umorismo sull’Armageddon che incombe; Alba Donati si soffermerà sul perché spesso è proprio la geografia a ispirarci l’inizio di una nuova vita. Alessandro Vanoli racconterà la storia del mare dal Paleolitico al Plasticene, Amedeo Feniello spiegherà come l’uomo ha saputo affrontare catastrofi e cataclismi nella storia; Moreno Di Marco chiarirà come la perdita di biodiversità mette in pericolo non solo le altre specie ma anche la nostra.
Si parlerà anche di economia circolare, insieme, tra gli altri, a Fabio Iraldo e Fabia Romagnoli, Marco Frey e Luca Ruini, Samir de Chadarevian e Rossano Ercolini; di finanza green con Francesco Profumo e Ferruccio de Bortoli; di transizione energetica in numerosi incontri, come quello con Marco Raugi e Nives Della Valle; di geopolitica dell’energia con Simone Tagliapietra e Valeria Termini, di transizione giusta con Giorgio Airaudo e Simone D’Alessandro; di relazione tra capitalismo e ambiente con Elena Granaglia e Alessio Terzi; di risorse strategiche come l’acqua con Giulio Boccaletti e Raul Caruso.
La Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna, l’Università di Pisa cureranno alcune importanti lecture.
Suoni dal pianeta Terra. Non mancheranno concerti e spettacoli: Stefano Mancuso, direttore del Festival, e il violoncellista Mario Brunello, fra i migliori interpreti di Bach, si troveranno insieme sul palco per raccontare da diverse prospettive la Ciaccona di Bach; il Maestro Gian Paolo Mazzoli eseguirà la Sinfonia n. 2 di Ezio Bosso, ispirata alla “foresta dei violini” della Val di Fiemme, dove crescono i cosiddetti abeti di risonanza e dove liutai di tutto il mondo, a partire dallo stesso Stradivari, sono sempre andati a selezionare i legni per i propri strumenti; e ancora due esperienze immersive con Earthphonia Sapiens Live di Max Casacci con Mario Tozzi, uno show di suoni, ritmi, parole e immagini della natura e dei suoi ecosistemi e con Vox Balaenae di George Crumb, una composizione iconica − eseguita nel blu più profondo − nella quale ci si ispira alla voce delle balene.
All’interno dell’Orto Botanico, è previsto un fitto calendario di laboratori per bambini e ragazzi, organizzato dall’associazione Talea APS e dall’Orto Botanico di Lucca in collaborazione con A.Di.P.A, Immagina ODV, Terra Di Tutti, Plastic Free.
Green Tree Award. Pianeta Terra Festival, in collaborazione con Lucca Film Festival e Green Cross Italia, lancia la prima edizione del Green Tree Award, premio rivolto al film europeo più attento e sensibile alle tematiche ambientali. Verranno selezionati cinque film e una giuria premierà, in occasione del Festival, il film vincitore.
IL TERRITORIO
“Siamo all’inizio di una nuova avventura – commenta Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – alla quale ci affacciamo con entusiasmo. Non si tratta soltanto di sostenere la nascita di un festival di respiro internazionale, ma di dar vita a occasioni di confronto su tematiche già al centro degli interventi della Fondazione e che coinvolgono direttamente anche il nostro territorio, soprattutto considerando le peculiarità del suo tessuto industriale e produttivo. Lucca potrà così diventare un centro di riferimento per l’innovazione a favore della “rivoluzione per la sostenibilità”.
Una manifestazione che arriva a Lucca grazie alla Fondazione ed è costruita con la straordinaria partecipazione corale delle molte realtà culturali, istituzionali e imprenditoriali del territorio: l’Associazione Musicale Lucchese, l’Associazione Talea, la Biblioteca Civica Agorà, il Centro di Ricerca Rifiuti Zero, la Fondazione Giuseppe Pera, Green Cross Italia, Lucca Biennale Cartasia, Lucca Comics & Games, Lucca Film Festival, Lucense, l’Orto Botanico di Lucca, Photolux Festival e Virtuoso & Belcanto.
Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio di importanti enti locali e non solo. Quello della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, della Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’Università di Pisa, dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, della Coldiretti Lucca e di Rai per la Sostenibilità ESG.
Pianeta Terra Festival è un progetto ideato e organizzato dagli Editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Mancuso. È promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la partnership istituzionale della Città di Lucca e grazie al sostegno di Banco BPM, partner della manifestazione; Sofidel, main sponsor; Confindustria Toscana Nord, Ecopol, EOS IM, Green Utility, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini, tutti sponsor del Festival; e Gruppo RetiAmbiente e Toscotec, supporter del progetto. Media partner dell’iniziativa sono Rai Radio 1 e Rai Radio 3.
Gli incontri di Pianeta Terra Festival sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo e tutte le informazioni pratiche sono disponibili e costantemente aggiornati sul sito pianetaterrafestival.it e sui canali social Facebook, Instagram e Twitter.







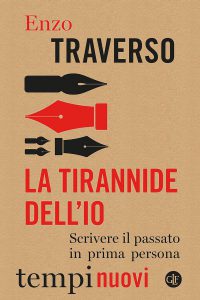




 www.pianetaterrafestival.it
www.pianetaterrafestival.it