Il 23 maggio 1992 un’esplosione devastava un tratto dell’autostrada A29 all’altezza di Capaci, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nemmeno due mesi dopo – il 19 luglio – in via D’Amelio a Palermo venivano uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque poliziotti della sua scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi e Eddie Walter Cosina.
Trent’anni dopo, rileggiamo quei giorni spaventosi nelle parole di Salvo Palazzolo e Giovanni Tizian.
«Bisogna ricordare cosa è successo a Palermo in quel 1992 – dice Tina Montinaro, la vedova di Antonio, il caposcorta del giudice Falcone, morto con lui nella strage di Capaci –, tante cose sono cambiate, ma non abbiamo ancora tutta la verità. Memoria deve essere anche giustizia, continueremo a chiederla». Tina porta in giro per l’Italia i resti della Quarto Savona 15, l’auto blindata su cui viaggiavano il marito e i colleghi Rocco Dicillo e Vito Schifani. «Voglio dimostrare che quei ragazzi non li hanno fermati».
 Porticello (Santa Flavia), 11 aprile 1992
Porticello (Santa Flavia), 11 aprile 1992
Le lampare illuminano il mare, che è una tavola dopo l’ultima burrasca. Cinque uomini sono appena saliti su uno dei pescherecci ormeggiati alla banchina di questo borgo incastonato fra gli scogli a poca distanza da Bagheria, dove i palermitani vengono a mangiare il pesce fresco. Stanno tirando delle funi. «Fate piano», dice uno di loro. Dall’acqua emerge un fusto di metallo, poi un altro.
È Fifetto Cannella a guidare il gruppo, l’uomo che ha accompagnato Graviano a Roma. La trasferta è durata poco, appena dieci giorni. Neanche il tempo di fare un po’ di shopping e frequentare i locali più alla moda, fra un appostamento e l’altro. All’improvviso, chissà perché, Totò Riina ha fatto sapere che per adesso non serve colpire nella Capitale. «A Palermo ci sono cose più grosse per le mani», ha detto. «E dunque bisogna scendere», ha spiegato Giuseppe Graviano. Anche se l’attentato a Maurizio Costanzo si sarebbe potuto già imbastire, con la carica di tritolo arrivata col camion partito da Mazara. «Ma a Palermo ci sono cose più grosse per le mani». Palermo sta iniziando a precipitare dentro un baratro, che presto risucchierà tutto il Paese. Il 12 marzo, Riina ha mandato altri killer a uccidere l’eurodeputato democristiano Salvo Lima, il luogotenente di Giulio Andreotti in Sicilia, è accusato di non aver fatto abbastanza per aggiustare l’esito del maxiprocesso in Cassazione. Poi, Riina ha chiesto a Graviano di procurare dell’esplosivo perché il piano di morte riguardante Falcone è cambiato. Il giudice dovrà essere ucciso a Palermo, e non a Roma. Non più da un commando armato, ma da un’onda che travolgerà l’autostrada. E Graviano ha ordinato ai suoi di provvedere.
[…] «Sicuramente c’è qualcuno che ancora oggi cerca di tirare i fili. I depistaggi, purtroppo, continuano», mi ha detto Antonio Vullo mentre camminavamo in via D’Amelio. Il pomeriggio del 19
luglio 1992, fu l’unico sopravvissuto della strage che spazzò via Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. «Chi non vuole la verità? – ripete – Chi non vuole sapere cosa accadde realmente?».
In via D’Amelio, Giuseppe Graviano azionò il telecomando dell’autobomba. «Ma chi è entrato poi in quell’inferno, mentre tutto era in fumo, per rubare l’agenda rossa di Borsellino?».
Salvo Palazzolo, I fratelli Graviano
Quella sera davanti alla televisione, mentre scorrevano le immagini della strage di Capaci, mi ricordai di quando mia nonna Amelia mi portò a vedere la piazzola del museo di Locri, il luogo dell’assassinio di Peppe Tizian, mio padre.
 Il 23 maggio 1992 avevo dieci anni, ero un bambino, e vivevamo ancora in Calabria. Per la precisione nella provincia di Reggio Calabria, a Bovalino, un paese di 8mila abitanti, sospeso tra l’Aspromonte e il mar Jonio. A soli dieci anni portavo un carico di dolore sulle spalle e nel cuore che quelle macerie di asfalto e lamiere di Capaci rendevano se possibile ancora più insopportabile, opprimente. «Nonna, nonna, hanno ucciso un giudice a Palermo, siamo in guerra!», urlai correndo attraverso il corridoio arioso verso la grande cucina della casa della mia infanzia.
Il 23 maggio 1992 avevo dieci anni, ero un bambino, e vivevamo ancora in Calabria. Per la precisione nella provincia di Reggio Calabria, a Bovalino, un paese di 8mila abitanti, sospeso tra l’Aspromonte e il mar Jonio. A soli dieci anni portavo un carico di dolore sulle spalle e nel cuore che quelle macerie di asfalto e lamiere di Capaci rendevano se possibile ancora più insopportabile, opprimente. «Nonna, nonna, hanno ucciso un giudice a Palermo, siamo in guerra!», urlai correndo attraverso il corridoio arioso verso la grande cucina della casa della mia infanzia.
Guerra, dissi così. La guerra che avevamo imparato a riconoscere con l’attacco americano in Iraq nel 1991, il primo conflitto trasmesso in diretta tv, con i traccianti verdi dei missili che illuminavano il cielo di Baghdad. I bambini davanti alle edizioni straordinarie dei tg insieme agli adulti, sorpresi e impauriti. Palermo come Baghdad. L’Italia come l’Iraq.
Amelia mi guardò con gli occhi lucidi, aveva visto, aveva sentito il tg. La prima edizione straordinaria andò in onda intorno alle sei e mezza di pomeriggio, o forse erano le sette. Quella bomba fu l’inizio della fine, capimmo che se neanche il celebre pool antimafia di Palermo poteva niente contro la mafia, come avremmo potuto noi soli e abbandonati dalle istituzioni, in una Calabria ridotta in schiavitù, combattere contro le feroci cosche della ’ndrangheta che avevano ucciso mio padre e incendiato il mobilificio di famiglia? L’idea di andare via si trasformava giorno dopo giorno sempre più in certezza che divenne definitiva il 19 luglio 1992, intorno alle cinque del pomeriggio: l’edizione straordinaria del Tg3 annunciava un’altra strage, quella di via Mariano D’Amelio. Voci confuse, all’inizio senza conferma, indicavano un giudice ammazzato. Ma chi? Chi era?, ci chiedevamo. Paolo Borsellino, sentenziò la giornalista quando arrivò la conferma dal territorio trasformato in Beirut da cosa nostra e da chissà quale altro potere. Lasciammo la Calabria un anno dopo, il tempo di organizzarci e trovare un luogo dove ricominciare a vivere, lontano dal dolore.
Lasciammo lì ogni desiderio di giustizia e di verità. Perché non sempre si trova la forza di lottare.
Sono trascorsi trent’anni dalle stragi. Dal 1992 che doveva cambiare l’Italia e che ha lasciato ogni cosa immutata: le bombe di cosa nostra, certo, ma anche il Paese sull’orlo del fallimento, la crisi politica, l’alba di Tangentopoli. Un Paese dilaniato, che già portava le lacerazioni degli anni della strategia della tensione, con altre bombe, altre stragi. La strategia della tensione, forse, che non è mai finita seppure si manifesti in forme diverse. Perché in fondo, per quanto la pelle del Paese muti, lo scheletro marcio e ipocrita resta intatto. Gli sconvolgimenti politici, giudiziari, sociali ed economici di quell’anno rappresentavano l’occasione unica offerta dalla storia per rivoluzionare la società italiana. Opportunità sprecata. Il gorgo di vizi e illegalità ha risucchiato ogni tentativo di cambiamento.
A distanza di trent’anni dunque che cosa è cambiato? La lotta alla mafia è diventata la lotta alle mafie, c’è maggiore consapevolezza, dicono esperti e studiosi del fenomeno. L’ho detto anche io per un periodo, l’ho scritto, l’ho ripetuto spesso nelle scuole agli studenti, più per non deluderli che perché ci credessi veramente.
Ma è arrivato il momento di dire la verità anche se questa fa l’effetto dell’ortica strofinata su una ferita.
Giovanni Tizian, Il silenzio



 «Il Giappone è quel luogo dove i fantasmi sono reali. È un paese che nasconde la propria spiritualità dietro alle luci brillanti dei malls, al cemento degli uffici e delle autostrade, al fumo dei bar e degli izakaya. È nelle campagne silenziose, nell’intimità delle case, che appaiono i fantasmi della tradizione, gli dèi dello shintoismo e gli eroi delle leggende, i tengu e gli spiriti dispettosi che interagiscono con gli umani. Conoscere questo Giappone è molto complesso per un gaikokujin, uno straniero, perché è difficile esserne accettato, è difficile da comprendere, difficile da trovare. Ho dovuto lasciarmi alle spalle la città, le guide, i reportage scritti in inglese per gettarmi nel vuoto. È così che li ho incontrati, questi spettri reali, per la prima volta in una foresta tanto imponente quanto dimenticata, dove i primi passi mi hanno lasciato letteralmente senza fiato. E da lì questi fantasmi mi hanno seguito per tutto il mio viaggio, tra le decine di villaggi abbandonati, gli ultimi monaci animisti al mondo, gli alberi millenari grandi come torri e venerati come dèi. Erano con me tra le case piccole, dai tetti blu, immerse nella nebbia, circondate dal tè profumato di rugiada, negli altari nascosti dal muschio, nella foresta che divora la vallata e i suoi abitanti».
«Il Giappone è quel luogo dove i fantasmi sono reali. È un paese che nasconde la propria spiritualità dietro alle luci brillanti dei malls, al cemento degli uffici e delle autostrade, al fumo dei bar e degli izakaya. È nelle campagne silenziose, nell’intimità delle case, che appaiono i fantasmi della tradizione, gli dèi dello shintoismo e gli eroi delle leggende, i tengu e gli spiriti dispettosi che interagiscono con gli umani. Conoscere questo Giappone è molto complesso per un gaikokujin, uno straniero, perché è difficile esserne accettato, è difficile da comprendere, difficile da trovare. Ho dovuto lasciarmi alle spalle la città, le guide, i reportage scritti in inglese per gettarmi nel vuoto. È così che li ho incontrati, questi spettri reali, per la prima volta in una foresta tanto imponente quanto dimenticata, dove i primi passi mi hanno lasciato letteralmente senza fiato. E da lì questi fantasmi mi hanno seguito per tutto il mio viaggio, tra le decine di villaggi abbandonati, gli ultimi monaci animisti al mondo, gli alberi millenari grandi come torri e venerati come dèi. Erano con me tra le case piccole, dai tetti blu, immerse nella nebbia, circondate dal tè profumato di rugiada, negli altari nascosti dal muschio, nella foresta che divora la vallata e i suoi abitanti».

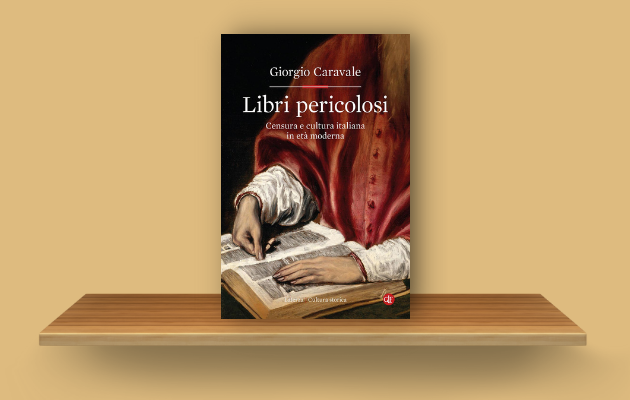













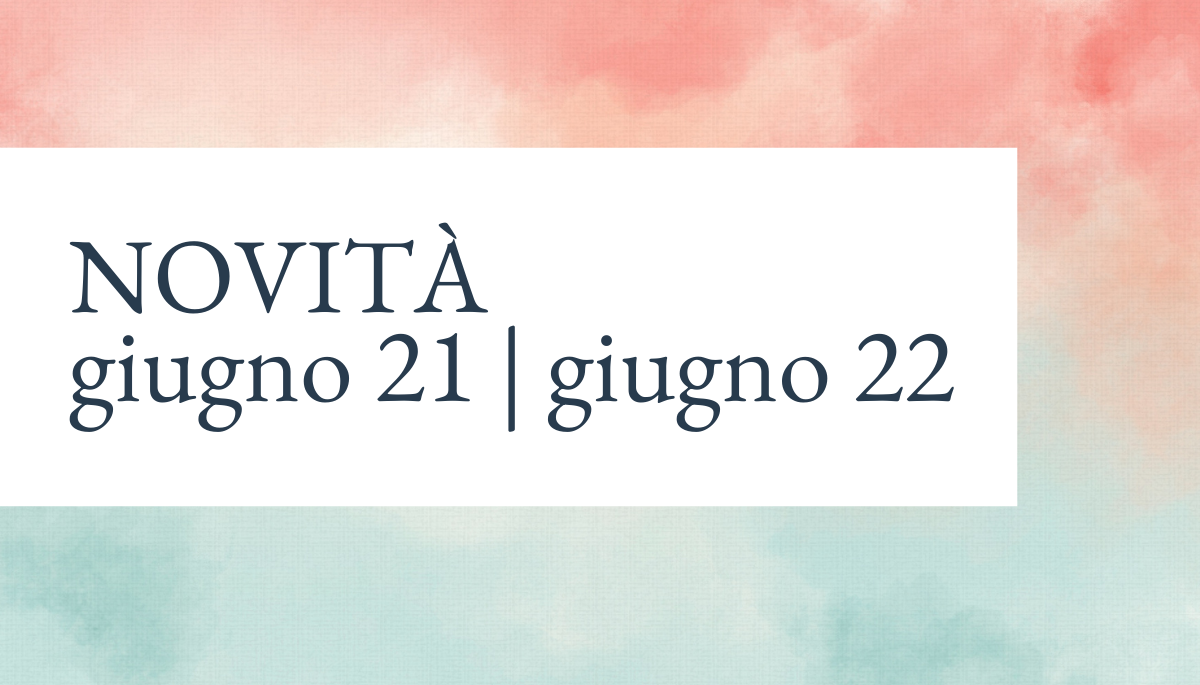









 Carlo Greppi
Carlo Greppi Eric Gobetti
Eric Gobetti Francesco Filippi
Francesco Filippi Pino Ippolito Armino
Pino Ippolito Armino Chiara Colombini
Chiara Colombini Gianluca Falanga
Gianluca Falanga Mimmo Franzinelli
Mimmo Franzinelli Tommaso Speccher
Tommaso Speccher
