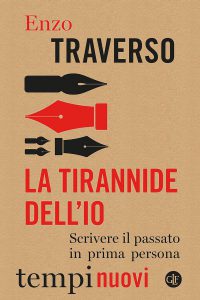Trent’anni fa, a i tempi di Mani Pulite, si affermarono programmi che secondo Simona Colarizi allevarono i prototipi degli odierni haters. Ma quello, a differenza di guanto accade con i social, fu un fenomeno collettivo
Giandomenico Crapis | l’Espresso | 15 maggio 2022
La storica Simona Colarizi nel saggio Passatopresente, uscito di recente, parla dell’azione «devastante» della tv nei primi anni Novanta, che allevò con i suoi talk i prototipi degli odiatori del ventunesimo secolo. Un giudizio tranchant e senza appello. Ma davvero i lanciatori di monetine dell’hotel Raphaël erano gli antenati degli odierni haters? Lo vedremo più avanti, dopo avere ricordato a trent’anni da Mani Pulite il ruolo che vi ebbe la televisione, cercando di collocarne l’azione in una prospettiva di più lungo periodo. Certo, la tv fu la protagonista principale di Tangentopoli, non solo documentandone gli sviluppi quotidiani ma costruendo sulle inchieste, proprio in virtù di questo fatto, una saga avvincente. Se a partecipare a questo racconto fu l’intero sistema dei media, la parte del leone però se la ritagliò il piccolo schermo. E con esso alcuni programmi come quelli condotti da Michele Santoro, Gianfranco Funari, Gad Lerner, che da qualche anno avevano inventato la gente, un soggetto sociale inedito. Proprio Santoro ne aveva certificato l’esistenza pochi giorni prima del fatidico 17 febbraio del ‘92, quando il «mariuolo» Mario Chiesa veniva preso con le mani nel sacco. L’aveva fatto allestendo una puntata di “Samarcanda” sul «partito che non c’è» dando spazio all’indignazione del «partito invisibile», quello, spiegava, della gente arrabbiata «nei confronti dei partiti che ci sono». La stessa indignazione e la medesima gente che un mese e mezzo dopo da Palermo gridava ai microfoni del conduttore che la morte di Salvo Lima non era come quella di Piersanti Mattarella.
 Da un versante meno politicamente segnato un altro conduttore, Gianfranco Funari, riservava ai politici ospitati un trattamento ruvido e diretto: del resto per lui il talk show era «chiamare gente comune, dargli un tema e farglielo svolgere indipendentemente dal linguaggio che usa». Man mano che il verminaio di Tangentopoli veniva scoperchiato “Conto alla rovescia” cresceva negli ascolti, mentre lui incitava apertamente i magistrati e Antonio Di Pietro ad andare avanti. Più forbito ma non meno spigoloso appariva Gad Lerner, che nel ‘92 aveva cominciato a rovistare nel malessere filoleghista, e un poco razzista, del “profondo Nord”, diventando presto anch’egli con “Milano Italia”, un approfondimento quotidiano dedicato alle vicende di Mani Pulite di cui ci offriva sera per sera un’immagine aggiornata, uno degli alfieri di coloro che mettevano alla sbarra tutta una classe politica.
Da un versante meno politicamente segnato un altro conduttore, Gianfranco Funari, riservava ai politici ospitati un trattamento ruvido e diretto: del resto per lui il talk show era «chiamare gente comune, dargli un tema e farglielo svolgere indipendentemente dal linguaggio che usa». Man mano che il verminaio di Tangentopoli veniva scoperchiato “Conto alla rovescia” cresceva negli ascolti, mentre lui incitava apertamente i magistrati e Antonio Di Pietro ad andare avanti. Più forbito ma non meno spigoloso appariva Gad Lerner, che nel ‘92 aveva cominciato a rovistare nel malessere filoleghista, e un poco razzista, del “profondo Nord”, diventando presto anch’egli con “Milano Italia”, un approfondimento quotidiano dedicato alle vicende di Mani Pulite di cui ci offriva sera per sera un’immagine aggiornata, uno degli alfieri di coloro che mettevano alla sbarra tutta una classe politica.
La verità era che la tv da qualche anno aveva assunto una nuova collocazione dentro la società e rispetto alla politica. Vanno di svolta era stato il 1987 con “Linea Rovente”, trasmissione condotta da Giuliano Ferrara che nei panni di un pubblico ministero imbastiva un processo su fatti che coinvolgevano politici o altri personaggi, sollecitando alla fine (tramite il telefono) il verdetto degli spettatori, primo nucleo costituivo di quella che poi sarebbe diventata la “gente”. Gli si sarebbe affiancato l’anno dopo Michele Santoro con “Samarcanda”, sguardo puntato su mafia e Sud trattati con reportage “forti”, e lo studio aperto alle piazze. Anche lo spettacolo del sabato sera nel 1987 sperimentava un’edizione di “Fantastico” «impegnata» condotta da Adriano Celentano, che proprio alla “gente” si rivolgeva con i suoi provocatori sermoni. Sia Ferrara sia Santoro andavano in onda nella neonata Raitre di Angelo Guglielmi dove il cambiamento si realizzava anche grazie ad altre trasmissioni, alcune delle quali in auge ancora oggi (“Telefono Giallo”, “Chi l’ha visto”, “Un giorno in pretura”). Poiché la filosofia del neodirettore era quella di «raccontare la realtà con la realtà», il racconto del reale divenne la mission della rete: fu così che il genere “informazione” si ritagliò una fetta centrale nel palinsesto della Rai, conquistandosi la prima serata con una visibilità prima appannaggio solo di qualche fuoriclasse come Enzo Biagi o Sergio Zavoli. Di questa tv della realtà l’uomo di punta, il conduttore più celebrato e contestato, divenne ben presto il salernitano Santoro: «Il numero uno, ma quanto antipatico», avrebbe scritto alla fine del 1991 Beniamino Placido. Santoro, come Ferrara, aveva puntato su un modello eterodosso di giornalismo, ma a differenza di quest’ultimo non solo riempiva il piccolo schermo di contenuti poco frequentati come il Sud e la mafia, ma apriva lo studio alla piazza, garantendo a casalinghe, operai, disoccupati, studenti l’interlocuzione con i politici e gli ospiti che sedevano dietro la telecamera.
La “tv militante”, chiamiamola così, di cui la “gente” fu l’indubbio prodotto, impresse una formidabile torsione alla “neotelevisione”. Con Santoro essa s’imponeva definitivamente (dopo “Samarcanda”, “Il Rosso e il Nero”, “Tempo Reale”) e se con Funari il modello era quello del bar sport (“Aboccaperta”, “Mezzogiorno italiano”), con Lerner assumeva quello neoassembleare e sessantottino, con i programmi allestiti in teatro dando la parola al pubblico in sala (“Profondo Nord” e “Milano, Italia”). Da questa tv veniva fuori un racconto dell’Italia dall’impianto drammaturgico e conflittuale, con messe in scena collettive in cui l’esuberanza della parola la faceva da padrona, dando un taglio netto alle nobili tradizioni giornalistiche dell’inchiesta o del documentario. Insomma una tv che scompaginava l’arena del discorso pubblico e un modello che se da una parte dava voce a saperi quotidiani prima esclusi dalla scena, dall’altra, esposto alla forte prevalenza del contenuto sulla forma, dominato dal conflitto e dalla drammatizzazione, correva il rischio di degenerare, specie in assenza di professionisti all’altezza. Ma soprattutto è con il talk impegnato e la comparsa dei nuovi conduttori (ma sono da ricordare anche Maurizio Costanzo e Piero Chiambretti) che il video diventava insieme bussola e termometro del Paese. Inoltre ribaltava i rapporti con la società e soprattutto con la politica animando passioni e conflitti, tematizzando questioni, creando eventi, come accadde con la staffetta antimafia tra “Samarcanda” e il “Costanzo show” del 26 settembre ‘91. Fu questo forse, con i suoi otto milioni e più di spettatori e la sua altissima carica emotiva, il punto più alto (oggi del tutto dimenticato, anche nelle ricostruzioni storiche) di un inedito sommovimento civile, il momento clou di una stagione che sembrò prima di impantanarsi in un teatrino inconcludente, ricaricare di forze vitali il dipolo società-politica.
Il mito della “società civile” contrapposta a quella “politica” (il vecchio “Paese reale” vs “Paese legale”), nasceva anche da queste trasmissioni che davano voce, e speranza, a tante persone fino ad allora rimaste in silenzio, schiacciate da ‘ndranghete e mafie, dal pizzo e dalle estorsioni. Era la società civile dei commercianti di Capo d’Orlando, degli otto milioni di spettatori della staffetta antimafia in memoria di Libero Grassi, dei tanti, militanti o senza tessera, ani- mati dalla voglia di cambiare una politica ingessata o peggio corrotta. Prima di diventare un mito autoassolutorio, come giustamente scrive Colarizi, la società civile celebrata dalla tv di quegli anni emergeva da un inferno di malaffare e sopraffazione, dal senso di soffocamento, prodotto da partiti immobili e dal giogo della mafia, su un’ampia fetta di italiani. La tv con e le sue battaglie e le sue denunce era diventata un riferimento, più che i partiti, i sindacati, la Chiesa. È bene non dimenticarlo.
L’impatto di questa “tv militante” che prendeva di mira mafia, politica, corruzione con ascolti stellari fu potente, tanto che proprio in televisione, più che altrove, finì col celebrarsi la morte della prima Repubblica. Il decesso lo certificava sempre RaiTre con “Un giorno in pretura”, mandando in onda nel corso del ‘93 i processi che vedevano imputata la classe di governo, infliggendole davanti a milioni di persone un “rituale di degradazione” impensabile solo qualche anno prima.
Il mutamento inauguratosi nel ‘87 però si esauriva presto. Nel gennaio del 1996 la nascita del “Porta a Porta” di Bruno Vespa tra lustrini e paillettes ne sanciva il tramonto, ma la carica dirompente c’era stata, eccome, e aveva cambiato tutto: sfera pubblica, partiti, politica, la stessa televisione. Perché era indubbio che la tv con le sue piazze e i suoi teatri aveva allargato i contorni ristretti ed elitari della sfera pubblica, che i partiti e la politica ne uscivano stravolti, cercando salvezza nella scorciatoia di leadership personali invece che nel reinsediamento sociale. La medesima tv ne usciva deformata, fuori margine, con una funzione ipertrofica e con qualche rischio in agguato. Ma davvero gli haters dei social sono i nipotini di quella tv? Non scherziamo: nella tv fiammeggiante dei Santoro, dei Ferrara, dei Lerner l’indignazione aveva una matrice collettiva, non priva di passioni altruiste, era il prodotto di un sistema che si mostrava immutabile, corrotto, a volte colluso con le mafie. La rabbia degli odiatori di oggi, invece, è frutto dell’individualismo esasperato dei social, non ha altre passioni che il narcisismo patologico, in un contesto storico privo di riferimenti che non siano l’attenzione per il sé. Se in quella c’era ancora un briciolo di comunità in questa c’è solipsismo malato.
Il punto piuttosto è che di quella televisione non è rimasto nulla. Non i conduttori di un tempo né gli ascolti, non un programma che detti come allora l’agenda, faccia le prime pagine dei giornali. La tv politica di oggi ha finito sovente per accentuare le componenti emotive, teatrali e buffonesche della rappresentazione mediatica. Se quella tv fu capace di portare in video un dramma autentico e di esercitare un reale contropotere, oggi siamo di fronte, tranne qualche eccezione, a una commedia delle parti dai tratti a volte farseschi o fake, le piazze finte, le parole vuote. Insomma se quella tv allargava la sfera pubblica del Paese arricchendola, questa la immiserisce, la banalizza infine la restringe.