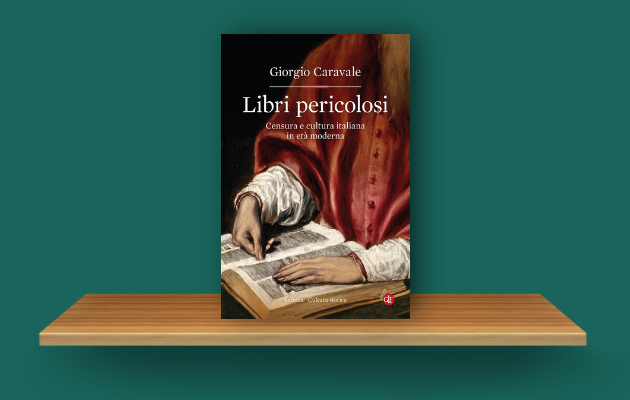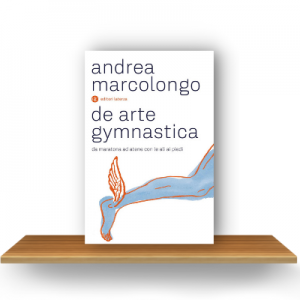Un libro dello storico Giorgio Caravale ripercorre la storia delle politiche di limitazione della libertà d’espressione, smontando i luoghi comuni. Il nostro mondo è il prodotto di filtraggio e sintesi all’interno di una dialettica aspra.
Raffaele Alberto Ventura | Domani | 18 marzo 2022
Siamo abituati a considerare la censura come un fenomeno condannabile e retrogrado, caratteristico di regimi autoritari come Russia o Cina. La “cancel culture” degli americani ci appare come la sua forma più blanda, un retaggio arcaico inspiegabilmente sopravvissuto al vento del progresso. Questa nostra diffidenza è figlia della cultura illuminista e liberale, forgiata nella lotta contro le istituzioni tradizionali, stato chiesa famiglia.
La censura, nel nostro immaginario, coincide con il Super-Io freudiano che viene a bastonare la vitalità e la creatività.
Eppure siamo pronti a concedere che sia talvolta opportuno sanzionare la disinformazione, la diffamazione, il bullismo, l’odio, fenomeni amplificati dalla tecnologia: un tempo era la stampa, oggi la rete. Con la modernità nasce la censura, ma forse vale anche il contrario: e se invece fosse dalla censura che nasce la modernità?
Con la modernità nasce la censura, ma forse vale anche il contrario: e se invece fosse dalla censura che nasce la modernità?
LE VIRTÙ DELLA CENSURA Prendiamo l’esempio dell’Inghilterra del Cinquecento, nella quale fiorivano gli spettacoli popolari a tema biblico, dalla storia di Adamo ed Eva alla passione di Cristo.
Una tradizione, quella del mistery play, brutalmente annientata da una serie di misure di censura. In un contesto di crescenti tensioni religiose, di tafferugli e violenze a margine delle rappresentazioni, come tre attori bruciati vivi a Salisbury nel 1541, i poteri pubblici iniziarono a intervenire per limitare la libertà: per andare in scena bisognava far verificare il testo alle autorità, ci voleva il nome di un autore da perseguire, bisognava rispettare certi luoghi e certi tempi, professionalizzarsi, e soprattutto venne proibito di affrontare temi caldi legati alla fede.
Insomma in pochi anni tra il 1543 e il 1576 la censura impose lo sviluppo del testo scritto, la definizione della figura dell’autore, la professionalizzazione degli attori, la costruzione di teatri e l’approdo a temi storici, politici, comici.
Così hanno iniziato a spuntare nuove forme teatrali, che ancora oggi leggiamo e mettiamo in scena perché la messa per iscritto, imposta dal legislatore, ha permesso di tramandarle: storie di vendetta e di potere, d’amore e di gelosia.
Tempo pochi anni e nel 1592 andò in scena il Riccardo III, capolavoro che viene rappresentato quotidianamente ancora oggi. In breve, la censura aveva creato Shakespeare. E pazienza per Adamo ed Eva, no?
UN’EPIDEMIA DA CONTENERE Fenomeni simili sono accaduti in tutta Europa, perché tutta Europa era divisa sulle questioni religiose: nel 1517 Lutero aveva reso pubbliche le sue 95 tesi contro il papa, nel 1534 veniva ratificato lo scisma anglicano.
Con la diffusione della stampa, i diversi poteri si erano convinti che fosse necessario controllare la proliferazione e la circolazione dei libri, che portava con sé il seme della divisione. Le società dell’epoca, proprio come la nostra, erano fondate sulla condivisione di un immaginario comune, e comprensibilmente si temeva quel che sarebbe accaduto – e che infatti accadde – e si fosse frammentata quell’unità.
Bisogna resistere alla tentazione di leggere la storia della Riforma come una lotta tra progressisti e reazionari: spesso erano i protestanti i più fondamentalisti e sessuofobi, e taluni episodi che associamo alla Controriforma cattolica, come i celebri braghettoni aggiunti al Giudizio Universale di Michelangelo, non erano altro che misure predisposte per venire incontro alla nuova sensibilità.
Una fetta importante di questa vicenda la racconta lo storico Giorgio Caravale in Libri pericolosi. Censura e cultura italiana in età moderna, appena uscito per Laterza, mostrando come la censura non fosse un banale interruttore che accende e spegne la vita culturale bensì una forza che la rimodula, la orienta, la filtra, al di là del bene e del male: un fenomeno storico a tutto tondo, nella sua complessità.
Un tentativo, fin dall’inizio, non soltanto di affrontare problemi politici e di ordine pubblico, ma anche di gestire il sovraccarico costituito dalla produzione intellettuale attraverso un’ambiziosa economia pianificata del sapere, che a sua volta produce delle strategie di aggiramento che trasformano in profondità le forme di espressione e i registri espressivi.
LA POLITICA CULTURALE DELLA CHIESA Da parte papista, il contenimento della pubblicistica protestante apparve come un’urgenza in tutta Europa dalla metà del Cinquecento.
Come se già non fosse abbastanza complesso arginare i borbottii ereticali disseminati da predicatori e fraticelli con i poveri mezzi del passaparola, l’invenzione di Gutenberg aveva spostato il problema su una scala epidemica.
A Parigi, Lovanio, Milano, Venezia si stilano elenchi di libri proibiti, come poi a Roma con il Sant’Uffizio e il proverbiale Indice (1558), s’istituiscono magistrature preposte al controllo delle pubblicazioni e si definiscono sanzioni per i contravventori.
Il fosco ritratto della macchina repressiva papista viene tuttavia temperato da Caravale con vari elementi: innanzitutto la chiesa è tutt’altro che monolitica, e le maree della censura rispecchiano il moto astrale dei poteri al suo interno, i contrasti tra il centro e la periferia, l’equilibrio tra spinte riformatrici e spinte conservative; secondariamente non è monolitico lo spettro dell’eresia da sanzionare, che va da minuscoli scarti terminologici alle più visionarie cosmogonie alternative, in pratica le “fake news” dell’epoca. Soprattutto emerge un conflitto permanente tra norma e prassi.
Lontano da ogni caricatura, Caravale mostra bene quanti margini di libertà lasciano in ogni tempo i dispositivi di repressione.
La massa di testi da controllare e perseguire era troppo grande e i mezzi semplicemente non bastavano. Più profondamente perché lo scopo della chiesa spesso non era di cancellare i testi, soprattutto quando presentavano un valore intrinseco come quelli di Boccaccio e Petrarca, bensì correggerli ed emendarli dai loro errori.
Il risultato concreto fu di operare un continuo aggiornamento per renderli leggibili di epoca e in epoca: una fondamentale opera di mediazione culturale.
NON SI POTEVA PIÙ DIRE NIENTE Non era solo la chiesa a censurare: come nel caso inglese, o come in Francia dove Francesco I istituisce il deposito legale di ogni libro presso la Biblioteca del re, la censura è il primo grande banco di prova del potere dello stato moderno, lo spazio nel quale inizia a costituirsi un nuovo tipo di giurisdizione, spesso in conflitto con quella papale.
Caravale mostra come il dibattito all’epoca non fosse tanto sull’opportunità o meno che vi fosse una qualche forma di censura sulla produzione intellettuale e libresca, quanto su chi dovesse effettivamente svolgerla e in che modo.
Perché i problemi dell’epoca non erano tanto diversi da quelli da cui sorge oggi il dibattito sul “politicamente corretto”. Anzi erano esattamente gli stessi: controllare le esternalità negative della libertà sessuale, temperare l’odio intercomunitario, arginare la diffusione di saperi non conformi.
Obiettivo primario delle politiche di censura non era tanto quello di reprimere le minoranze religiose quanto piuttosto di evacuare i conflitti. Gli editti di pacificazione francese, dal 1570 in avanti, non fanno altro che insistere sulla necessità di una censura trasversale per cancellare la memoria delle violenze reciproche.
Lo stato moderno nasce facendo nascere uno spazio nuovo, che prima non esisteva, e che oggi chiamiamo “spazio pubblico”. Uno spazio sociale ordinato, sottomesso a dispositivi giuridici e polizieschi, ovvero oggetto di privilegio, registrazione, controllo, amministrazione, protezione ed eventualmente sanzione.
Il risultato di queste politiche fu di dare corpo a nuove comunità, definite dall’influenza di specifici centri di coordinamento della produzione culturale, che diventeranno poi le comunità nazionali.
LA CENSURA NON È UN PRANZO DI GALA Ovviamente la censura non è un pranzo di gala. Essa appare, a ogni epoca, come una forza sostanzialmente conservativa, che rallenta il cambiamento. È ovvio che soltanto spingendo in là i limiti del dicibile sia possibile generare innovazione – nella scienza, nelle arti, nella politica – e smuovere i rapporti di potere. La censura inoltre ricorre in talune occasioni a strumenti di repressione violenta, raramente persino alla morte.
E Caravale insiste sulla dimensione elitista nel progetto di “proteggere” i meno istruiti dai danni della lettura.
Tuttavia Libri pericolosi ci ricorda che la nascita della modernità non è banalmente il risultato dell’esplosione di certe istanze spontanee di novità, bensì il prodotto di un filtraggio e di una sintesi, all’interno di una dialettica aspra. Ci mostra, insomma, come la censura ha plasmato il mondo in cui viviamo.