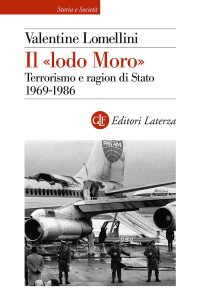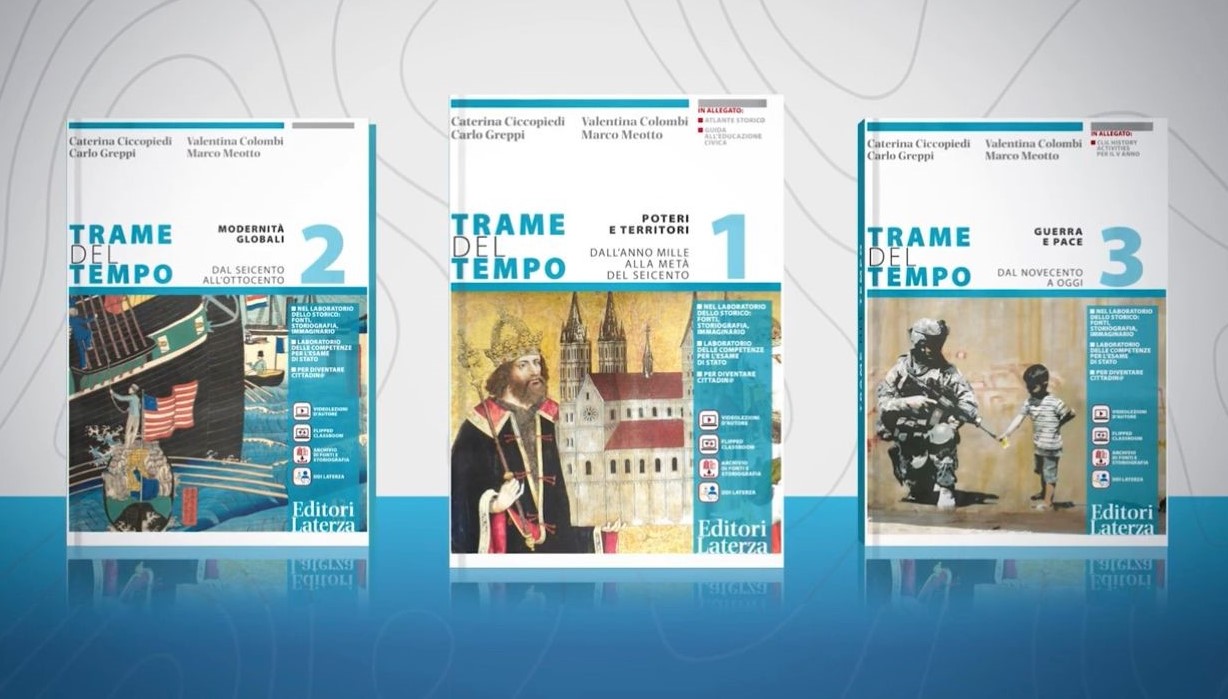Prof. Claudio Vercelli, Lei è autore del libro Israele. Una storia in 10 quadri edito da Laterza: quale dibattito percorre la società israeliana in merito al carattere ebraico dello Stato?
 Che Israele sia lo Stato degli ebrei è un dato assodato, prima di tutto attraverso la cognizione dei processi storici che tra l’Ottocento e il Novecento hanno portato alla nascita di quella comunità politica. Stato degli ebrei indica non una proprietà esclusiva ma il prodotto di un percorso che ha visto gli ebrei medesimi protagonisti di un via nazionale alla soluzione dei loro problemi, innanzitutto l’antisemitismo ma anche, non di meno, l’assimilazionismo, ovvero il rischio di perdere definitivamente i tratti identitari che avevano comunque mantenuto, sia pure attraverso molti cambiamenti, nella Diaspora. Altra cosa, anche se convenzionalmente si usa le espressioni come intercambiabili, è parlare invece di «Stato ebraico». Poiché in questo secondo caso, invece, ci si riferisce ad una sovranità politica che sarebbe basata sul diritto ebraico, ossia su un insieme di norme derivate dai testi religiosi fondamentali. Tradizionalmente, infatti, le religioni codificano e trasmettono non solo valori e principi ma anche regole vincolanti di condotta. I processi di secolarizzazione che hanno interessato le società negli ultimi secoli hanno invece concorso ad affrancare la sfera della politica da quella dell’autorità religiosa. Di fatto, la capacità di generare norme vincolanti si è trasferita in un potere che si vuole laico poiché indipendente dalla religione, ancorché non indifferente ad essa da un punto di vista tuttavia esclusivamente etico. Altrimenti, piuttosto che parlare di democrazia sarebbe meglio rifarsi alla teocrazia. Israele ha un corpus giurisprudenziale che si rifà solo per minima parte alla tradizione ebraica, mentre invece le sue leggi, e il modo in cui esse vengono applicate, sono tipici di una moderna democrazia secolarizzata. Altro tema, invece, è il rapporto tra identità ebraica, religiosità e sfera pubblica. Questo secondo aspetto rimanda non tanto all’autonomia delle amministrazioni collettive (lo Stato), chiamate a tutelare e realizzare l’interesse comune, ma al modo in cui gli israeliani si sentono ebrei e a cosa ciò comporti per davvero. A tale riguardo, le idee sono molto differenziate, posto che non esiste un unico modo di «essere ebrei». Così come, l’ebraismo medesimo è vissuto solo da una parte degli israeliani come una radice religiosa, divenendo semmai una sorta di collante, estremamente fluido nelle sue accezioni, rispetto alla definizione di un’appartenenza civile comune, ossia alla cittadinanza israeliana. Non di meno, almeno un quinto degli israeliani non è di origine ebraica. Ed anche questo pesa molto nelle discussioni sull’identità nazionale.
Che Israele sia lo Stato degli ebrei è un dato assodato, prima di tutto attraverso la cognizione dei processi storici che tra l’Ottocento e il Novecento hanno portato alla nascita di quella comunità politica. Stato degli ebrei indica non una proprietà esclusiva ma il prodotto di un percorso che ha visto gli ebrei medesimi protagonisti di un via nazionale alla soluzione dei loro problemi, innanzitutto l’antisemitismo ma anche, non di meno, l’assimilazionismo, ovvero il rischio di perdere definitivamente i tratti identitari che avevano comunque mantenuto, sia pure attraverso molti cambiamenti, nella Diaspora. Altra cosa, anche se convenzionalmente si usa le espressioni come intercambiabili, è parlare invece di «Stato ebraico». Poiché in questo secondo caso, invece, ci si riferisce ad una sovranità politica che sarebbe basata sul diritto ebraico, ossia su un insieme di norme derivate dai testi religiosi fondamentali. Tradizionalmente, infatti, le religioni codificano e trasmettono non solo valori e principi ma anche regole vincolanti di condotta. I processi di secolarizzazione che hanno interessato le società negli ultimi secoli hanno invece concorso ad affrancare la sfera della politica da quella dell’autorità religiosa. Di fatto, la capacità di generare norme vincolanti si è trasferita in un potere che si vuole laico poiché indipendente dalla religione, ancorché non indifferente ad essa da un punto di vista tuttavia esclusivamente etico. Altrimenti, piuttosto che parlare di democrazia sarebbe meglio rifarsi alla teocrazia. Israele ha un corpus giurisprudenziale che si rifà solo per minima parte alla tradizione ebraica, mentre invece le sue leggi, e il modo in cui esse vengono applicate, sono tipici di una moderna democrazia secolarizzata. Altro tema, invece, è il rapporto tra identità ebraica, religiosità e sfera pubblica. Questo secondo aspetto rimanda non tanto all’autonomia delle amministrazioni collettive (lo Stato), chiamate a tutelare e realizzare l’interesse comune, ma al modo in cui gli israeliani si sentono ebrei e a cosa ciò comporti per davvero. A tale riguardo, le idee sono molto differenziate, posto che non esiste un unico modo di «essere ebrei». Così come, l’ebraismo medesimo è vissuto solo da una parte degli israeliani come una radice religiosa, divenendo semmai una sorta di collante, estremamente fluido nelle sue accezioni, rispetto alla definizione di un’appartenenza civile comune, ossia alla cittadinanza israeliana. Non di meno, almeno un quinto degli israeliani non è di origine ebraica. Ed anche questo pesa molto nelle discussioni sull’identità nazionale.
Quanto è radicato il sionismo nella società e nella cultura israeliane contemporanee?
Israele identifica il sionismo, in quanto movimento di indipendenza nazionale, come radice della sua storia. Si tratta di un fenomeno che è in linea con i nazionalismi ottocenteschi e che trova il suo sbocco nella costruzione prima di una comunità politica autonoma e poi nella nascita, con il 1948, dello Stato. Tuttavia, se il rimando sentimentale e affettivo alla radice culturale e politica della propria storia ha una sua coerenza, oggi il sionismo continua ad esistere soprattutto come ispirazione di principio. Poiché il quadro del paese è completamente mutato. Difficilmente si troveranno israeliani che non dicano di essere anche «sionisti», al netto di alcune componenti del radicalismo politico e religioso invece distanti da esso, ma il richiamo si rivela da subito insufficiente nel momento stesso in cui si chiede di aggettivare il senso di una tale identità. Il problema, per così dire, sta anche nel fatto che il sionismo ruota intorno ad un’irrisolta commistione tra ebraicità e cittadinanza politica. Ciò che resta del sionismo, e il suo parziale superamento nel neonazionalismo radicale di cui sono espressione alcune formazioni politiche, si basa d’altro canto sull’unione di tre presupposti che sono inscritti nel programma della destra sociale e di movimentazione di oggi: il rimando alla sovranità nazionale come espressione dell’identità collettiva, fondata non su un presupposto di natura costituzionalistico ma sul richiamo ad un’appartenenza di gruppo, preesistente allo Stato stesso; la rinegoziazione dei diritti di cittadinanza, stabilendo che alla base di essi sussista un solo vincolo, quello etnico; la riformulazione del sistema di equilibri tra poteri diversi, favorendo ogniqualvolta possibile, gli esecutivi, soprattutto se su base carismatica, con un premierato identificabile più con un «capo» che non con un leader. Queste ultime accezioni, che vengono proposte come una sorta di nuovo orizzonte del “vecchio” sionismo, in realtà aprono orizzonti problematici di riflessione, soprattutto per gli effetti che potrebbero produrre nel corso del tempo all’interno della stessa società israeliana.
Quale tensione caratterizza il rapporto tra demografia e democrazia in Israele?
Storicamente il Paese si è strutturato come società ebraica nazionale in almeno centoquaranta anni, dalla fine dell’Ottocento in poi. Poiché se lo Stato nasce nel 1948 alla sua origine ci sono almeno un’altra settantina d’anni di costruzione delle sue strutture fondamentali, a partire dal 1880, con le prime immigrazioni nella Palestina ottomana. L’Israel Central Bureau of Statistics (ICBS), l’istituzione che elabora e aggiorna i dati in materia, indica per la fine del 2021 la presenza di una popolazione stimata in 9.391mila individui. Attualmente il Paese raccoglie il 45,3% dell’ebraismo mondiale. La società israeliana è rigorosamente multietnica, essendo il prodotto dell’incontro tra individui e gruppi dalle più disparate origini. Il rimando all’elemento ebraico è tanto ovvio in linea di principio quanto problematico nei fatti, generando non poche volte conflitti di appartenenza, di legittimazione, di reciprocità. Il paradosso di Israele è che si fonda anche su questa inesistente omogeneità, rendendo difficile l’identificazione non tanto giuridica quanto culturale della nozione di cittadinanza, sottoposta in maniera permanente alle tensioni che derivano dal suo accostamento all’ebraicità come elemento prevalente se non esclusivo. I conflitti sulla concreta declinazione della democrazia, ossia sui modi di condividerla e viverla, si inscrivono dentro questo prisma mutevole, dove il legame tra cultura, identità e sovranità non sono per nulla risolti.
Come si esprime il populismo nella società politica israeliana?
Esiste una lunga tradizione, legata alla destra nazionalista, antagonista della sinistra laburista, quest’ultima al potere fino al 1977 e poi scalzata dalla prima. Ma il populismo odierno non ha troppe analogie con le politiche del passato. In realtà è partecipe di un trend molto più ampio, che riguarda un po’ tutti i paesi a sviluppo avanzato, dinanzi agli affaticamenti della democrazia rappresentativa. Benjamin «Bibi» Netanyahu è la figura più significativa in queste trasformazioni. È infatti il premier che ha governato più a lungo, assicurandosi quindici anni di mandati, tra il 1996 e il 2021. Abilissimo navigatore nella politica nazionale, ha spesso rivelato la capacità di sapere sopravvivere a se stesso, giovandosi delle contraddizioni dei suoi avversari, fuori e dentro il suo medesimo partito. Non a caso, quindi, ha trasformato la sua formazione politica, il Likud, in una sorta di partito personale, ovvero una piattaforma permanente delle proprie posizioni, traducendo inoltre le elezioni in un permanente plebiscito su se stesso. Volutamente divisivo, quanto meno nella medesima misura in cui ha rivelato di sapere raccogliere i voti parlamentari quando gli necessitano, si è conquistato sul campo l’appellativo di «Re Bibi». Anche per questa ragione, ha fatto sì che il Likud, da espressione della vecchia destra nazional-conservatrice, come anche in parte liberale, divenisse un soggetto il cui programma politico assomma elementi sovranisti, populisti e identitari. Ciò facendo, ha trovato sponde ed interlocutori interessati in quella destra europea, spesso invece non liberale, che schiaccia completamente l’idea di Israele sulla rappresentazione artefatta di un Paese che ha trasformato il suo bisogno esistenziale di sicurezza in un’opzione di autoaffermazione egemonica. Netanyahu, in questi anni, non ha caso si è comodamente riconosciuto nel milieu di una destra occidentale che ha abbandonato la vecchia radice istituzionale, debitrice del rispetto dei sistemi costituzionalisti, per rilanciarsi sul piano della mobilitazione sociale, raccogliendo una parte dei crescenti malumori e dei disagi delle rispettive società. Destra di lotta e, al medesimo tempo, di governo, capace di interpretare le due parti contemporaneamente. Il suo vero successo è stato il poterlo fare essendo parte di quelle stesse élite che dice invece di volere mettere in discussione, spesso identificandole sbrigativamente con i suoi avversari politici.
Quali sono, a Suo avviso, le maggiori sfide per il futuro di Israele?
La globalizzazione, per sua stessa natura, mette in discussione le identità nazionali. Soprattutto, tende ad erode confini e barriere. La qual cosa, per un paese come Israele, risulta essere una sorta di contrappasso, dal momento che da sempre invece rivendica il diritto a confini, non solo spaziali, certi e garantiti. Se mai si dovesse addivenire alla loro definitiva determinazione, cosa del tutto improbabile dinanzi alla permanenza della questione palestinese, ciò accadrebbe quindi nell’epoca in cui essi sono sottoposti ad una generale rimessa in discussione. Non dalla politica quanto dall’evoluzione economica che, per più aspetti, li rende secondari rispetto alla libera circolazione delle merci, delle idee, ma anche dei corpi e quindi delle identità. La sfida culturale, in questo caso, si gioca più che mai tra l’universalismo del mercato, che introduce nuove diseguaglianze, nel mentre abbatte muri e vincoli di antica data, e il vivace particolarismo delle identità degli ebrei israeliani. Quale sarà il punto di sintesi? Lo Stato d’Israele è come uno specchio. Una comunità di idee nata sulla base di una cultura politica – il sionismo – che ha solidi ancoraggi nel pensiero occidentale, prodotto di un intenso processo di secolarizzazione intellettuale, ha originato una società nella quale per molti europei ed americani è facile identificarsi poiché richiama diversi elementi della propria esperienza, rendendoli semmai ancora più intellegibili. Israele, la cui reale natura è quella propria ad una qualsiasi moderna società politica, offre come una sorta di surplus sentimentale ed affettivo, che facilmente può trasformarsi in una deformante adesione ideologica o, alternativamente, in un non meno aprioristico rifiuto fondato sul pregiudizio. Su Israele si proiettano ombre e angosce del nostro recente passato, quello consumatosi laddove tutto sembra avere avuto inizio e al quale tutto riconduciamo, ossia la “vecchia” Europa. Pesa in ciò il segno indelebile lasciato nella società continentale dalla cultura ebraica; pesa, non di meno, l’atroce vicenda dello sterminio sistematico degli ebrei per mano dei nazisti e dei fascisti. Israele diventa così l’irrisolta coscienza (o l’incoscienza a seconda dei casi), del mondo occidentale. Per il mondo arabo e, ancor di più, per la numerosissima comunità musulmana, presente non solo in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico ma, oramai, in tutto il pianeta, le tante storie individuali che confluiscono in quella collettiva d’Israele sono invece perlopiù estranee alla propria esperienza. L’emotività che vi si ricollega non ha quindi nulla a che fare con quell’effetto di rispecchiamento che per noi è così importante. Ciò che resta d’Israele, oltre ad Israele stessa, è quindi il tema dell’appartenenza condivisa nell’età della globalizzazione. Una tensione irrisolvibile tra particolarismo e universalismo nell’era dell’insicurezza collettiva. Non solo in quei luoghi ma negli spazi dell’uomo in quanto tali.
Letture.org | 13 febbraio 2022
 «Ci sono estati chiuse come scatole, sigillate. Sono estati che trascorri in una stanza, in ufficio, o su un letto d’ospedale, in una cella, in uno spazio delimitato da pareti che ti sono ostili. A volte è il lavoro che ti costringe alla clausura, altre volte la malattia, tua o di un tuo caro, oppure la necessità di concentrarti per originare un’opera, o è la depressione che ti impedisce di uscire. Sei rinchiuso in un buio che non se ne va nemmeno quando spalanchi le finestre. Sei al centro della stanza ma è come se non ci fossi. Capitano estati così. È da quel buio che nasce il desiderio incontenibile del cammino. Non è desiderio di andare in ferie dopo un anno di lavoro. Chi è al centro del buio non ha bisogno di ferie, non sa che farsene. Né di spiagge, di hotel, di baite, di centri storici, di musei. Chi sta in quel buio vuole di più. Vuole solamente una cosa: il cammino».
«Ci sono estati chiuse come scatole, sigillate. Sono estati che trascorri in una stanza, in ufficio, o su un letto d’ospedale, in una cella, in uno spazio delimitato da pareti che ti sono ostili. A volte è il lavoro che ti costringe alla clausura, altre volte la malattia, tua o di un tuo caro, oppure la necessità di concentrarti per originare un’opera, o è la depressione che ti impedisce di uscire. Sei rinchiuso in un buio che non se ne va nemmeno quando spalanchi le finestre. Sei al centro della stanza ma è come se non ci fossi. Capitano estati così. È da quel buio che nasce il desiderio incontenibile del cammino. Non è desiderio di andare in ferie dopo un anno di lavoro. Chi è al centro del buio non ha bisogno di ferie, non sa che farsene. Né di spiagge, di hotel, di baite, di centri storici, di musei. Chi sta in quel buio vuole di più. Vuole solamente una cosa: il cammino».