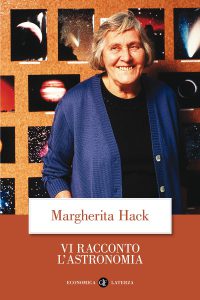Il saggio di Marco Santambrogio recupera un concetto diventato tabù dopo la rivolta contro le élite
Giancarlo Bosetti | Robinson | 6 novembre 2021
La caccia al tesoro intellettuale della spiegazione della vittoria di Trump nel 2016 ha finito per mettere sotto accusa la “meritocrazia”. Diluviano libri e articoli contro. Persino Squid Games, la serie di Netflix sulla gara dei 456 disperati, che si lasciano ammazzare per il miraggio di un bottino che li liberi dai debiti, viene ora interpretata come metafora delle iniquità di una competizione sociale a carte truccate. Nel linguaggio corrente sta diventando un insulto alla povera gente. Se quella stessa parola – e sottolineo “se” – rappresenta l’anima della società americana, allora Dio ne scampi dal metterla in pratica. Imbocchiamo qui la strada di un paradosso nel quale sarà bene districarsi senza perdere di vista l’importanza delle critiche che, insieme a quell’idea, sono state rivolte alla società americana e a tante situazioni simili: Brexit e altri populismi. Se per meritocrazia intendiamo che i posti assegnati per concorso devono andare al più bravo e titolato dei candidati, faremo bene a presidiare il senso di giustizia, che qui va d’accordo con il senso comune: no al raccomandato e no ai concorsi truccati. Ma quel concetto ha anche, e soprattutto, quell’altro significato, fin da quando la parola fu inventata dal suo autore, Michel Young, nel 1958, in un’opera geniale, The Rise of Meritocracy (L’avvento della meritocrazia), metà satirica e metà no.
 Young era un laburista e aveva lavorato al programma con cui Attlee batté Churchill alla fine della guerra e in particolare alla riforma della scuola, che voleva introdurre mobilità sociale e correggere fin dalle elementari il classismo del sistema inglese, introducendo una valutazione, appunto meritocratica, ché alla fine delle elementari aprisse la via alle carriere sulla base del talento, ovvero del quoziente di intelligenza. Era un criterio largamente prevalente nelle convinzioni scientifiche del tempo anche per la selezione delle università americane. Negli anni successivi però Young fu come perseguitato da un incubo, relativo alla sua stessa riforma, che prese la forma di quel famoso libro, nel quale la “meritocrazia” finisce per partorire un mostro, un mondo in cui le posizioni elevate diventano ereditarie, una selezione darwiniana, eugenetica, razzista, con l’aggiunta di matrimoni in base al QI: tutti “i migliori” sopra tutti “gli scartati” sotto.
Young era un laburista e aveva lavorato al programma con cui Attlee batté Churchill alla fine della guerra e in particolare alla riforma della scuola, che voleva introdurre mobilità sociale e correggere fin dalle elementari il classismo del sistema inglese, introducendo una valutazione, appunto meritocratica, ché alla fine delle elementari aprisse la via alle carriere sulla base del talento, ovvero del quoziente di intelligenza. Era un criterio largamente prevalente nelle convinzioni scientifiche del tempo anche per la selezione delle università americane. Negli anni successivi però Young fu come perseguitato da un incubo, relativo alla sua stessa riforma, che prese la forma di quel famoso libro, nel quale la “meritocrazia” finisce per partorire un mostro, un mondo in cui le posizioni elevate diventano ereditarie, una selezione darwiniana, eugenetica, razzista, con l’aggiunta di matrimoni in base al QI: tutti “i migliori” sopra tutti “gli scartati” sotto.
Il risultato è una società che, sessant’anni dopo, cade nella rivolta cieca, nell’anarchia, nella violenza. Young dedicò per questo il resto della sua vita a correggere i programmi viziati dal peccato originale del QI. E negli anni Novanta sconsigliò a Blair di usare quella parola.
Una accurata storia di questo paradosso si trova ora nel libro, in (parziale) controtendenza, di Marco Santambrogio, filosofo analitico e del linguaggio (Il complotto contro il merito, Laterza). Dopo Trump, le pagine di Young offrivano qualche utile spiegazione alle follie degli elettori: evidenti le somiglianze tra quella distopia e l’America in preda ai fumi della rivolta dei “perdenti”. Cominciava Anthony Appiah, nel 2018, con un brillante saggio dedicato proprio a Young, sul Guardian: “Contro la meritocrazia: l’idea di una società che premia il talento ha creato nuove élite di privilegiati”. La critica mordeva la campagna elettorale di Hillary Clinton e la sua infausta battuta sui deplorables, che incendiava il risentimento dal basso contro l’élite. Proseguiva e allargava l’opera Daniel Markovits, con The Meritocracy Trap (Penguin), una trappola che è il mito fondativo del sogno americano e che invece «nutre l’ineguaglianza, distrugge il ceto medio e divora l’élite». Markovits spiega crudamente ai suoi studenti di Yale che per arrivare fino a lì hanno goduto del beneficio di un investimento famigliare di diversi milioni, inaccessibile non solo ai poveri, ma anche al ceto medio. A Young dà ulteriore credito Michael Sandel, il bestselling di Harvard, con La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e perdenti (Feltrinelli). L’incubo si è avverato, prima del previsto 2033: i vincitori si ritengono tali non più per diritto di nascita, ma per i propri meriti e sviluppano perciò arroganza nei confronti dei perdenti, i quali sono non solo sconfitti, ma anche umiliati dall’idea di esserselo meritati.
Santambrogio, con gli strumenti della logica, riprende nelle sue mani la discussione a cominciare dal principio aristotelico – «giustizia è dare a ciascuno ciò che merita» – per evitare che il principio ragionevole, e a portata del senso comune di cui dicevamo all’inizio, non vada perso. Buttiamo insomma, propone, l’acqua sporca ma non il bambi no, facendo chiarezza sulla omonimia pericolosa tra la visione angosciosa di Young e un modello virtuoso di ideale meritocratico: quello di una società che apre le camere ai talenti, che offre pari opportunità a prescindere dalle differenze e assegna i posti in base al merito.
A ben vedere allora, la società americana non è una meritocrazia, ma una meritocrazia fallita. Una utopia capovolta, come Bobbio diceva di quella comunista? Rispetto a una tradizione liberale che ha messo da parte il merito nel senso morale (l’impegno, la dedizione, le qualità umane) per preferirgli il valore economico o i titoli acquisiti con il curriculum, Santambrogio vuole aggiornare la considerazione del merito e insieme contrastare le sproporzionate differenze economiche che sono associate alla selezione. Sulle ricchezze dovrà allora agire la redistribuzione attraverso il fisco, antica scoperta socialdemocratica.
Ma la società dovrà assegnare al merito insieme alla ricompensa economica, da calibrare meglio che in Squid Games, anche l’onore che tocca non solo a chi ha i titoli, come il celebrato chirurgo, ma anche – e spesso di più – ai bravi e coraggiosi infermieri in corsia, uomini e più spesso donne.
Il libro:


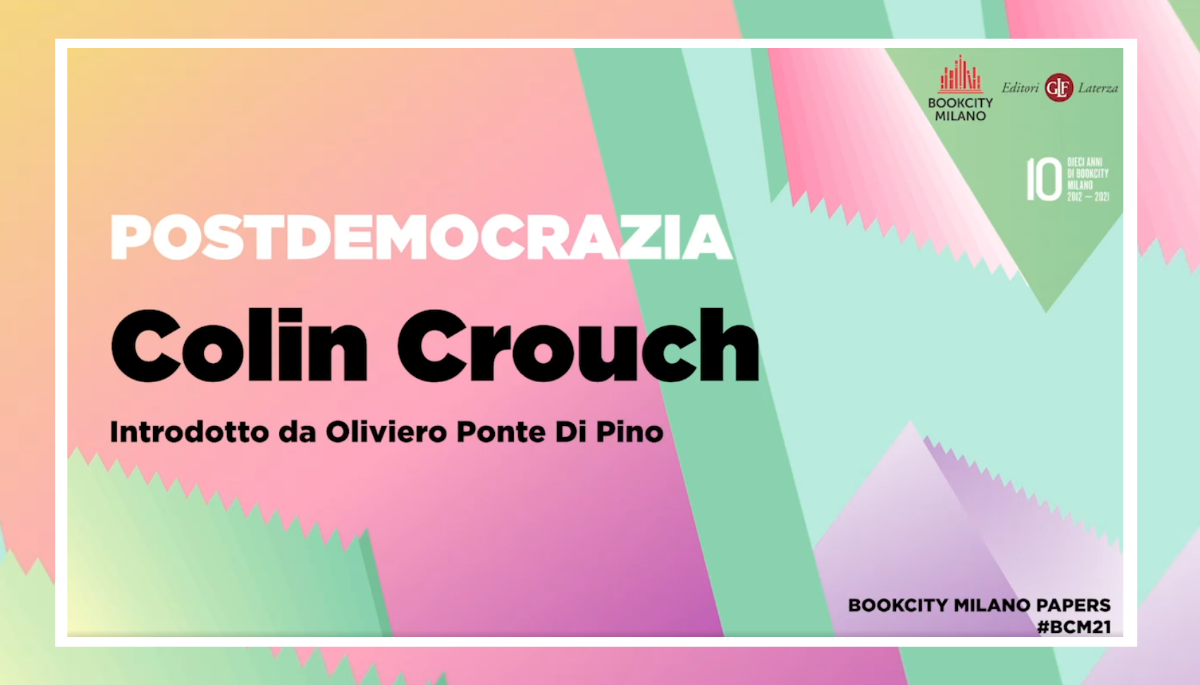
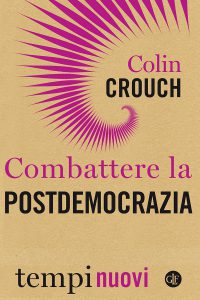







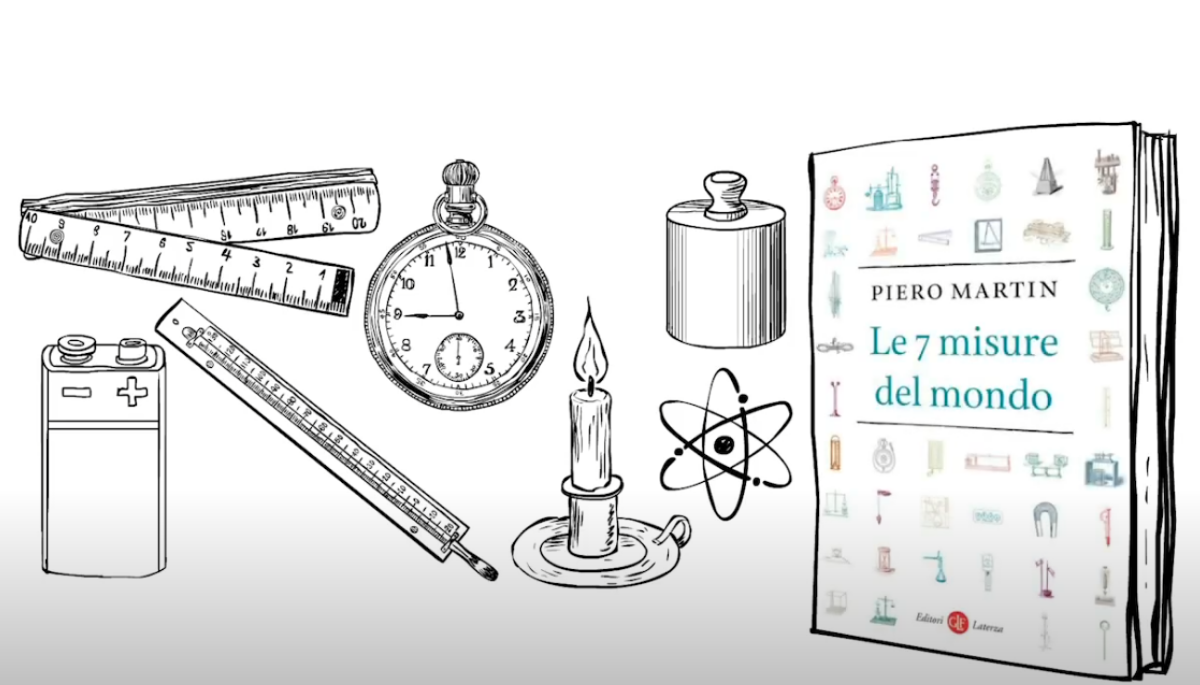



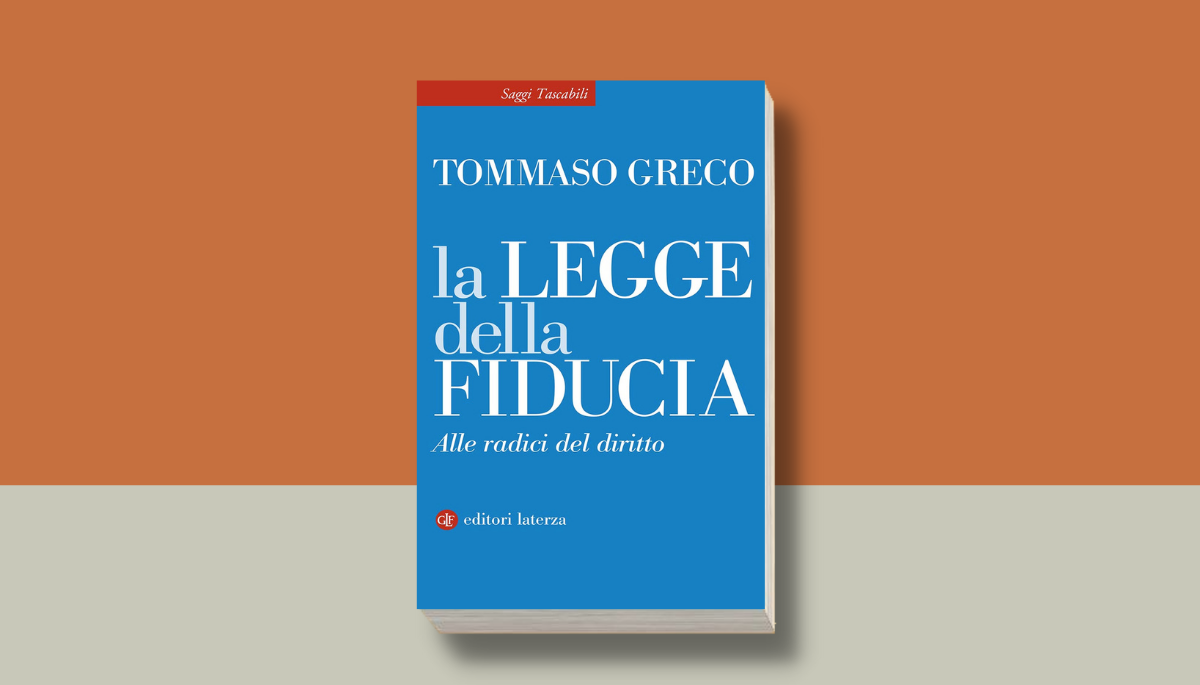




![[Proposte di lettura] Scrivere di scienza](https://www.laterza.it/wp-content/uploads/2021/12/anteprima-sito-61.png)