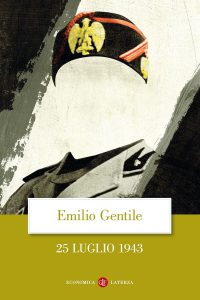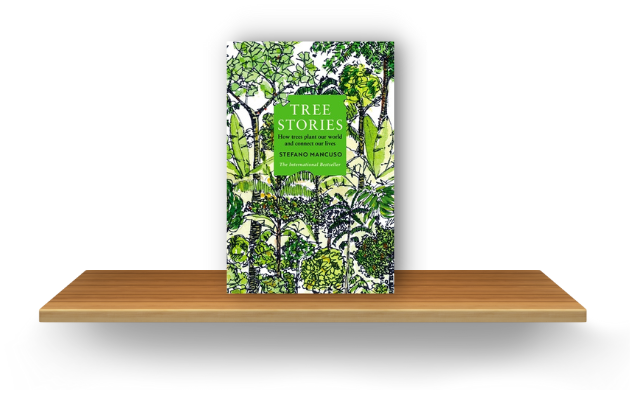FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA
Torino, 30 maggio – 2 giugno 2024
A discutere del tema Chi possiede la conoscenza, premi Nobel, relatori italiani e internazionali provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca mondiali. E poi giornalisti, storici, analisti e rappresentanti autorevoli delle istituzioni italiane ed europee.
Scarica il programma qui
Riparte a Torino giovedì 30 maggio per chiudersi domenica 2 giugno il Festival Internazionale dell’Economia. Tema di quest’anno: Chi possiede la conoscenza. “Oggi – riflette Tito Boeri, direttore scientifico del festival – il progresso tecnologico è in gran parte legato alla conoscenza, all’uso delle informazioni per creare valore.” Ragionare su questo processo, le sue dinamiche e le sue conseguenze è essenziale per comprendere il mondo in cui viviamo.
“Le nuove frontiere del progresso tecnologico – prosegue Boeri – stanno ridefinendo il nostro modo di lavorare molto più che in passato. Le macchine non sono più soltanto in condizione di sostituire l’uomo in attività ripetitive, di routine, ma anche in mansioni e professioni intellettuali. Compiti che un tempo erano appannaggio esclusivo dell’uomo, come scrivere, tradurre, disegnare, possono essere svolti da macchine anziché da persone. E si teme che anziché essere noi a guidare questi sviluppi e a utilizzarli per elevare la qualità del nostro lavoro, siano gli algoritmi a prendere il sopravvento, a decidere loro per noi in direzione per noi svantaggiose. Il problema di fondo è governare, anziché subire, il progresso tecnologico.
Ma come farlo?” Nei quattro giorni di incontri cercheranno di rispondere a questa domanda i più autorevoli esperti sul tema tra economisti, informatici, tecnologi, storici, sociologi, giuristi, studiosi dei media e imprenditori.
Per aiutare il pubblico ad orientarsi nel ricco programma del festival tutti gli appuntamenti sono suddivisi nei tradizionali formati: parole chiave, vere e proprie lezioni su concetti fondamentali, appunto, come “IA e mercati”, “piattaforme digitali”, “social media”; alla frontiera dove saranno raccontate le ricerche più innovative legate al tema del festival; visioni per guardare alla probabile evoluzione futura di molti fenomeni; intersezioni per promuovere la fertilizzazione reciproca fra economia e altre discipline; nella storia e storia delle idee dove il passato aiuta a meglio comprendere le ragioni del presente; testimoni del tempo, racconto in prima persona di testimoni autorevoli del mondo dell’economia, della scienza e della politica. A quest’ultimo formato si affiancano i dialoghi e i forum che saranno occasioni di scambio di opinioni e competenze diverse; i confronti che mettono in connessione le esperienze provenienti dal mondo dell’università, delle istituzioni e del territorio e dove quest’anno, tra le altre, figurano iniziative in collaborazione con Biennale Democrazia e Biennale Tecnologia; incontri con l’autore in cui si presentano le novità editoriali più interessanti nel dibattito economico e politico, compresi libri freschi di stampa, ancora non tradotti in italiano; cineconomia, l’economia spiegata attraverso il grande cinema. Infine non mancheranno la Alan Krueger Lecture, la Luca d’Agliano Lecture, l’Inet dialogue cui si sono aggiunte la Marco Fanno Lecture, la Mario Pagliero e Alessandro Sembenelli Lecture e la Carlo Alberto Medal Lecture.
A seguire una selezione degli eventi in programma al festival. Il programma è scaricabile qui.
Partiamo da giovedì 30 maggio. Dopo la tradizionale inaugurazione al Teatro Carignano, alle 15.00, sempre in teatro alle 16.00, Andrea Malaguti, direttore de “La Stampa”, dialoga con Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Le norme di genere, reali e percepite, sono un ostacolo importante e possono contribuire a sostenere politiche per l’uguaglianza delle opportunità, ma come sono percepite nel mondo? Su questo tema riflette Alessandra Voena alle 17.00 al Collegio Carlo Alberto, Common Room.
Alle 17.30 (Circolo dei lettori) Ilvo Diamanti e Nando Pagnoncelli, coordinati da Innocenzo Cipolletta, discutono su opinione pubblica, informazione digitale e IA. Prima di Darwin la facevano facile: siamo umani da sempre, da quando ci hanno creati. Collocando l’uomo in mezzo all’evoluzione, Darwin solleva il problema e il genetista Guido Barbujani lo tematizza attraverso alcuni passaggi chiave del nostro cammino evolutivo (Accademia delle Scienze di Torino, Sala Mappamondi alle 18.30). Alle 19.00 al Teatro Carignano Tito Boeri è con Tomaso Poggio, tra i padri dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze. Quali sono le potenzialità e le sfide associate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per l’incontro tra datori di lavoro e lavoratori? Ce lo spiega Michele Belot alle 19.00 (Collegio Carlo Alberto, Common Room). Alle 19.30 Francesco Giavazzi e Jeromin Zettelmeyer analizzeranno i punti di maggiore vulnerabilità dell’economia europea di fronte agli shock geopolitici indicando quali strategie adottare per ridurne i rischi (Collegio Carlo Alberto, Auditorium).
Tra gli appuntamenti di venerdì 31 maggio si segnala: alle 10.00, Collegio Carlo Alberto Common Room, la lecture di Emilio Calvano sulla parola chiave, IA e mercati. Alle 10.30 (Collegio Carlo Alberto, Classroom 3) il workshop L’antidoto è il dato: informazione a prova di fake news a cura di Youtrend nell’ambito dell’iniziativa Economia futura – il Festival Internazionale dell’Economia per i giovani e riservato al pubblico under 30 (per prenotarsi tutte le info sul sito del festival). Una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente equa è possibile? John Van Reenen ci spiega come alle 11.00 al Collegio Carlo Alberto, Auditorium.
Alla stessa ora ma al Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana, Chiara Goretti e Daniel Gros esaminano il nuovo Patto di Stabilità. Sempre alle 11.00 ma al Teatro Carignano Andrea Gavosto e Fabiola Gianotti dialogano su quanto inaspettatamente vicini siano il Bosone di Higgs e la nostra vita quotidiana. La relazione tra apprendimento collaborativo e intelligenza artificiale è il tema della lecture di Michael Jordan (Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi alle 11.30).
Uno dei nodi cruciali del dibattito economico mondiale è la regolamentazione del potere di mercato delle grandi big tech: lo affronta guardando alle due sponde dell’Atlantico Thomas Philippon alle 12.00 al Collegio Carlo Alberto (Common Room).
A che punto siamo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale e dell’utilizzo dei dati, a livello nazionale ed europeo? Quando l’uso dei dati si trasforma in abuso? Ne discutono Elisabetta Iossa e Roberto Viola (Auditorium San Filippo Neri, ore 12.30). La tecnologia sta ridefinendo il nostro modo di lavorare. Che effetto avrà sulla crescita e sull’occupazione? A questo interrogativo rispondono Pietro Garibaldi e Antonio Spilimbergo al Collegio Carlo Alberto (Common Room) alle 14.00. Come l’intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà il mondo dell’università? Quale sarà l’impatto sul modo di fare ricerca? Si confrontano sulla questione Stefano Corgnati, Francesca Cornelli, Antonio Merlo e Stefano Geuna, alle 14.00 al Museo Nazionale del Risorgimento, Sala Codici.
Quali sono i potenziali scenari che emergono dal continuo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale? Quali sono i fondamenti dell’IA generativa, i limiti tecnici e concettuali dell’attuale stato dell’arte e le principali sfide che rimangono? Riccardo Zecchina fa il punto su questi interrogativi alle 14.30 all’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria. La rapida evoluzione delle nuove tecnologie sta ridisegnando il panorama delle competenze e delle occupazioni. L’OCSE prevede che 1,1 miliardi di posti di lavoro subiranno trasformazioni significative nel prossimo decennio a causa delle nuove tecnologie. La riqualificazione è un imperativo, ma come realizzarla in tempi ragionevoli? Questo il tema dell’intervento di Raffaella Sadun alle 15.00 (Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana).
Si discute molto della regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Ma quando è utile farlo? Joshua Gans ne parla alle 15.30 (Collegio Carlo Alberto, Auditorium). In che modo l’intelligenza artificiale sta cambiando editoria e giornalismo? Ne discutono con Andrea Malaguti, Giuliano Amato e Innocenzo Cipolletta alle 16.00 (Museo Nazionale del Risorgimento, Sala Codici).
Sempre alle 16.00 (Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo) David Card, Premio Nobel per l’Economia 2021, si sofferma sulle conseguenze su studenti e lavoratori della sempre maggiore richiesta di competenze tecnologiche – con lui saranno Tito Boeri a introdurre e Gregorio De Felice per un saluto di benvenuto. Petra Moser (Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi, alle 16.30) indaga sulla diseguaglianza di genere nella ricerca scientifica. Quali possono essere i rischi di trasferire i processi decisionali nei mercati ad algoritmi sofisticati ed efficienti? Se lo chiedono Giacomo Calzolari e Vincenzo Denicolò alle 17.00 presso il Collegio Carlo Alberto, Common Room. Cos’era la conoscenza per San Francesco e quanto conosciamo realmente la sua persona? Alessandro Barbero, introdotto da Giuseppe Laterza, ce lo svela alle 17.00 al Teatro Carignano.
Tra i forum coordinati da Paola Pica a cura de lavoce.info segnaliamo Finanziare l’innovazione: il ruolo del private capital con gli interventi di Andrea Bonomi, Anna Gervasoni, Samuele Murtinu, Carlo Pesenti, Ermenegildo “Gildo” Zegna (Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana, ore 17.15). Quali vantaggi può arrecare l’intelligenza artificiale nella lotta alla povertà e per lo sviluppo dei mercati emergenti? Un tema cruciale sul quale interviene Indermit Gill alle 17.30 (Collegio Carlo Alberto, Auditorium).
Francesco Decarolis e Ahmit Gandhi discutono sulla regolamentazione della raccolta di dati da parte delle big tech tra Europa ed America (18.30, Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi). Nello sviluppo di interfacce sempre più evolute tra mente e algoritmo, da un lato ci sarà un approfondimento sull’alleanza tra uomo e informatica dall’altro scopriremo come già oggi la creatività umana possa essere “espansa” verso nuove dimensioni di intrattenimento musicale e visuale. Sulla relazione tra creatività e scienza riflettono Alex Braga e Guido Saracco alle 18.30 all’Auditorium dell’Oratorio San Filippo Neri. Come si sta evolvendo il panorama della conoscenza e della competizione commerciale internazionale nell’era digitale? Dovremmo spostare la nostra attenzione dalla conoscenza ai dati? Richard Baldwin suggerisce una nuova prospettiva su come percepire le competenze e l’innovazione nel nostro mondo interconnesso (Collegio Carlo Alberto, Auditorium ore 19.30).
A concludere la giornata, alle 21.00 al Teatro Carignano, Tracce di Marco Baliani, uno spettacolo dove stupore e incantamento, due sostanze profonde della conoscenza autentica ma anche dell’atto teatrale, si presentano attraverso costellazioni narrative molteplici.
Sabato 1 giugno primo appuntamento alle 10.00 con la parola chiave di Chiara Farronato, Piattaforme Digitali (Collegio Carlo Alberto, Common Room) mentre alle 10.30 c’è il workshop dedicato agli under 30 L’antidoto e il dato: informazione a prova di fake news (Collegio Carlo Alberto, Classroom 3) – per prenotarsi tutte le info sul sito del festival. Alle 11.00 (Collegio Carlo Alberto, Auditorium) Philippe Aghion illustra quali politiche possano rendere l’intelligenza artificiale un volano per la crescita e l’occupazione. Sempre alle 11.00 ma all’Accademia delle Scienze di Torino, Sala dei Mappamondi, Francesca Lagioia affronta il delicato tema della tutela dei diritti nell’età dell’IA.
Nell’ambito di Economia Futura, la sezione del festival dedicata alla cultura economico finanziaria dei più giovani alle 11.00 si svolge presso l’Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo la premiazione dei concorsi EconoMia ed EcoQuiz. Per l’occasione interviene Carlo Cottarelli con lo speech L’importanza di conoscere l’economia. A seguire un debate tra gli studenti vincitori del concorso EconoMia. Cosa succede quando l’intelligenza artificiale è uno strumento nelle mani dei regimi autocratici? Ne parla David Yang alle 12.00 al Collegio Carlo Alberto, Common Room.
La salute della nostra specie è legata in modo circolare a quella del pianeta, Ilaria Capua sollecitata dalle domande di Ilaria Sotis interviene alle 12.00 al Teatro Carignano su un argomento di cui abbiamo ancora tutti poca consapevolezza. Sulle sfide del nuovo patto di stabilità si confrontano Giorgio Airaudo, Flavio Padrini e Lucia Piana alle 12.30 al Museo Nazionale del Risorgimento, Sala Codici. Quando la conoscenza non è per tutti, è l’intera società a risentirne gli effetti. Quali strumenti adottare per contrastare la povertà educativa è il tema del dialogo tra Andrea Morniroli, Marco Rossi-Doria e Chiara Saraceno (Museo Nazionale del Risorgimento, Sala Codici, alle 14.00).
Sempre alle 14.00 all’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria, la lecture di Danielle Li su IA generativa e competenze umane. Numerosi studi empirici permettono di fare luce su come le imprese sono influenzate da governi e società, e come, a loro volta, li influenzano. Di questo reciproco impatto discute Emanuele Colonnelli con Giorgio Barba Navaretti (Collegio Carlo Alberto, Auditorium alle 15.30). Intelligenza Artificiale: motore di crescita per le imprese italiane? Ne parlano Giorgia Abeltino, Marco Gay, Anna Roscio al Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana alle 15.00. Come apprendono le piante e che cosa ci insegnano è il tema dell’intervento di Stefano Mancuso alle 16.00 al Teatro Carignano. Stiamo costruendo una Machina sapiens e con quali conseguenze? Lo spiega Nello Cristianini alle 16.30 all’Auditorium Oratorio San Filippo Neri.
Joel Mokyr, analizzando dinamiche storiche di lunghissimo periodo, spiega per quale motivo Europa e Cina hanno intrapreso percorsi di sviluppo così differenti (Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi alle 16.30). Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione culturale ed antropologica che impone un’etica della responsabilità che paradossalmente rimette al centro l’attenzione sulla persona. Questo è il focus del dialogo fra Paolo Benanti e Mario Rasetti al Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana alle 17.00. Gli attuali cambiamenti normativi nel settore farmaceutico statunitense ne potrebbero ridurre significativamente il mercato. Su come mitigare tali effetti interviene Ariel Pakes alle 17.00 al Collegio Carlo Alberto, Common Room.
Alle 17.30 al Collegio Carlo Alberto, Auditorium il dialogo tra il Premio Nobel per l’Economia 2015, Angus Deaton (in collegamento) e Antonio Spilimbergo su economia, disuguaglianza, sfiducia e populismo. Alla stessa ora ma al Teatro Carignano Marcella Beccaria e Michelangelo Pistoletto ragionano insieme all’economista Stefano Baia Curioni sul rapporto tra arte e intelligenza artificiale. La conoscenza nella Grecia antica è l’accesso alla verità, ma quale verità? Lo scopriremo con Laura Pepe che interviene alle 18.00 all’Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo. L’intelligenza artificiale può davvero invertire il declino della produttività e ridare slancio alla crescita?
James Manyika (in collegamento) ne discute con Michael Spence, Premio Nobel per l’Economia nel 2001 e Michael Jordan (Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi alle 18.30). I libri sono il più antico e funzionale strumento di condivisione della conoscenza, creano comunità anche distanti nel tempo e nello spazio. Ne discutono, al Circolo dei Lettori alle 18.30, Giulio Biino, Enzo Cipolletta, Cecilia Cognigni, Giuseppe Laterza e Rocco Pinto.
All’Auditorium Oratorio San Filippo Neri, sempre alle 18.30, Riccardo Staglianò affronta il tema dei rischi per società e mercato del cosiddetto gigacapitalismo. Annamaria Lusardi, introdotta da Elsa Fornero interviene sui rischi per le famiglie causati dall’inconsapevolezza finanziaria (Collegio Carlo Alberto, Common Room, alle 19.00). Per anni il lavoro di organizzazione delle conoscenze e dei saperi all’interno del nuovo ecosistema digitale si è basato su paradigmi architettonici: il web semantico, le ontologie, Wikipedia… Negli ultimi mesi, però, l’esplosione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa ha modificato radicalmente la situazione. Gino Roncaglia illustra i risultati, in parte inattesi, di questa vera e propria rivoluzione (Collegio Carlo Alberto, Auditorium, ore 19.30). A chiudere la giornata lo spettacolo Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno di Laura Curino e Gabriele Vacis, con Laura Curino (Teatro Carignano, alle 21.00).
L’ultima giornata del festival, domenica 2 giugno, si apre con Social media, la parola chiave affidata a Rafael Jiménez-Durán (Collegio Carlo Alberto, Common Room, alle 10.00). La finanza globale oggi contribuisce alle diseguaglianze economiche. Ciò dipende dal fatto che non tutti hanno le stesse disponibilità a investire, ma anche dall’alto livello di conoscenze necessario a sfruttare i sistemi legali e contrattuali che regolano la finanza. Francesca Trivellato ci conduce in un viaggio che ci aiuta a riconoscere chi ha accesso a queste conoscenze e a sfatare pericolosi falsi miti (Auditorium Oratorio San Filippo Neri, alle 10.30).
Cosa si ottiene in cambio della condivisione dei nostri dati e comportamenti online? Quale è il punto di equilibrio tra vantaggi della pubblicità mirata e la tutela dei consumatori? Steve Tadelis fa il punto su un argomento che riguarda tutti (Collegio Carlo Alberto, Auditorium alle 11.00).
Il rapporto tra democrazia e conoscenza è stato un tema molto caro a Norberto Bobbio, ne discutono Valentina Pazé e Gustavo Zagrebelsky, Accademia delle Scienze di Torino, Sala dei Mappamondi alle 11.00. Che cosa possono fare le nostre società per creare un’informazione digitale equa ed efficace? Andrea Prat utilizzando gli strumenti dell’economia politica dei media – un campo di ricerca principalmente empirico e sperimentale, all’intersezione tra economia e scienze politiche – misura questi fenomeni, sfata alcuni miti e valuta le soluzioni che sono state proposte nel tempo (Biblioteca Nazionale Universitaria, Auditorium Vivaldi, alle 11.30).
Nonostante le politiche proattive che indirizzano risorse per favorire una crescita più rapida, cos’è che non sta funzionando nell’economia? Lo spiega Ufuk Akcigit, Collegio Carlo Alberto, Common Room alle 12.00). Crescita lenta, ritardo nell’innovazione, investimenti insufficienti nella ricerca e nell’istruzione, basse remunerazioni e scarsa domanda di lavoro qualificato: come possiamo rompere il circolo vizioso italiano? Risponde Ignazio Visco intervistato da Giorgio Zanchini, Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana alle 12.00.
Alle 14.00, alla Biblioteca Nazionale Universitaria Auditorium Vivaldi, Luigi Zingales sulla base dell’esperienza storica illustra come dovrebbero essere concepite le regole legali e le norme sociali per produrre e distribuire la conoscenza a beneficio di tutti. Di questioni di genere e accesso alla conoscenza discutono Maria Laura Di Tommaso e Chiara Saraceno alle 14.30 all’Auditorium Oratorio San Filippo Neri.
Per aumentare il nostro potenziale di modernizzazione e ridurre al contempo le disuguaglianze, è urgente coinvolgere tutti nel processo di innovazione soprattutto le donne e le persone di estrazione sociale svantaggiata. Come farlo, lo spiega Xavier Jaravel sempre alle 14.30 al Collegio Carlo Alberto Common Room. Finanziamenti, concorsi, pubblicazioni, carriere, Stefano Corgnati e Marco Ottaviani dialogano sui meccanismi che producono conoscenza (Museo Nazionale del Risorgimento, Aula della Camera Italiana alle 15.00). Come si possono sfruttare gli algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) per fare nuove scoperte, in settori che vanno dall’economia e dalla fisica fino alla medicina? Risponde Sendhil Mullainathan, sempre alle 15.00 al Collegio Carlo Alberto, Auditorium.
Le paure suscitate dall’IA sono tante e vanno prese sul serio. Barbara Caputo e Diletta Huyskes partendo dalla consapevolezza che la tecnologia non è mai un destino dialogano su come esercitarne il controllo con responsabilità (Museo Nazionale del Risorgimento, Sala Codici alle 16.00). Secondo il senso comune la mente alla nascita sarebbe una tabula rasa, che via via si riempirebbe di contenuti grazie alle successive esperienze. Non è così. Parte da qui l’intervento di Giorgio Vallortigara alle 16.00 all’Accademia delle Scienze di Torino, Sala dei Mappamondi. Janet Currie interviene su un tema ancora poco battuto: investire nella salute mentale dei più giovani (Collegio Carlo Alberto, Common Room alle 16.30).
La discriminazione è considerata una causa importante delle differenze socioeconomiche tra persone di diverso genere, razza, cultura, ecc. Cosa la determina? Nicola Gennaioli mostra come la psicologia della memoria ci aiuti a capire cause e conseguenze economico-sociali di questo odioso fenomeno (Collegio Carlo Alberto, Auditorium, alle 17.00).
Chiudono il festival il dialogo di Tito Boeri con David Card, Danielle Li e Max Welling, alle 18.00 Binario 3 OGR e il Concerto Armonie italiane dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta dal maestro Valerio Galli in occasione della Festa della Repubblica Teatro Regio, 20.30. L’ingresso è gratuito. A partire da venerdì 26 aprile 2024 sarà possibile scaricare i biglietti online sul sito www.teatroregio.torino.it fino a esaurimento dei posti disponibili e al massimo 4 biglietti per ciascuna operazione.
Tra gli ospiti degli incontri con l’autore coordinati da Eva Giovannini: Veronica De Romanis, Emanuele Felice, Marianna Filandri, Federico Fubini, Paolo Guerrieri, Robert Johnson, Marco Magnani, Armando Massarenti, Alberto Mingardi, Tommaso Monacelli, Pier Carlo Padoan, Roberto Perotti, Irene Soave, Michael Spence, Luigi Zingales.
Il Festival Internazionale dell’Economia è ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri.
La manifestazione è promossa dal TOLC (Torino Local Committee), coordinato dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto e composto dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dalla Camera di commercio di Torino, da Unioncamere Piemonte, da Unione Industriali Torino e da Legacoop. L’iniziativa è inserita nell’ambito di Torino Futura – Generazione di Cultura.
L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Cassa Depositi e Prestiti sono partner istituzionali dell’evento.
Il Festival è realizzato anche grazie al contributo di aziende, enti e istituzioni. Di particolare rilievo la collaborazione con Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.
Main sponsor dell’iniziativa sono ABI – Associazione Bancaria italiana, Lavazza Group e Reale Mutua.
Global Thinking Foundation, Google e PedersoliGattai sono sponsor del Festival.
Supporter tecnico è Turismo Torino e Provincia. Media partner dell’iniziativa sono La Stampa, Rai Radio 1, Rai Radio 3, Rai News.it. L’Accademia delle Scienze di Torino e INET – Institute for New Economic Thinking sono scientific advisor.
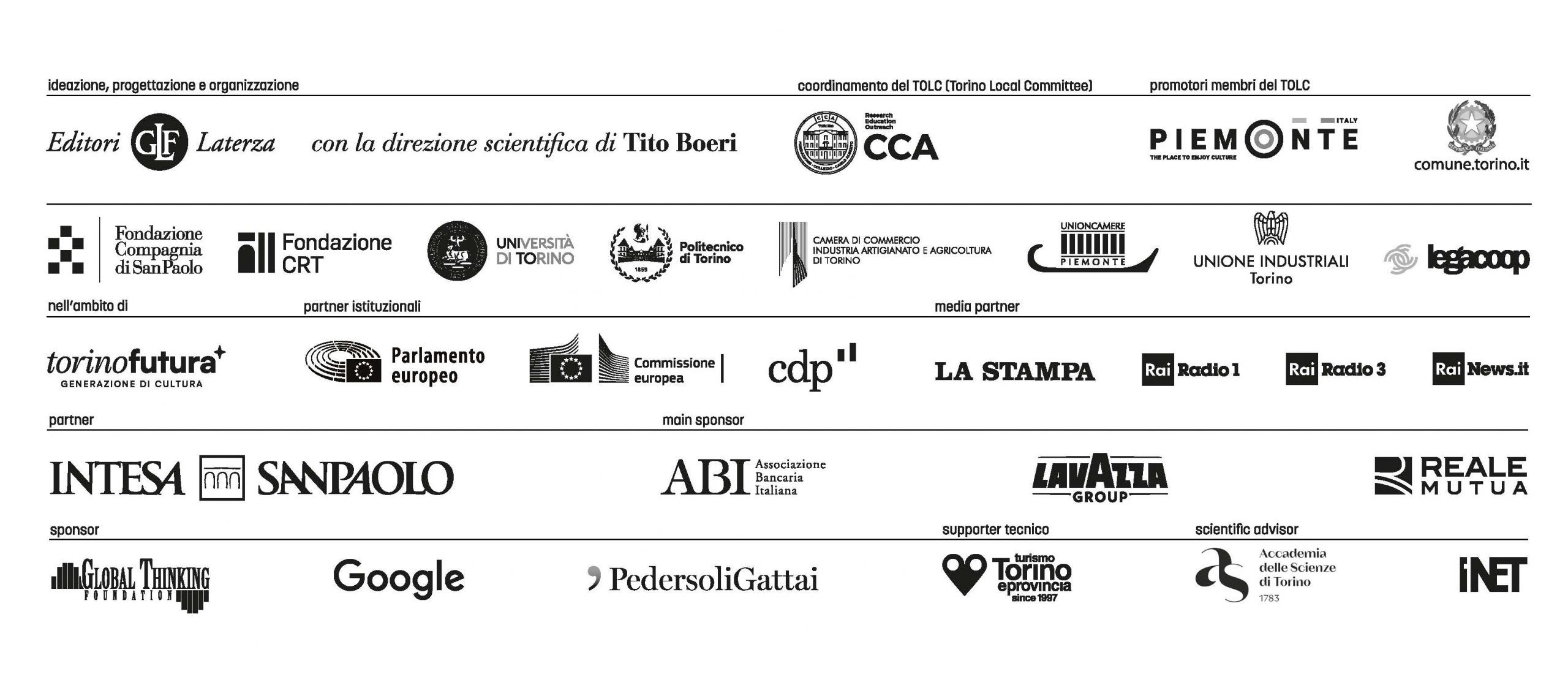

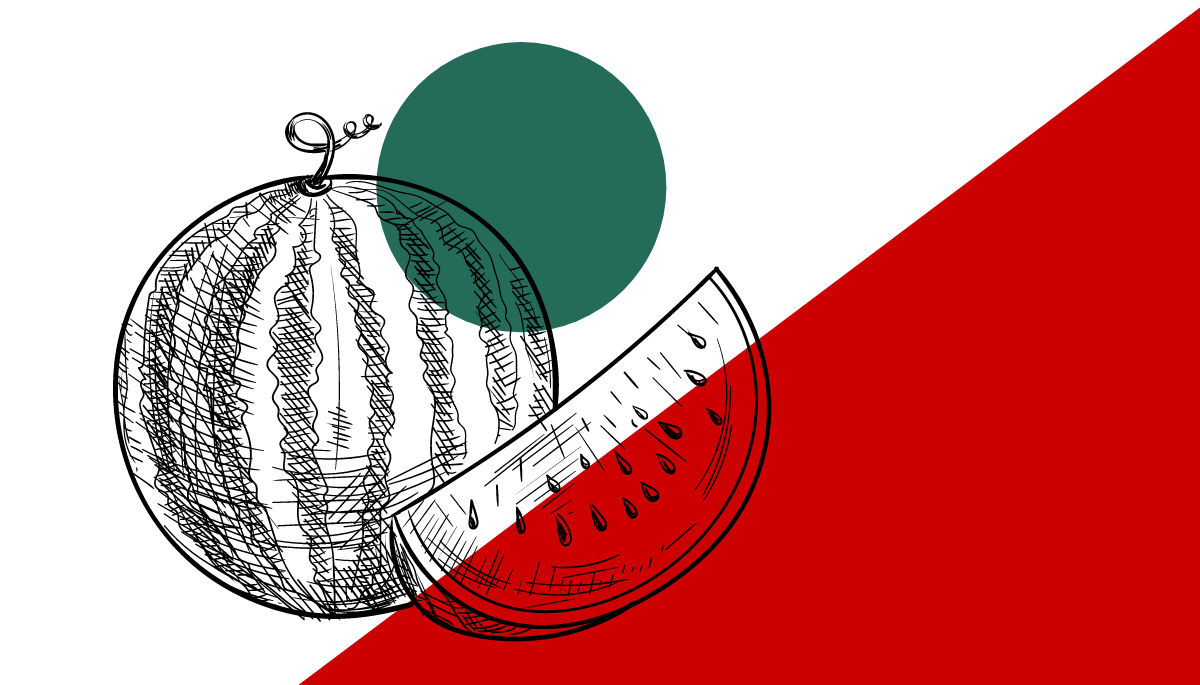






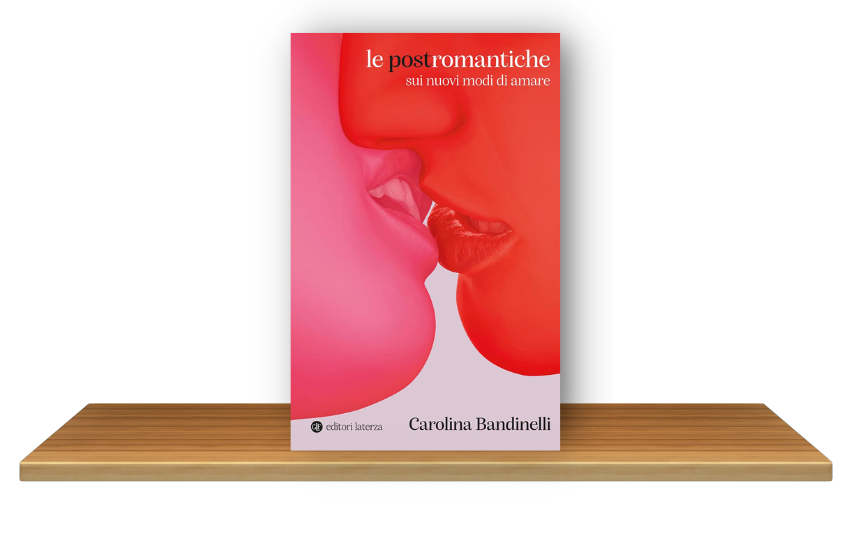
![[Proposte di lettura] Europa](https://www.laterza.it/wp-content/uploads/2021/03/europa-scaled.jpg)


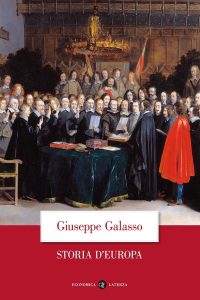

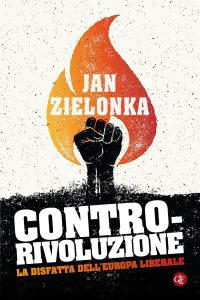


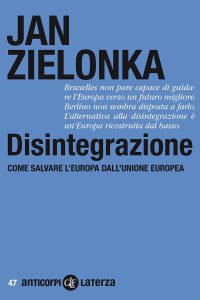



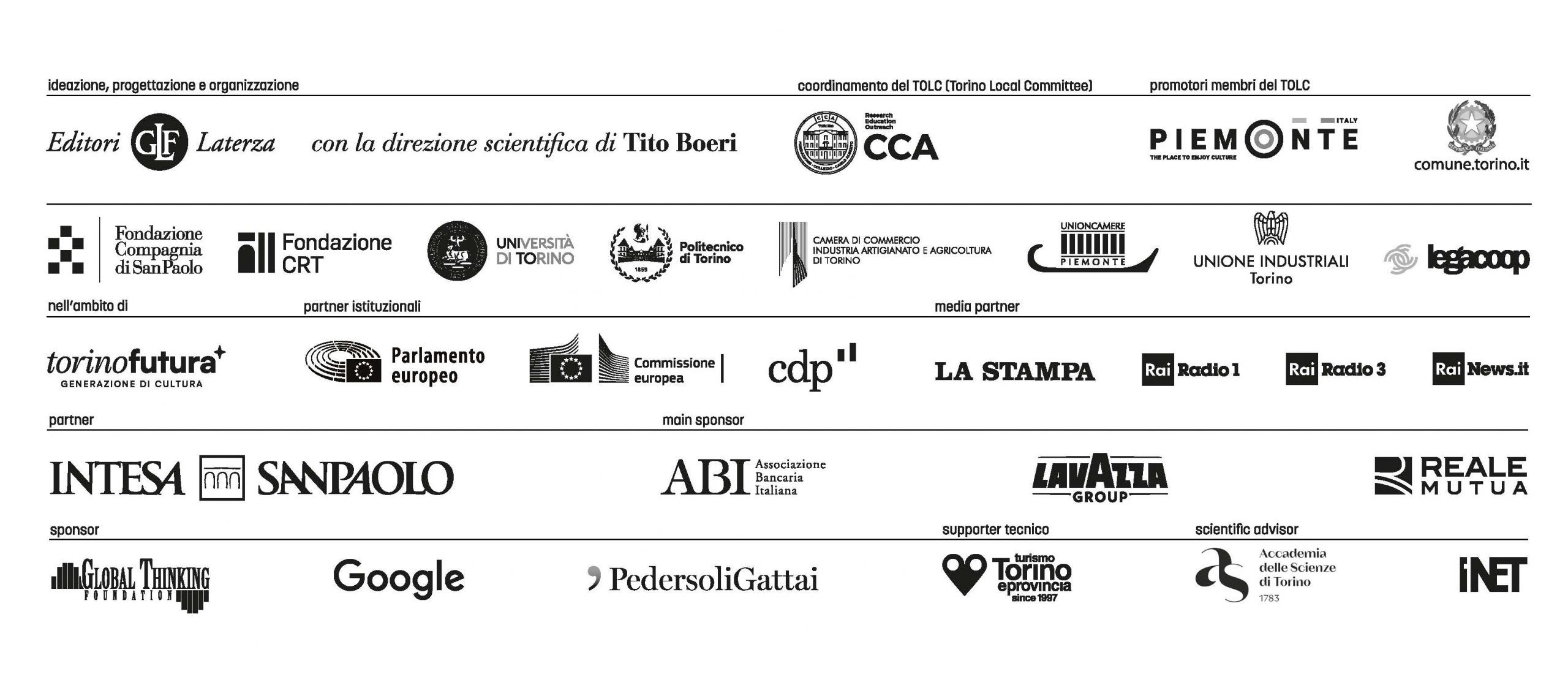

![[Proposte di lettura] 25 aprile](https://www.laterza.it/wp-content/uploads/2021/04/25-aprile-ante.png)
 Chiara Colombini
Chiara Colombini Simona Colarizi
Simona Colarizi

 Mimmo Franzinelli
Mimmo Franzinelli
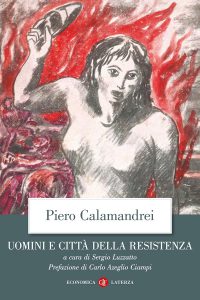 Piero Calamandrei
Piero Calamandrei Marcello Flores – Giovanni Gozzini
Marcello Flores – Giovanni Gozzini
 Emilio Gentile
Emilio Gentile
 Carlo Greppi
Carlo Greppi