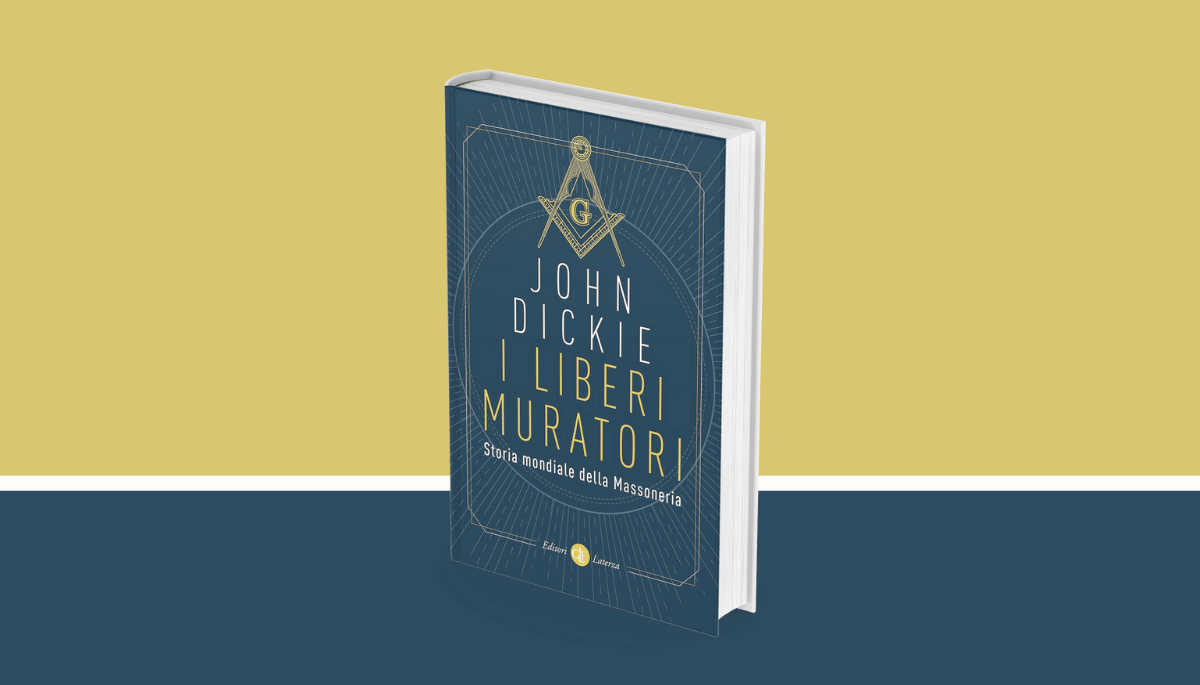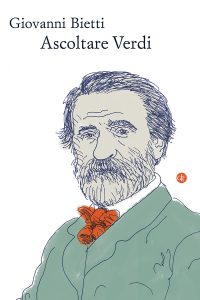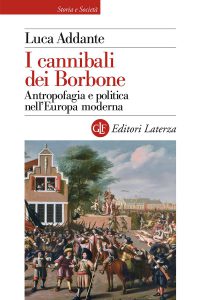Daniele Baron | Filosofia e nuovi sentieri | 8 settembre 2021
 «Un mattino, quando il giorno non è ancora cominciato né ha dispiegato il suo corso fatale, un dubbio si insinua in noi: la vita potrebbe essere tutt’altra rispetto a quella che stiamo vivendo. Dubbio tanto insidioso quanto vertiginoso, forse il più antico del mondo, sorto con il mondo stesso: la vita che viviamo potrebbe non essere davvero la vita. Potremmo non avere nemmeno cominciato a esplorarla. Potremmo non avere neppure iniziato a vivere veramente».
«Un mattino, quando il giorno non è ancora cominciato né ha dispiegato il suo corso fatale, un dubbio si insinua in noi: la vita potrebbe essere tutt’altra rispetto a quella che stiamo vivendo. Dubbio tanto insidioso quanto vertiginoso, forse il più antico del mondo, sorto con il mondo stesso: la vita che viviamo potrebbe non essere davvero la vita. Potremmo non avere nemmeno cominciato a esplorarla. Potremmo non avere neppure iniziato a vivere veramente».
La vita può essere oggetto di riflessione? Può essere un argomento per il pensiero oppure è posta su un piano differente, nell’immediatezza, e il pensiero per essere tale deve per forza astrarre dalla vita?
Ha ragione chi dice: primum vivere, deinde philosophari?
Per il filosofo e sinologo François Jullien la ricerca di quella che definisce la “vera vita” è essenziale e urgente per ogni individuo, ma deve essere intrapresa attraverso gli strumenti propri della filosofia, sgombrando il campo da tutta quella pseudo-filosofia che al giorno d’oggi è tanto in voga.
Infatti, molti tematizzano la vita senza sforzarsi di darne una definizione, come se fosse ovvio ciò a cui si riferiscono o come se non fossero in grado di farlo; il che rende i loro discorsi sulla vita delle nebulose, forse emozionanti e poetiche, ma di certo non significative da un punto di vista concettuale. Oppure c’è di fa di questo tipo di pensiero un mercato, come testimoniato dalla pletora di libri di successo che affollano gli scaffali delle librerie, farciti di frasi di buon senso spacciate per filosofia, libri di “auto aiuto” che commercializzano il tema della vita con una trattazione superficiale per una ricerca della felicità.
La riflessione sulla vita è un tema urgente e universale e il pregio del libro di Jullien è proprio quello di costruire un percorso profondo e originale da un punto di vista teoretico, ricollegando la tradizione occidentale con quella orientale.
Jullien parte da una constatazione molto semplice, come si è visto nella prima citazione: a ciascuno di noi capita un giorno o l’altro il dubbio di non vivere veramente o per meglio dire di condurre quella che non è la vera vita. Il dubbio è tremendo, è come un terremoto, perché mette in discussione tutto, fa crollare ogni certezza, è più comodo e tranquillizzante obliterarlo.
Da qui origina l’atteggiamento filosofico, dalla tematizzazione del dubbio che in ognuno sorge sulla vera vita. Ciò è molto difficile perché «il paradosso fondamentale della vita, infatti, è che essa non coincide originariamente con se stessa. Se “la vera vita è assente” come ha detto Rimbaud con una formulazione divenuta decisiva, ciò non dipende da qualche incidente o malessere personale […] ma dalla capitale contraddizione che affligge la vita stessa» (p. 7).
Se l’essenza della vita è la mancanza di coincidenza con sé, con il passare del tempo ogni persona avverte uno scarto tra la vita ordinaria, vincolata alla ricerca della soddisfazione, e un’altra vita possibile, che sembra far scivolare nell’illusione la prima.
«Quello di cui ci si rende conto è che la vita che si conduceva prima e che si reputava essere davvero la vita non era forse altro che una vita apparente, fittizia o falsa: forse era solo una pseudo-vita in cui ci si teneva al sicuro – al riparo – rispetto a ciò che la vita è effettivamente» (p. 23).
La vera vita per molti pensatori, tuttavia, sembra essere assente da questo mondo, ma raggiungibile Altrove; questa posizione metafisica, inaugurata da Platone ma ripresa pur con sfumature differente in tutta la storia del nostro pensiero, non è condivisa da Jullien.
«La vera vita infatti non è la vita che sogna di essere perfetta, la vita pienamente appagata, conforme all’idealità, la “vera vita” del platonismo, che si richiama alla salvezza di Lassù, che trova la verità nell’Essere o in Dio» (p. 41). Allo stesso tempo, Jullien mostra come non si debba cadere nell’estremo opposto, nel vitalismo, in cui la vita diviene valore di per sé nella sua autoaffermazione, come in Nietzsche. Infatti, se «la vera vita non è la scoperta di un’altra vita che la metafisica proietta nell’al di là, non è neppure un altro modo di vivere come quello predicato da Zarathustra» (Ivi).
Per Jullien occorre riuscire a elaborare quella che chiama una metafisica minima: un pensiero che non si lasci all’esperienza dell’empirico, che oltrepassi la chiusura del mondo e dell’esperienza senza però fare appello a un altro mondo o a un’altra esperienza. Un pensiero che è una critica alla nostra idea di sapienza, che ha prodotto uno scarto tra conoscere ed esistere, tra vita e verità. Solo in questo modo si può operare un ricongiungimento tra verità e vita e arrivare a riflettere in modo esatto sulla vera vita.
Il concetto di vera vita si tiene lontano da tutte le enunciazioni positive sulla vita, proprio perché la vita non può essere definita senza incorrere in equivoci e in dispute senza fine.
Un capitolo molto denso e interessante dal titolo significativo Vite Perdute (cfr. pp. 79-109) dell’opera di Jullien è dedicato all’analisi della non-vita che sembra caratterizzare molte delle esistenze della nostra società contemporanea. Un’analisi approfondita della non-vita, infatti, è in grado di farci capire come intraprendere il cammino verso la vera vita. Una vita perduta, la non-vita, è la vita rassegnata: quando ci si rassegna si è passivi, non si è più aperti all’inaudito che porta con sé la vera vita, si perde la speranza. In un mondo dominato dal mercato, dove tutto è tecnicizzato, la vita si reifica, vale a dire diventa cosa tra le cose, «la mia vita si è persa in quanto si è alienata: è divenuta estranea a se stessa a causa del formidabile sfruttamento, della dominazione, delle influenze o dei condizionamenti che essa subisce» (p. 80).
L’alienazione imposta dalla società, dai condizionamenti esterni della società capitalistica, per Jullien corrisponde agli atteggiamenti esistenziali della rassegnazione e dello sprofondamento.
Come ci si può ribellare a questo stato di cose che ha prodotto la non-vita? Ciò che è certo per Jullien è che questa situazione ci permette di intravedere cosa può essere la vera vita: la negazione della vita reificata.
«Ecco che allora, per via negativa, la non rassegnazione ci sollecita a ribellarci contro l’accettazione, compiuta con troppa facilità […]; il disoccultamento ci sollecita a de-concidere con il già-là instaurato dalla vita ripiegata nell’adeguazione e condotta all’inverzia; la disalienazione ci sollecita a ribellarci contro il fatto che la vita si sia lasciata espropriare da se stessa […]; la dereificazione, infine, ci sollecita a rifiutare che la vita subisca l’appiattimento allo stato di cosa» (p. 102).
La ribellione alla non-vita a cui si è ridotta la nostra vita avviene sempre per uno stimolo esterno: «la vita può rimettersi in movimento, riacquistare il suo slancio […] solo grazie ad un incitamento proveniente dall’esterno» (p. 103), che ci fa capire che la vita potrebbe essere tutt’altra cosa.
I capitoli conclusivi sono dedicati a indicare al lettore quale potrebbe essere la vera vita, con la precisazione che la vita non è oggetto insegnamento o apprendimento, non si può “imparare a vivere”, non ci si può preparare a vivere, perché nel vivere si è già sempre implicati, si può solo in senso profondo tentare di vivere. La vera vita non ha un’essenza, si può quindi solo definire negativamente, come resistenza alla non-vita, alla pseudo-vita in cui la vita cede alla rassegnazione, sprofonda, si aliena o si reifica. Tentare di vivere vuol dire in primo luogo quindi resistere alla non-vita che s’infiltra.
«La definizione migliore, la più esplicita e la più densa, di ciò che significa vivere, nella sua contraddittorietà, potrà forse essere questa. Da una parte, vivere è l’immediatezza, anzi la sola immediatezza possibile. Dall’altra, il vivere va cercato, conquistato, tentato – bisogna “tentare di vivere”. È dunque necessaria una mediazione incessante e prima di tutto da parte del pensiero che deve spingerci a non cadere nella rassegnazione, a disseppellire, disallineare e dereificare la vita. Questa interminabile mediazione è necessaria per avere accesso all’immediatezza del vivere: la mediazione del no detto alla non-vita per potersi elevare alla vita che vive» (p. 141).
Scopri il libro: