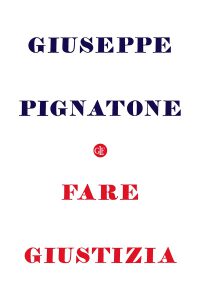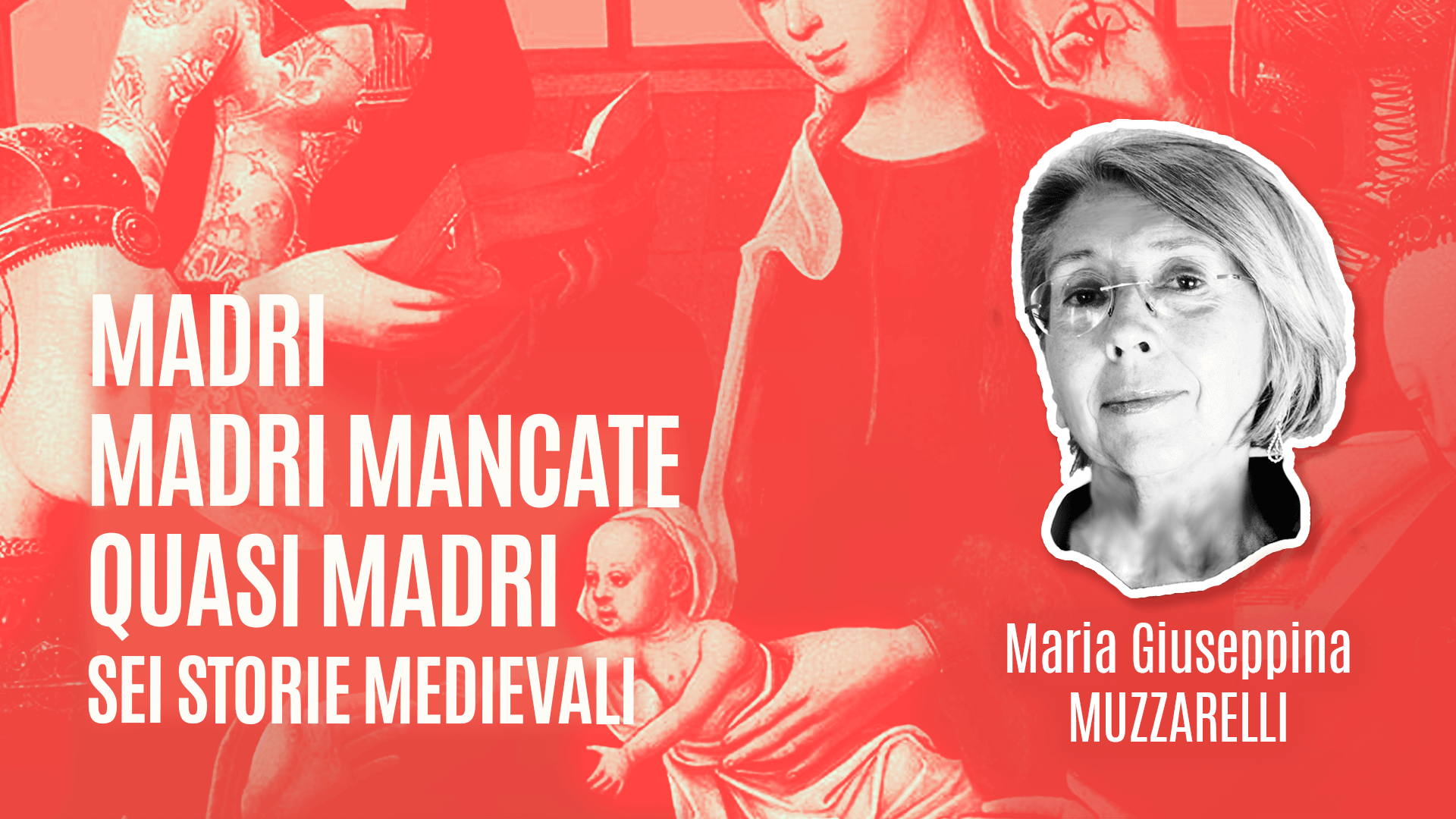Attraversiamo metropoli futuristiche e hutong, locali fumosi e campi di ginseng, antichi principi confuciani e intelligenza artificiale, neomarxismo e ipercapitalismo. Incontriamo l’ambiguo funzionario del Partito comunista, l’operosa dottoressa di Wuhan, l’eterea vlogger della Cina rurale, l’astro della letteratura fantascientifica, la giovanissima attivista per l’ambiente.
Addentriamoci nella Cina nuova, quella che scopriamo appena smettiamo di leggerne soltanto la superficie, insieme a Simone Pieranni: qui un estratto dal suo nuovo libro, La Cina nuova.
_____________________________________________________
 La memoria è un concetto piuttosto mobile per i cinesi e da sempre «truccato» da chi è deputato a scrivere la storia. Questo accade tanto più oggi, periodo nel quale il Partito comunista – oltre a rinnovare in modo continuo il panorama urbano del paese – guarda al passato per trovare la propria legittimazione, grazie a un racconto «epico» proposto dalla leadership del Pcc. Pensiamo solo alla Nuova Via della Seta: quando il presidente Xi Jinping ha presentato nel 2013 il suo progetto «One Belt One Road», ha descritto l’antica strada carovaniera come qualcosa di essenzialmente cinese. In realtà il termine fu creato da un occidentale (il geografo tedesco Ferdinand von Richthofen) e per lungo tempo la lingua parlata lungo le rotte commerciali fu il persiano. La storia, dunque, oggi più che mai serve al Partito comunista per marcare una linea di continuità, in alcuni casi con chiari accenti di natura etnica, tra presente e passato. E come sempre accade in questi casi, il Pcc non ammette discussioni, anche per quanto riguarda la storia recente. Nel 2018 Xi Jinping ha fatto approvare una legge dall’Assemblea nazionale (quanto di più simile esiste in Cina ai parlamenti occidentali, benché abbia solo la funzione di ratificare quanto deciso dal Consiglio di Stato, l’organo esecutivo, a sua volta controllato in toto dal Partito comunista) che impone a «tutta la società» di onorare gli eroi rivoluzionari e i martiri approvati dal Partito, rendendo la diffamazione un potenziale reato punibile dalla legge. Chun Han Wong, commentatore di fatti cinesi sul «Wall Street Journal», a questo proposito scrisse che «rafforzare il controllo sulla storia cinese è una priorità per il presidente Xi Jinping, che ha rivendicato la legittimità del governo comunista affermando che lui e il suo Partito al governo stanno guidando il ritorno della Cina alla grandezza del passato». Per questo eroi e martiri hanno un posto di rilievo nelle campagne di propaganda che spesso risalgono alle radici rivoluzionarie del Partito. «I funzionari hanno affermato che è necessaria una legislazione forte per promuovere il patriottismo e reprimere il nichilismo storico, termine ufficiale per lo scetticismo sui contributi del Partito al progresso della Cina». Insieme alla legge è arrivata la censura di libri, articoli, saggi. Questi ritocchi storici, in realtà, non sono l’unico modo che il Partito ha di controllare il passato; in alcuni casi la memoria è travisata o completamente annullata.
La memoria è un concetto piuttosto mobile per i cinesi e da sempre «truccato» da chi è deputato a scrivere la storia. Questo accade tanto più oggi, periodo nel quale il Partito comunista – oltre a rinnovare in modo continuo il panorama urbano del paese – guarda al passato per trovare la propria legittimazione, grazie a un racconto «epico» proposto dalla leadership del Pcc. Pensiamo solo alla Nuova Via della Seta: quando il presidente Xi Jinping ha presentato nel 2013 il suo progetto «One Belt One Road», ha descritto l’antica strada carovaniera come qualcosa di essenzialmente cinese. In realtà il termine fu creato da un occidentale (il geografo tedesco Ferdinand von Richthofen) e per lungo tempo la lingua parlata lungo le rotte commerciali fu il persiano. La storia, dunque, oggi più che mai serve al Partito comunista per marcare una linea di continuità, in alcuni casi con chiari accenti di natura etnica, tra presente e passato. E come sempre accade in questi casi, il Pcc non ammette discussioni, anche per quanto riguarda la storia recente. Nel 2018 Xi Jinping ha fatto approvare una legge dall’Assemblea nazionale (quanto di più simile esiste in Cina ai parlamenti occidentali, benché abbia solo la funzione di ratificare quanto deciso dal Consiglio di Stato, l’organo esecutivo, a sua volta controllato in toto dal Partito comunista) che impone a «tutta la società» di onorare gli eroi rivoluzionari e i martiri approvati dal Partito, rendendo la diffamazione un potenziale reato punibile dalla legge. Chun Han Wong, commentatore di fatti cinesi sul «Wall Street Journal», a questo proposito scrisse che «rafforzare il controllo sulla storia cinese è una priorità per il presidente Xi Jinping, che ha rivendicato la legittimità del governo comunista affermando che lui e il suo Partito al governo stanno guidando il ritorno della Cina alla grandezza del passato». Per questo eroi e martiri hanno un posto di rilievo nelle campagne di propaganda che spesso risalgono alle radici rivoluzionarie del Partito. «I funzionari hanno affermato che è necessaria una legislazione forte per promuovere il patriottismo e reprimere il nichilismo storico, termine ufficiale per lo scetticismo sui contributi del Partito al progresso della Cina». Insieme alla legge è arrivata la censura di libri, articoli, saggi. Questi ritocchi storici, in realtà, non sono l’unico modo che il Partito ha di controllare il passato; in alcuni casi la memoria è travisata o completamente annullata.
Durante una cena a Shanghai, nel marzo del 2006, mi ritrovai seduto accanto a una ragazza cinese nata nel 1984. A un certo punto, mentre parlavamo, le dissi che l’indomani sarei andato a Pechino. Le dissi anche che era la prima volta che avrei visitato la capitale cinese. Mi rispose che lei non c’era mai stata e mi chiese se potevo mandarle delle foto. Le dissi di sì. Poi lei mi chiese: «Qual è il primo posto dove andrai?». Io le risposi in un lampo, «Tiananmen», cosa che poi effettivamente si avverò. «Tiananmen è famosa anche in Occidente?», mi chiese. «Non lo sapevo», aggiunse. Le dissi che, sì, era molto famosa anche in Italia, per il ritratto di Mao, per la Città proibita e per quanto accaduto nel 1989. «Nel 1989?», domandò. Avevo sentito dire, benché fossi in Cina da poco, che molti cinesi delle nuove generazioni ignoravano totalmente quanto accaduto nel 1989 in Cina, ma non pensavo di ritrovarmi così presto di fronte a questa realtà. Balbettai una risposta: «Proteste, scontri…». Il suo volto, con gli occhi alla ricerca di risposte comprensibili, mi raccontò che non ne sapeva niente.
A questo proposito, Louisa Lim ha scritto un libro dal titolo The People’s Republic of Amnesia in cui descrive un esperimento che ha fatto per misurare la profondità dell’oblio. La giornalista ha portato l’iconica foto del «tankman» – il giovane che blocca una colonna di carri armati a Pechino nel 1989 – in quattro campus della capitale. La netta maggioranza degli studenti, tra i più istruiti del paese, non l’ha riconosciuta, alcuni hanno provato a indovinare «È in Kosovo?», «La Corea del Sud?»; su 100 studenti, solo 15 hanno identificato la foto scattata il 5 giugno 1989.
Walter Benjamin sosteneva che la storia sia «l’inventario del vincitore» e mai come in Cina questo è vero. Il 1989 è stato eliminato dalla storia cinese proprio nel momento in cui i cinesi erano posti più che mai di fronte a scelte su come interpretare il proprio passato e legarlo all’ingresso nella modernità occidentale, tentando di preservare le proprie «caratteristiche».
A questo proposito, secondo la critica letteraria e cinematografica, femminista e marxista Dai Jinhua – una intellettuale capace di muoversi tra film, letteratura e produzione culturale popolare e di massa, quanto di più simile a Mark Fisher esista in Cina –, uno dei momenti di maggior rilettura della storia da parte dei cinesi sarebbe avvenuta proprio negli anni Ottanta, quelli fondamentali per l’ingresso cinese nelle dinamiche del capitalismo globale: «Alla base della cosiddetta revisione della storia negli anni Ottanta e della concettualizzazione di una Cina del ventesimo secolo, c’erano gli sforzi per stabilire la continuità da un lato e la trascendenza dall’altro, come se potessimo eliminare, per mezzo di nuove interpretazioni ed ellissi, le interruzioni interne della storia cinese del ventesimo secolo. La riscrittura della storia mette in luce fatti e verità che erano stati gettati nell’oblio. Getta nuove sfumature e ombre. Oggi possiamo vedere più facilmente, con il senno di poi, che la storia non è un rullino che può essere montato liberamente».
Scopri il libro:










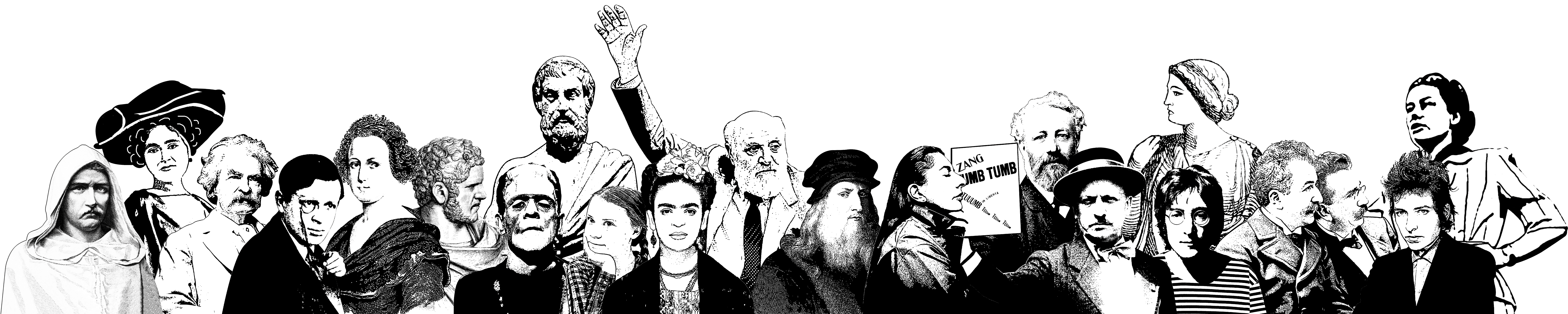
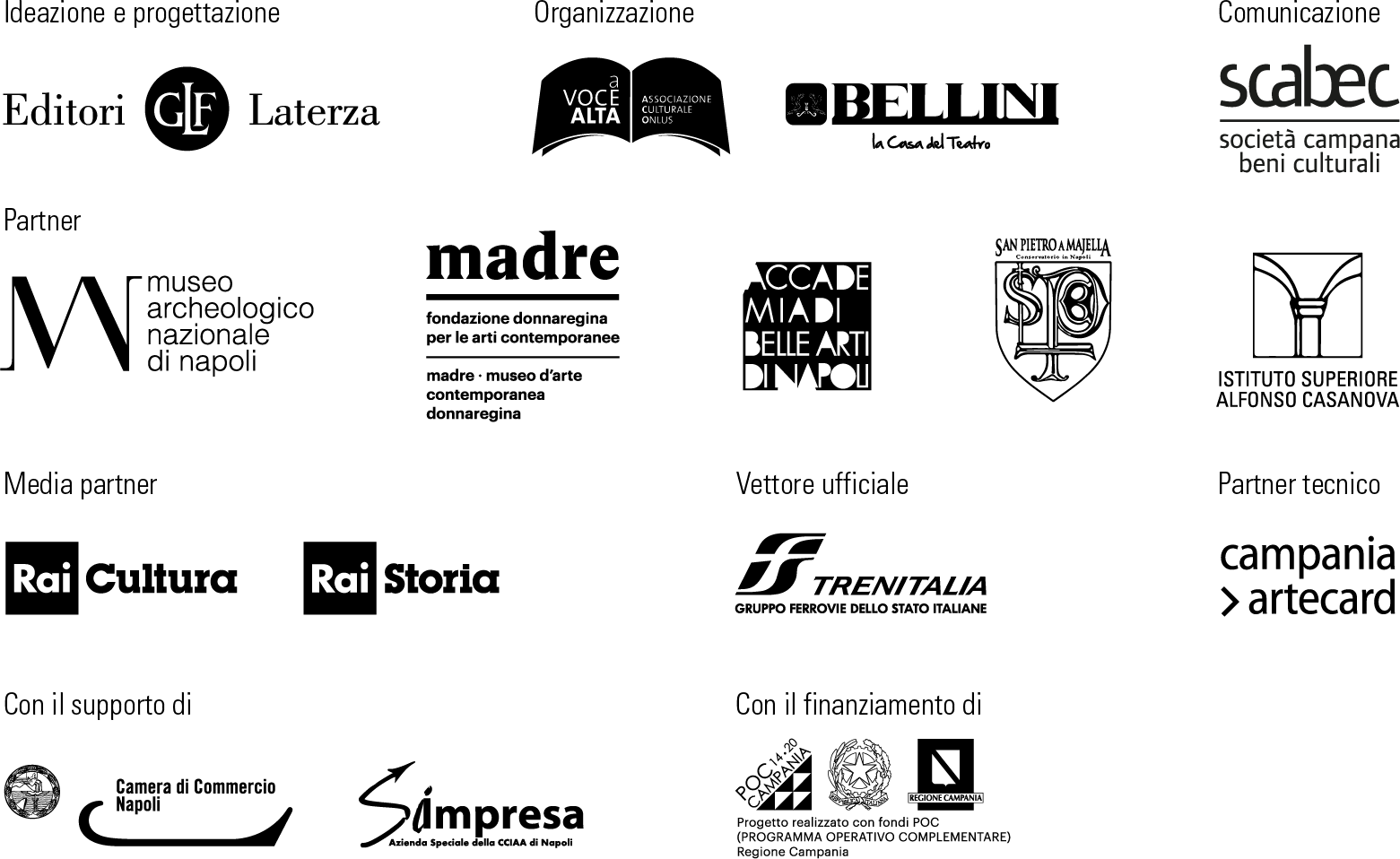

 Che si potesse fare un festival intorno all’economia all’epoca lo credevano in pochi ma la prima edizione che si tenne nel 2006 fu un tale successo di pubblico che i giornali la paragonarono a un concerto rock: dovemmo cambiare in corsa buona parte delle sale per accogliere un numero di persone doppio o triplo rispetto al previsto.
Che si potesse fare un festival intorno all’economia all’epoca lo credevano in pochi ma la prima edizione che si tenne nel 2006 fu un tale successo di pubblico che i giornali la paragonarono a un concerto rock: dovemmo cambiare in corsa buona parte delle sale per accogliere un numero di persone doppio o triplo rispetto al previsto.