Questi gli store online che aderiscono all’iniziativa:
*escluse le novità degli ultimi sei mesi
Questi gli store online che aderiscono all’iniziativa:
*escluse le novità degli ultimi sei mesi
Legenda è uno sguardo rapido ai fatti che hanno scandito la settimana e un invito a leggere il presente togliendo il piede dall’acceleratore.
Legenda è un tentativo di legare il mondo che corre alle parole che aiutano a capirlo.
Afghanistan. Mentre vengono annunciati i componenti del nuovo governo dell’Afghanistan, rileggiamo il libro che Valerio Pellizzari scriveva dieci anni fa, come a marcare un inconsapevole punto di mezzo, un checkpoint, tra gli eventi del 2001 e la crisi di questo 2021. In battaglia, quando l’uva è matura è il racconto intenso di un Afghanistan sul doppio binario della Storia e delle storie, un mondo dissociato tra aquiloni e kalashnikov, tra giardini segreti curati con amore e attentati brutali, tra vendette tribali e nevrosi del mondo digitale.
«Sopra la vecchia fortezza color fango di Kolola Pushta, sopra il forno, la moschea, la scuola, le ceste di meloni esposte sulla strada, i letti di legno appena finiti dal falegname, incombe un enorme involucro, un aerostato, un dirigibile color topo, che si muove lento, silenzioso, circospetto come un animale da preda. Lo sfondo unico, incantato, delle montagne e del cielo è disturbato, sfregiato, da questo pallone gigante. […] È carico di telecamere e di sensori elettronici che scrutano la vita quotidiana di questo piccolo quartiere e dell’intera città, senza chiedere e spiegare nulla ai suoi quattro milioni di abitanti. Quegli occhi artificiali riferiscono a un personaggio sconosciuto, in un ufficio sconosciuto, in una località sconosciuta di un paese straniero ignoto, lontanissimo, oltre l’oceano.
L’occhio del Grande fratello si interessa a un paese popolato in gran parte da contadini, pastori, venditori ambulanti, nomadi, profughi. Composto anche in misura minore da commercianti intraprendenti, da mullah spesso senza cultura, da funzionari civili mal pagati, da guerriglieri instancabili e facilmente infiammabili.
Solo due su dieci tra questi abitanti adulti sanno leggere e scrivere. Gli altri non conoscono la differenza tra le parole mongolfiera, aerostato, dirigibile, zeppelin. Ma tutti sanno che quell’enorme pallone sopra le loro teste non è innocente, non studia l’aria, il vento, la pioggia, la temperatura, ma spia i loro gesti e i loro movimenti. Sanno anche che lo hanno portato i soldati stranieri, in questo paese formato da zone desertiche, montagne impervie, vallate verdissime, fiumi impetuosi, spazzato da venti improvvisi, con estati bollenti e inverni gelidi.»
→ Pellizzari, In battaglia, quando l’uva è matura
______________________________________________________
Vaccini. Secondo quanto ricostruito da Reuters, mentre in Italia e in molti altri paesi si parla di terza dose, il numero delle dosi previste per il 2021 dal programma COVAX per i paesi più in difficoltà sarebbe stato tagliato di circa il 30%.
→ Florio: “Brevetti sui vaccini: le (tante) ragioni di Biden”
→ Duflo: “Sì ai brevetti liberi ma anche più dosi per i Paesi poveri”
→ Morozzo della Rocca, La strage silenziosa
______________________________________________________
Aborto. In vigore dal primo settembre in Texas la legge sull’aborto più restrittiva degli Stati Uniti, che vieta l’interruzione di gravidanza una volta rilevata l’attività cardiaca embrionale, a circa sei settimane, e non prevede eccezioni nemmeno in caso di stupro.
«La cosa più grave» riporta L’Espresso, «in quanto crea un precedente pericoloso, è che il “Senate Bill 8”, chiaramente anti costituzionale come ha sottolineato lo stesso presidente Biden, è stato pensato proprio per evitare ricorsi e successivi blocchi, garantendo ai cittadini di fare rapporto sui medici che infrangono la legge.
Le denunce, dunque, possono arrivare da un infermiere, da un impiegato della clinica o persino dal conducente di un taxi».
Intanto, nella vicinissima Repubblica di San Marino, il 26 settembre si terrà un referendum per la depenalizzazione dell’aborto.
→ MacKinnon, Le donne sono umane?
→ Butler, Questione di genere
→ Duby-Perrot, Storia delle donne in Occidente. Il novecento
______________________________________________________
Ex Jugoslavia. Racconto la guerra perché non ho altra scelta
Questo articolo di Zoran Žmirić, tradotto da Internazionale, fa parte di una serie dedicata ai trent’anni dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia, cominciata nel 1991.
«Capisco e accetto che per molte persone la guerra sia la cosa più eccitante che hanno vissuto. Di fronte a queste persone, con un certo imbarazzo ammetto che non è il mio caso.
La donna che mi ha sempre atteso ha detto “sì”. Non c’è nulla di paragonabile. Nessun altro mi avrebbe aspettato come ha fatto lei. Ha atteso il mio ritorno dall’Esercito popolare jugoslavo. Ha atteso il mio ritorno dalla guerra. Ha aspettato il mio ritorno dall’ospedale, dopodiché ha aspettato che fossi del tutto guarito. E poi ha aspettato che tornassi a essere me stesso, l’uomo che, mi ha detto, quando l’ha visto per la prima volta a una festa, le ha fatto tremare le ginocchia. Credo stia ancora aspettando quell’uomo, che non è mai tornato.
Quell’uomo è rimasto bloccato da qualche parte, nella tarda pubertà, alla fine di un’estate che doveva durare per sempre. Un altro uomo è tornato al suo posto e, invece dell’estate infinita che non eravamo destinati ad avere, abbiamo ottenuto quello che abbiamo ora e che sarà, fino alla fine.»
→ Colombo, Guerra civile e ordine politico
→ Kershaw, L’Europa nel vortice
______________________________________________________
Viaggi. La nuova vita dei treni di notte – RivistaStudio
«“Cinema’s enduring love affair with the sleeper train” è un articolo del Guardian risalente al 2014, appena accennato e troppo sintetico, dedicato a tutte quelle volte che il grande schermo ha romanzato le cuccette, romanticamente “i treni di notte”, più intimi di un aereo, più spaziosi di una macchina e quindi perfetti per accogliervi le storie che lì dentro sarebbero nate o finite.
[…] E nonostante nella realtà di storie simili, almeno quelle sentimentali e con il lieto fine, è probabile non ce ne siano mai state e le tratte notturne decisamente costose da gestire e abbandonate dai viaggiatori per i voli a basso prezzo siano state interrotte dalle compagnie ferroviarie, mentre l’Europa affrontava la pandemia lo scorso anno, quelle stesse compagnie hanno iniziato a raccogliere segnali indicativi che una nuova alba per questi viaggi si stava avvicinando.
[…] Enduring love, quindi, ma anche un’opportunità per ridurre le emissioni di carbonio e dare nuova vita alle cuccette una volta quasi predisposte per passare notti infernali, e persino un primo passo verso la Trans Europe Express 2.0 proposta dal ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer, recuperando quella “Trans Europe Express” cantata dai Kraftwerk, con i treni con la livrea crema e rossa e la sigla TEE che hanno rappresentato uno dei pilastri su cui è nata l’Europa unita.»
→ Pace, La libertà viaggia in treno
→ Magrelli, La vicevita
→ Mystery train, un podcast in quattro puntate
Figlio, santo, poeta, cavaliere, riformatore. San Francesco è stato tutto questo e anche molto di più: senza dubbio la più grande figura religiosa e spirituale della storia italiana. Come in un caleidoscopio, la sua vita ci permette di comprendere meglio gli uomini e le donne del medioevo: qui un estratto da L’avventura di un povero cavaliere del Cristo, il nuovo libro di Franco Cardini.
_______________________________________________________________
L’età di Francesco in quel torno di tempo corrispondeva a quella in cui, nelle tradizioni cavalleresche allora in uso in Europa – che, intendiamoci, variavano di luogo in luogo e di tempo in tempo: ma non troppo –, il domicellus compiva il suo tirocinio per giungere infine a ricevere la cintura di miles. In una società in rapida evoluzione, egli apparteneva a un ceto potenzialmente ascendente, con l’ambizione e la necessità di adeguarsi al rango e al «genere di vita» dell’oligarchia consolare, costituita dopo i fatti del 1198 in tutto o in massima parte di populares: al di là della nascita o degli averi, quel gruppo emergente o prominente era infatti caratterizzato dalla diffusione delle forme culturali, cioè di un «genere di vita» aristocratico.
 Si stava in quegli anni, tra la fine del XII e i primi del XIII secolo, assistendo a un processo d’integrazione tra ceti sociali diversi che senza dubbio non escludeva – al contrario! – attriti, tensioni e addirittura violenze, ma che era favorito da una sostanziale omogeneità culturale e politica delle aristocrazie cittadine e del ceto dominante d’origine popolana, presupposto del quale era la penetrazione del costume, della cultura e del «genere di vita» cortesi-cavallereschi in ambienti quali quelli «dei notai e dei giudici che frequentavano gli Studi e le corti signorili, e dei mercanti che vivevano accanto ai nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell’esercito comunale».
Si stava in quegli anni, tra la fine del XII e i primi del XIII secolo, assistendo a un processo d’integrazione tra ceti sociali diversi che senza dubbio non escludeva – al contrario! – attriti, tensioni e addirittura violenze, ma che era favorito da una sostanziale omogeneità culturale e politica delle aristocrazie cittadine e del ceto dominante d’origine popolana, presupposto del quale era la penetrazione del costume, della cultura e del «genere di vita» cortesi-cavallereschi in ambienti quali quelli «dei notai e dei giudici che frequentavano gli Studi e le corti signorili, e dei mercanti che vivevano accanto ai nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell’esercito comunale».
Il figlio del mercante Pietro di Bernardone – abbastanza colto, dotato senza dubbio di parecchio fascino personale nonostante l’aspetto fisico non prestante, soprattutto ricco abbastanza da fare le spese per tutta una «brigata» di giovani gaudenti – aspirava non solo a vivere nobilmente, ma addirittura a far proprio il modus cogitandi del ceto al quale intendeva socialmente assimilarsi: al punto da divenire per i suoi compagni, membri naturali di quel ceto, maestro di tale modus, interprete di cortesia e di «gaia scienza». Sapeva cantare, suonare, danzare, corteggiar le donzelle dei casati dei boni homines suoi amici o clienti (e debitori?) di suo padre; aveva viaggiato, lui figlio di mercante, più dei figli dei milites, l’orizzonte dei quali era incollato alla torre avita e alle colline circostanti; conosceva forse un po’ gli idiomi oltralpini; sapeva abbastanza di Carlo imperatore, di Rolando, della Tavola Rotonda. E la sua passione per la dignità cavalleresca lo avvicinava al personaggio forse più affascinante della letteratura arturiana: a quel Perceval che forse egli conosceva nel nome attribuitogli dal romanziere Chrétien de Troyes, al «puro folle» il cui unico amore – racconta il Conte du Graal che gli è dedicato – sono i cavalieri e che, incontrandone alcuni nel bosco, li crede angeli. Né il padre lesinava il suo denaro per favorire i sogni cavallereschi del figlio, che a suo avviso avrebbero potuto tradursi in termini concreti e cittadini di ascesa sociale, prestigio, buone amicizie e scelta clientela, magari anche di nobile accasamento. Quello era del resto un tempo di nuovi ricchi non meno che di nuovi poveri: come il cavaliere caduto in miseria al quale Francesco, ripetendo un gesto tradizionale di cortesia, avrebbe donato come vedremo il ricco mantello che indossava.
Ma questa prima fase della carriera del giovane, brillante figlio del mercante Pietro fu interrotta dalla forza degli eventi. Nell’ottobre del 1201 le milizie di una lega formata dagli abitanti di Foligno, Assisi, Spello, Bevagna, Nocera e Fabriano mossero contro la città dominante dell’area, Perugia, dove avevano trovato rifugio da ormai tre anni i boni homines assisani costretti o indotti a scegliere la via dell’esilio. Tra gli esuli, volontari o meno, poteva esserci la potente consorteria dei signori di Sasso Rosso e di Coccorano, figli di messer Offreduccio di Bernardo o Bernardino, ch’era già morto nel 1177. Capo del casato era adesso l’irruento messer Monaldo, sire di Coriano; accanto a lui il fratello Favarone, che dalla moglie Ortolana aveva avuto la figlia Chiara, una bambina di circa sette anni quando scoppiò il conflitto. Per la verità, non vi sono fonti sicure ad attestare che dopo il 1198 anche la famiglia di Monaldo si fosse trasferita a Perugia, raggiungendovi gli altri aristocratici assisani in esilio: ma la cosa è tutto sommato verosimile. Quanto a Favarone, sullo scorcio fra i due secoli era con molta probabilità già venuto a mancare.
Francesco partecipò attivamente al conflitto, in particolare al forse modesto episodio della battaglia di Ponte San Giovanni presso Collestrada nel 1202, a metà strada fra Perugia e Assisi. Possiamo immaginarcelo armato ed attrezzato come un cavaliere, anche se nessuno lo aveva mai armato miles? Nel regime podestarile gestito dai boni homines i populares erano esclusi dalla militia, anzi, a rigore non facevano neppure parte del commune: quindi la presenza di un popularis in armi e a cavallo tra giovani boni homines non sarebbe stata de iure ammissibile. Tuttavia ciò poteva de facto ben accadere sulla base di rapporti d’amicizia e di accordi interfamiliari: quale pater familias d’illustre lignaggio avrebbe rifiutato una cortesia del genere al figlio di un suo creditore (dal momento che una delle attività di Pietro di Bernardone doveva con ogni probabilità essere anche quella feneratizia)? D’altro canto, certe esclusioni formali dovevano essere venute a cadere con il moto del 1198.
Comunque gli assisani e i loro alleati ebbero la peggio: nobili e non-nobili furono catturati insieme. Ma in quali circostanze, francamente non lo sappiamo: davvero in combattimento? In tal caso bisogna acconciarsi all’idea che il giovane mercante che amava abbigliarsi da arlecchino avant la lettre, cucendo secondo un bizzarro uso cortese pezze di stoffa ruvide e rozze su abiti preziosi, dopo aver giocato al nobile cavaliere per le vie e per le strade di Assisi abbia anche impugnato le armi e magari perfino ucciso. A meno che non s’ipotizzi una cattura verificatasi non in battaglia, bensì durante qualche fortunato raid di nobili perugini (guidati, perché no?, da assisani esuli in Perugia e desiderosi di rientrarvi) vòlto a catturare ostaggi di qualità per usarli come oggetti di scambio. Una ragione di più perché i perugini e i loro alleati assisani badassero bene a tener Francesco segregato dai populares sistemandolo piuttosto insieme con gli aristocratici e comunque con gli «ospiti di riguardo», merce preziosa da restituire intatta a chi avesse pagato il riscatto. Gli sconfitti rimasero a quanto pare prigionieri almeno un anno. Chissà se a Perugia Francesco ebbe modo d’incontrare in qualche modo qualche giovane appartenente alla cerchia dei maiores che poteva già aver conosciuto al tempo delle liete brigate assisane, per quanto se ne fosse poi andato in esilio col padre in seguito ai fatti del 1198: alludiamo a Rufino, cugino di Chiara.
Anche durante la prigionia le doti di generosità e di cortesia del figlio di Pietro di Bernardone ebbero comunque modo di palesarsi: e l’esperienza fatta con i milites assisani, proprio per la sua durezza, rinsaldò vecchie amicizie e forse ne creò di nuove. Ciò dovette riempirlo di gioia e d’orgoglio, mentre schiudeva dinanzi a lui anche prospettive che non si sarebbe aspettato.
Infine un accordo tra maiores e minores, nel novembre 1203 – ne è espressione la carta pacis – portò alla liberazione dei prigionieri assisani. Ciò non risolveva ancora del tutto il conflitto con Perugia né sopiva le lotte interne; ad esse si aggiungeva anzi, poco dopo, l’interdetto papale sulla città, fulminato e poi ritirato nel fatale 1204, l’anno della presa crociata di Costantinopoli. Ad ogni modo la sia pur problematica convivenza cittadina tra maiores e minores riprese: e con essa anche quella che sembrava la bella vita delle societates iuvenum, forse turbata sempre più dalla fatale dinamica delle violenze e delle faide ch’erano in realtà fisiologiche rispetto alla loro natura «gioiosa» – una «gioia» fatalmente materiata di prepotenza, di violenza, di sopruso –, ma anche suscettibile di riconciliazioni e di nuove alleanze che a quelle violenze erano funzionali anziché contrapposte. Al di là delle spettacolarizzazioni festose e festive, i comitatus feudosignoriali e le societates o «brigate» cittadine, con i loro riti e le loro insegne, si presentavano e si comportavano secondo moduli che sul piano storico sembrano singolarmente statici e monotoni, mentre su quello antropologico mantengono una formalizzazione straordinariamente coerente in culture differenti tra loro al di là della loro apparente anomia: i mitici, semiferini gandharva vedici, precursori dei centauri ellenici, sono divini teppisti non meno dei fin troppo umani destructores descritti da Agostino d’Ippona, dei nobili attaccabrighe Montecchi e Capuleti della Verona comunale reinterpretati da Shakespeare, degli Hell’s Angels di Chicago, degli Hooligans di Liverpool, dei Bloods e dei Crips dei Colours della New York o della San Francisco del Novecento, dei čelovieki delle cosche mafiose dell’Arbat di Mosca, dei ragazzi della «Triade» di Hong Kong o della «Yakuza» di Tokyo, dei «guagliuncielli» della Gomorra di Scampia o dei «picciotti» di Palermo. Non per nulla simboli «medievali», o «religiosi», o immaginati come tali, circolano ancor oggi – anzi sono in pieno revival – in tutte queste «società di giovani».
Scopri il libro:
È Alberto Mario Banti a chiudere “Le smanie per la villeggiatura”, la rubrica estiva della pagina Facebook Lezioni di Storia Laterza.
Domenica dopo domenica, la rubrica ha accompagnato i lettori alla scoperta del significato delle ‘vacanze’ e dei viaggi in diverse epoche e contesti storici, dall’antica Roma alla Germania della DDR, dai Greci dell’Odissea al Medioevo, fino all’avvento del turismo di massa, con gli scritti di Simona Colarizi, Alberto Mario Banti, Laura Pepe, Massimiliano Papini, Maria Giuseppina Muzzarelli, Alessandro Marzo Magno e Gianluca Falanga.
> Qui tutti i contributi già online.
All’origine di tutto c’è il tempo libero. Che non è un dato di natura. È un capitale sociale, che alcuni possiedono e altri no. Chiariamo meglio: in epoca medievale e moderna, il tempo libero è un privilegio delle classi alte, e in particolare delle nobiltà. Fa parte dell’insieme delle loro prerogative. E c’è un tempo libero quotidiano (una parte della giornata dedicata alla lettura, o alla conversazione, o alle visite, o alla caccia); un tempo libero stagionale (in particolare le vacanze estive, quando ci si allontana dalla città e ci si ritira in una fresca villa di campagna); e un tempo libero educativo: questo è il tempo che si dedica al «grand tour», un viaggio per i principali luoghi d’arte e di cultura dell’Europa, la matrice originaria del turismo culturale in senso proprio.
Dopodiché ci sono le differenze economiche e sociali. In epoca medievale e moderna viaggiare costa molto, sia che si faccia un viaggio relativamente breve – tipo: dalla città di abitazione alla villa di campagna –, sia, soprattutto, che si faccia il «grand tour». Ecco, questo sì che è un viaggio complicato e costoso! Partire da Londra per andare a Parigi, e poi a Baden Baden, e poi a Venezia, e poi a Roma, in un’epoca in cui si viaggia su carrozze a cavalli, o in navi a vela, è un’operazione che richiede capacità di organizzazione (evitare le strade pericolose e i briganti che vi stazionano è essenziale!), che richiede tempo, e che richiede un sacco di soldi. E così, fino grosso modo al XVIII secolo sono quasi solo i nobili che viaggiano per scopi ricreativi ed educativi. Ma poi arrivano grandi cambiamenti. Che sono di quattro tipi.
I cambiamenti politici: le radicali trasformazioni che hanno inizio alla fine del XVIII secolo con le rivoluzioni americana e francese, mutano la struttura delle gerarchie sociali, e cancellano in gran parte i privilegi legali e una cospicua parte delle ricchezze delle famiglie nobiliari; adesso altri soggetti sociali si fanno avanti e sono in grado di accumulare le risorse economiche che permettono viaggi e vacanze.
I cambiamenti sociali: il primo gruppo sociale ad emergere, nel corso del XIX secolo, è quello che raccoglie il variegato mondo delle borghesie: persone che vengono da famiglie non nobili, che si fanno strada nel commercio, nell’industria, nelle libere professioni, nella funzione pubblica, e che sono in grado di regalare alle proprie famiglie (tipicamente mogli che fanno le casalinghe, figli e figlie) il tempo libero necessario per ricrearsi e viaggiare. Ma poi ci sono anche altri gruppi sociali, sotto-privilegiati, operai delle fabbriche, contadini, braccianti, il cui numero cresce nel corso del XIX secolo, e che ingaggiano durissime battaglie con gli imprenditori e con gli Stati e le loro forze di polizia. Organizzati in sindacati, e poi – dalla fine dell’Ottocento – in partiti che allora si chiamano socialisti, usano lo strumento dello sciopero per chiedere salari migliori, orari meno disumani, condizioni di lavoro più sicure; e poi, in un percorso lungo che va dalla fine dell’Ottocento agli anni ’70 del Novecento, e con un timing che cambia da area ad area, lottano anche per avere il fine settimana libero, per avere periodi di riposo più lunghi e infine per assicurarsi una delle grandi conquiste della modernità: le ferie pagate. Tutto questo complicato percorso fa sì che tra Ottocento e Novecento non sia più un pugno di persone che si possono permettere di viaggiare per turismo o di andare in vacanza al mare o in montagna: ma sono numeri crescenti di persone, fino a raggiungere le dimensioni di massa, fino a coinvolgere una parte predominante della popolazione.
Inoltre ci sono anche i cambiamenti economici che sono numerosissimi e fondamentali, e troppi da poter essere ricordati qui; ma una dinamica di mutamento la si deve menzionare senz’altro, ovvero il progressivo miglioramento del sistema dei trasporti: dalla diffusione della ferrovia (anni ’30 dell’Ottocento), alla utilizzazione delle navi a vapore (fine Ottocento), alla disponibilità delle automobili (inizio ‘900) e poi degli aerei per trasporto civile (soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale), con costanti ondate di innovazioni tecniche e organizzative che consentono un abbassamento dei prezzi, tale da rendere progressivamente disponibili i nuovi mezzi di trasporto anche ai «social newcomers» (borghesi; ceti medi; classi operaie).
Infine contano anche le strategie della distinzione. Non tutti i luoghi di vacanza sono uguali e non tutte le vacanze valgono allo stesso modo. Intanto perché ci sono dei mutamenti culturali che cambiano radicalmente il significato sociale dei luoghi. Per esempio, fino alla fine dell’Ottocento l’esposizione alla luce del sole per le classi alte è una sorta di anatema; avere la pelle abbronzata, significa essere di classe bassa, significa dover lavorare per lunghe ore all’aperto, come i contadini, gli scaricatori di porto, i manovali. Dunque non si va al mare (le spiagge sono luoghi selvaggi e inospitali) e quando si va in campagna si usano cappelli a larghe tese e, per le signore, dei deliziosi ombrellini da sole, in modo da conservare un incarnato latteo, che è la massima aspirazione estetica. Se proprio si deve fare una vacanza salutare, si va nelle numerosissime stazioni termali, dove si raduna il «bel mondo» dell’Europa ottocentesca. Ma poi, sul finire dell’Ottocento, le nuove teorie seguite da medici che cominciano a prescrivere l’elioterapia (l’esposizione al sole per finalità curative) o la talassoterapia (i bagni di mare per la stessa finalità) fanno sì che le località di mare comincino ad essere ambìti luoghi di vacanza, soprattutto estiva, attrezzati con alberghi, resort, ristoranti e stabilimenti balneari. Poi, la voga della cura corporea e dello sport praticato apre la strada anche alle località alpine, che nel corso del Novecento diventano un luogo privilegiato di esibizione della propria preminenza sociale, anche in ragione del costo delle attrezzature per fare alpinismo, e ancor più sci alpino. Tutte queste trasformazioni aprono la strada al turismo di massa, che tutti abbiamo sperimentato (o sperabilmente, stiamo tornando a sperimentare).
È divertente, il turismo? Da un lato, sì, di sicuro. Niente è più bello che starsene sdraiati in una spiaggia assolata con una bella bevanda fresca in mano: è lì che uno realizza appieno il significato di «vacanza»: un tempo vuoto, un tempo senza impegni, e soprattutto, senza l’ansia del lavoro.
Sono faticose le vacanze? Accidenti, sì! I viaggi di trasferimento sono un incubo, e chi dice il contrario mente sapendo di mentire. Solo gli stra-super-ricchi possono permettersi località super-esclusive con trasferimenti comodissimi e personalizzati. E con ciò è un po’ come se si ritornasse al Medioevo o all’Età moderna. Mentre la massa si conquista le vacanze che può, le nuove nobiltà (sportivi strapagati; star della televisione o del cinema; imprenditori di successo) godono di spazi privilegiati e inaccessibili ai più, ma molto esibiti grazie ai social, questa nuova arma di intimidazione di massa.
E poi ci sono le vacanze culturali, croce e delizia di chiunque (più croce che delizia, temo). La fatica del gran tour dei tempi moderni è descritta con una stupefacente lucidità già nel 1866 da Trollope, che nei suoi Travelling Sketches scrive dei gruppi di turisti in viaggio per il mondo: «Il pater familias sa fin dall’inizio che non si divertirà, e già vorrebbe avere terminato il viaggio ed essere libero di tornare al suo club. La mamma ha il terrore del viaggio, che le procura più apprensione che un senso di piacevole aspettativa. Non è molto felice quando papà è arrabbiato e lui di solito lo è quando si sente a disagio. Poi la gente nelle locande è spesso incivile, e lei ha orrore dei letti! E le ragazze non prevedono grandi soddisfazioni. Sanno che le attende un duro lavoro, e la paura di fare sbagli in francese non le rallegra. Ma bisogna pur partire. Non avere visto Firenze, Roma, Monaco e Dresda, non sentirsi perfettamente a proprio agio sul Reno, non essere saliti sul Rigi o avere parlato con gli scalatori alpini a Zermatt, significa essere fuori moda». E anche oggi, per le masse di turisti vaganti, dietro la guida con la bandierina che si trascina il gregge sudato per le strade di Firenze, o Venezia, o Parigi, o Madrid, l’obiettivo è poter raccontare poi al ritorno di aver fatto anche loro ciò che fanno tutti; magari senza capire nulla di ciò che hanno visto, o senza ricordare nulla in dettaglio; ma con la soddisfazione di poter ammorbare il prossimo con la proiezione delle slides nel salotto di casa, circondati dagli amici affranti; oppure inondando i Facebook altrui con le loro meravigliose fotografie: cosa non si farebbe per un selfie!
In più ci sono i disastri della cultura di massa. «Ha fatto più danni Dan Brown di un branco di vandali»: a questa sconsolata considerazione mi abbandonavo qualche tempo fa (in un periodo abbondantemente pre-Covid) durante una mia visita al Louvre. Lì, arrivato nella sala che ospitava la Gioconda, mi sono imbattuto in un fittissimo assembramento (… lessico odierno…), composto da persone di tutte le età e di tutte le provenienze, che si accalcavano davanti al quadro. C’era chi cercava di sollevare oltre le teste di chi stava davanti un telefonino, per scattare una foto. E c’era chi chiacchierava animatamente. Ma i commenti erano mediamente desolanti, tipo (giuro): «Ovvia, ora che s’è visto questo Michelangelo, si può anch’andar via» (pronuncia toscana, priva di ogni ritegno, persino nelle sonorità). Pochissimi degnavano di una pari attenzione gli altri quadri presenti nella sala, o nel corridoio, o nelle altre sale vicine. E dire che c’erano capolavori di una bellezza travolgente, dal Concerto campestre, di Tiziano (o Giorgione), a Sant’Anna con la Vergine e il Bambino, dello stesso Leonardo, a un’infinità di altri quadri di un’intensità estetica e culturale travolgenti. Dan Brown, quindi. E il suo stramaledetto Codice da Vinci. Ma di certo non tutte le responsabilità sono sue. Se uno si sposta al Musée d’Orsay, e ama gli impressionisti, e li conosce, e vorrebbe soffermarsi davanti ai capolavori che lì sono conservati, deve attendersi un’altra delusione: le sale riservate a quei pittori sono gremitissime di visitatori (… un altro assembramento… ancora!!!); il chiacchiericcio multilingue è incontrollato; le persone sembrano – nella maggior parte dei casi – avere lo stesso atteggiamento che potrebbero avere a Eurodisney: «Oh, toh, ecco Biancaneve!»; «Oh, toh, ecco il Déjeuner sur l’Herbe!»; e data un’occhiata più o meno distratta, via avanti, a riconoscere Elsa di Frozen o Olympia, che tanto fa lo stesso.
Troppo severo? Magari sì. Oppure: provare per credere, e poi ditemi cosa ve ne è sembrato.
In occasione del 120° anniversario della casa editrice Laterza e dei 25 anni del Festivaletteratura,
un incontro di note e parole
This is a vital guide to the life of Dante, a poet equal to Homer and Shakespeare, says AN Wilson
AN Wilson | The Times | August 7, 2021
William Gladstone is not known for his jokes, but he was a learned amateur Dante scholar, and his essay arguing the case for Dante having studied at Oxford University still repays rereading. Of course, he did not mean it to be taken seriously, but it was written from the viewpoint of a man who had read everything there was to read around the subject. He argued that Dante never normally mentions rivers in the Divine Comedy unless he has seen them, and that the allusions to the Thames in the great poem must lead us to suppose that he once visited the Home of Lost Causes.
The point behind the Gladstonian joke is that Dante (1265-1321) tantalises biographers. So much of his work is about himself, so many of the references in the Divine Comedy and his other works can be verified, or checked, by reference to contemporary sources. Did he, for example, after his exile from Florence, go to Paris to study philosophy and theology as the 14th century biographer Boccaccio attests? (It was Boccaccio who applied the epithet Divine to the work known to Dante simply as his Comedy — Comedy, not because it was intended as a medieval equivalent of PG Wodehouse, but because it is the reverse of tragic, it ends with a journey to Paradise and a vision of the ineffable.)
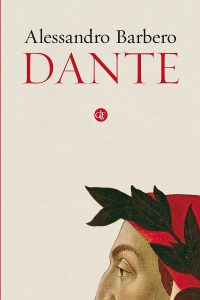 Dante draws on the long tradition of unreliable autobiography that could be said to begin with St Augustine’s Confessions. Dante tells us that he met Beatrice Portinari when he was nine and she was eight. The Beatrice of his dreams and poems, celebrated in La Vita Nuova (1294) and above all in the Divine Comedy, might have been this little girl, as Boccaccio tells us she was — who grew up and married a man called Simone dei Bardi and died in her twenties. But there is no proof that Dante’s Beatrice was this girl — and in the poetry she is so elevated and symbolic that she could just as well have been anyone.
Dante draws on the long tradition of unreliable autobiography that could be said to begin with St Augustine’s Confessions. Dante tells us that he met Beatrice Portinari when he was nine and she was eight. The Beatrice of his dreams and poems, celebrated in La Vita Nuova (1294) and above all in the Divine Comedy, might have been this little girl, as Boccaccio tells us she was — who grew up and married a man called Simone dei Bardi and died in her twenties. But there is no proof that Dante’s Beatrice was this girl — and in the poetry she is so elevated and symbolic that she could just as well have been anyone.
There is no Gladstonian whimsy about Alessandro Barbero’s sober book, which sticks firmly to what can be known. It is difficult to imagine anyone seriously interested in Dante who will not want to own this book, because it weighs all the sources. It traces who Dante’s family were. They were prosperous, but not as aristocratic as he would have liked to suggest; they were mercantile, moneylending folk.
The poet aspired to knightly status. Barbero believes that he fought at the Battle of Campaldino in 1289, on the side of the Florentine Guelphs against the Ghibellines of Arezzo. The only source we have for this is Leonardo Bruni. The point, though, is Dante wanted us to think that he had been at this battle — “I have before now seen horsemen moving camp,” as he says in Inferno 22 — because he wants us to think he was of a knightly caste, rather than being the son of a moneylender. Dante was a poet who had a fervent political ambition, becoming a member of the various councils that administered the Republic of Florence, and became a prior, in effect a joint prime minister of the republic.
Florence, remember, was one of the largest cities in Europe in Dante’s day. The florin, its currency, was the one reliable coinage in Europe, which gave it huge prestige and political power. The very word “banco” (bench), is the object of furniture on which Florentines sat to lend and authenticate coinage to the popes, kings and potentates of the Continent. Dante’s frequent complaints that his native city had degenerated into a mere marketplace did not stop him, as Barbero shows, from accumulating a fortune himself, although his sense of his noble ancestry enables him to obscure, or actually fib about, the extent of his family’s involvement with banking and moneylending.
Barbero is a solid, reliable guide to the complex story of internecine Tuscan rivalries. Most readers of Dante will be aware that the Guelphs supported the Pope and the Guibellines the Holy Roman Emperor in their rivalries for dominance in European realpolitik. A general reader who starts to wonder about the difference between the White Guelphs and the Black Guelphs, and the mafia-style warfare in Florence between the separate factions, will definitely need some help, and this is patiently, coolly and wisely given here.
These rivalries rose to a head towards the close of the 13th century, when Dante, as prior of the city, was 35, in what the opening of his famous poem calls “the middle of the journey of our life”. When Pope Boniface VIII asked the Florentines to supply him with men for his mercenary army, Dante was among those who spoke out against this. It counted against him. A little while later the Black Guelphs used this as the occasion for a ruthless putsch.
Dante and the other White Guelphs were driven out of Florence; their property was confiscated. Dante spent the last two decades of his life in exile, learning. After his exile, the documentation for Dante becomes much more sparse, but Barbero escorts us from the various aristocratic houses where he took refuge — with the Malaspina family in the Appenines, with the Della Scala in Verona, before settling in Ravenna and completing the Divine Comedy, which is such a curious blend of malice, hate, paranoia, mystic piety, love, wit, the scabrous, the spiritual.
We have to take Dante’s word for it that he was not guilty of the offences for which he was sent into exile — corruption and selling political offices. We can note from his writings that he changed his mind a great deal, beginning as a fervent Guelph, a supporter of the Pope, and ending as a sort of proto-fascistic worshipper of the emperor Henry VII, whom he implored to invade Italy, massacring the inhabitants as he did so, not sparing old women or children. As the Divine Comedy shows, Dante was not a sweetie pie. He was a product of his violent times and the belief that love moved the sun and other stars did not stop him cruelly imagining the physical torments of his enemies in hell.
So frequent are the references to actual people and actual events in his life that we need an accurate historian to escort us through the maze of fact and fiction. Barbero’s book, then, will be essential reading for anyone wanting to know the bare bones of Dante’s earthly pilgrimage.
This book begins by explaining that Dante and Shakespeare have been seen, next to Homer, as among the greatest of European poets, but Barbero admits that it will not tell you why. If you want a book that explains how Dante transformed the raw material of his life experience into the Divine Comedy, this is not it.
If you have not read the Comedy, you are in the position of someone who has never heard Bach’s St Matthew Passion, or seen Rome or Istanbul. You are missing out on something mind-blowingly stupendous. Buy a copy, preferably a parallel text such as Robin Kirkpatrick’s Penguin edition. When you have begun to realise that this poem is, among other things, the autobiography of a catastrophic political failure, who is shocked by the condition of the medieval church but who is also on a spiritual quest, you will want to know the facts.
How reliable is Dante’s version of the actual historical circumstances in which he lived? That is the moment when you reach for Barbero, and you will not find a better guide.
Una storia millenaria quella della Sardegna. Una storia che nasce con la civiltà dei nuraghi, passa attraverso lo sviluppo dei giudicati, l’egemonia di Pisa e Genova, la conquista catalano-aragonese, fino ai Savoia, allo Stato unitario e ai problemi dell’oggi.
Una storia ‘popolare’ perché mantiene una dimensione epica e speciale come in fondo è fatale per una grande isola distante da ogni sua possibile terraferma.
Ne abbiamo parlato insieme allo storico Luciano Marrocu a partire dal suo nuovo libro, Storia popolare dei sardi e della Sardegna, e alla scrittrice Paola Soriga, per ripercorrere e capire insieme la sorprendente vicenda di un’isola che ribadisce da sempre la propria diversità, dai Nuraghi alla globalizzazione.
Scopri il libro:
«Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio» di Gaetano Azzariti, pubblicato da Laterza
Alessandra Algostino | il manifesto | 11 giugno 2021
Il mondo è preda di poteri selvaggi, che fagocitano la rappresentanza e le istituzioni, frantumano e plasmano la società, liquidano i diritti: la barbarie è una minaccia che incombe.
Gaetano Azzariti, in Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio (Laterza), scava nelle cause profonde del naufragio del tempo presente, alla ricerca di una rotta che proietti la società verso un futuro che abbia al centro la dignità della persona.
In un percorso intenso, che si rivolge alle anime inquiete», che avvertono il malessere della società, retrocede alle radici per trovare una via per cambiare lo stato delle cose, per contrastare lo «sviluppo disumanizzato» dominante.
 La ricerca delle ragioni della crisi si coniuga, prospettando un futuro possibile, con la consapevolezza, ancorata ad una concezione materialistica, che nulla è predeterminato, sulla scia dell’interpretazione storica di Vico, della sua ciclicità non lineare: si può arrestare la corsa verso la barbarie, così come precipitare nel «ricorso». La storia è l’esito dell’azione di persone concrete, in un’accezione dialettica, che si fonda sul conflitto, sull’antagonismo tra le forze sociali, dove il soggetto della trasformazione è l’oppresso che lotta per la propria «degnità» (Vico), in una prospettiva che guarda alle forze materiali, a «come e per quali ceti sociali si governa».
La ricerca delle ragioni della crisi si coniuga, prospettando un futuro possibile, con la consapevolezza, ancorata ad una concezione materialistica, che nulla è predeterminato, sulla scia dell’interpretazione storica di Vico, della sua ciclicità non lineare: si può arrestare la corsa verso la barbarie, così come precipitare nel «ricorso». La storia è l’esito dell’azione di persone concrete, in un’accezione dialettica, che si fonda sul conflitto, sull’antagonismo tra le forze sociali, dove il soggetto della trasformazione è l’oppresso che lotta per la propria «degnità» (Vico), in una prospettiva che guarda alle forze materiali, a «come e per quali ceti sociali si governa».
Lo smarrimento che attraversa l’epoca attuale è tratteggiato con un realismo demistificante, che prende le distane sia da un irenico idealismo sia da un arreso nichilismo, nell’ottica di una comprensione che non semplifichi e non riduca artificialmente la complessità. Il malessere del presente è analizzato con le armi di un costituzionalismo critico e immerso nelle vicende umane ed è ricostruito come processo, come rivoluzione passiva, che prende l’avvio dalla svolta neoliberista degli anni Ottanta, sancita, nel 1992, a livello europeo, dal «paradigma Maastricht».
L’immagine che ne risulta è dominata dal vuoto: il legame sociale è allentato, il popolo si è tramutato in un «corpo sociale invertebrato», la solidarietà è scomparsa, gli individui sono spaesati, i partiti hanno perso radicamento sociale e capacità rappresentativa, la Costituzione è sospesa e svalorizzata.
Non è un vuoto neutro, ma segnato dall’adozione di una razionalità, fondata sullo scambio, che si inserisce nell’eterna lotta tra classi e si contraddistingue per la sostituzione dell’eguaglianza con la competizione, del popolo con una moltitudine dispersa, del lavoro come strumento di trasformazione sociale con l’egemonia del finanzcapitalismo. È un cambio di paradigma, con i suoi assi nella «sublimazione del mercato» e nella «sterilizzazione della politica», che travolge i partiti e la rappresentanza: i primi abbandonano il compito di dare voce al popolo, nella sua pluralità, e ripiegano su una autoreferenzialità che trae legittimità dalla «tecnica»; la seconda si trasforma in mero strumento di gestione del potere. Non solo: come è argomentato nella seconda parte del volume, dedicata all’Europa, la rivoluzione passiva neoliberista invade lo spazio europeo, ponendo fine al fragile sogno di un’Europa politica e sociale.
A mutare è il senso stesso del diritto, che si avvita su se stesso, diviene astratto, «senza società», ovvero senza legame con forze sociali concrete, consegnato all’impotenza: considerazioni che, come precisa l’Autore, si riferiscono in modo particolare al diritto costituzionale. A rischiare l’estinzione – si può annotare – non è il diritto in sé: imperversa, infatti, il diritto liquido, postmoderno, à la carte, legato, e asservito, a soggetti reali, al côté del neoliberismo; a perdere il legame con la base materiale è la tradizione giuridica del costituzionalismo moderno, del diritto teso all’eguaglianza e alla giustizia. Le Costituzioni e la loro forza prescrittiva dipendono dalla condivisione sociale e politica, ove essa venga erosa ad entrare in crisi sono le ragioni profonde del costituzionalismo.
Dal fondo della crisi, tuttavia, si può risalire, evitando la caduta nella barbarie: la critica del presente e la comprensione dei processi dai quali esso deriva sono il primo passo per provare a cambiare. Il futuro possibile, per Gaetano Azzariti, si situa ancora nell’orizzonte del costituzionalismo moderno, a partire dai suoi principi fondativi, liberté, égalité, fraternité, dal modello dell’homo dignus, dalla centralità della persona come homme situé. La via della Costituzione, mescolando la spinta propulsiva della fantasia e la materialità delle trasforma[1]zioni sociali, appare come una «utopia concreta»; essa – può aggiungersi – traduce, in un dato contesto storico, il motore che anima la storia, l’eterno conflitto intorno all’uguaglianza.
Imprescindibile, quindi – Gaetano Azzariti lo evidenzia con forza ed è un fil rouge che percorre le tre parti del volume – è la costruzione di un soggetto storico reale: un popolo, consapevole e determinato, organizzato in forme politiche, che lotti per «un progetto di emancipazione e liberazione». Diritto o barbarie, concludendo, è un libro che assolve alla responsabilità che l’autore affida agli studiosi: contribuire a formare coscienza critica e consapevolezza; è un tentativo – riuscito – di comprendere e insieme anche, gramscianamente, di sentire.
Scopri il libro:
Sovrano di Norvegia fra il 1103 e il 1130, salpò da Bergen nel 1107 alla volta della Terrasanta riconquistata
Antonio Musarra | tuttolibri | 3 aprile 2021
«Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre». Le parole di Fernand Braudel hanno un suono tremendamente familiare. Noi, gente mediterranea – d’un Mediterraneo che s’insinua a fondo nell’interno –; noi che amiamo il sole, il mare ma anche le montagne; noi, che di mediterraneo abbiam pure la dieta: noi s’è, senz’altro, consapevoli (o, almeno, c’è d’augurarselo) di quanto il mare nostrum sia stato, nei millenni, un crocevia di popoli e culture. Ciò vale, a maggior ragione, per il Mediterraneo medievale: un mare plurale, parcellizzato in una miriade d’isole sociali, culturali ed economiche, strettamente connesse tra loro, interessate da interazioni frequenti e da lenti fenomeni d’acculturazione. Un mare che abbiamo imparato a conoscere grazie al moltiplicarsi degli studi, che ne hanno sottolineato la vitalità – a scapito di stanche visioni tese a propinarci l’idea d’un Medioevo terrigeno, chiuso in sé stesso –; e, nonostante ciò, un mare che non smette di stupire.
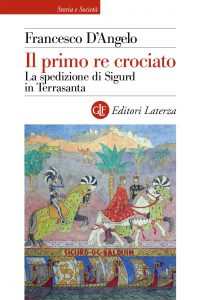 Esiste, infatti, un Mediterraneo ulteriore. Un Mediterraneo che non t’aspetti. Un «Mediterraneo nordico», se vogliamo, sovente ignorato ma altrettanto importante. A questo Mediterraneo, Francesco d’Angelo – tra i maggiori esperti dell’universo scandinavo medievale – ha dedicato un libro recente, edito per Laterza: Il primo re crociato. La spedizione di Sigurd in Terrasanta.
Esiste, infatti, un Mediterraneo ulteriore. Un Mediterraneo che non t’aspetti. Un «Mediterraneo nordico», se vogliamo, sovente ignorato ma altrettanto importante. A questo Mediterraneo, Francesco d’Angelo – tra i maggiori esperti dell’universo scandinavo medievale – ha dedicato un libro recente, edito per Laterza: Il primo re crociato. La spedizione di Sigurd in Terrasanta.
Una vicenda singolare, quella di Sigurðr Magnússon, re di Norvegia fra il 1103 e il 1130. Salpato da Bergen nel 1107, questi compì un vero e proprio periplo del mondo conosciuto, seguendo la rotta atlantica sino in Galizia per poi oltrepassare le Colonne d’Ercole e toccare in successione le Baleari e la Sicilia, prima di volgersi verso Gerusalemme: primo sovrano cristiano a giungervi dopo la conquista cristiana, il 15 luglio del 1099, nel corso di quella che siamo soliti definire «prima crociata».
Certo, la presenza nordica nel Mediterraneo non era una novità, montando a un paio di secoli addietro. Così come non lo era la presenza di Nordmaenner, «uomini del nord», in Terrasanta, di cui si ha notizia per il secolo precedente; in particolare, per qualche membro della celebre Guardia variaga, di stanza a Bisanzio, cui non era estranea la pratica di raggiungere la Città Santa a conclusione del proprio servizio. Ma si pensi, altresì, al pellegrinaggio dell’«apostolo dell’Islanda», Thorvald Kodransson, spintovisi – pare – nel 992. Non solo: la memoria stessa degli uomini del Nord avrebbe legato strettamente le vite di alcuni sovrani all’Oriente cristiano. È il caso di Olaf I Tryggvason (995-1000), la cui tomba – si diceva – si trovava a Gerusalemme, di Olaf II Haraldson (1015-1128), due volte pellegrino, o, ancora, di Harald III (1047-1066), partito attorno al 1034. Siamo di fronte a viaggi immaginari, che dicono molto, però, della centralità del luogo nell’ambito della progressiva alfabetizzazione cristiana dei popoli settentrionali.
Il viaggio-pellegrinaggio di Sigurðr – vero e proprio «eroe tra due mondi» – risalta per la propria peculiarità, oltre che per essere narrato con dovizia di particolari. Che D’Angelo maneggia con maestria, mostrando il modo in cui questi fosse andato guadagnandosi l’appellativo «Jórsalafari»: colui che ha viaggiato a Gerusalemme. La circostanza sottolinea una volta di più il valore periodizzante della «prima crociata». La presa di Gerusalemme richiamò a sé pellegrini e viaggiatori da tutta la Cristianità, compresa quella nordica, imprimendosi nelle coscienze. È il caso di Sigurðr; ma è anche il caso dell’anglosassone Saewulf, la cui Relatio de situ Ierusalem costituisce il primo resoconto di pellegrinaggio redatto all’indomani della conquista, o dell’islandese Nikúlas Bergsson, probabile autore del Leiðarvísir ok borga-skipan («Guida e lista delle città»), risalente alla metà del secolo. Certo, la vicenda di Sigurðr «Jórsalafari» riveste un ruolo di primo piano, vista la dignità regale del nostro. Non a caso, questi fu accolto favorevolmente sia dal primo re di Gerusalemme, Baldovino I (1100-1118), sia da Alessio Comneno (1081-1118), imperatore di Costantinopoli, incontrato nel corso del viaggio di ritorno, al quale pare avesse donato il dragone ligneo ricoperto di bronzo dorato che decorava la propria nave. E ciò, prima di rientrare a casa – per via di terra, attraverso i territori bulgari, ungheresi, germanici e danesi –, dove sarebbe giunto, in gloria, nel 1111. Siamo di fronte, dunque, a una vicenda singolare, ricostruita nei particolari, capace d’allargare – per così dire – la nostra «ragione mediterranea», narrata in un libro accurato, denso d’informazioni e di piacevolissima lettura. Storia di viaggi e di fede. Storia di mare e di guerre. Storia di contaminazioni. Storia d’un re venuto dal nord, desideroso di mettere piede in Terrasanta per venerare il Sepolcro di Cristo.
Scopri il libro:
Gianni Rodari, who has been almost unknown in English till now, united a fantastical imagination with a deep interest in education
Joan Acocella | The New Yorker | December 7, 2020
“Telephone Tales,” a collection of stories by the Italian children’s writer Gianni Rodari (1920-80), contains a piece called “The War of the Bells,” which begins, “Once upon a time, there was a war—a great and terrible war—in which vast numbers of soldiers died on both sides. We were on this side and our enemies were on the other, and we shot at each other day and night, but the war went on so long that finally, there was no more bronze to make cannons.” That didn’t stop “our” general. He ordered the army to melt down all the church bells in the land and recast them, together, to make a single cannon:
Just one, but one big enough to win the whole war with a single shot.
It took a hundred thousand cranes to lift that cannon; it took ninety-seven trains to transport it to the front. The Mega General rubbed his hands together in delight and said, “When my cannon fires, our enemies will run away all the way to the moon.”
The great moment arrived. The super cannon was aimed at the enemy. We’d all stuffed cotton wads into our ears. . . .
An artilleryman pushed a button. Suddenly, from one end of the front to the other, came the gigantic sound of pealing bells: Ding! Dong! Bong!
We took the cotton out of our ears to be able to hear it more clearly.
Yes, it was true. No cannon blast, just chimes. The opposing general, who had adopted the same strategy, got the same result. Whereupon the two commanders, greatly embarrassed, jumped into their jeeps and drove away. The soldiers, left with no means of killing one another, crawled out of the trenches and embraced. “Peace has broken out!” they cried.
 In Italy, everyone knows who Gianni Rodari was: one of the country’s most cherished writers of children’s books. In the United States, practically nobody knows his name. Of his thirty books, not one was published here during his lifetime. A few came out in the U.K., and you can still get a copy of one of these translations, if, for example, you are willing to mortgage your house. The other day, I tried to buy “Tales Told by a Machine,” from 1976. Amazon had a hardcover copy, for nine hundred and sixty-seven dollars, plus shipping. This is a crime against art.
In Italy, everyone knows who Gianni Rodari was: one of the country’s most cherished writers of children’s books. In the United States, practically nobody knows his name. Of his thirty books, not one was published here during his lifetime. A few came out in the U.K., and you can still get a copy of one of these translations, if, for example, you are willing to mortgage your house. The other day, I tried to buy “Tales Told by a Machine,” from 1976. Amazon had a hardcover copy, for nine hundred and sixty-seven dollars, plus shipping. This is a crime against art.
Things may be changing, though. In honor of the centenary, this year, of Rodari’s birth, a small, enterprising publisher in Brooklyn, Enchanted Lion, has brought out the first full English-language edition of “Telephone Tales,” in a spirited translation by Antony Shugaar. Now, albeit decades late, Anglophone readers can find out why Italians love this writer.
Gianni (Giovanni) Rodari was born in 1920 in Omegna, a quiet little town on the edge of Lake Orta, in northern Italy. His father was a baker. Gianni loved his father. Every day, he said, the man would make a dozen rolls out of white flour for him and his younger brother. “These rolls were very crisp, and we devoured them like gluttons,” he recalled. Another memory he recorded of his father was that one night, during a rainstorm, the family looked out the window and saw a cat marooned between two huge puddles, unable to move forward or back. The father went out, in the storm, and carried the cat to safety. When he returned, he was drenched. Rodari remembered him trembling, with his back pressed against the big oven, trying to get warm. Seven days later, he died, of pneumonia. Gianni was nine.
His mother moved the family back to her home town, Gavirate, near Milan. As Vanessa Roghi narrates in her new biography of Rodari— “Lezioni di Fantastica”, not yet translated—Gianni, in his teens, dreamed of going somewhere else, doing something interesting. (Maybe music? He had studied violin, and he played at weddings and such.) But the family needed money, and so he went to work as a teacher in local primary schools. He discovered that he was good at making up children’s stories, not so much because he wanted to, he said, but as a way of getting his students to sit down and pay attention. In his free time, he read hungrily, especially books on philosophy and politics. In 1940, Italy entered the Second World War. Rodari, who was in delicate health all his life, was excused from military service on medical grounds. Late in the war, after two of his friends had died in action and his brother Cesare, the one he had shared the rolls with, had been interned in a German prison camp, he joined the Resistance and enrolled in the Italian Communist Party.
After the war, the Party got in touch with him. Would he like to do some writing for its newspapers? In the next few years, Rodari produced copy—on sports, crime, the arts, everything—for Communist papers, one of which, L’Unità, finally asked him to write some pieces for children. In 1950, the Party transferred him to Rome, to edit a children’s weekly. And now he began publishing books, not just stories.
The Communist context of his writing is evident in the book that soon made his name, “The Adventures of Cipollino” (1951), in which a small onion-boy, Cipollino (the word means “little onion” in Italian), leads an uprising of aggrieved garden vegetables—Potato, Leek, Radish, et al.—against the tyranny of Prince Lemon and his brutal enforcer, Signor Tomato. Given the Cold War, it is no surprise that this book did not appear in English (Enchanted Lion hopes to publish a translation in 2022), or, conversely, that Rodari acquired a huge following in the Soviet Union, where “Cipollino” was adapted into an animated film, a live-action film, and even a ballet. Its hero’s sweet, bland face adorned a Russian postage stamp, and when the Soviet astronomer Nikolai Chernykh discovered a new minor planet, between Mars and Jupiter, he named it 2703 Rodari.
Gradually, Rodari’s reputation spread beyond leftist circles, and he acquired some literary friends. Italo Calvino, tiller of the same fields (folktales, new tales), admired him and stumped for him. But, like many autodidacts, Rodari was wary of the in-crowd, and he socialized mostly with newspapermen. In 1960, after being picked up by Giulio Einaudi, a politically unaffiliated and highly respected publisher (he published Primo Levi, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Calvino), Rodari began to attract a mainstream audience. Eventually, he received the Hans Christian Andersen Award for Writing, a sort of children’s-literature equivalent of the Booker Prize.
“Telephone Tales” is from this period. The book has a frame story. Once upon a time, there was a man, Signor Bianchi, who worked as a travelling salesman of pharmaceutical goods, a job that kept him on the road six days a week. He had one child, a daughter (as did Rodari, who married in 1953), and she missed him when he was away. But they had a deal. Every night, before she went to sleep, he would call her and tell her a story. Long-distance calls were expensive, so the stories were always very short, but they were wonderful. When Signor Bianchi was on the line, Rodari wrote, “all the young ladies who worked the telephone switchboard simply stopped putting calls through, so they could listen.”
The sixty-seven tales in the collection show us where Rodari came from, and where he was going. A few are frank agitprop. Rodari had spent twenty-three years of his life under Fascism, and as the book’s translator, Antony Shugaar, has pointed out, the subject of a number of the stories is simply how not to be a Fascist. That’s what they say: Don’t kill one another, and don’t listen to bullies who tell you to do so. But in other tales we can see agitprop morphing into something more bizarre. In “The Unlucky Hunter,” a boy, Giuseppe, whose sister is getting married the next day is told by his mother to go hunting and bring back a rabbit to accompany the polenta at the nuptial feast. He goes off and soon spies a rabbit. But, when he shoots his rifle, what issues from the gun is not a bullet but a “cheerful, fresh little voice,” saying, “Boom!,” almost as if it were making fun of him. Next thing, “the same rabbit as before strolled by, right in front of Giuseppe, only this time it had a white veil over its head dotted with orange blossoms.” “ ‘Well, what do you know,’ said Giuseppe. ‘The rabbit is getting married too.’ ” This is like a Surrealist painting, half funny, half unsettling. A rabbit bride, a talking gun: what’s going on?
Part of what makes this story genuinely weird is that, unlike the chimes in “The War of the Bells,” which employs the same comic device, the unexpected sound is human. This sort of transfer, from one mode of expression to another, starts to become common in Rodari’s tales. In “A Distractible Child Goes for a Walk,” the child in question, Giovanni, taking a stroll, loses his body parts along the way. He is looking at this and that—the cars, the clouds—and, oops, his hand falls off. Then he gets interested in a dog with a limp, and as he follows the animal one of his arms detaches itself and vanishes. By the time he gets home, he’s missing both arms, both ears, and a leg. “His mother shakes her head, puts him back together.” (The neighbors have thoughtfully collected Giovanni’s body parts and brought them to her.) She kisses him. “ ‘Is anything missing, Mama? Have I been a good boy?’ ‘Yes, Giovanni, you’ve been a very good boy.’ ” This is sweet, and also appalling. When we leave the house, young readers might ask, do we have to be careful that our feet won’t fall off?
From the moment he began teaching, Rodari never stopped thinking about the education of children. He wrote about it, delivered lectures on it, gave interviews on it, to the end of his life. In 1972, to his great satisfaction, he was invited to confer for four days with a group of fifty teachers in the city of Reggio Emilia, a hot spot of postwar Italy’s vigorous early-education movement. The following year, he published a book, “The Grammar of Fantasy,” based on the talks he had given there. Here are the opening lines of Chapter 1, translated by the fairy-tale scholar Jack Zipes:
A stone thrown into a pond sets in motion concentric waves that spread out on the surface of the water, and their reverberation has an effect on the water lilies and reeds, the paper boat, and the buoys of the fishermen at various distances. All these objects are just there for themselves, enjoying their tranquility, when they are wakened to life, as it were, and are compelled to react and to enter into contact with one another. Other invisible vibrations spread into the depths, in all directions, as the stone falls and brushes the algae, scaring the fish and continually causing new molecular movements. When it then touches the bottom, it stirs up the mud and bumps into things that have rested there forgotten, some of which are dislodged, others buried once again in the sand.
How I love this image, with its dark, wet, secret transactions, its mud and molecules. This is Rodari’s metaphor for cognition. In his view, children learned not by having something jammed into their brains—the multiplication tables, the sonnets of Petrarch—but by responding, almost involuntarily, to a sight, an idea, or often just a word, absorbing it, moving other mental contents around to make room for it, and thereby creating something new.
There seems to be no question that Rodari’s concern for education was related to the poverty of his youth. A modest man, he spoke not of his own difficulties but of other people’s—his mother’s, for example. She went to work at the age of eight, he wrote, first in a paper factory, then in a textile works, then as a domestic. When he began teaching, his pupils, too, were poor. In the winter, some could not come to school, because they had no shoes. Many of them also spoke a non-standard Italian, and he worried lest people make them feel embarrassed.
Apart from his students’ ability to get to school, what most concerned Rodari was the development of their imaginations. He said that a line of Novalis’s, which he read as a young man, always stuck in his mind: “If there were a theory of the fantastic such as there is in the case of logic, then we would be able to discover the art of inventing stories.” This he connected with fantasist art of his own time, above all Surrealism. Surrealism is a brew of many ideas, but the one most important to Rodari, it seems, was the simplest, the pairing of opposites—particularly the joining of a dream world to a punctilious realism. A hardy movement, Surrealism lasted from the nineteen-twenties until well after the Second World War, because it fit those wild and disastrous years. A locus classicus is Vittorio De Sica’s breakthrough film, “Miracle in Milan” (1951), which ends with a collection of homeless people who have just seen their shantytown razed by the authorities, taking off, on broomsticks, into the sky. Italy, after the war, was very, very poor. De Sica’s other early films—“Shoeshine,” “Bicycle Thieves,” “Umberto D.”—give a sense of this, as do Rossellini’s “Paisan” and “Rome, Open City.” The country was also humiliated. Many Italian artists were glad to move into new territory. Surrealism provided a picture of the truth they now faced—ugliness, violence, ruin—combined, however, with the memory of a happier past: trees, pocket watches, town squares, pretty women.
Many of the early Surrealists were committed Marxists. In “The Grammar of Fantasy,” Rodari writes of a day that he spent drinking wine with friends in a village outside Kazan, near the Volga. The group visited a local landmark, a wooden house whose furniture, he noticed, was curiously arranged. Sturdy benches were set under the windowsills, so that the erstwhile owners’ children, who liked to come in and out by the windows rather than by the door, could do so without breaking their necks. This, Rodari later decided, was a lesson of Communism. As it turned out, the house had once been the property of Lenin’s grandfather. Whether or not Lenin adapted his political philosophy from his grandparent’s furniture arrangements, Rodari learned critical thinking from Marxist doctrine. Whatever he writes about, he subjects to questioning, scrutiny, a mild irradiation of irony, or just wit. (Rodari inherited this approach in part, he said, from Russian formalist critics of the early twentieth century such as Viktor Shklovsky, who called it ostranenie, defamiliarization.) People in the West tend to associate Marxism with thought control. It is hard to convince them that, in the late nineteenth century, Marxism was considered by its adherents to be the standard-bearer of thought liberation.
In keeping with Rodari’s concern for children’s imaginations, some stories in “Telephone Tales,” like the stone in the pond in “The Grammar of Fantasy,” journey into distant realms of strangeness. Two of them feature a little girl named Alice Tumbledown. Alice falls a lot, into places where we wouldn’t think to look for a missing child. Her favorite landing place is the silverware drawer in the kitchen. She loves it there, in the spoon section. One time, her grandfather finds her inside the alarm clock. Later, he has to fish her out of a bottle. “I was thirsty and fell in,” she explains. Elsewhere, Alice wanders into the ocean. She’d like to become a starfish, she thinks:
But instead she fell into the shell of a giant mollusk just as it was yawning, and it immediately snapped shut its valves, imprisoning Alice and all her dreams. Here I am, in trouble again, thought Alice. But she also felt what silence—what fresh, cool peace—was there inside the giant mollusk. It would have been wonderful to stay there forever.
Who would want to live inside a clamshell, in that cold, pungent fluid, next to that pink blob of a clam? Alice. But then she thinks of her parents, how they love her and would miss her. Regretfully, she pries the shell open, swims out, and goes home. I don’t know of any writer, before Rodari, who would have explored such an experience.
There is worse, or better. In the tale called “Pulcinella’s Escape,” a Pulcinella marionette (Punch, from Punch and Judy) manages to cut the strings that attach him to his control bar. He escapes from the puppet theatre and hides in a nearby garden, where he survives by eating flowers. When winter comes, there are no more flowers, but he’s not afraid. “Oh, well,” he says, “I’ll just die here.” And he does. In the spring, a carnation grows on the spot where his body lies. Under the ground, he says to himself, “Who could be happier than me?” Here, and in “Alice Falls Into the Sea,” two realities sit side by side, looking rather surprised, but not actually annoyed, to see each other. Yes, it would be rather dark and lonely under the ground or inside a clamshell. But how peaceful!
In keeping with his leftist sympathies, there is a rich vein of utopianism in Rodari’s work. “When they are little, children must stock up on optimism,” he wrote, “for the challenge of life.” In one story, Jordan almonds rain down from a cloud in the sky. In a later tale, a Russian astronaut reports that, on Planet X213, people who don’t want to get up in the morning just grab the alarm clock and eat it and go back to sleep. Another planet, called Mun, has a machine that manufactures lies:
For one token, you could hear fourteen thousand lies. The machine contained all the lies in the world—the lies that had already been told, the lies that people were thinking of at that very moment, and all the others that would be invented in the future. Once the machine had recited all the possible lies, people were forced to always tell the truth. That’s why the planet Mun is also known as the Planet of Truth.
But there’s always a hitch. Even a young child could tell you that Mun is not a good name for a planet, nor should anyone try to eat an alarm clock. As for the rain of Jordan almonds, Rodari says that people always waited for it to come back, but it never did. The humor is not as daffy as in Edward Lear, and not as elaborate as in Lewis Carroll. (Rodari loved both writers.) “Telephone Tales” also carries a heavy load of sarcasm. In one story, a man’s nose runs away. (Rodari credits Gogol.) It is finally chased down, brought back, and reattached to the man’s face. The man remonstrates with it: “ ‘But why did you ever run away in the first place? What did I ever do to you?’ The nose glared at him . . . and said, ‘Listen, just never pick me again as long as you live.’ ” Rodari was also fond of bathroom jokes. King Midas, when his touch-of-gold magic is revoked, does not immediately revert to normal. For a brief time, everything he touches turns to shit. These narratives were probably very popular with listeners young enough to remember their toilet training, but adults, too, may have enjoyed such talk.
Some people have asked whether Rodari’s writing, so witty and strange, is not better suited to adults than to children, but children apparently love it. Rodari, before publishing his work, often tried it out on elementary-school classes, and made a note of which parts made the children laugh. I think that, like “Alice in Wonderland,” his writing makes children feel intelligent. Rodari once said that it might be best not to worry about whether his books were for children or adults, but just to consider them “books, tout court.”
It would be hard for anyone, of any age, not to love the illustrations—mostly in Magic Marker—that Enchanted Lion commissioned for “Telephone Tales,” from the Italian artist Valerio Vidali. The book design itself harbors surprises. Some pages have extra little inner pages glued to them. Others are gatefold pages, where you pull the inner edge and another page folds out. In the drawings, you are shown entire worlds of semi-abstract figures: giant noses, a palace made of ice cream, birds eating cookies, plus, of course, kings and queens and a princess in a tower. The pages are sewn with stitches worthy of a Balenciaga gown. It is astonishing that the book costs only $27.95. Go buy one, right now.
Politics accompanied Rodari all the days of his life. He first visited the Soviet Union in 1951 and went back every few years thereafter, to accept prizes, judge competitions, and, as he no doubt felt, just to do his part. Communism, in some measure, gave him his morals, without laying its heavy hand on his blithe spirit. But in the end, according to Vanessa Roghi’s biography, it let him down. He wasn’t the only one. Events in the Soviet Union—the show trials of the thirties, Khrushchev’s famous speech three years after Stalin’s death, enumerating the man’s crimes—caused leftists across the Western world to abandon their loyalty to the U.S.S.R. If those developments didn’t discourage them, later ones did: the bloody suppression of the Hungarian Revolution of 1956, the quelling of the Prague Spring in 1968.
Many Western Marxists openly disavowed the Soviet system, but not Rodari. He had been a Communist practically from his teen-age years, and he would not abandon the Party now, or not publicly. He stood by it even after Italy’s so-called “years of lead,” beginning in the late sixties, when the country was shocked almost daily, it seemed, by acts of political terrorism. (An especially horrifying episode was the 1978 kidnapping and murder of Aldo Moro, a centrist who had served five terms as the nation’s Prime Minister, by the Red Brigades, a neo-Marxist organization. Italians who lived through those years still speak of them with emotion.) In 1979, when Rodari made his last trip to the Soviet Union, he found little to praise about the country in which he had once placed so much hope. Roghi quotes his travel diary, in which he deplores the venality of the Soviet Union and the hypocrisy of its young people. “One thing is certain,” he wrote. “They aren’t Communists.”
Rodari fans, however, should thank the U.S.S.R. By inspiring him and then disappointing him, it set him free, to work in a genre, the so-called children’s tale, where he would not have to confront his bitterness. And, in the end, it drove him beyond bitterness, into a wonderful wildness. The year before that last trip to the Soviet Union, Einaudi brought out Rodari’s final novel, a brilliant satire of both capitalists and revolutionaries. (It was published in English in 2011 with the title “Lamberto, Lamberto, Lamberto.”) In the book, a certain Baron Lamberto, who is ninety-three and fears that he may die, hears that the Egyptian pharaohs believed that if your name was endlessly repeated you could live forever. He decides to give it a try. He has his servants speak his name continuously into microphones placed in the attic of his castle. By the end—despite the best efforts of a gang of terrorists, who take him hostage and cut off his ear (this is actually funny)—he survives.
Rodari didn’t. Not long after “Lamberto” was published, an aneurysm was discovered in his leg. This necessitated a seven-hour operation, which seemed at first to be successful. But then, three days later, he died suddenly, of heart failure. He was only fifty-nine. I hope that his soul is at rest on the Planet of Truth.
Published in the print edition of the December 14, 2020, issue, with the headline “A Theory of Fantasy.”