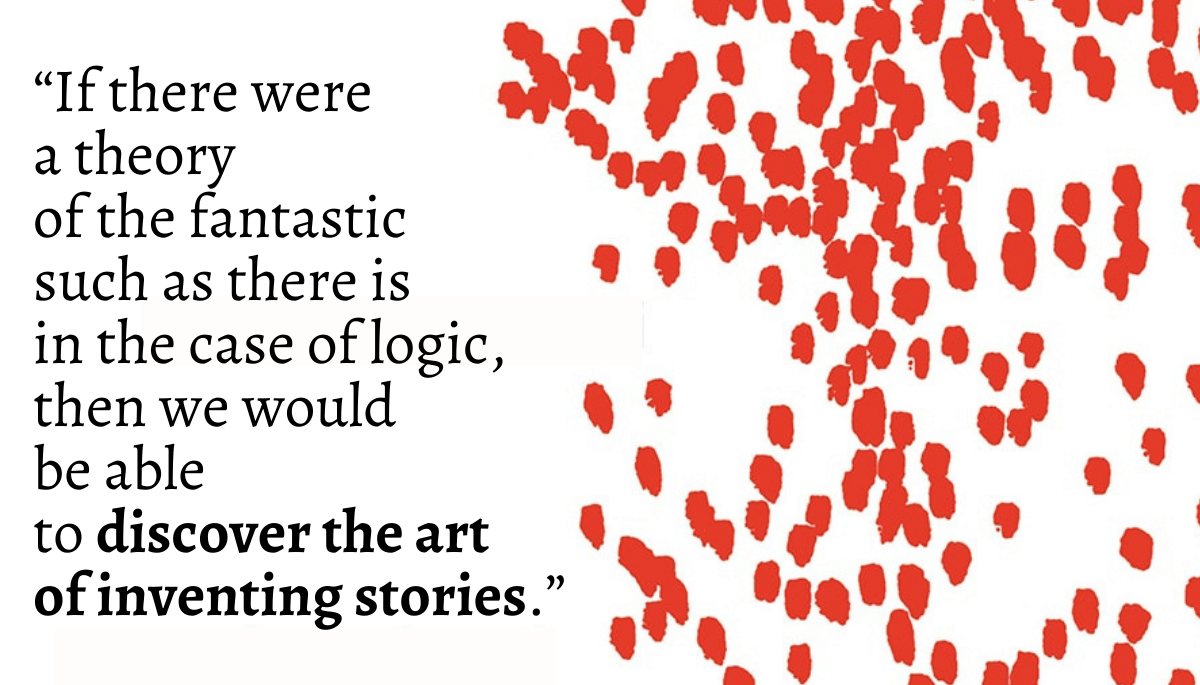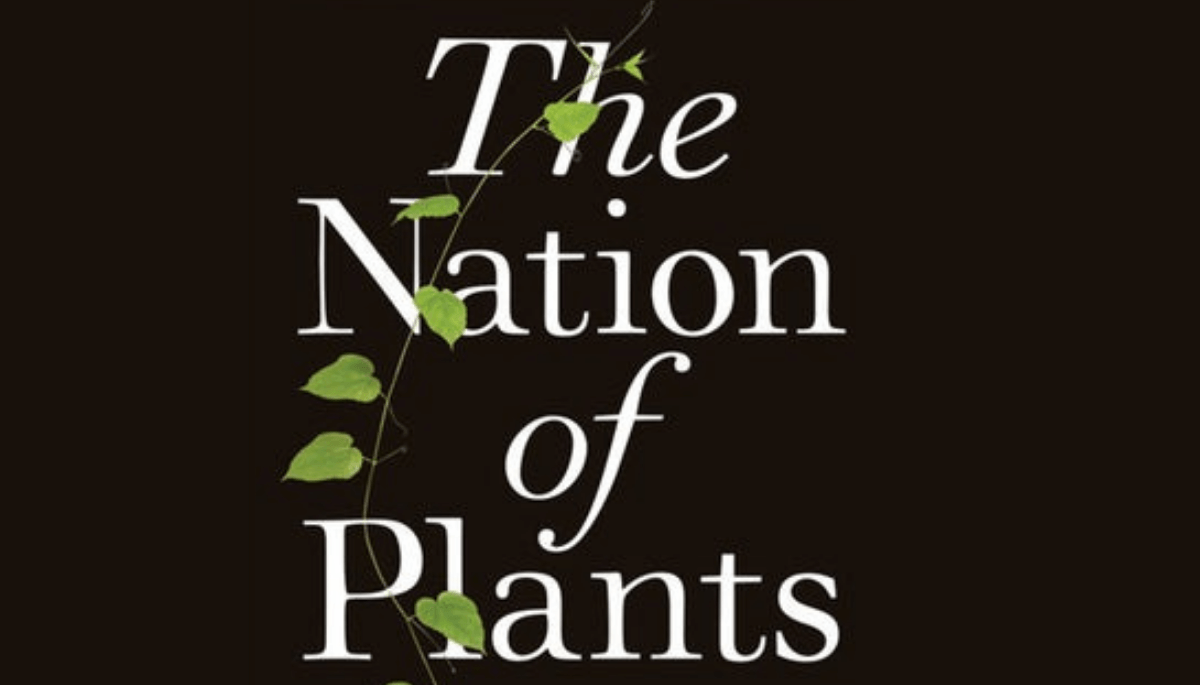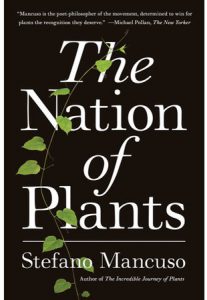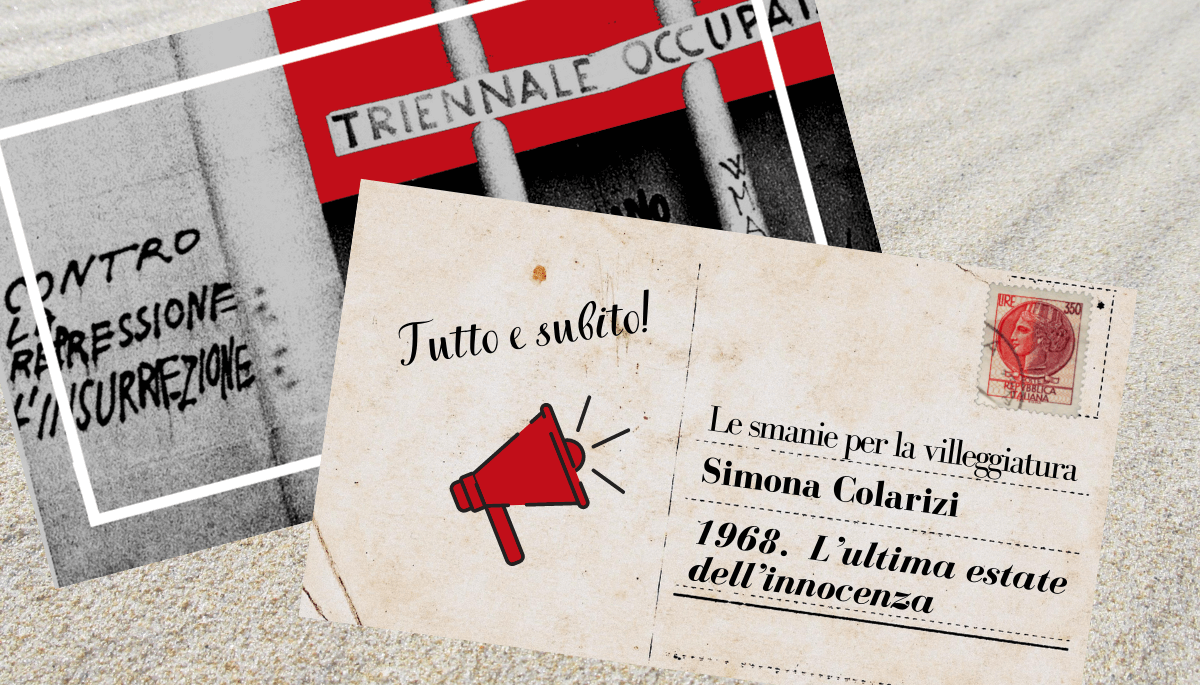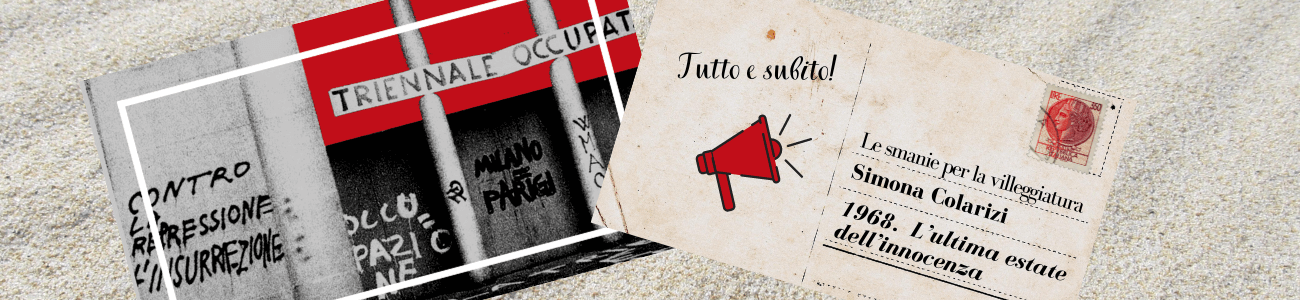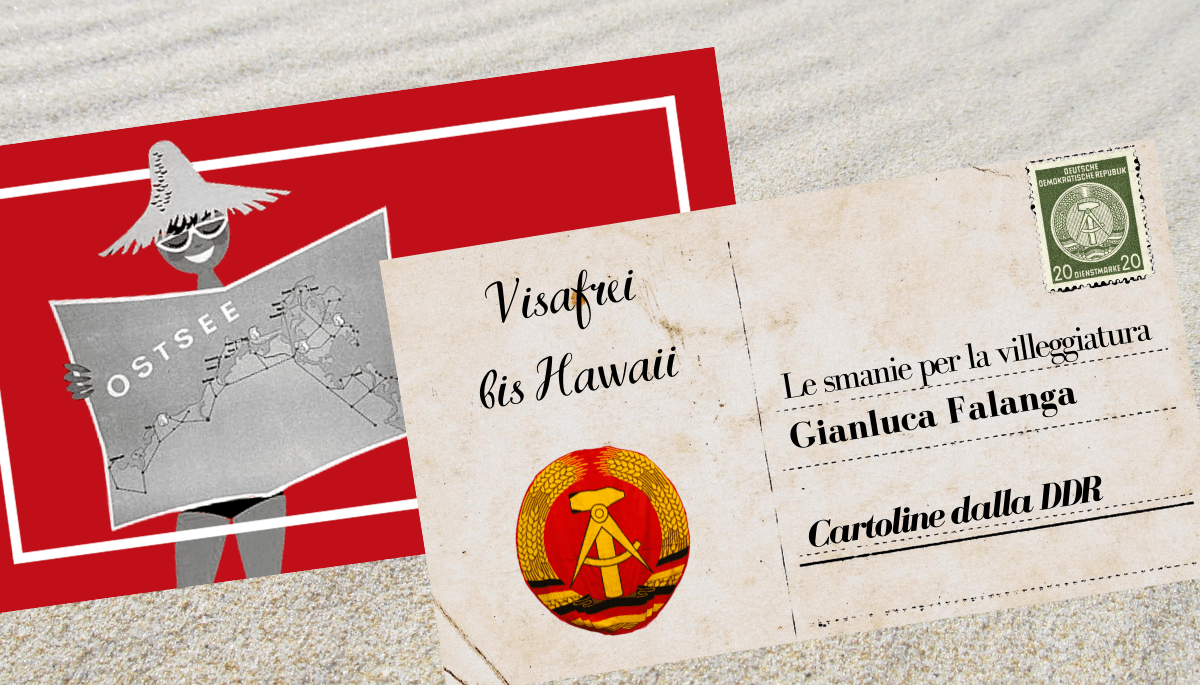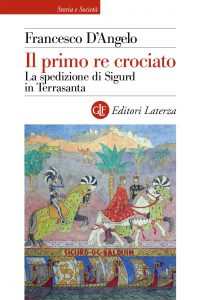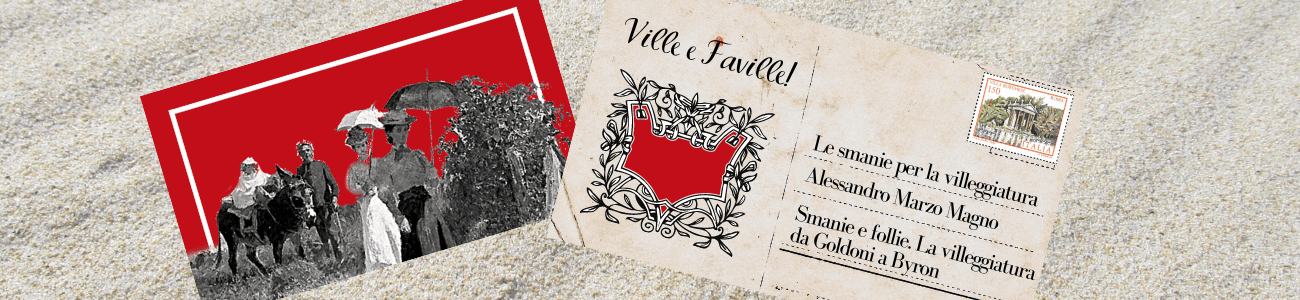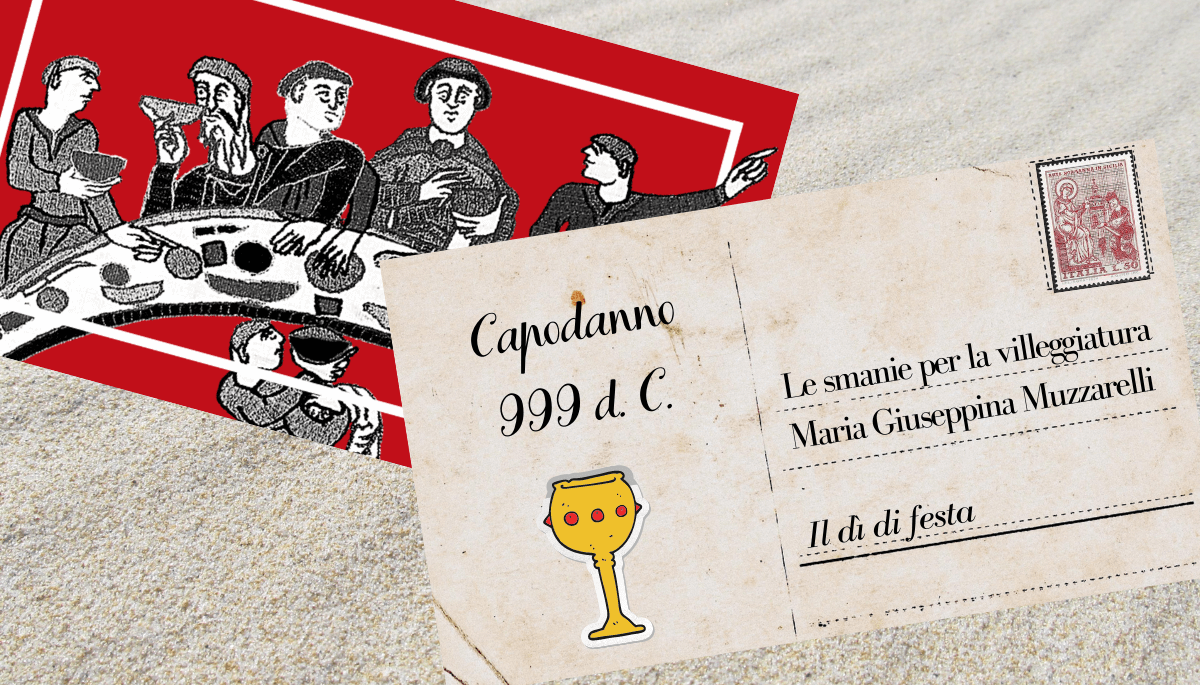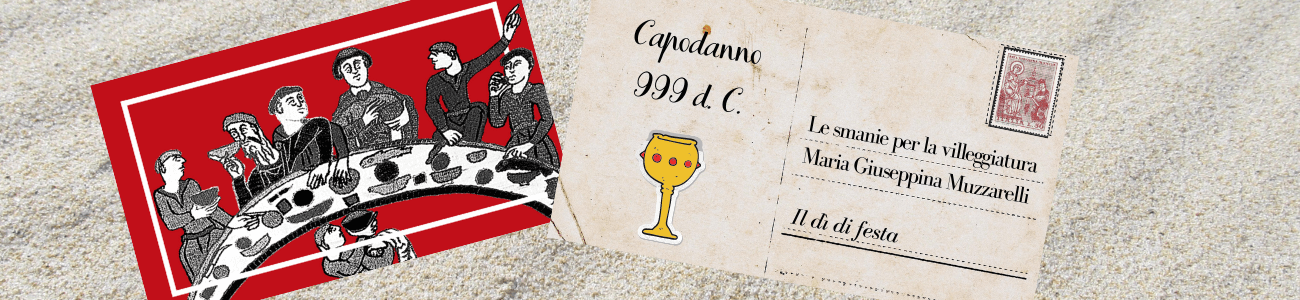Gianni Rodari, who has been almost unknown in English till now, united a fantastical imagination with a deep interest in education
Joan Acocella | The New Yorker | December 7, 2020
“Telephone Tales,” a collection of stories by the Italian children’s writer Gianni Rodari (1920-80), contains a piece called “The War of the Bells,” which begins, “Once upon a time, there was a war—a great and terrible war—in which vast numbers of soldiers died on both sides. We were on this side and our enemies were on the other, and we shot at each other day and night, but the war went on so long that finally, there was no more bronze to make cannons.” That didn’t stop “our” general. He ordered the army to melt down all the church bells in the land and recast them, together, to make a single cannon:
Just one, but one big enough to win the whole war with a single shot.
It took a hundred thousand cranes to lift that cannon; it took ninety-seven trains to transport it to the front. The Mega General rubbed his hands together in delight and said, “When my cannon fires, our enemies will run away all the way to the moon.”
The great moment arrived. The super cannon was aimed at the enemy. We’d all stuffed cotton wads into our ears. . . .
An artilleryman pushed a button. Suddenly, from one end of the front to the other, came the gigantic sound of pealing bells: Ding! Dong! Bong!
We took the cotton out of our ears to be able to hear it more clearly.
Yes, it was true. No cannon blast, just chimes. The opposing general, who had adopted the same strategy, got the same result. Whereupon the two commanders, greatly embarrassed, jumped into their jeeps and drove away. The soldiers, left with no means of killing one another, crawled out of the trenches and embraced. “Peace has broken out!” they cried.
 In Italy, everyone knows who Gianni Rodari was: one of the country’s most cherished writers of children’s books. In the United States, practically nobody knows his name. Of his thirty books, not one was published here during his lifetime. A few came out in the U.K., and you can still get a copy of one of these translations, if, for example, you are willing to mortgage your house. The other day, I tried to buy “Tales Told by a Machine,” from 1976. Amazon had a hardcover copy, for nine hundred and sixty-seven dollars, plus shipping. This is a crime against art.
In Italy, everyone knows who Gianni Rodari was: one of the country’s most cherished writers of children’s books. In the United States, practically nobody knows his name. Of his thirty books, not one was published here during his lifetime. A few came out in the U.K., and you can still get a copy of one of these translations, if, for example, you are willing to mortgage your house. The other day, I tried to buy “Tales Told by a Machine,” from 1976. Amazon had a hardcover copy, for nine hundred and sixty-seven dollars, plus shipping. This is a crime against art.
Things may be changing, though. In honor of the centenary, this year, of Rodari’s birth, a small, enterprising publisher in Brooklyn, Enchanted Lion, has brought out the first full English-language edition of “Telephone Tales,” in a spirited translation by Antony Shugaar. Now, albeit decades late, Anglophone readers can find out why Italians love this writer.
Gianni (Giovanni) Rodari was born in 1920 in Omegna, a quiet little town on the edge of Lake Orta, in northern Italy. His father was a baker. Gianni loved his father. Every day, he said, the man would make a dozen rolls out of white flour for him and his younger brother. “These rolls were very crisp, and we devoured them like gluttons,” he recalled. Another memory he recorded of his father was that one night, during a rainstorm, the family looked out the window and saw a cat marooned between two huge puddles, unable to move forward or back. The father went out, in the storm, and carried the cat to safety. When he returned, he was drenched. Rodari remembered him trembling, with his back pressed against the big oven, trying to get warm. Seven days later, he died, of pneumonia. Gianni was nine.
His mother moved the family back to her home town, Gavirate, near Milan. As Vanessa Roghi narrates in her new biography of Rodari— “Lezioni di Fantastica”, not yet translated—Gianni, in his teens, dreamed of going somewhere else, doing something interesting. (Maybe music? He had studied violin, and he played at weddings and such.) But the family needed money, and so he went to work as a teacher in local primary schools. He discovered that he was good at making up children’s stories, not so much because he wanted to, he said, but as a way of getting his students to sit down and pay attention. In his free time, he read hungrily, especially books on philosophy and politics. In 1940, Italy entered the Second World War. Rodari, who was in delicate health all his life, was excused from military service on medical grounds. Late in the war, after two of his friends had died in action and his brother Cesare, the one he had shared the rolls with, had been interned in a German prison camp, he joined the Resistance and enrolled in the Italian Communist Party.
After the war, the Party got in touch with him. Would he like to do some writing for its newspapers? In the next few years, Rodari produced copy—on sports, crime, the arts, everything—for Communist papers, one of which, L’Unità, finally asked him to write some pieces for children. In 1950, the Party transferred him to Rome, to edit a children’s weekly. And now he began publishing books, not just stories.
The Communist context of his writing is evident in the book that soon made his name, “The Adventures of Cipollino” (1951), in which a small onion-boy, Cipollino (the word means “little onion” in Italian), leads an uprising of aggrieved garden vegetables—Potato, Leek, Radish, et al.—against the tyranny of Prince Lemon and his brutal enforcer, Signor Tomato. Given the Cold War, it is no surprise that this book did not appear in English (Enchanted Lion hopes to publish a translation in 2022), or, conversely, that Rodari acquired a huge following in the Soviet Union, where “Cipollino” was adapted into an animated film, a live-action film, and even a ballet. Its hero’s sweet, bland face adorned a Russian postage stamp, and when the Soviet astronomer Nikolai Chernykh discovered a new minor planet, between Mars and Jupiter, he named it 2703 Rodari.
Gradually, Rodari’s reputation spread beyond leftist circles, and he acquired some literary friends. Italo Calvino, tiller of the same fields (folktales, new tales), admired him and stumped for him. But, like many autodidacts, Rodari was wary of the in-crowd, and he socialized mostly with newspapermen. In 1960, after being picked up by Giulio Einaudi, a politically unaffiliated and highly respected publisher (he published Primo Levi, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Calvino), Rodari began to attract a mainstream audience. Eventually, he received the Hans Christian Andersen Award for Writing, a sort of children’s-literature equivalent of the Booker Prize.
“Telephone Tales” is from this period. The book has a frame story. Once upon a time, there was a man, Signor Bianchi, who worked as a travelling salesman of pharmaceutical goods, a job that kept him on the road six days a week. He had one child, a daughter (as did Rodari, who married in 1953), and she missed him when he was away. But they had a deal. Every night, before she went to sleep, he would call her and tell her a story. Long-distance calls were expensive, so the stories were always very short, but they were wonderful. When Signor Bianchi was on the line, Rodari wrote, “all the young ladies who worked the telephone switchboard simply stopped putting calls through, so they could listen.”
The sixty-seven tales in the collection show us where Rodari came from, and where he was going. A few are frank agitprop. Rodari had spent twenty-three years of his life under Fascism, and as the book’s translator, Antony Shugaar, has pointed out, the subject of a number of the stories is simply how not to be a Fascist. That’s what they say: Don’t kill one another, and don’t listen to bullies who tell you to do so. But in other tales we can see agitprop morphing into something more bizarre. In “The Unlucky Hunter,” a boy, Giuseppe, whose sister is getting married the next day is told by his mother to go hunting and bring back a rabbit to accompany the polenta at the nuptial feast. He goes off and soon spies a rabbit. But, when he shoots his rifle, what issues from the gun is not a bullet but a “cheerful, fresh little voice,” saying, “Boom!,” almost as if it were making fun of him. Next thing, “the same rabbit as before strolled by, right in front of Giuseppe, only this time it had a white veil over its head dotted with orange blossoms.” “ ‘Well, what do you know,’ said Giuseppe. ‘The rabbit is getting married too.’ ” This is like a Surrealist painting, half funny, half unsettling. A rabbit bride, a talking gun: what’s going on?
Part of what makes this story genuinely weird is that, unlike the chimes in “The War of the Bells,” which employs the same comic device, the unexpected sound is human. This sort of transfer, from one mode of expression to another, starts to become common in Rodari’s tales. In “A Distractible Child Goes for a Walk,” the child in question, Giovanni, taking a stroll, loses his body parts along the way. He is looking at this and that—the cars, the clouds—and, oops, his hand falls off. Then he gets interested in a dog with a limp, and as he follows the animal one of his arms detaches itself and vanishes. By the time he gets home, he’s missing both arms, both ears, and a leg. “His mother shakes her head, puts him back together.” (The neighbors have thoughtfully collected Giovanni’s body parts and brought them to her.) She kisses him. “ ‘Is anything missing, Mama? Have I been a good boy?’ ‘Yes, Giovanni, you’ve been a very good boy.’ ” This is sweet, and also appalling. When we leave the house, young readers might ask, do we have to be careful that our feet won’t fall off?
From the moment he began teaching, Rodari never stopped thinking about the education of children. He wrote about it, delivered lectures on it, gave interviews on it, to the end of his life. In 1972, to his great satisfaction, he was invited to confer for four days with a group of fifty teachers in the city of Reggio Emilia, a hot spot of postwar Italy’s vigorous early-education movement. The following year, he published a book, “The Grammar of Fantasy,” based on the talks he had given there. Here are the opening lines of Chapter 1, translated by the fairy-tale scholar Jack Zipes:
A stone thrown into a pond sets in motion concentric waves that spread out on the surface of the water, and their reverberation has an effect on the water lilies and reeds, the paper boat, and the buoys of the fishermen at various distances. All these objects are just there for themselves, enjoying their tranquility, when they are wakened to life, as it were, and are compelled to react and to enter into contact with one another. Other invisible vibrations spread into the depths, in all directions, as the stone falls and brushes the algae, scaring the fish and continually causing new molecular movements. When it then touches the bottom, it stirs up the mud and bumps into things that have rested there forgotten, some of which are dislodged, others buried once again in the sand.
How I love this image, with its dark, wet, secret transactions, its mud and molecules. This is Rodari’s metaphor for cognition. In his view, children learned not by having something jammed into their brains—the multiplication tables, the sonnets of Petrarch—but by responding, almost involuntarily, to a sight, an idea, or often just a word, absorbing it, moving other mental contents around to make room for it, and thereby creating something new.
There seems to be no question that Rodari’s concern for education was related to the poverty of his youth. A modest man, he spoke not of his own difficulties but of other people’s—his mother’s, for example. She went to work at the age of eight, he wrote, first in a paper factory, then in a textile works, then as a domestic. When he began teaching, his pupils, too, were poor. In the winter, some could not come to school, because they had no shoes. Many of them also spoke a non-standard Italian, and he worried lest people make them feel embarrassed.
Apart from his students’ ability to get to school, what most concerned Rodari was the development of their imaginations. He said that a line of Novalis’s, which he read as a young man, always stuck in his mind: “If there were a theory of the fantastic such as there is in the case of logic, then we would be able to discover the art of inventing stories.” This he connected with fantasist art of his own time, above all Surrealism. Surrealism is a brew of many ideas, but the one most important to Rodari, it seems, was the simplest, the pairing of opposites—particularly the joining of a dream world to a punctilious realism. A hardy movement, Surrealism lasted from the nineteen-twenties until well after the Second World War, because it fit those wild and disastrous years. A locus classicus is Vittorio De Sica’s breakthrough film, “Miracle in Milan” (1951), which ends with a collection of homeless people who have just seen their shantytown razed by the authorities, taking off, on broomsticks, into the sky. Italy, after the war, was very, very poor. De Sica’s other early films—“Shoeshine,” “Bicycle Thieves,” “Umberto D.”—give a sense of this, as do Rossellini’s “Paisan” and “Rome, Open City.” The country was also humiliated. Many Italian artists were glad to move into new territory. Surrealism provided a picture of the truth they now faced—ugliness, violence, ruin—combined, however, with the memory of a happier past: trees, pocket watches, town squares, pretty women.
Many of the early Surrealists were committed Marxists. In “The Grammar of Fantasy,” Rodari writes of a day that he spent drinking wine with friends in a village outside Kazan, near the Volga. The group visited a local landmark, a wooden house whose furniture, he noticed, was curiously arranged. Sturdy benches were set under the windowsills, so that the erstwhile owners’ children, who liked to come in and out by the windows rather than by the door, could do so without breaking their necks. This, Rodari later decided, was a lesson of Communism. As it turned out, the house had once been the property of Lenin’s grandfather. Whether or not Lenin adapted his political philosophy from his grandparent’s furniture arrangements, Rodari learned critical thinking from Marxist doctrine. Whatever he writes about, he subjects to questioning, scrutiny, a mild irradiation of irony, or just wit. (Rodari inherited this approach in part, he said, from Russian formalist critics of the early twentieth century such as Viktor Shklovsky, who called it ostranenie, defamiliarization.) People in the West tend to associate Marxism with thought control. It is hard to convince them that, in the late nineteenth century, Marxism was considered by its adherents to be the standard-bearer of thought liberation.
In keeping with Rodari’s concern for children’s imaginations, some stories in “Telephone Tales,” like the stone in the pond in “The Grammar of Fantasy,” journey into distant realms of strangeness. Two of them feature a little girl named Alice Tumbledown. Alice falls a lot, into places where we wouldn’t think to look for a missing child. Her favorite landing place is the silverware drawer in the kitchen. She loves it there, in the spoon section. One time, her grandfather finds her inside the alarm clock. Later, he has to fish her out of a bottle. “I was thirsty and fell in,” she explains. Elsewhere, Alice wanders into the ocean. She’d like to become a starfish, she thinks:
But instead she fell into the shell of a giant mollusk just as it was yawning, and it immediately snapped shut its valves, imprisoning Alice and all her dreams. Here I am, in trouble again, thought Alice. But she also felt what silence—what fresh, cool peace—was there inside the giant mollusk. It would have been wonderful to stay there forever.
Who would want to live inside a clamshell, in that cold, pungent fluid, next to that pink blob of a clam? Alice. But then she thinks of her parents, how they love her and would miss her. Regretfully, she pries the shell open, swims out, and goes home. I don’t know of any writer, before Rodari, who would have explored such an experience.
There is worse, or better. In the tale called “Pulcinella’s Escape,” a Pulcinella marionette (Punch, from Punch and Judy) manages to cut the strings that attach him to his control bar. He escapes from the puppet theatre and hides in a nearby garden, where he survives by eating flowers. When winter comes, there are no more flowers, but he’s not afraid. “Oh, well,” he says, “I’ll just die here.” And he does. In the spring, a carnation grows on the spot where his body lies. Under the ground, he says to himself, “Who could be happier than me?” Here, and in “Alice Falls Into the Sea,” two realities sit side by side, looking rather surprised, but not actually annoyed, to see each other. Yes, it would be rather dark and lonely under the ground or inside a clamshell. But how peaceful!
In keeping with his leftist sympathies, there is a rich vein of utopianism in Rodari’s work. “When they are little, children must stock up on optimism,” he wrote, “for the challenge of life.” In one story, Jordan almonds rain down from a cloud in the sky. In a later tale, a Russian astronaut reports that, on Planet X213, people who don’t want to get up in the morning just grab the alarm clock and eat it and go back to sleep. Another planet, called Mun, has a machine that manufactures lies:
For one token, you could hear fourteen thousand lies. The machine contained all the lies in the world—the lies that had already been told, the lies that people were thinking of at that very moment, and all the others that would be invented in the future. Once the machine had recited all the possible lies, people were forced to always tell the truth. That’s why the planet Mun is also known as the Planet of Truth.
But there’s always a hitch. Even a young child could tell you that Mun is not a good name for a planet, nor should anyone try to eat an alarm clock. As for the rain of Jordan almonds, Rodari says that people always waited for it to come back, but it never did. The humor is not as daffy as in Edward Lear, and not as elaborate as in Lewis Carroll. (Rodari loved both writers.) “Telephone Tales” also carries a heavy load of sarcasm. In one story, a man’s nose runs away. (Rodari credits Gogol.) It is finally chased down, brought back, and reattached to the man’s face. The man remonstrates with it: “ ‘But why did you ever run away in the first place? What did I ever do to you?’ The nose glared at him . . . and said, ‘Listen, just never pick me again as long as you live.’ ” Rodari was also fond of bathroom jokes. King Midas, when his touch-of-gold magic is revoked, does not immediately revert to normal. For a brief time, everything he touches turns to shit. These narratives were probably very popular with listeners young enough to remember their toilet training, but adults, too, may have enjoyed such talk.
Some people have asked whether Rodari’s writing, so witty and strange, is not better suited to adults than to children, but children apparently love it. Rodari, before publishing his work, often tried it out on elementary-school classes, and made a note of which parts made the children laugh. I think that, like “Alice in Wonderland,” his writing makes children feel intelligent. Rodari once said that it might be best not to worry about whether his books were for children or adults, but just to consider them “books, tout court.”
It would be hard for anyone, of any age, not to love the illustrations—mostly in Magic Marker—that Enchanted Lion commissioned for “Telephone Tales,” from the Italian artist Valerio Vidali. The book design itself harbors surprises. Some pages have extra little inner pages glued to them. Others are gatefold pages, where you pull the inner edge and another page folds out. In the drawings, you are shown entire worlds of semi-abstract figures: giant noses, a palace made of ice cream, birds eating cookies, plus, of course, kings and queens and a princess in a tower. The pages are sewn with stitches worthy of a Balenciaga gown. It is astonishing that the book costs only $27.95. Go buy one, right now.
Politics accompanied Rodari all the days of his life. He first visited the Soviet Union in 1951 and went back every few years thereafter, to accept prizes, judge competitions, and, as he no doubt felt, just to do his part. Communism, in some measure, gave him his morals, without laying its heavy hand on his blithe spirit. But in the end, according to Vanessa Roghi’s biography, it let him down. He wasn’t the only one. Events in the Soviet Union—the show trials of the thirties, Khrushchev’s famous speech three years after Stalin’s death, enumerating the man’s crimes—caused leftists across the Western world to abandon their loyalty to the U.S.S.R. If those developments didn’t discourage them, later ones did: the bloody suppression of the Hungarian Revolution of 1956, the quelling of the Prague Spring in 1968.
Many Western Marxists openly disavowed the Soviet system, but not Rodari. He had been a Communist practically from his teen-age years, and he would not abandon the Party now, or not publicly. He stood by it even after Italy’s so-called “years of lead,” beginning in the late sixties, when the country was shocked almost daily, it seemed, by acts of political terrorism. (An especially horrifying episode was the 1978 kidnapping and murder of Aldo Moro, a centrist who had served five terms as the nation’s Prime Minister, by the Red Brigades, a neo-Marxist organization. Italians who lived through those years still speak of them with emotion.) In 1979, when Rodari made his last trip to the Soviet Union, he found little to praise about the country in which he had once placed so much hope. Roghi quotes his travel diary, in which he deplores the venality of the Soviet Union and the hypocrisy of its young people. “One thing is certain,” he wrote. “They aren’t Communists.”
Rodari fans, however, should thank the U.S.S.R. By inspiring him and then disappointing him, it set him free, to work in a genre, the so-called children’s tale, where he would not have to confront his bitterness. And, in the end, it drove him beyond bitterness, into a wonderful wildness. The year before that last trip to the Soviet Union, Einaudi brought out Rodari’s final novel, a brilliant satire of both capitalists and revolutionaries. (It was published in English in 2011 with the title “Lamberto, Lamberto, Lamberto.”) In the book, a certain Baron Lamberto, who is ninety-three and fears that he may die, hears that the Egyptian pharaohs believed that if your name was endlessly repeated you could live forever. He decides to give it a try. He has his servants speak his name continuously into microphones placed in the attic of his castle. By the end—despite the best efforts of a gang of terrorists, who take him hostage and cut off his ear (this is actually funny)—he survives.
Rodari didn’t. Not long after “Lamberto” was published, an aneurysm was discovered in his leg. This necessitated a seven-hour operation, which seemed at first to be successful. But then, three days later, he died suddenly, of heart failure. He was only fifty-nine. I hope that his soul is at rest on the Planet of Truth.
Published in the print edition of the December 14, 2020, issue, with the headline “A Theory of Fantasy.”