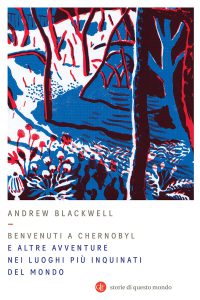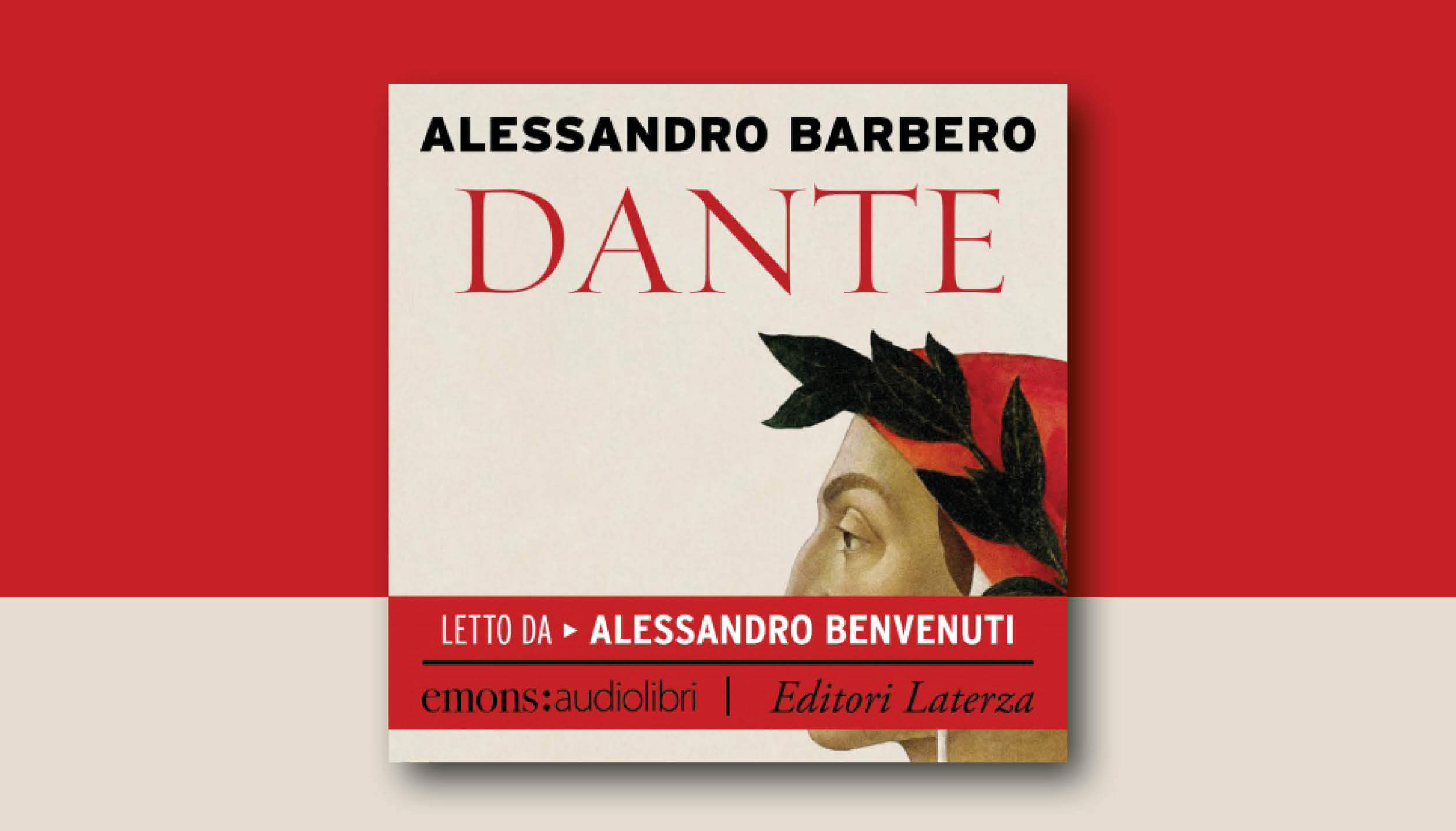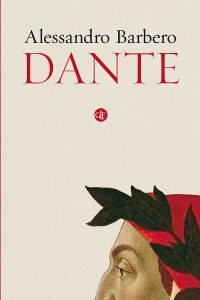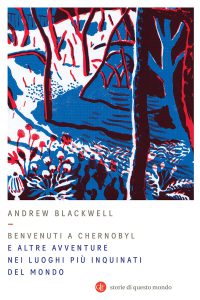Per la maggior parte di noi viaggiare significa visitare i luoghi più belli della terra: Parigi, il Taj Mahal, il Grand Canyon.
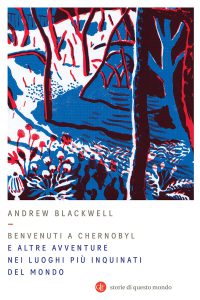 Non succede spesso di prenotare un biglietto per visitare il paesaggio lunare e senza vita dei giacimenti di sabbie bituminose del Canada o di far vela alla volta della Grande chiazza di immondizia del Pacifico. In Benvenuti a Chernobyl, Andrew Blackwell lo fa e viaggia per i luoghi più inquinati della terra: da Chernobyl alla grande isola di rifiuti del Pacifico, dall’Amazzonia devastata dalle coltivazioni di soia alle miniere di carbone in Cina.
Non succede spesso di prenotare un biglietto per visitare il paesaggio lunare e senza vita dei giacimenti di sabbie bituminose del Canada o di far vela alla volta della Grande chiazza di immondizia del Pacifico. In Benvenuti a Chernobyl, Andrew Blackwell lo fa e viaggia per i luoghi più inquinati della terra: da Chernobyl alla grande isola di rifiuti del Pacifico, dall’Amazzonia devastata dalle coltivazioni di soia alle miniere di carbone in Cina.
Perché? Forse l’attrazione di risalire la traccia del futuro, oltre che del presente. Ma c’è anche dell’altro: qualcosa di inafferrabile bellezza abita questi luoghi. Scopriamo così che questo libro, irriverente e pensoso, è anche una lettera d’amore agli ecosistemi più contaminati e più degradati della nostra biosfera e una riflessione su che cosa significano per noi.
In questo estratto, disastri nucleari, fiumi di liquami, nubi di circuiti fritti: tre avventurose destinazioni per viaggiatori curiosi, pronti a cercare “pappagalli verdi volare sopra l’acqua scura”.
_____________________________________
«Noi siamo qui. Chernobyl», disse, e batté sulla carta. «Andiamo con macchina a Kolači. Villaggio sepolto». Batté di nuovo. «Poi a Foresta Rossa. Questo oggi è punto più radioattivo». Mi fissò, come a sottolineare le sue parole. Aveva ancora addosso gli occhiali da sole.
Riprese, rivolto di nuovo verso la carta. «Da qui andiamo a Pryp’jat’. È città deserta. Poi possiamo andare vicino a reattore fino a centocinquanta metri». Era l’itinerario abituale, che permette ai visitatori di vivere i propri preconcetti su Chernobyl come luogo di disastro e orrore, ma senza allontanarsi mai dalle vie battute o rischiare di contaminarsi. Dopo tutto era quello che voleva la maggior parte della gente. Ma non ero venuto fin qui solo per sguazzare nella paranoia post-nucleare. Ero qui per godermi il posto e questo era il momento per riuscirci.
«C’è modo…». Come potevo dirglielo? «C’è modo di andarci in barca?».
Dennis mi scrutò con sguardo assente da dietro gli occhiali da sole. Nelle lenti argentate vidi il riflesso di uno che mi somigliava e che aveva sulla faccia un’espressione che diceva: Sì, sono un idiota.
«Questo non è possibile», disse Dennis.
«Be’, se fosse possibile passare per il fiume, o magari visitare un posto dove si pesca bene, rinuncerei volentieri a parte dell’itinerario previsto». Nella sala riunioni non volava una mosca.
Sul volto di Dennis passò l’ombra di una smorfia. «Questo non. È possibile», disse in modo asettico. Mi raggelava vederlo immune al mio entusiasmo che credevo contagioso. Ma è in momenti come questo, quando uno cerca di andare in vacanza nella zona di un disastro nucleare, controllata militarmente – e per visitare la quale, aggiungerei, nessuno ha mai pubblicato una vera guida – che bisogna avere più del solito il coraggio di fare la figura del cretino al servizio dei propri obiettivi. Scoprii tutte le mie carte.
«Guardi, mettiamo che io voglia fare un picnic e una gita in barca con gli amici in qualche punto della zona», dissi. «Parlando in via del tutto ipotetica, dove potremmo andare? Voglio dire, quali sono i punti migliori?».
Sulla sommità della testa di Dennis si era formato un accenno di ruga. Lo incalzai, dicendogli che i miei interessi non erano tanto da giornalista o da ricercatore, quanto da turista. Da visitatore. Per esempio, qual era un bel posto per fare un picnic nella Zona di esclusione? Lui dove andava nei giorni in cui non aveva da fare? E se non era possibile all’interno della zona, qual era il posto migliore più vicino? Indicai Stracholissja, appena fuori dalla zona, una cittadina che avevo identificato studiando la carta la sera prima. Lì com’era?
«Sì, quello è posto carino», disse Dennis. «Lì puoi pescare». Stavo facendo qualche progresso. Pescare? «Sì», disse Dennis, prendendoci gusto. «Ma questo posto è meglio». Indicò Teremci, una località minuscola nascosta in mezzo a un gruppo di isolette fluviali all’interno della zona. «Questo è buon posto per pescare», disse. «Sono andato una volta. Vado soprattutto per raccogliere funghi». Lo fissai. I funghi raccolgono e concentrano i radionuclidi del terreno e quindi sarebbero l’ultima cosa da mangiare nell’area contaminata. E Dennis li coglieva nel cuore della Zona di esclusione.
«Raccoglie funghi? E li mangia?». La mia voce manifestava soggezione.
«Sì, questa è area pulita, lo so. Questo non è problema». Non credevo alla mia fortuna. Appena arrivato, ero già pappa e ciccia con un tipo per cui la zona era una fungaia e una riserva di pesca. Volevo abbandonare l’itinerario. Perché uno dovrebbe andare a vedere un reattore nucleare distrutto quando appena più a valle si può pescare?
Non pensate che non lo abbia implorato. Ma Dennis era un professionista, troppo per scartare il programma ufficiale – con tutti gli incartamenti approvati, timbrati e firmati in duplice copia per ogni posto di controllo – solo perché uno straniero mezzo scemo gli diceva ti prego ti prego. Ma questa volta esitò per un attimo. «Questo non, ehm. È possibile», disse, tornando subito al copione. Ma intravidi l’accenno di un sorriso mentre si allontanava dalla carta.
Prima di partire da Delhi per il viaggio lungo il fiume, però, andai a vedere la fonte dei problemi. Il canale di scolo di Najafgarh un tempo era un corso d’acqua naturale, ma è stato completamente sopraffatto dal suo uso come canale per i liquami persino più dello Yamuna. Con una portata che si avvicina ai due miliardi di litri al giorno, comprese quasi quattrocento tonnellate di solidi sospesi – sì, quei solidi – il solo Najafgarh è responsabile di quasi un terzo di tutto l’inquinamento dell’intero fiume lungo quasi 1.400 chilometri. È il punto zero dello Yamuna.
Ci avvicinammo a piedi, facendoci strada nella baraonda di un cantiere edile. Stavano costruendo un nuovo ponte stradale che avrebbe oltrepassato il collo di bottiglia della strada che passava per lo sbarramento di Wazirabad. Superato il cantiere trovammo un ponticello pedonale che attraversava il canale a varie centinaia di metri dal punto in cui si immetteva nello Yamuna. Il ponticello pedonale era un sentiero in terra fiancheggiato da parapetti di cemento. Guardando di sotto si vedeva l’ampio letto coperto di cemento del canale, profondo forse come una casa di due piani. Una fanghiglia scura si agitava lungo il fondo. L’aria quasi risuonava dell’odore, quell’odore fermentato, quasi salmastro. Liquami. Era un odore in qualche modo distinto da quello delle feci vere e proprie. Un odore, si può dire, che distillava e concentrava qualunque cosa sia che nelle feci puzza così tanto. Avevo già sentito quell’odore, ma non aveva mai puzzato come puzzava quel giorno a Najafgarh. La puzza era tale che mi fece venire la pelle d’oca. La puzza era tale che mi riempì la bocca di saliva. I conati di vomito cercavano una presa per farmisi strada su per la gola. Cercai di inspirare a fondo.
Eppure.
Guardai di nuovo di sotto. La vegetazione si inerpicava nelle giunzioni del cemento sulle pareti del canale. Sopra l’acqua scura volavano pappagalli verdi con la testa affusolata. I piccioni si posavano su un margine di cemento e intingevano il becco. Le farfalle svolazzavano verso l’alto nell’aria assolata. Passando al lato del ponte a valle, vidi corone di fiori impigliate nei cavi elettrici che traversavano il canale. Erano rimaste lì quando la gente le aveva gettate. Persino qui facevano offerte.
E perché no? Sotto la puzza e il rumore, il motivo permaneva. Era un affluente dello Yamuna. Non dovremmo venerarlo soltanto perché puzza? Perché non essergli devoti, con tutti i solidi in sospensione? Che cosa ci può essere di più sacro di un fiume che sgorga dal ventre del tuo vicino?
Un salone di manicure con sei giovani donne in collant e stivali a tacchi alti lungo una strada piena di botteghe e di attività. A Guiyu tutte le donne giovani o giovanili vestono così. Chiacchieravano chine sul loro lavoro. Ovviamente non era un salone di manicure ma un negozio di circuiti. Ogni donna aveva una manciata di chip. Usando delle pinzette ne prendevano uno e immergevano ognuna delle due file di contatti in un recipiente di lega fusa su una piastra elettrica comune, lavorando con la velocità e l’efficienza di movimenti che deriva dal ripeterli con precisione tutti i giorni.
Chiedemmo se potevamo fotografarle mentre lavoravano. Risposero con risolini. Una di loro, nel secondo necessario per raccogliere la successiva manciata di chip, agitò la mano libera davanti alla faccia e sorrise. Per piacere no.
Vagammo per le strade, passando sopra piccoli canali zeppi di immondizia. Ma i rigagnoli zeppi di immondizia sono come i tramonti. Sono meravigliosi da ammirare, ma non è che significhino poi tanto. Sono più interessanti i molti odori presenti a Guiyu, le molte sfumature di acqua e aria che completano le nubi di circuiti fritti. Presso il fiume, macchie fluttuanti e sentore di fogna. Vicino alla stazione dei pullman, un odore fetido tossico generalizzato rimaneva sospeso sopra un canale lungo la strada. Sul ponte un puzzo inchiostrato di gas di scarico che viene da un trattore a tre ruote di passaggio. Guardai con un certo sgomento il pennacchio asfissiante che si avvicinava. Ma poi, mentre ci passava accanto, il conducente lasciò l’acceleratore per un momento, risparmiandoci il peggio. La cortesia era ancora viva persino a Guiyu.
Passando per un vicolo ci imbattemmo in un gruppo al lavoro su bancali di Motorola Broadband Media Center, i decoder per la tv via cavo. Un uomo ne aveva impilati una cinquantina lungo un lato dell’area di lavoro, formando un muro di scatole metalliche identiche, e passava dall’una all’altra con un’avvitatrice, svitando le stesse quattro viti di ognuna. Dietro a lui gli altri incolonnavano ordinatamente coperture, lati, sostegni di schermi a cristalli liquidi da cui penzolavano cavi a nastro: un groviglio di colori in un pomeriggio grigio. Lungo la strada ruttavano camion pieni di semiconduttori. Una motocarrozzetta ci passò accanto carica di strani oggetti verdi. Mi accorsi con un sussulto che erano cavoli.
Ci fermammo accanto a un autocarro col cassone sovraccarico di sacchi rigonfi da cui sporgevano angoli di circuiti stampati ripuliti. Materia grezza da portare ai misteriosi estrattori d’oro, dovunque fossero. Gli uomini che caricavano il camion sorrisero e mi chiesero da dove venissi.
Mei guo, rispondemmo. America. Che cosa porta il camion? Sorrisero un po’ meno. Cartone, dissero. Carta. Da riciclare. Montarono sul camion e partirono.
Un gruppetto di adolescenti ci sequestrò e ci portò a fare un breve giro fino a un centro civico in cui gli insegnanti cercavano di tenere sotto controllo una turba irrequieta di studenti di musica. Destammo sensazione. Per un momento capii la vita delle stelle del rock, che provocano convulsioni ai fan con uno singolo sguardo. I nostri rapitori ci portarono a un tempio vicino. È il nostro tempio, dissero. Ci addentrammo tra fatiscenti sale decorate, sotto lo sguardo di un plotone di divinità e semidei.
Dovresti pregare qui, dissero, a questo dio. Inginocchiati, unisci le mani, inchinati ed esprimi un desiderio. Lo feci. Ma non riuscivo a decidere se desiderare la pace o l’amore.
Scopri il libro: