DER SPIEGEL – Andreas Wassermann on Rudolf Jacobs and The Good German, by Carlo Greppi: READ THE REVIEW
[>>> Carlo Greppi, The Good German]
DER SPIEGEL – Andreas Wassermann on Rudolf Jacobs and The Good German, by Carlo Greppi: READ THE REVIEW
[>>> Carlo Greppi, The Good German]
[Nell’intenzione di offrire un contributo alla discussione di una vicenda così difficile da comprendere in tutte le sue componenti, abbiamo rivolto alcune domande ad autori della casa editrice e studiosi competenti delle diverse questioni implicate nel conflitto in corso.
La situazione cambia di giorno in giorno e nuovi elementi potranno integrare l’analisi.
Dopo gli interventi di Anna Foa, Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Claudio Vercelli, Arturo Marzano, Ignazio De Francesco, Sarah Parenzo e Fabrizio Mandreoli, pubblichiamo il contributo di Chantal Meloni (professoressa associata di diritto penale internazionale presso l’Università degli Studi di Milano e senior legal advisor presso lo European Center for Constitutional and Human Rights di Berlino (ECCHR). Da molti anni come giurista si occupa del contesto israelo-palestinese. È rappresentate legale delle vittime di Gaza nel procedimento dinnanzi alla Corte Penale Internazionale) e di Lavinia Parsi (dottoranda di ricerca in diritto penale internazionale presso l’Università degli Studi di Milano e la Humboldt Universität zu Berlin. Ha vissuto e svolto ricerca in Israele/Palestina, dove ha collaborato con diversi studi legali dediti alla tutela dei diritti umani).]
Nel dibattito pubblico di questi mesi, per descrivere la terribile situazione in corso in Israele/Palestina sono stati impiegati concetti e termini forti, che hanno in alcuni casi sollevato reazioni avverse se non di scandalo. Oltre ad inquadrare i fatti nella nozione di crimini di guerra, concetto ovviamente legato all’esistenza di un conflitto armato, si è parlato di crimini contro l’umanità, apartheid e persecuzione, di terrorismo e diritto all’autodeterminazione, di colonialismo, pulizia etnica ed anche di genocidio. Tali parole, tuttavia, hanno un significato giuridico, di cui si può e si deve discutere, e che è legittimo impiegare in questo contesto. Altri autori hanno qui evidenziato la complessità di un giudizio morale sulla inestricabile situazione in Israele/Palestina; oltremodo complicato è immaginare una soluzione politica di un conflitto che pare oggi insolvibile. Per certi versi, minore è invece la complessità di un’analisi giuridica. Se è vero che alcuni termini, usati in modo acritico, possono diventare slogan incapaci di produrre alcun effetto, è dunque utile ricondurre queste parole al loro significato giuridico per consentire una valutazione consapevole dei fatti. A tale scopo, possiamo prendere in considerazione tre diversi piani giuridici sui quali la questione è attualmente affrontata: il piano della responsabilità degli Stati, dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia; quello della responsabilità penale degli individui accusati di crimini internazionali, oggetto di indagine presso la Corte Penale Internazionale; quello, infine, delle responsabilità degli attori terzi, come gli Stati europei a vario titolo coinvolti nella commissione delle gravissime violazioni cui stiamo assistendo. Tali piani sono tra loro distinti ma hanno intersezioni e punti di contatto.
Da un punto di vista giuridico, gli atti perpetrati da Hamas il 7 ottobre nel Sud di Israele costituiscono prima facie possibili crimini di guerra e potenziali crimini contro l’umanità. Sempre prima facie, l’offensiva militare israeliana in corso a Gaza sta integrando numerose fattispecie di crimini di guerra e potenzialmente altri crimini internazionali; tra questi, ricorre l’accusa di genocidio. Di quest’ultima questione è stata investita, a seguito del ricorso presentato dal Sud Africa il 29 dicembre 2023, la Corte Internazionale di Giustizia. La Corte – per il cui giudizio nel merito occorrerà attendere anni – ha peraltro già riscontrato l’esistenza di un “rischio concreto ed imminente” che atti integranti genocidio siano commessi da Israele contro la popolazione palestinese di Gaza. Ritenendo che il rischio di un “danno irreparabile” nei confronti dei Palestinesi determinasse perciò un’urgenza, la Corte ha ordinato a Israele, già per ben due volte da gennaio ad oggi, di porre in essere una serie di misure cautelari volte ad arginare la catastrofe umanitaria causata dalle modalità della sua operazione militare.
Sebbene il rischio di genocidio di cui si sta occupando la Corte Internazionale di Giustizia sia riferito ai Palestinesi di Gaza, la richiesta del Sud Africa rappresenta un tentativo di allargare lo sguardo, collocando la situazione contingente nel suo ampio contesto. Sarebbe infatti miope considerare l’attuale situazione di Gaza in modo slegato dalla Cisgiordania, dove negli stessi mesi sono stati uccisi ben 438 Palestinesi oltre ai circa 5.000 feriti, di cui più di 700 bambini. Non si tratta semplicemente di un conflitto armato tra due potenze: in seguito all’occupazione nel 1967 da parte di Israele della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e Gaza, la situazione nel territorio palestinese occupato va ricondotta alle norme di diritto internazionale umanitario relative all’occupazione militare. Tale quadro giuridico, tuttavia, a fronte della incalzante annessione territoriale effettuata con la forza tanto da singoli coloni quanto dalle istituzioni israeliane stesse, non è più sufficiente per regolare la situazione da un punto di vista giuridico. Ciò è tanto più vero se si considera, come altri hanno già notato negli interventi precedenti, che la politica di espansione degli insediamenti in Cisgiordania ha raggiunto il picco nell’ultimo anno e si è ulteriormente intensificata proprio dopo il 7 ottobre.
È interessante notare che la questione delle conseguenze giuridiche della prolungata occupazione del territorio palestinese è a sua volta pendente davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, che ne è stata investita a gennaio dello scorso anno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pur non esplicitamente, la richiesta di parere consultivo sostanzialmente domanda alla Corte di pronunciarsi sulla qualifica della situazione in termini di apartheid, come è emerso dagli interventi dei molti Stati che hanno presentato i loro argomenti nel corso dell’udienza celebrata lo scorso febbraio. Secondo gli esperti, infatti, il regime applicato nel Territorio palestinese occupato e nello Stato di Israele costituirebbe un regime di apartheid, e cioè un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominazione razziale in violazione del diritto internazionale. Solo di recente tale qualificazione giuridica è rientrata nella narrativa mainstream grazie anche ai rapporti di organizzazioni per i diritti umani di peso mondiale, come Amnesty International e Human Rights Watch, ma già negli anni ’90 tale terminologia e analisi era impiegata dalle organizzazioni per i diritti umani locali.
Oltre alla Corte Internazionale di Giustizia, che si occupa di responsabilità statali, la situazione Israele/Palestina è inoltre oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale. Tali indagini riguardano le specifiche responsabilità individuali di natura penale per la commissione di crimini internazionali nella situazione in questione. Non vi è dubbio infatti che, anche in strutture collettive come le istituzioni statali, “i crimini internazionali sono commessi da persone, non da entità astratte”. La Corte Penale Internazionali applica il diritto penale internazionale, come è stato concepito da Norimberga, e si pone l’ambizioso obiettivo di stabilire le responsabilità in particolare di coloro che rivestono posizioni apicali o sono qualificabili come i maggiori responsabili dei crimini commessi. Appartengono allo stesso ambito i procedimenti presso la Corte Penale Internazionale relativi ai crimini di guerra perpetrati in Ucraina, i mandati di arresto nei confronti del Presidente Putin e della Ministra Lvova-Belova, nonché l’istituzione di un organismo di indagine in seno all’Unione Europea dedicato al crimine di aggressione. A differenza dell’Ucraina, tuttavia, le indagini relative alla Palestina sono in grave ritardo.
Al di là delle responsabilità delle parti in conflitto, è necessario in questa sede interrogarsi anche e soprattutto sulle possibili responsabilità sul piano giuridico dei nostri governi. In questo senso, il caso portato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dal Sud Africa, che ha agito invocando gli obblighi erga omnes in materia di genocidio, ha ricordato che gli Stati terzi possono a loro volta essere considerati complici in questo crimine qualora vi contribuiscano, ad esempio fornendo i mezzi che rendono possibile o facilitano la commissione del genocidio, o qualora vengano meno al loro obbligo di intraprendere tutte le misure in loro potere per prevenirlo. In questo solco si inserisce il caso portato dal Nicaragua contro la Germania sempre davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, dove si sostiene che il supporto politico, finanziario e militare fornito ad Israele dalla Germania abbia mancato nel prevenire potenziali atti di genocidio a Gaza e abbia potenzialmente contribuito alla loro commissione.
Alla luce di ciò, è significativo che nelle ultime settimane alcuni Stati abbiano rivisto le proprie posizioni in materia di esportazione di armi. Il governo italiano ha annunciato pubblicamente l’interruzione delle esportazioni delle armi ad Israele – circostanza poi smentita dai dati Istat. Anche il capo della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, a febbraio 2024 affermava che “se la comunità internazionale crede che si tratti di un massacro, forse dobbiamo pensare alla fornitura di armi”. Sulla stessa linea, una lettera firmata da oltre 200 parlamentari europei chiede l’impegno ad arrestare l’export di armi divenuto “oltre che una necessità morale, un requisito legale”. Si moltiplicano poi i ricorsi giuridici intentati presso tribunali di Paesi occidentali storicamente vicini a Israele, volti all’interruzione di ogni forma di sostegno alle gravi violazioni del diritto internazionale commesse a Gaza. Denunce relative all’export di armi, in particolare, sono già state presentate in Australia, Canada, Regno Unito, Germania, Danimarca, Olanda e negli Stati Uniti, ove lo stesso Presidente Biden, il Segretario di Stato Blinken e il Segretario alla Difesa Austin sono stati accusati di non aver impedito, se non addirittura di aver sostenuto, atti di genocidio nei confronti dei Palestinesi di Gaza.
Di fronte all’atteggiamento dei Paesi occidentali, il muro di impunità che sinora li ha coperti sembra stia iniziando a sgretolarsi. Significativamente, ciò sta avvenendo grazie all’iniziativa dei Paesi del cosiddetto “Sud globale”, che, per usare le parole di Audre Lorde, stanno tentando di “smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone”. In questo scenario, per gli Stati europei, compresa l’Italia, che hanno fatto della “rule of law” un fondamento dei propri sistemi democratici, è necessario un netto cambio di rotta per scongiurare ulteriori violazioni del diritto internazionale e riaffermare la validità dei principi così gravemente infranti.
[Nell’intenzione di offrire un contributo alla discussione di una vicenda così difficile da comprendere in tutte le sue componenti, abbiamo rivolto alcune domande ad autori della casa editrice e studiosi competenti delle diverse questioni implicate nel conflitto in corso.
La situazione cambia di giorno in giorno e nuovi elementi potranno integrare l’analisi.
Dopo gli interventi di Anna Foa, Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Claudio Vercelli, Arturo Marzano, Ignazio De Francesco e Sarah Parenzo, pubblichiamo il contributo di Fabrizio Mandreoli, che insegna teologia comparata e fondamentale a Bologna e Firenze e collabora con l’Istituto per la storia delle religioni dell’ISSR della Toscana. Insegna anche presso il carcere di Bologna ed è responsabile del centro ricerche Insight.]
Nella serie di analisi qui presentate – tutte di grande valore – mi pare utile soffermarmi su un aspetto centrale dal punto di vista ideale e simbolico, che può sembrare meno urgente rispetto alla questione di fermare le uccisioni, le ingiustizie e l’odio. Nella priorità che ha in questo momento la salvezza della vita di molti, ci permettiamo di accennare ad un tema che sta sullo sfondo del conflitto sanguinoso che ha visto negli attacchi del 7 ottobre e nella risposta israeliana la sua più recente manifestazione. Si tratta dello sfondo religioso e teologico che, caso per caso, anima o sostiene, giustifica o appoggia, le rispettive rappresentazioni di sé e dell’altro nel conflitto. Il tema è stato già evocato quando si è citato – nel testo di De Francesco – un hadith escatologico che fa parte del repertorio anti-ebraico: “Non giungerà l’ora sino a quando non combattete con gli ebrei, e persino la pietra dietro la quale l’ebreo si nasconde dirà: Oh Musulmano, c’è un ebreo dietro di me, uccidilo”. In maniera speculare, le conseguenze del sionismo declinato in chiave religiosa sono davanti agli occhi di tutti [1] ed invitano alla rilettura delle importanti opere di Aviezer Ravitzky che ha studiato attentamente l’evoluzione in senso religioso delle idee sioniste.
La questione non è, certo, nuova ma sembra di trovarsi di fronte ora, in piena post-modernità, ad un’alleanza perversa tra senso religioso, teologie di riferimento e percezione della terra, dell’etnia e di un ‘noi’ superiore ed esclusivo. Quando, come ci è capitato di ascoltare ad Hebron, qualcuno afferma che è proprio compito religioso – percepito come dato direttamente da Dio – riprendersi tutta la terra, la presenza dell’altro diviene una presenza demonica, da eliminare religiosamente. Certamente, la psicologia sociale e la criminologia possono aiutare a decifrare questi fenomeni di violenza collettiva e personale, nondimeno credo valga la pena indagare – per poterlo disinnescare – quel fenomeno per cui il mistero di Dio – rivendicato da tutti i figli di Abramo, ebrei, cristiani e musulmani, come l’unico, il trascendente, il sempre più grande – viene singolarmente tribalizzato ed etnicizzato (“il nostro Dio”), territorializzato (la “nostra terra santa”) e politicizzato (“Dio è con noi”).
Per disinnescare tale paradossale riduzione teologica, che ha disastrose conseguenze interiori e politiche, credo si possa accennare al modo di leggere i testi sacri e alle opzioni di fondo che stanno dietro tali processi di interpretazione. Propongo questa schematica analisi, consapevole che molti – ricordo qui André Wenin, Giuseppe Dossetti, Meir Bar Asher, Jawdat Said, Gian Domenico Cova, Jonathan Sacks – hanno lavorato con grande sapienza in questa direzione.
In primo luogo, fa parte della lettura dei testi la consapevolezza del proprio punto di osservazione e della propria collocazione. Nessuno riflette “a partire da nessun luogo” con tutto quello che questo comporta in termini di parzialità, di questioni non viste e non visibili, di interessi in gioco, di traumi subiti o inferti. Un posizionamento consapevole, sempre nuovamente da guadagnare, aiuta nel coltivare una postura modesta che, a ben vedere, fa parte del patrimonio mistico di ogni grande tradizione religiosa.
In secondo luogo i testi, per quanto legittimamente creduti come ispirati da Dio, sono dentro la storia umana e, quindi, affidati alla responsabilità degli uomini e delle donne. Si tratta di quella storicità essenziale della fede islamica, cristiana ed ebraica: in tal senso le fonti sono come alberi rovesciati che hanno radici profonde nel mistero di Dio, ma la cui terra, il tronco, le foglie e i frutti abitano all’interno di contesti storici precisi. In tale quadro, quando la lettura incontra nei testi la violenza e l’etnocentrismo, la giustizia intesa come vendetta, l’esclusione e l’eliminazione dell’altro, essa è spinta a chiedersi che senso storico abbiano questi aspetti e se siano compatibili con le istanze etiche e religiose di fondo della propria tradizione. Si tratta della domanda su quali e quante dialettiche interne vivono nel proprio testo sacro.
Questo vale anche – ed è un terzo passaggio – per le rispettive tradizioni interpretative che rappresentano l’alveo vitale delle Scritture sacre e mediano, selezionando e trasmettendo, i significati e le chiavi di lettura principali. Il solo fatto che le tradizioni interpretative – nell’Islam, nel Cristianesimo e nell’Ebraismo – siano cosi ampie e pluralizzate – storicamente e geograficamente – è un potente suggerimento all’interprete che molti sono stati i modi di cogliere le prospettive di verità e che quindi tali modi possono essere strutturalmente parziali, limitati, o anche fuorvianti. Le tradizioni talora sono molto attente e in ascolto dei testi e delle loro profondità, in altri casi li aggrediscono per trovare in essi e giustificare quello che già si pensa.
Tale lavorio – un quarto punto – può giovarsi di un sostegno incredibile quando chi legge i testi della propria tradizione è consapevole e/o conosce i testi di quelle altrui. È la prospettiva della cosiddetta teologia comparativa: la lettura attenta e immersiva, critica e simpatetica, dei testi appartenenti ad altri ‘mondi’ religiosi e culturali permette di ritornare ai propri con un bagaglio di preziosi insights storici e umani, politici e spirituali. Questo modo di procedere per le tradizioni ebraica, islamica e cristiana è reso ancora più eloquente dal fatto che i testi stessi – animati da secoli di storia interpretativa – sono tra loro intrecciati da una serie di riletture e costanti riferimenti.
Un quinto passaggio crediamo sia decisivo: si tratta del momento della scelta ermeneutica. In questa fase, il lettore o la comunità scelgono umanamente – e per chi crede questa scelta avviene davanti al mistero di Dio – nel grande intreccio, che i testi e le loro interpretazioni costituiscono, la modalità di rispondere oggi alle domande proposte dalla storia e dall’esistenza concreta: come si ricostruisce la giustizia? Come trattare il nemico? Che sacralità ha la vita di ogni uomo e donna sulla terra? In che modo guardare e rimediare alle proprie colpe? Come il mistero di Dio ci interpella qui ed ora? Sono le domande che il credente si pone come singolo e come comunità cercando, in modo diuturno, di trovare le risposte che ritiene provenire da Dio. Quest’operazione non consiste, a ben vedere, in un depauperamento della credenza nel parlare di Dio, nella sua alterità, ma assume in maniera seria il fatto che Dio – se esiste – ha scelto di parlare a uomini e donne in quanto tali.
Arriviamo così ad un sesto passaggio: la cassa di risonanza – etica e spirituale, esistenziale e politica – del parlare di Dio è la concretezza umana. In questo spazio credo che possa giocare un ruolo importante – e ampiamente testimoniato dai mistici dei tre monoteismi – la capacità di un sentire largo e buono (la pietà/hesed, la misericordia/rahmah, la magnanimità/macrothumia). Ossia la possibilità di percepire il proprio trauma, quello personale e del proprio popolo, insieme con il faticoso riconoscimento della sofferenza e della storia dell’altro, del nemico. In un’opera storica recente – B. Bashir e A. Goldberg (edd.), Olocausto e Nakba, Zikkaron, Bologna 2023 – tale idea viene descritta come dislocazione empatica. Nell’opera si ripercorre l’obiettivo legame tra due tragedie di popolo, dove la custodia della singolarità ed unicità della Shoah si combina con il riconoscimento della Nakba attraverso uno studio attento della letteratura israeliana e palestinese che mostra l’intreccio di lunga data tra i due eventi. Senza volerci dilungare in dettagli complessi, risulta possibile rilevare in sintesi come questo atteggiamento, che sa riconoscere insieme il dolore dei propri e il dolore dell’altro, sia radicato in maniera profonda – anche se non sempre mainstream – nei rispettivi testi sacri e rappresenti un atteggiamento umano e religioso che può essere scelto e accolto. Una prospettiva delineata in maniera magistrale nel capitolo 58, 6-9 del profeta Isaia che qui glossiamo (e che invitiamo a rileggere sullo sfondo degli eventi degli ultimi decenni in Medio Oriente):
“Non è piuttosto questo il digiuno che voglio
[ossia l’autentico volere di Dio]:
sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi
e spezzare ogni giogo?
[cioè sollevare i poveri e le vittime, liberare gli oppressi]
Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza trascurare i tuoi parenti?
[ossia la capacità di riconoscere i propri e gli altri]
8Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
[il proprio trauma è guarito insieme al trauma dell’altro]
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
9Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”.
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione”
[l’eliminazione dell’oppressione riaccende un dialogo possibile con il mistero di Dio].
Quanto detto tratta di prospettive “religiose” che – composte con un serio rispetto del diritto internazionale – ritengo vadano seminate, fatte crescere e difese nella speranza che modalità altre – aldilà della distruzione violenta del nemico – possano, in qualche modo, attecchire e contribuire ad innervare le scelte politiche, militari e ideali, diminuendo il tasso di quella violenza che rovina Israele e Palestina. L’urgente disarmo militare e politico mi pare necessiti sempre anche di un disarmo ideologico e teologico.
____
[1] Cf. D. Neuhaus, Israele, dove vai?, in La Civiltà Cattolica 2 marzo 2024 (4169), 417-429.
Paolo Mieli | Corriere della Sera | 17 gennaio 2024
La più grande invenzione dell’antica Roma fu l’imperium, quella forma di potere pressoché assoluto che nacque sostanzialmente con Romolo, si perfezionò nell’età repubblicana e si completò, esplicitandosi, ai tempi di Augusto. Ad essa è dedicato un libro prezioso di Giovanni Brizzi, Imperium. Il potere a Roma. Alle radici dell’imperium, mette in risalto Brizzi, si pone una doppia matrice, ad un tempo politica e religiosa. Quella politica è stata sviscerata in ogni suo aspetto e anche qui viene ripercorso il progressivo affermarsi dei «poteri personali» da Publio Cornelio Scipione a Caio Giulio Cesare. Ma su quella religiosa — il cosiddetto «assenso dei Numi» — c’è ancora molto da indagare.
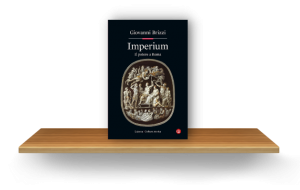 Fino a quando ci sono sullo sfondo gli Dèi il tragitto ha una sua coerenza e una sua linearità. Ma tutto rischia di andare all’aria allorché il potere romano è costretto a fare i conti con il cristianesimo. Qui la personalità della «svolta» è Paolo di Tarso, l’ebreo vissuto nel I secolo dopo Cristo che si convertì alla nuova fede e dedicò la seconda parte della propria vita alla diffusione del messaggio cristiano. In forme che resero tale messaggio compatibile con l’imperium.
Fino a quando ci sono sullo sfondo gli Dèi il tragitto ha una sua coerenza e una sua linearità. Ma tutto rischia di andare all’aria allorché il potere romano è costretto a fare i conti con il cristianesimo. Qui la personalità della «svolta» è Paolo di Tarso, l’ebreo vissuto nel I secolo dopo Cristo che si convertì alla nuova fede e dedicò la seconda parte della propria vita alla diffusione del messaggio cristiano. In forme che resero tale messaggio compatibile con l’imperium.
Che Paolo sia una figura fondamentale nella storia del cristianesimo (e non solo) è un dato storico ormai acquisito. Per qualcuno fu addirittura più importante di Gesù Cristo. Qualche anno fa Andrew Norman Wilson diede alle stampe Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo (Rizzoli) in cui sosteneva la tesi secondo cui il «Gesù dei Vangeli, se non una creazione di Paolo, è un frutto di Paolo». A Wilson quella del santo appariva, nella tradizione neotestamentaria, una figura «più dominante di quella dello stesso Gesù». Si spinse a sostenere che «se Paolo non fosse esistito, è assai improbabile che noi avremmo avuto i Vangeli nella forma presente». E, benché Wilson riconoscesse che c’erano stati molti personaggi di primo piano «coinvolti nell’evoluzione del cristianesimo», gli aspetti che avevano distinto il cristianesimo dall’ebraismo e in effetti lo avevano reso incompatibile con esso, erano «un contributo esclusivo di Paolo». Talché Wilson si spinse a sostenere che fu Paolo (e non Gesù) il «fondatore del cristianesimo».
Il libro piacque pochissimo a monsignor Gianfranco Ravasi che (su «Avvenire») lo stroncò ricordando che l’autore era null’altro che un giornalista dell’«Evening Standard». D’altra parte, perfino Antonio Gramsci aveva parlato dell’Apostolo di Tarso come del «Lenin del cristianesimo» (laddove Marx sarebbe stato Gesù Cristo). «Asserti lapidari» e «approssimazione» furono i capi d’accusa di Ravasi. Il quale — sempre sul quotidiano della Conferenza episcopale italiana — suggerì, come «sano antidoto» all’opera di Wilson, il libro di Rinaldo Fabris Paolo. L’apostolo delle genti (Edizioni Paoline) che pur faceva propria la celebre definizione di William Wrede (1904) di Paolo come «secondo fondatore del cristianesimo». A dispetto della stroncatura di Ravasi, suggestioni in un certo senso wilsoniane si sono potute cogliere in libri successivi come Paolo. L’ebreo che fondò il cristianesimo di Riccardo Calimani (Mondadori) e Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo di Corrado Augias (Rai Libri). Lo stesso Brizzi manifesta un particolare rispetto per la figura del santo e lo presenta come «il genio di Tarso».
Ma — prima di passare a Paolo — torniamo a Gesù e ai suoi rapporti con l’imperium. Nell’affrontare il tema, Brizzi fa sua un’affermazione che fu di Pierre Vidal-Naquet nel libro Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica (Editori Riuniti): «Il non specialista che si avventura in questo tipo di ricerca piomba nell’angoscia». E la evoca come «in qualche modo assolutoria» nei propri confronti. Anche, forse, per mettersi al riparo da critiche sferzanti come quelle di Ravasi. Quella fondata da Gesù gli appare in ogni caso come una «setta giudaica che si distacca certamente — almeno secondo i Vangeli — dagli aspetti più intransigenti» della tradizione ebraica «per l’atteggiamento di apertura verso i dominatori romani». E «persino verso i rappresentanti più odiati del potere, vale a dire i pubblicani, gli esattori delle imposte». La posizione del Cristo nei confronti dell’imperio è stata dedotta soprattutto dalla sua celebre risposta ai farisei. Interrogato se fosse legittimo o meno, ovviamente dal punto di vista della legge mosaica, pagare il tributo a Roma, il Maestro di Nazareth si fece portare una moneta di Tiberio e chiese ai suoi interlocutori di chi fosse l’effigie impressa sulla moneta stessa; avutane la risposta che si trattava di Cesare, Gesù replicò sostenendo che si doveva «rendere» a Cesare le cose di Cesare e a Dio le cose di Dio. In quel «rendere» c’è, secondo Brizzi, «una sfumatura difficilmente eludibile che richiama al tributo morale se non economico da rendersi al potere in cambio dei servigi alla collettività». Tanto che qualcuno, come Ethelbert Stauffer, ha intravisto nell’uso di quel verbo un implicito «assenso» di Gesù «all’impero».
Ma in Paolo, più specificamente nella Lettera ai Romani, c’è di più. La legittimazione nei confronti del dominio di Roma — che pure, già nella frase di Gesù per alcuni è, come si è visto, qualcosa di più di un semplice accenno — nell’enunciato dell’apostolo non è solo una chiosa al detto del Maestro. Contiene un assenso e, ciò che più conta, un «avallo di natura trascendente» al potere imperiale. Il verbo usato è sempre lo stesso: «rendete a tutti quanto è dovuto». Paolo però aggiunge altre parole non irrilevanti: «Ognuno sia soggetto alle autorità superiori, poiché non c’è autorità che non venga da Dio». Perciò «chi si oppone all’autorità resiste all’ordine stabilito da Dio». Autorità che «non per nulla porta la spada», ed essendo «ministra di Dio», ha il dovere di «punire chi opera il male». Paolo, sostiene Brizzi, «non solo divinizza il potere fino ad ogni sua ultima propaggine ed emanazione funzionale». Giunge addirittura a sostenere che «persino gli esecutori di un atto che per i Giudei costituisce un autentico abominio (l’esazione delle imposte)», sono in quel momento «servitori di Dio».
Qualcuno — come il rabbino filosofo austriaco Jacob Taubes in La teologia politica di san Paolo (Adelphi), le ultime lezioni da lui tenute nel febbraio 1987 a Heidelberg, e soprattutto Wolf-Daniel Hartwich, Alejda e Jan Assmann nella prefazione al libro stesso — ha considerato la dottrina di Paolo come una «intensificazione del giudaismo» o come un «potenziamento liberatorio dell’ebraismo stesso». Ma allora perché Paolo aveva definito gli ebrei «nemici»? Qui Taubes, spiega Brizzi, era stato costretto a far ricorso a qualche «forzatura» per dar conto di quella definizione. Ma, in dialogo con Taubes, Carl Schmitt — in Teoria del partigiano (Adelphi) — aveva tagliato il nodo laddove sosteneva che con quel termine, «nemici», l’apostolo definiva la sua Chiesa per opposizione piena nei confronti degli ebrei. Dopodiché, sempre secondo Brizzi, sono molti i segni che Paolo «seguisse da tempo una linea assai meno radicale rispetto a Giacomo, a Giovanni e persino a Pietro». Finché, forse nella primavera del 61, Paolo abbandonò la Giudea per trasferirsi a Roma. Da dove non sarebbe mai più tornato a Gerusalemme. Comunque, è certo che da allora in poi egli fu «decisamente ripudiato» dagli ebrei. Ed è questo, conclude Brizzi, «ciò che qui importa davvero».
In una prefazione alle Lettere di san Paolo (Bur) il teologo e biblista Giuseppe Barbaglio — già autore di Paolo di Tarso e le origini cristiane (Cittadella editrice) — ha constatato come Paolo, pur trasformato dall’incontro con il Cristo, non si era in realtà poi riferito alle tradizioni evangeliche se non «in misura trascurabile e su punti di secondaria importanza». Si è invece reso in grado di elaborare «una teologia capace di giustificare l’apertura universalistica della Chiesa». Quello di Israele era, secondo Barbaglio, anch’esso un «universalismo», ma «centripeto», cioè atto a trascinare a sé, al mondo giudaico, donne e uomini provenienti da mondi diversi. Quello di Paolo, invece, era per così dire «centrifugo», cioè «incondizionato». Brillante intuizione, afferma Brizzi, senonché a Barbaglio sembra sfuggire il fatto che quell’universalismo «centrifugo», «in forma persino più aperta, esisteva già con altre coordinate ben prima che a diffonderlo si dedicasse l’apostolo». Il precedente «era rappresentato dall’universalismo romano, nel quale rientrava in realtà, perfettamente partecipe e conscio proprio Paolo». Ed «è la coincidenza tra i due modelli a costituirne la straordinaria novità».
Si avverte qui l’eco della scuola di Santo Mazzarino («un’intelligenza storica superiore», secondo Brizzi) e ogni riferimento va alla sua opera L’Impero romano (Laterza). Quel Mazzarino che ben comprese di che pasta fosse fatto l’universalismo romano in grado di assorbire, in nome del diritto, i popoli via via conquistati. Mazzarino intuì tra i primi l’intero senso di questo discorso e approdò alla conclusione che «nessun cittadino romano ha avuto nella storia dell’impero quell’importanza decisiva che noi dobbiamo assegnare a Paolo».
Rispetto al modello proposto da Mosè, scrive Brizzi, la posizione prediletta da Paolo «era, credo, quella che contemplava la possibilità di un ordine politico sancito da Dio attraverso il suo avallo e inverato come forma visibile attraverso un’autorità che potesse per questo pretendere di essere rispettata». Tale autorità, «dovette pensare Paolo», poteva «identificarsi — fino a che la Chiesa non l’avesse sostituita? — con la forma, pur perfettibile, dell’imperio». Brizzi ritiene «che un gigante del pensiero qual era l’apostolo possa avere antiveduto in parte le smisurate possibilità future offerte dalla soluzione proposta».
Avrebbe dovuto essere però un processo graduale, «che richiedeva un paziente lavorio di secoli» e «un adeguamento delle strutture esistenti», scartando «le scelte estreme del giudaismo». Scelte estreme (qui Brizzi si dice sicuro che Paolo ne fosse via via sempre più «chiaramente presago») che «avrebbero finito per condurre la religione dei padri, con le istanze proprie delle anime che la componevano, quella palestinese e quella della diaspora, ad un mortale confronto con l’universalismo opposto, quello di Roma». La «Legge divina contro quella, umana ma potenzialmente inflessibile dell’Urbe».
Ad ogni modo, quale che ne sia stato il germe originario, l’autore ritiene che «l’idea della Nuova Alleanza — proposta in Paolo ancora prima che nei Vangeli — presenta indiscutibili e suggestivi parallelismi con il gigantesco sistema ideologico su cui si regge la nozione prescelta dal primo degli imperatori». Nell’implicito «connotarsi come civis», quando, nella Lettera ai Romani, «dichiara la sua piena adesione all’impero», Paolo è debitore a quel modello augusteo di una suggestione «forse neppure del tutto inconscia». Paolo aveva intuito, ben prima di dar vita alla sua personale impalcatura della Chiesa nascente, come, per sopravvivere, la nuova fede dipendesse «dall’adesione o almeno dalla capacità di inserirsi in un kosmos ecumenico dominato da Roma». Senza «dapprima turbarlo troppo». Adesione in mancanza della quale «rischiava di perire con il resto di una realtà ebraica che, viceversa, con l’Urbe e le sue leggi andava ponendosi su un’irreparabile rotta di collisione». Lungo questo percorso, come sostiene Giuseppe Zecchini in Storia della storiografia romana (Laterza), Paolo offrirà un formidabile sostegno ideologico alla monarchia, guidandola verso la forma assoluta vagheggiata dalla maggior parte dei Cesari.
E la Chiesa? Giovanni Brizzi precisa che esita «a credere che il genio di Tarso possa avere antiveduto l’evoluzione ultima della sua creatura, la Chiesa». Anche se «le infinite, estreme derive della sua visione dovettero risultare inimmaginabili persino per lui», il suo pensiero «approdò comunque di fatto alla genesi di un edificio millenario, proponendo per la sovranità dimensioni nuove almeno in Occidente». E «destinate a rimanere insuperate a lungo». Molto a lungo.
Quali sono i lati nascosti delle ‘tecnologie di genere’ come pillola contraccettiva, test di gravidanza o ecografia? Tutti questi dispositivi hanno certamente promosso emancipazione e liberazione dai vincoli della ‘natura’. Eppure, hanno anche aperto le porte a nuove e più subdole forme di violenza e discriminazione. In Gender tech Laura Tripaldi racconta gli aspetti più controversi di queste tecnologie e ci invita a riflettere sul loro significato culturale e politico.
Visualizza questo post su Instagram
Gli antifascisti hanno costruito le fondamenta della nuova Italia repubblicana e democratica. Un patrimonio ricco di pensiero, di saperi, di progetti per il futuro…
A distanza di quasi ottant’anni dalla fondazione della Repubblica italiana, democratica e antifascista, il significato del termine antifascismo sembra aver perduto la sua dimensione storica in un uso corrente, troppo spesso improprio, quasi sempre contrapposto a quello di fascismo, anch’esso privato dei suoi specifici contenuti, ma diventato un “marchio” politico di cui fregiarsi a seconda delle circostanze.
 Un oblio già evidente, a metà degli anni Settanta, in una minoranza di giovani, quando antifascismo e fascismo finivano per ridursi a mere etichette in quella lotta per bande, a volte sanguinosa, che ha marcato una delle stagioni più difficili della democrazia italiana.
Un oblio già evidente, a metà degli anni Settanta, in una minoranza di giovani, quando antifascismo e fascismo finivano per ridursi a mere etichette in quella lotta per bande, a volte sanguinosa, che ha marcato una delle stagioni più difficili della democrazia italiana.
Nel periodo ‘92-‘96, in seguito alla traumatica fine di tutti i partiti storici fondatori nel 1945 dell’Italia repubblicana, un intenso dibattito scientifico sulle origini aveva riproposto il discorso sull’antifascismo nel suo significato storico di lievito valoriale alla Carta Costituzionale, rimasta pilastro della continuità istituzionale nella cosiddetta seconda Repubblica. Ancora oggi, lo scontro politico si continua ad alimentare impropriamente di una vicenda storica lontana ormai più di un secolo, col risultato di ignorare il contesto politico, culturale, sociale e internazionale dell’epoca e di cancellare la stessa identità degli antifascisti, diversi gli uni dagli altri nei valori ideologici, morali e politici, ma alla fine uniti per fondare il nuovo Stato democratico. Quando si lamenta l’assenza di impegno civile nelle generazioni più giovani, forse vale la pena riflettere su quanto questa costante rimozione e distorsione della storia abbia contribuito a indebolire i valori repubblicani che i padri antifascisti avevano affermato nel corso della lunga lotta contro il fascismo.
La storia dell’antifascismo va dunque letta come storia dei tanti soggetti antifascisti che hanno combattuto il regime fascista: i partiti antifascisti le cui radici risalivano all’Italia liberale, le nuove formazioni politiche antifasciste, i giovani antifascisti cresciuti nel ventennio che non si riconoscevano nei vecchi partiti, la generazione dei più anziani protagonisti della prima guerra civile del ‘19-‘22, ritornati sulla scena nella seconda guerra civile del ‘43-‘45. Accanto ai militanti c’è poi il mondo della cultura antifascista legata ai valori dell’Italia liberale, e infine la moltitudine di anonimi antifascisti silenti dalle più diverse provenienze politiche e sociali il cui antifascismo si esprime in un gesto, in un insulto, in una scritta sui muri, in un atto sporadico di disobbedienza.
La maggior parte degli studiosi ha dunque fissato nell’8 settembre 1943 l’inizio di un’altra storia, questa sì decisiva per le sorti dell’Italia, trasformata in una democrazia grazie al coraggio e al sacrificio di un intero popolo che finalmente si era ribellato armi in pugno contro i fascisti e i loro alleati tedeschi. Ovviamente aver privilegiato questo campo di ricerca sta anche nel carattere epico della vicenda resistenziale che coinvolge l’intero paese al contrario di quella degli antifascisti, condannati all’esilio, alle carceri, alla clandestinità e resi invisibili agli occhi degli italiani. Eppure la loro scelta antifascista era costata privazioni, sofferenze, ferite profonde, senza contare quante vittime il fascismo aveva lasciato sul terreno nel percorso verso il potere, culminato con la marcia su Roma nel 1922 e proseguito all’insegna della violenza e del terrore fino al consolidamento della dittatura nel 1926. I caduti negli scontri con gli squadristi e i tanti bastonati a morte o assassinati a sangue freddo si contano a migliaia, un numero di sicuro inferiore ai caduti nella resistenza — tra partigiani e civili quasi 50 mila — ma certo non trascurabile.
Nelle ricostruzioni storiche ha pesato questa visione eroica dei partigiani, scesi sul campo di battaglia armi alla mano per combattere finalmente i fascisti alleati dei nazisti e riscattare così agli occhi del mondo l’intero popolo italiano dalla colpa della guerra fascista. Si tratta di una lettura semplificata, risuonata nelle celebrazioni ufficiali e riproposta nei manuali scolastici che poggia SII una storiografia fortemente condizionata dalla dinamica politica del primo cinquantennio repubblicano.
A ridare un equilibrio interpretativo all’intera storia dell’antifascismo, non riassumibile nella fase finale del ‘43-‘45, mi pare si debba ritornare alla definizione di Max Salvadori che in un libro del 1974 ha parlato di “resistenza lunga”, iniziata con le spedizioni punitive degli squadristi nel 1920 e continuata fino al 1945: in questa cornice 1’8 settembre ‘43 «fu solo una tappa, non un punto di partenza».
L’interpretazione di “resistenza lunga” comporta anche una revisione della vulgata corrente, che propone la guerra partigiana come il solo terreno sul quale si va legittimando la futura classe dirigente antifascista della Repubblica democratica. Una legittimazione che si sono guadagnati tutti gli antifascisti nelle diverse fasi e nelle diverse modalità della loro lotta contro il fascismo; a maggior ragione se si considera il ruolo che ricoprono nella nuova Italia tutti i leader dei partiti antifascisti ante marcia — De Gasperi, Nenni, Togliatti, ma anche La Malfa e Saragat e gli esponenti ai vertici del Partito d’Azione (Pda), aderenti alle altre formazioni politiche dopo lo scioglimento del loro partito nel 1947.
La loro legittimazione come futura classe dirigente dell’Italia postfascista nasce da un dibattito sui futuri assetti democratici dello Stato che non può essere circoscritto al confronto aperto nel Cln, dove si consolida l’unità politica degli antifascisti. Il dialogo tra tutti i partiti ciellenisti in questi venti mesi di guerra poggia infatti sul ricco patrimonio di pensiero e di riflessioni maturato dalle forze politiche e dalle singole personalità dell’antifascismo che per anni si sono misurate su quale Stato far nascere dopo il fascismo. Esiliati in terre straniere, socialisti, repubblicani, democratici e liberali avevano fatto i conti con le loro responsabilità, i loro ritardi, la loro cecità su quanto era avvenuto in Italia nel ‘19-‘22, attraverso un’autocritica anche dura, necessaria però a riconsiderare i limiti non solo della loro azione, ma dei rispettivi patrimoni valoriali. Con questa sorta di censura nei confronti di Amendola — un esponente di primo piano del Pci, ma anche un intellettuale che in numerose pubblicazioni ha ricostruito la storia di questo periodo — non si vuole certo ridimensionare i sacrifici della lotta contro il fascismo in esilio e in Italia dei militanti comunisti. Per Mussolini erano i suoi peggiori nemici, contro i quali la repressione in Italia era stata durissima, come testimonia il numero degli aderenti al Pci rinchiusi nelle carceri; un numero superiore a quello degli altri antifascisti. Si intende però sottolineare la peculiarità del loro antifascismo, finalizzato ad abbattere la dittatura fascista per instaurare la dittatura del proletariato. Anche i comunisti lottavano nelle carceri e in esilio per la libertà, ma era lotta per abbattere il regime capitalista identificato con il regime fascista.
La storia dell’antifascismo va dunque letta nella cornice del più sanguinoso periodo storico attraversato dall’Europa, iniziato con la grande guerra del 1914 e terminato con un’altra catastrofe durata sei terribili anni, dal 1939 al 1945; un trentennio di totalitarismi e di conflitti nei quali si era consumata fino quasi a scomparire la stessa civiltà millenaria dell’intero continente. Ritrovare il significato storico dell’antifascismo e ridare identità agli antifascisti significa anche misurarsi con quasi cent’anni di storiografia, se si considerano le tante ricostruzioni sull’avvento al potere di Mussolini scritte negli anni precedenti alla caduta del fascismo. Un percorso di approfondimento sulle diverse fasi di una storia complessa per la quantità e la diversità di soggetti, di luoghi, di valori espressi dagli antifascisti in esilio, nelle carceri, nella lotta clandestina, ma anche nella loro sfera privata, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie e persino nelle organizzazioni fasciste.
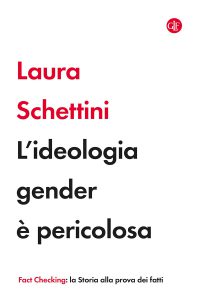 Laura Schettini
Laura Schettini
L’ideologia gender è pericolosa
L’‘ideologia gender’ minaccia la nostra società! Confonde l’identità e le menti dei nostri figli, mette a repentaglio l’ordine naturale delle cose, quello che distingue in maschi e femmine! Ma davvero esiste un progetto globale per renderci tutti ‘fluidi’? Dove nasce l’ossessione per le questioni di genere e gli orientamenti sessuali non conformi? E quali sono le fratture politiche che si nascondono dietro a questi temi?
____________________________
 Laura Tripaldi
Laura Tripaldi
Gender tech
Come la tecnologia controlla il corpo delle donne
Quali sono i lati nascosti delle ‘tecnologie di genere’ come pillola contraccettiva, test di gravidanza o ecografia? Hanno certamente promosso emancipazione e liberazione dai vincoli della ‘natura’, ma hanno anche aperto le porte a più subdole forme di violenza e discriminazione. Laura Tripaldi ne racconta gli aspetti più controversi e invita a riflettere sul loro significato culturale e politico.
____________________________
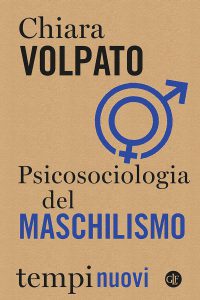 Chiara Volpato
Chiara Volpato
Psicosociologia del maschilismo
nuova edizione
Il maschilismo è ancora tra noi. Irritante e potente, continua a condizionare la nostra vita collettiva. Quali sono i processi psicologici e sociali che sorreggono il fenomeno, frenano il cambiamento e limitano diritti, libertà e creatività delle donne ma anche degli uomini, costretti troppo spesso in ruoli stereotipati?
____________________________
 Chiara Bottici
Chiara Bottici
Nessuna sottomissione
Il femminismo come critica dell’ordine sociale
Il femminismo non è un movimento che ha a che fare solo ed esclusivamente con ‘questioni di donne’. Costituisce, piuttosto, una forma di critica dell’ordine sociale nella sua globalità. Consente di affinare la concezione dell’oppressione attraverso un’analisi dei modi di dominio interiorizzati e di decostruirli.
____________________________
 Chiara Bottici
Chiara Bottici
«O tutte, o nessuno di noi sarà libero». Questo il motto dell’anarca-femminismo. Questa nuova e rivoluzionaria visione vuol dire la liberazione di ogni creatura vivente dallo sfruttamento capitalista e dalla politica androcentrica di dominazione.
____________________________
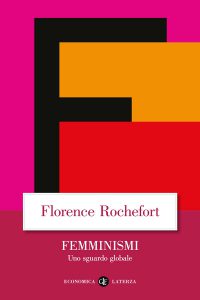 Florence Rochefort
Florence Rochefort
Femminismi
Uno sguardo globale
Dall’Europa all’America Latina, dall’Asia all’Africa, una mappa della storia dei movimenti femministi che negli ultimi duecento anni hanno lottato per la libertà delle donne.
____________________________
 Judith Butler
Judith Butler
Questione di genere
Il femminismo e la sovversione dell’identità
Il libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internazionale e che è divenuto un classico del pensiero di genere. Judith Butler argomenta perché il corpo sessuato non è un dato biologico ma una costruzione culturale.
____________________________

Judith Butler
«Il desiderio è stato considerato filosoficamente pericoloso a causa della sua propensione ad oscurare una visione chiara e a promuovere la miopia filosofica, incoraggiandoci a vedere solo ciò che noi vogliamo e non ciò che è. Il desiderio, in quanto immediato, arbitrario, immotivato e animale, è ciò che dev’essere superato: esso minaccia di indebolire l’attitudine al distacco e all’oggettività che ha condizionato, in modalità alquanto variegate, il pensiero filosofico.»
____________________________
 Cinzia Arruzza – Tithi Bhattacharya – Nancy Fraser
Cinzia Arruzza – Tithi Bhattacharya – Nancy Fraser
Femminismo per il 99%
Un manifesto
Abbiamo bisogno di un femminismo che dia la priorità alle vite delle persone. Oggi che il sistema di valori liberisti è in crisi e stiamo vivendo una nuova ondata femminista internazionale, abbiamo lo spazio per creare un altro femminismo: anticapitalista, antirazzista ed ecosocialista.
____________________________

Paola Columba
“Il femminismo è superato”
Falso!
Dalle battaglie delle femministe ‘storiche’ alle ragazze della youtube generation il punto resta la difesa dei diritti delle donne. Perché vanno difesi ogni giorno e di nuovo conquistati. Non possono mai essere dati per scontati. Le donne lo sanno. Lo sapevano le ragazze di ieri, devono saperlo le ragazze di oggi.
____________________________
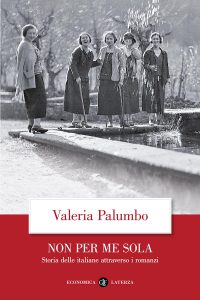 Valeria Palumbo
Valeria Palumbo
Non per me sola
Storia delle italiane attraverso i romanzi
Le opere delle nostre scrittrici – da Ada Negri a Elsa Morante, da Grazia Deledda a Luce d’Eramo, da Matilde Serao a Sibilla Aleramo e Anna Maria Ortese – offrono il racconto di un’epopea sotterranea: quella della battaglia durata più di un secolo per garantire alle donne italiane piena cittadinanza.
____________________________

Emma
Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano
Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l’affitto / chiamare l’idraulico / prendere la pillola / finire quella mail di lavoro / controllare che i tuoi figli abbiano fatto i compiti / caricare la lavatrice. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per caso sai dove sono finite le sue scarpe. Storie esilaranti e tremendamente serie. Un fumetto femminista che ogni donna (e ogni uomo) dovrebbe leggere.
____________________________

Sandra Petrignani
Sandra Petrignani, attraverso alcune delle opere da lei più amate, riesce a costruire un lessico femminile che restituisce le sfumature che il pensiero delle donne è stato capace di assumere quando, traducendosi in parole, ha raccontato il mondo. Michela Marzano, “Robinson – la Repubblica”
____________________________
 Sandra Petrignani
Sandra Petrignani
Fra esercizi di ammirazione e scatti di rabbia, Sandra Petrignani ci porta dentro tante pagine indimenticabili, da Dumas a Roth, da Pavese a Proust, da Calvino a Tolstoj, da Gary a Dostoevskij e a mille altri. Cercando davvero di capirli i maschi, nella scrittura e nella vita, nel coraggio e nella fragilità, nelle ossessioni di cui sono preda. Una scorribanda molto personale e appassionata che ci fa scoprire, come insegna Virginia Woolf, quanto «nella vita come nell’arte i valori delle donne non sono i valori degli uomini» e che esiste, probabilmente, un modo femminile di essere lettore.
____________________________

Daniela Danna
“Fare un figlio per altri è giusto”
Falso!
Spesso la ‘gestazione per altri’ o ‘maternità surrogata’ è presentata come un dono, un atto di liberalità e solidarietà da parte di donne generose che aiutano coppie infertili ad avere figli. Ma le cose stanno davvero così? Siamo consapevoli del fatto che non è una ‘tecnica di riproduzione assistita’, bensì una gravidanza come le altre? È giusto considerare delle donne ‘portatrici’ di figli altrui? È giusto che dei neonati siano dati a ‘genitori committenti’ in cambio di denaro?
____________________________

Catharine A. MacKinnon
Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha sancito a cosa un essere umano ha diritto. Sono passati oltre cinquanta anni e sorge un dubbio: anche le donne sono umane? Catharine A. MacKinnon risponde senza esitazioni. Quel che accade alle donne ha poco a che fare con i diritti umani perché, nonostante i buoni propositi, la società, il diritto e la politica restano maschili e a molte, troppe, donne è negato il dominio di sé.
____________________________

Gisela Bock
Nel quadro di una storia culturale delle relazioni fra i sessi, Gisela Bock descrive la situazione di vita, di lavoro e giuridica delle donne europee dal Medioevo a oggi, i loro ideali e le loro realtà, la loro faticosa lotta per i diritti civili, politici e sociali. E getta uno sguardo colto e appassionato su uno dei più importanti temi della storia europea.
____________________________
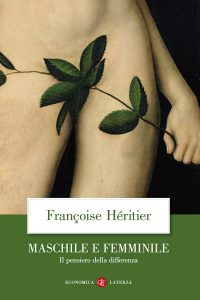
Françoise Héritier
Un classico dell’antropologia contemporanea, uno studio di riferimento per chiunque voglia affrontare oggi il tema della ‘differenza’.
____________________________
 Maria Giuseppina Muzzarelli
Maria Giuseppina Muzzarelli
Madri, madri mancate, quasi madri
Sei storie medievali
Sei storie esemplari di donne del Medioevo e del loro rapporto con la maternità, in un affresco della multiforme condizione femminile che testimonia la capacità di tante donne di reinventare il loro destino.
____________________________

Maria Giuseppina Muzzarelli
Nelle mani delle donne
Nutrire, guarire, avvelenare dal Medioevo a oggi
Madri, seduttrici, mogli, sante, streghe, guaritrici, assassine: donne che si fanno latte per il figlio, che seducono, curano, nutrono, uccidono con il cibo, sono educate alla sua moderazione, se ne privano. Una relazione, quella fra le donne e il cibo, che a tutti pare di conoscere e che invece è stata ed è molto più sfaccettata, mossa e contraddittoria di quanto comunemente si creda.
____________________________
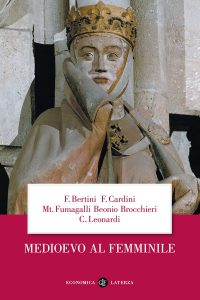
Ferruccio Bertini – Franco Cardini – Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri – Claudio Leonardi
Egeria la pellegrina, Baudonivia la biografa, Dhuoda la madre, Rosvita la poetessa, Trotula il medico, Eloisa l’intellettuale, Ildegarda la profetessa, Caterina la mistica: otto ritratti biografici e letterari tanto più avvincenti in quanto rappresentativi ciascuno di un diverso itinerario umano e sociale. Mai come in questo volume è stato messo in luce così chiara il molteplice, enigmatico, affascinante volto della donna medievale.
____________________________

a cura di Ottavia Niccoli
Attraverso significative figure di donne di estrazione e culture diverse – una grande signora, una strega, la compagna di due banditi, una monaca riverita e una «esorcizzata», una prostituta, una mistica – si delinea una prospettiva inconsueta dell’Italia dell’Umanesimo e della Controriforma.
[Nell’intenzione di offrire un contributo alla discussione di una vicenda così difficile da comprendere in tutte le sue componenti, abbiamo rivolto alcune domande ad autori della casa editrice e studiosi competenti delle diverse questioni implicate nel conflitto in corso.
La situazione cambia di giorno in giorno e nuovi elementi potranno integrare l’analisi.
Dopo gli interventi di Anna Foa, Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Claudio Vercelli, Arturo Marzano e Ignazio De Francesco, pubblichiamo il contributo di Sarah Parenzo. Traduttrice, ricercatrice e pubblicista, vive da vent’anni in Israele dove ha conseguito un Ph.D sui risvolti etici e psicoanalitici della ricezione dello scrittore Abraham B. Yehoshua in traduzione italiana.
Corrispondente de Il manifesto e dei ticinesi Azione e Naufraghi per le pagine di cultura e politica estera, da un decennio collabora stabilmente con il servizio pubblico israeliano di riabilitazione psichiatrica.]
Israele- Palestina: un conflitto catalizzatore di alterità.
Trascorsi quasi cinque mesi dal sette ottobre è evidente che solo un approccio multidisciplinare può consentire allo spettatore impotente della tragedia che si consuma in Israele-Palestina di reggerne la complessità, rifuggendo dicotomie e semplificazioni.
Il presente contributo propone di adottare, come punto di osservazione sul conflitto, il complesso prisma della salute mentale.
Negli anni sono stati pubblicati numerosi studi di psichiatria e psicoanalisi sui drammatici effetti dell’occupazione, molti dei quali riportano dati allarmanti sul degrado della salute mentale dei palestinesi, a cominciare dai minori, sottoposti ad uno stress costante in condizioni di miseria, paura, impotenza e frustrazione.
Tuttavia, come ha sottolineato anche il gruppo Psychoactive (Mental Health Professionals for Human Rights) che fornisce supporto psicologico agli attivisti, anche la società israeliana, seppure con le debite asimmetrie, paga un prezzo alto a causa delle proprie politiche. Non a caso negli ultimi mesi, mentre i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania sono impegnati nella lotta per la sopravvivenza, nello stato ebraico è in corso una vera e propria “emergenza salute mentale” e i servizi pubblici sono al limite del collasso.
A poche ore di distanza dai massacri del sette ottobre, psichiatri e psicoterapeuti si sono mobilitati in massa su base volontaria per fornire supporto ai superstiti, recandosi con generosità nelle strutture alberghiere destinate ad ospitare gli sfollati. Il tentativo, effettuato nelle settimane successive, di passare la palla alle istituzioni non ha fatto che sottolineare l’inadeguatezza del sistema, già sul banco degli imputati per infinite ragioni, anche in questo settore.
Alcuni anni fa era entrata in vigore una riforma che mirava ad alleggerire gli ospedali psichiatrici intasati, rafforzando la gamma di servizi di salute mentale fruibili attraverso le aziende sanitarie semi-privatizzate. Ma l’esperimento non è andato a buon fine, nelle strutture manca infatti personale e quello che c’è è oberato e sottopagato, mentre, come in un girone dantesco, le file dei pazienti si ingrossano ogni giorno che passa. La corsia preferenziale va naturalmente ai superstiti dei massacri, agli sfollati e ai parenti delle vittime e degli ostaggi, ai quali si aggiungono via via gli ostaggi liberati e i soldati che tornano da Gaza feriti nel corpo e nell’anima. Poi ci sono le vittime del cosiddetto “trauma secondario”, come i fruitori dei video shock diffusi in rete da Hamas, ma anche i telespettatori dei canali televisivi israeliani che 24 su 7 trasmettono quasi solo notizie sulla guerra riproponendo all’infinito le storie di morti e ostaggi. Esausti sono anche gli attivisti ebrei perennemente minacciati e censurati per le espressioni di dissenso politico, alcuni dei quali fungono da guardiani dei palestinesi quotidianamente assaliti dai coloni nel West Bank, piuttosto che i palestinesi di cittadinanza israeliana allontanati dai posti di lavoro e dalle università, perseguitati e arrestati per minime manifestazioni di empatia nei confronti dei civili inermi di Gaza. Un posto va anche alle migliaia di manifestanti divorati dalla rabbia per le mancate dimissioni di Netanyahu, il cui governo ha trascinato il paese in un baratro senza precedenti, ma la lista potrebbe continuare passando per i cittadini che lavoravano nel turismo o in uno degli altri settori stroncati dalla guerra, o per quelli che avevano investito i loro risparmi nelle località di confine a nord o a sud, inagibili a causa del pericolo. Poi ci sono quelli che si dibattono nella scelta di abbandonare la madrepatria in cerca di lidi migliori dove, tuttavia, troveranno ad accoglierli i fantasmi della Shoah, il vecchio antisemitismo e le nuove accuse di genocidio. Infine tutti temono di venire centrati dal prossimo missile o di trovarsi coinvolti in uno degli attentati che si fanno sempre più frequenti, e sempre tutti saltano in aria al minimo rumore e hanno i nervi a pezzi e gli occhi stanchi di chi legge continuamente le notizie sui dispositivi elettronici, in cerca di presagi di un futuro ancora troppo incerto.
Incapace di far fronte alla richiesta, il Ministero si barcamena tra linee telefoniche di pronto soccorso emotivo, terapie farmacologiche e interventi psicoterapeutici di breve durata, mentre elargisce generosamente corsi di formazione per la prevenzione della sindrome post-traumatica da stress di cui il sistema stesso è in buona parte l’artefice: cerotti per una vera e propria emorragia.
Ma il disagio psichico della società israeliana è anche lo specchio di meccanismi di difesa molto più profondi fino ad ora sepolti in un vaso di Pandora che i miliziani di Hamas, con i loro atti al limite dell’umano, hanno scoperchiato. Il malessere è il prezzo di una vita non autentica, vissuta in una bolla di denial alimentata dalle narrative della hasbarà, “l’advocacy israeliana”, e dalla censura dei media che non trasmettono nulla di quanto accade dall’altra parte del muro. L’israeliano medio, compresi i membri della cosiddetta sinistra liberale, assidui manifestanti alle proteste del 2023, ha scelto più o meno consapevolmente, di ignorare le insidie dell’occupazione, pensando ingenuamente che l’uso della forza potesse risolvere tutto, sostituendosi ad una soluzione politica definitiva. Questo è il prezzo di culture che accettano processi di esclusione come giusti e inevitabili, e che mettono in atto forme di dominio e tecniche pervasive di espropriazione e controllo. Forte dei miti che la sostengono, difficilmente una società ambigua o assuefatta alla malafede, sarà toccata dal dubbio, preferendo relegare e oggettivare gli elementi di disturbo. Ma il sette ottobre gli israeliani non hanno toccato con mano solo la fragilità del loro paese, bensì hanno incontrato l’Altro, quel vicino che hanno volutamente reso invisibile, nella sua esplosione di furia. E benché l’ego faccia del proprio meglio per riprendere il controllo reimmergendosi nella quotidianità, non bastano lo slogan della propaganda che recita “insieme vinceremo”, nè le arringhe di Netanyahu che promette di annientare Hamas, per rassicurare l’inconscio che ormai percepisce chiaramente la minaccia di disgregazione, fonte di angoscia profonda.
Ma gli altri restano celati, oscuri e indecifrabili nella misura in cui risiede in noi un alter ego incomprensibile, e ciò vale anche per gli spettatori terzi di questo scontro, la cui aggressività si traduce ora in antisemitismo, ora in islamofobia, due volti malsani di un’Europa che non ha mai saputo fare i conti con l’alterità che la abita.
Quello tra Israele e Palestina, è dunque uno scontro che sconfina il territorio, catalizzando l’Alterità presente in ognuno di noi. Ma come direbbe lo psichiatra Franco Basaglia, studioso di Fanon e grande esperto di alterità e colonialismi, la sfida va giocata sul terreno della pratica, mantenendo aperte le contraddizioni e accettando di affrontare la crisi identitaria che un cambio di logica del potere, in nome del principio di libertà, non può che comportare.
Non si tratta infine di giustificare, bensì di meglio comprendere i meccanismi di difesa e la fragilità dell’altro, riconoscendone i traumi e ascoltandone la storia nella sua versione dei fatti. Questo è ciò che possiamo fare mentre i grandi firmano trattati per il rifornimento di armamenti: sospendere il giudizio, anche quando il sistema nervoso è pronto a saltare, e tendere l’orecchio e il cuore verso l’altro, armandoci di un ascolto paziente e rispettoso, come quello suggerito nei sui scritti dalla psicoanalista Luciana Nissim Momigliano, ebrea e partigiana deportata ad Auschwitz con Primo Levi e, come lui, sopravvissuta.
Alfonso Venturini | Archivio Storico Italiano | dicembre 2023
Pier Giorgio Zunino | Gadda, Montale e il fascismo
Il volume ripercorre le vicende biografiche di due fra i maggiori scrittori e poeti del Novecento italiano, i quasi coetanei Carlo Emilio Gadda, nato nel 1893, ed Eugenio Montale di tre anni più giovane, focalizzandosi sul loro rapporto con il fascismo.
 Perché Gadda e Montale? I due scrittori praticamente non si sono mai incrociati e rari sono i punti di contatto: la collaborazione con la rivista a «Solaria», la frequentazione e conoscenza da parte di Montale del cugino di Gadda, Piero Gadda Conti, e infine il Gabinetto Vieusseux: entrambi gli scrittori sono stati in predicato di assumere la direzione della prestigiosa istituzione fiorentina. Nel 1929 il dimissionario Bonaventura Tecchi sceglie come suo successore Gadda che, però, rinuncia. Come direttore allora viene scelto Montale, che ricopre l’incarico fino al 1938.
Perché Gadda e Montale? I due scrittori praticamente non si sono mai incrociati e rari sono i punti di contatto: la collaborazione con la rivista a «Solaria», la frequentazione e conoscenza da parte di Montale del cugino di Gadda, Piero Gadda Conti, e infine il Gabinetto Vieusseux: entrambi gli scrittori sono stati in predicato di assumere la direzione della prestigiosa istituzione fiorentina. Nel 1929 il dimissionario Bonaventura Tecchi sceglie come suo successore Gadda che, però, rinuncia. Come direttore allora viene scelto Montale, che ricopre l’incarico fino al 1938.
Se, quindi, la scelta di raccontare in parallelo, con una specie di montaggio alternato per utilizzare il linguaggio filmico, Gadda, «il sommo scrittore» per Zunino (p. 187), e Montale è forse dettata all’autore semplicemente da una predilezione letteraria, la diversità caratteriale e le differenti posizioni politiche dei due grandi scrittori fanno sì che le due figure siano quasi complementari e, proprio per ciò, finiscono per essere rappresentative di gran parte della società del tempo. Gadda è uno studente brillante che dopo la laurea in ingegneria coltiva anche, mentre sta già lavorando, l’idea di laurearsi in filosofia e, a tal fine, diviene allievo di Piero Martinetti. Montale, invece, è uno studente svogliato e indolente che a malapena consegue un diploma in materie economiche e che ha il suo primo lavoro a trentatré anni quando diviene direttore del Vieusseux.
Agli opposti caratteri corrispondono anche diverse opinioni politiche. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, Gadda è un fiero nazionalista e, quindi, un convinto combattente, mentre Montale va in guerra a malincuore ma, nonostante ciò, fa a pieno il suo dovere di soldato. Gadda aderisce subito al fascismo iscrivendosi nel 1921, Montale, inizialmente tiepido, ne prende le distanze già nel 1923. Nel 1925 il poeta sottoscrive il manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce ma continua sostanzialmente a non interessarsi e a non impegnarsi in politica: lui stesso si definisce «bigio», intendendo con ciò di essere ben distante da qualsiasi parte politica. Montale non si è mai iscritto al PNF ma, come molti italiani, in occasione della guerra d’Etiopia si allinea e approva la politica coloniale del regime apprezzando convintamente la retorica del «posto al sole». Inoltre, nel 1938, nel tentativo di salvaguardare il suo posto di direttore al Gabinetto Vieusseux, chiede la tessera del partito che gli viene rifiutata. Pure Gadda ritorna in piena consonanza con il regime per la politica estera condividendo appieno il sentimento anti-inglese e di rivalsa nel Mediterraneo dopo che, alla fine degli anni Venti, ha vissuto un periodo di disillusione nei confronti del fascismo. Dalla fine degli anni Trenta, la loro visione politica converge: entrambi percepiscono come il regime mussoliniano stia andando verso un sostanziale fallimento ed esprimono, sia pure privatamente, il loro dissenso (p. 374).
Da questo sintetico excursus si evince come le loro posizioni siano rappresentative di quelle assunte nel corso del ventennio da una grande parte della popolazione, offrendo uno spaccato esemplare e composito della società italiana. L’autore ricostruisce le due vite illustri grazie a ricerche d’archivio, uno studio di una imponente bibliografia e di epistolari che ci permettono, ed è un ulteriore merito del volume, di conoscere anche alcune persone a loro vicine, fra le quali spicca per intelligenza, personalità e cultura Marianna, una delle sorelle maggiori di Montale. Proprio per il poeta ligure, molte informazioni sono desunte dalla ricca corrispondenza intercorsa fra lui e la giovane studiosa americana Irma Brandeis, di cui è stato innamorato.
In chiusura, una curiosità suscitata dai passaggi di queste lettere citati nell’opera: dato che Montale scrive in inglese in maniera velata, quasi in codice, per ingannare l’occhiuto controllo poliziesco (un esempio di questo strano linguaggio a p. 329), non si può non chiedersi quanto la giovane studiosa americana riuscisse a comprendere effettivamente di quello che le scriveva il poeta riguardo la situazione italiana.
[Nell’intenzione di offrire un contributo alla discussione di una vicenda così difficile da comprendere in tutte le sue componenti, abbiamo rivolto alcune domande ad autori della casa editrice e studiosi competenti delle diverse questioni implicate nel conflitto in corso.
La situazione cambia di giorno in giorno e nuovi elementi potranno integrare l’analisi.
Dopo gli interventi di Anna Foa, Marcello Flores, Giovanni Gozzini, Claudio Vercelli e Arturo Marzano, pubblichiamo il contributo di Ignazio De Francesco. Monaco e islamologo, membro della Piccola Famiglia dell’Annunziata, fondata da Giuseppe Dossetti, ha vissuto lungamente in Medio Oriente, tra Israele, Palestina, Siria, Libano, Giordania ed Egitto. Di Maher Charif ha curato l’edizione italiana di Storia del pensiero politico palestinese (2018) e I nodi irrisolti del pensiero arabo: Palestina, riformismo, Jihad (2022).]
Giustizia per la pace, e da qui il perdono
Seduto di fronte a Maher Charif (uno dei migliori storici palestinesi) nel suo studiolo al secondo piano dell’Institut français du Proche-Orient di Damasco, lo sfido a riassumere in una sola frase cento anni di storia del suo popolo. Risponde senza esitare: «Al-intiqāl min kāritha ilā ukhrā», letteralmente “il passaggio da un disastro all’altro”. Poi aggiunge: «Malgrado ciò il nostro popolo non se n’è andato. Anzi, cresce più degli israeliani, forse l’unica cosa concreta che dice che la nostra storia là non è finita». Da quel dialogo sono passati quasi venti anni, un tempo di tragica conferma delle sue parole: disastro dopo disastro, fino allo tsunami di violenza abbattutosi sulla Striscia di Gaza dopo il crimine orribile del 7 ottobre.
Allo stesso tempo, il ventennio trascorso conferma l’osservazione finale: per Cisgiordania e Gaza le statistiche più aggiornate forniscono una cifra di poco inferiore ai 5 milioni e mezzo di persone (erano 1,98 nel 1990), con un tasso di crescita annuale intorno al 2,5%. Vanno aggiunti i palestinesi cittadini di Israele, valutati in circa 2 milioni. Per quanto riguarda gli ebrei israeliani, gli ultimi rilevamenti forniscono il numero di 7,2 milioni, con un tasso di crescita leggermente al disotto del 2%. Ciò significa che una regione poco più grande della Sicilia ospita oggi una quindicina di milioni di abitanti, quasi equamente distribuiti tra ebrei e palestinesi. È dunque la demografia ad affermare, nel modo più semplice e diretto, che questa terra è Casa di due popoli. Come realizzarne la convivenza pacifica, per il bene di entrambi e del mondo intero?
La risposta è al tempo stesso semplice e ardua: non c’è pace senza giustizia. Il diritto di Israele all’esistenza e allo sviluppo è la metà esatta di questa giustizia, ha fondamento giuridico nella Risoluzione ONU 181 del 29 novembre 1947, mentre il fondamento morale è la sofferenza bimillenaria del popolo ebraico, sino al culmine della Shoah, crimine maturato e perpetrato – è bene ricordarlo – in Occidente. Proprio l’ingiustizia lungamente patita investe gli ebrei anche di un’alta missione globale: farsi autorevoli portavoce del diritto dei popoli all’autodeterminazione, pietra di fondazione della comunità internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. Che cosa ostacola l’esercizio di questo altissimo mandato etico nei confronti dei coinquilini palestinesi?
Segnalo due possibili cause: la prima è la tentazione di prendersi tutto, privilegiando il diritto della forza alla forza del diritto. L’occupazione militare di Cisgiordania e Gaza, a partire dal 1967, è emblematica: sempre più i palestinesi vivono come sospesi nel vuoto, per l’azione congiunta di esercito e coloni in territori che giuridicamente non appartengono a Israele. Un altro fattore è il senso di pericolo che serpeggia nella coscienza collettiva israeliana, tuttora segnata da “antiche ferite” nel rapporto con l’Altro. I palestinesi, che nessuna responsabilità hanno delle secolari persecuzioni di marca europea, riacutizzano il timore di una minaccia incombente. Eventi come la strage del 7 ottobre provocano la riemersione potente di questa corrente profonda.
L’approccio a un nodo tanto delicato non può così eludere anche l’analisi critica della travagliata evoluzione del pensiero politico palestinese: dal rifiuto iniziale a qualsiasi progetto di partizione (con la sola eccezione della componente comunista), sigillato con il fatale “no” alla Risoluzione ONU 181/1947, a “lā hudūd wa-lā yahūd” (nessun confine e nessun ebreo), grido di battaglia dei decenni successivi, dominati dall’idea che il fucile fosse l’unico strumento di interazione con l’Altro, per distruggerne la kiyān (“entità”) estranea e coloniale. Non si può omettere di notare, con il senno di poi, come questa opzione militare abbia fatto perdere vent’anni preziosi, dal ’48 al ‘67, durante i quali l’edificazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza sarebbe stata possibile, vicini arabi permettendo. Si giunge infine a “Terra contro Pace”, idea di compromesso che ha rappresentato una reale apertura e un significativo cambio di rotta ideologico. Gli accordi di Oslo del 1993 ne sono stati il frutto tangibile. Ma l’equilibrio di forze era ormai troppo dispari e l’avanzata inarrestabile dell’occupazione ha dato nuovo vigore al “fronte del rifiuto”, incarnato da Hamas, nella cui ideologia si trova che l’intera Palestina è un Waqf, proprietà sacra da custodire intatta sino al giorno del giudizio. Questa corrente di pensiero, speculare a quella del sionismo religioso, può nutrirsi di detti apocalittici attribuiti al Profeta dell’islam, come il seguente hadith, particolarmente impressionante: «Non giungerà l’Ora sino a quando non combatterete con gli ebrei, e persino la pietra dietro la quale l’ebreo si nasconde dirà: Oh musulmano, c’è un ebreo dietro di me, uccidilo!».
Come uscire da questo circolo di inimicizia sino alla distruzione reciproca? La risposta giusta è ancora nelle undici parole scolpite dalla comunità internazionale nella Risoluzione n. 181: «Indipendent Arab and Jewish States … shall come into existence in Palestine». Israele ha avuto ciò che le spetta, i palestinesi non ancora. Qui sta la chiave della pace, che aprirà la porta a un traguardo più alto di quello rappresentato dalla sola giustizia: il perdono. Come infatti ci ha insegnato Desmond Tutu, non c’è futuro senza perdono reciproco.