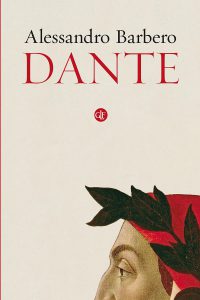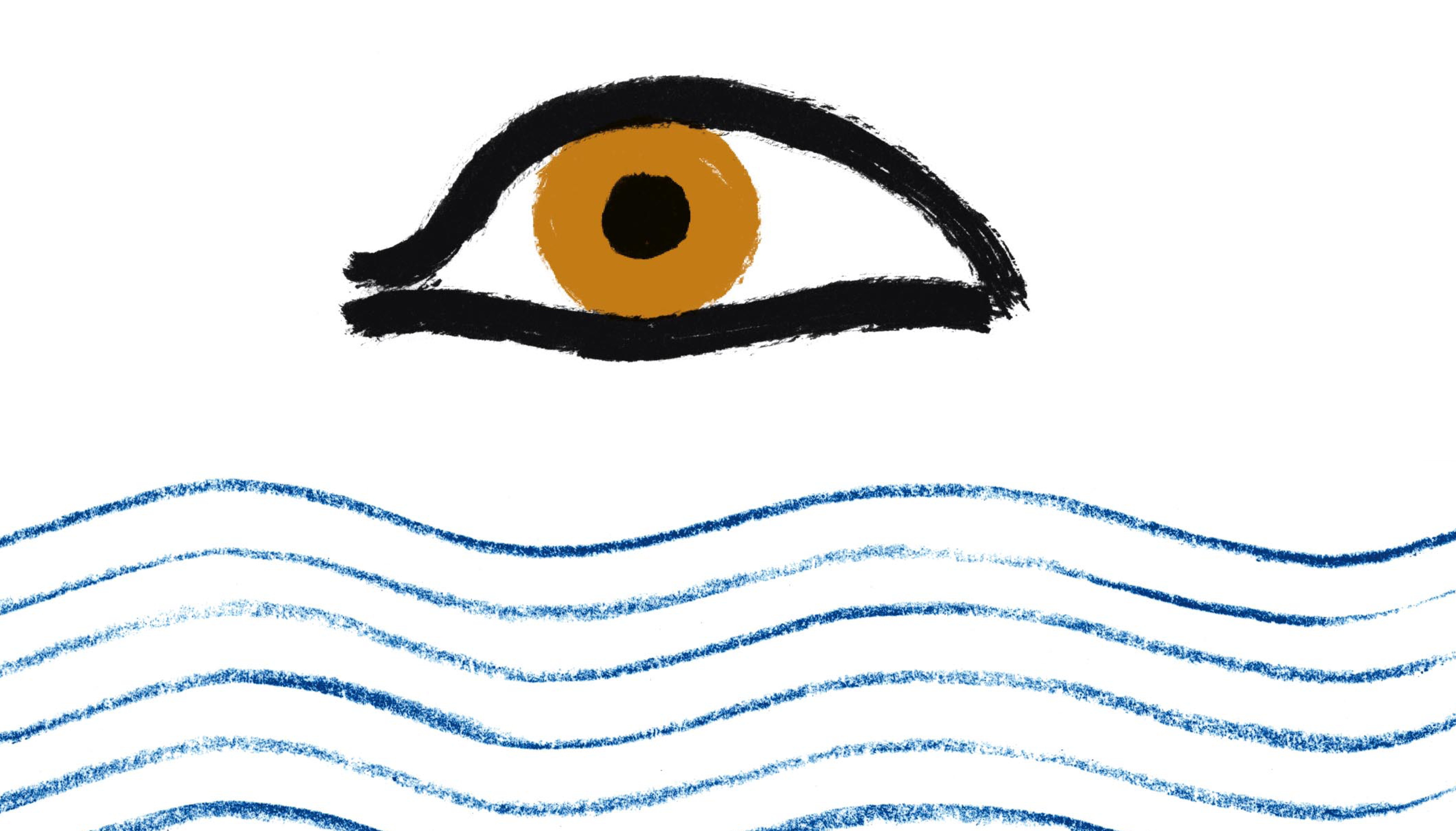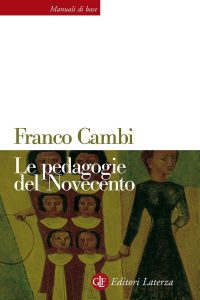Alessandro Barbero racconta Dante
Alessandro Barbero disegna un ritratto di Dante a tutto tondo, come uomo del suo tempo di cui condivide valori e mentalità, avvicinando il lettore alle consuetudini e ai costumi di una delle più affascinanti epoche della storia: il Medioevo.
Ecco dunque, in questa serie di video, le parole di Barbero a raccontare il mondo di Dante attraverso cinque particolari chiavi di lettura: i suoi antenati, la politica, ma anche gli amici, l’amore, la guerra.
Dante e gli antenati
“Il papà non era cavaliere, il papà era un uomo d’affari, un usuraio. Il nonno stessa cosa, il bisnonno non se ne sa molto. Ma il trisnonno? A Dante bambino in casa di sicuro hanno raccontato: “Il trisnonno era cavaliere!”, “Lo ha fatto cavaliere l’imperatore!”, “È andato alle crociate!”. Ci sarà qualcosa di vero? Noi non lo sappiamo. Ma di sicuro era questo che si raccontava in casa Alighieri.”
Dante e la politica
“Ebbene, il suo viaggio nell’oltretomba è collocato tra il marzo e l’aprile dell’anno 1300, cioè nel momento in cui lui era immerso fino al collo nella politica fiorentina […]. Insomma, non andiamo forse tanto lontano dalla verità dicendo che Dante, quando scrive la Commedia, sta anche pensando che se avesse continuato a far politica in quella città rischiava davvero di dannarsi l’anima.”
Dante e gli amici
“Avere tanti amici, per Dante, come per chiunque a quell’epoca, ha voluto dire anche sperimentare il dolore della morte delle persone care. Perché si moriva spesso, si moriva facilmente, si moriva giovani. Quando Dante scrive la Commedia, tanti dei suoi amici di giovinezza sono già morti. E lui fa di tutto per incontrarli nell’altro mondo.”
Dante e l’amore
“Dante per anni ha sognato Beatrice senza più rivederla. E poi la rivede: son sui diciotto anni, tutti e due. La incontra per la strada. Hanno più o meno la stessa età, lei un pochino più giovane, però la loro condizione sociale è cambiata enormemente. Perché Dante […] è pur sempre un adolescente, forse brufoloso, certo imbranato – perché lo racconta lui che era imbranato – e incontra per la strada Beatrice, che invece, alla stessa età, è una donna sposata […]. La incontra per la strada, lei è con altre gentildonne, più anziane, e lui quando vede che c’è Beatrice che gli viene incontro va nel panico, “io cercavo di non farmi vedere”. E invece lei lo vede, e lo riconosce, e lo saluta. E a lui sembra di toccare il cielo con un dito.”
Dante e la guerra
“Ci riesce difficile immaginare Dante a cavallo, con la cotta di maglia di ferro addosso, col grande elmo calato a nascondergli tutta la faccia e il nasone […]. Eppure Dante in vita sua ha indossato l’armatura e imbracciato lo scudo molto più spesso di quanto non gli sia capitato di mettersi in testa una corona d’alloro – cosa che probabilmente nella realtà non gli è capitata mai.”
Scopri il libro:
Andrea Marcolongo racconta “La lezione di Enea”

“Quella dell’Eneide è la storia dell’essere umano in quanto tale, con tutta la fatica che è richiesta per vivere e per esserlo. Quante energie si possono spendere per tutto questo? Quante volte è dato, in una singola esistenza, di restare delusi e di dover reagire? Esiste un fallo che segna il limite, un contraccolpo non plus ultra, una caduta dopo la quale è concesso di non reagire più? Nell’Eneide questa storia non è affatto quella divina di Enea. È la storia umana e poetica di Virgilio.”
Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo deporre Iliade e Odissea e affrettarci a riprendere in mano l’Eneide. Andrea Marcolongo ci fa scoprire l’essenza vera di Enea. L’eroe che cerca un nuovo inizio con in mano il bene più prezioso: la capacità di resistere e di sperare.
Una lezione attualissima.
Andrea Marcolongo racconta La lezione di Enea in un video illustrato da Luca Ralli.
Scopri il libro:
Stefano Mancuso racconta “La pianta del mondo”

“Ogni volta che si racconti una storia che riguarda la vita su questo pianeta, è impossibile che le piante non siano protagoniste.”
Le piante costituiscono la nervatura, la mappa sulla base della quale è costruito l’intero mondo in cui viviamo. Non vederla, o ancora peggio ignorarla, credendo di essere al di sopra della natura, è uno dei pericoli più gravi per la sopravvivenza della nostra specie.
Stefano Mancuso racconta La pianta del mondo
Scopri il libro:
Manuali di base – Politica
Politica comparata
Introduzione alle democrazie contemporanee
Sergio Fabbrini
Edizione: 2008, VI rist. 2021 | Pagine: 242
Storia politica della Repubblica. 1943-2006
Partiti, movimenti e istituzioni
Simona Colarizi
Edizione: 2007, XIII rist. 2021 | Pagine: 324
Manuali di base – Pedagogia
 Manuale di storia della pedagogia
Manuale di storia della pedagogia
Franco Cambi
Edizione: 2003, XXVI rist. 2021 | Pagine: 400
Le pedagogie del Novecento
Franco Cambi
Edizione: 2005, XXI rist. 2021 | Pagine: 234
Manuale di pedagogia e didattica
Franco Frabboni – Franca Pinto Minverva
Edizione: 2013, VI rist. 2019 | Pagine: 400
Introduzione alla pedagogia generale
Franco Frabboni – Franca Pinto Minverva
Edizione: 2003, XX rist. 2021 | Pagine: 304
Manuale della valutazione scolastica
Gaetano Domenici
Edizione: 2003, XIV rist. 2020 | Pagine: 206
Manuali di base – Psicologia
 Storia della psicologia
Storia della psicologia
Dal Novecento a oggi
Luciano Mecacci
Edizione: 2019, II rist. 2020 | Pagine: 536
Introduzione alla storia della psicologia
Carmela Morabito
Edizione: 2007, VIII rist. 2021 | Pagine: 250, con ill.
La psicologia sociale
Processi mentali, comunicazione e cultura
Giovanna Leone – Bruno M. Mazzara – Mauro Sarrica
Edizione: 2013, IX rist. 2021 | Pagine: 272
Psicologia dinamica
I modelli teorici a confronto
Alessandra De Coro – Francesca Ortu (a cura di)
Edizione: 2010, XIII rist. 2021 | Pagine: 422
Manuali di base – Linguistica
 Introduzione alla linguistica italiana
Introduzione alla linguistica italiana
Alberto A. Sobrero – Annarita Miglietta
Nuova edizione in uscita a settembre
Edizione: 2006, XVI rist. 2020 | Pagine: 276, con ill.
Fondamenti di sociolinguistica
Gaetano Berruto
Edizione: 2003, XII rist. 2019 | Pagine: 272
Manuale di semiotica
Ugo Volli
Edizione: 2003, XIX rist. 2020 | Pagine: 336
Manuali di base – Geografia
Spazi e poteri
Geografia politica, geografia economica, geopolitica
Claudio Cerreti – Matteo Marconi – Paolo Sellari
Edizione: 2019, II rist. 2020 | Pagine: 440, con ill.
Manuale di geografia culturale
Alessandra Bonazzi
Edizione: 2011, VI rist. 2021 | Pagine: 204
Manuali di base – Sociologia,
Scienze della Comunicazione
 Media digitali
Media digitali
La storia, i contesti sociali, le narrazioni
Gabriele Balbi – Paolo Magaudda
Nuova edizione in uscita a settembre
Edizione: 2021 | Pagine: 256
 Introduzione alla sociologia
Introduzione alla sociologia
Le teorie, i concetti, gli autori
Antonio Santambrogio
Nuova edizione
Edizione: 2019, IV rist. 2020 | Pagine: 320
Processi e trasformazioni sociali
La società europea dagli anni Sessanta a oggi
Loredana Sciolla (a cura di)
Edizione: 2009, III rist. 2016 | Pagine: 398
Manuale di sociologia della cultura
Franco Crespi
Edizione: 2003, III rist. 2019 | Pagine: 250
Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale
Sara Bentivegna – Giovanni Boccia Artieri
Edizione: 2019, VI rist. 2021 | Pagine: 280
Manuale di sociologia della comunicazione
Marino Livolsi
Edizione: 2011, III rist. 2020 | Pagine: 348
Sociologie della comunicazione
Alberto Abruzzese – Paolo Mancini
Edizione: 2007, VII rist. 2020 | Pagine: 304
Manuale di giornalismo
Alessandro Barbano
Edizione: 2012, IX rist. 2021 | Pagine: 310
Manuale di semiotica
Ugo Volli
Edizione: 2003, XIX rist. 2020 | Pagine: 336

Manuale di comunicazione pubblica
Paolo Mancini
Edizione: 2002, VIII rist. 2018 | Pagine: 254