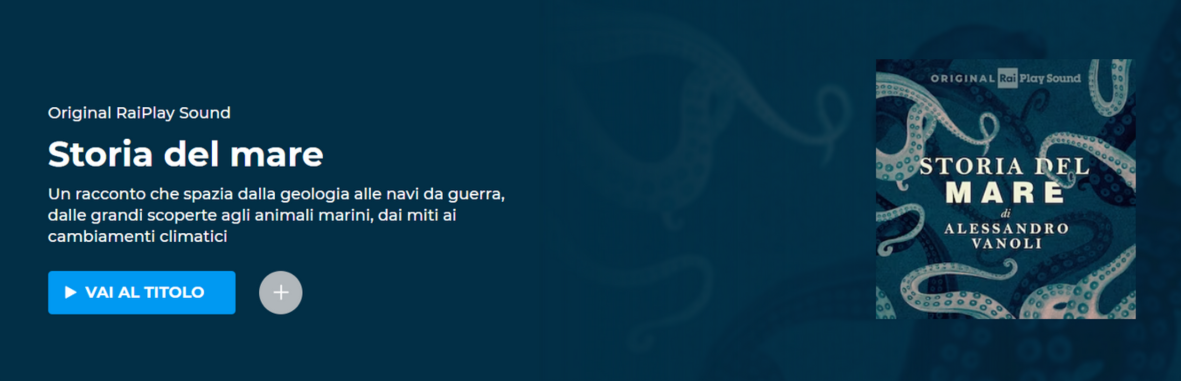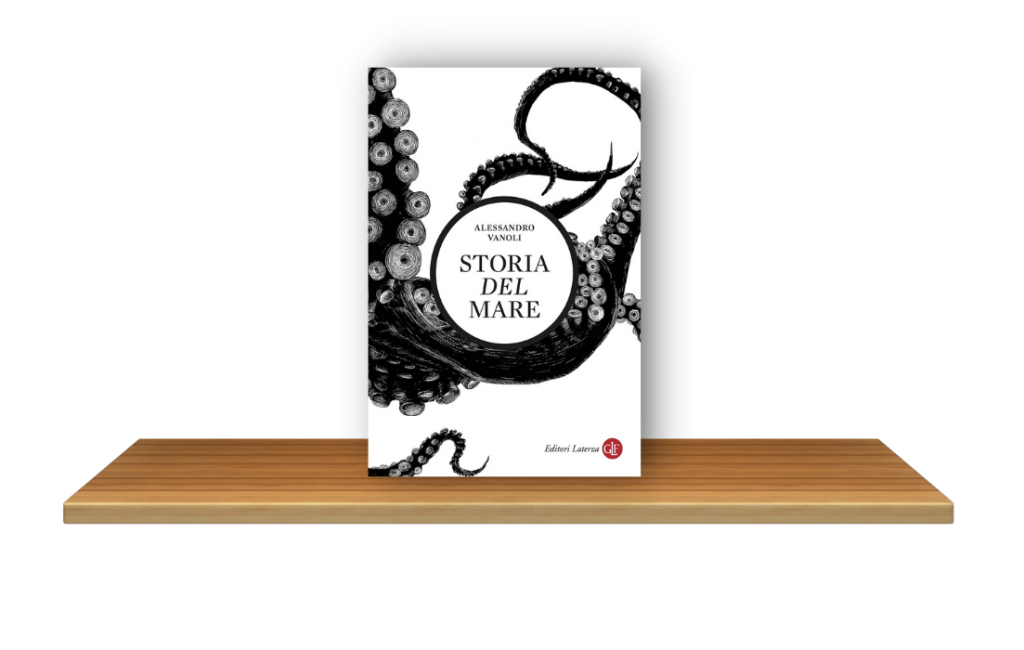Alberto Fraccacreta | Alias | 3 settembre 2023
In Eros e Priapo la posizione di Carlo Emilio Gadda su Mussolini è abbastanza chiara: il «kuce» è variamente appellato «scacarcione sifoloso», «spiritato basedòwico», «provolone imbischerito», «Maccherone Ingrognato», «Batrace luetico» e via dicendo. Lo stesso Ventennio coincide, per l’Ingegnere, con una sorta di catabasi, descensus ad inferos, in cui è sprofondato il paese guidato dal «Caino Giuda Maramaldo»: la fumea caliginosa si alza e vibra anche nel Maradagàl di Gonzalo Pirobutirro o nella Roma dell’«ubiquo ai casi» don Ciccio Ingravallo. Scenario stigio – simile a un luttuoso stampo annidato nell’inconscio collettivo – che avvolge persino la Firenze della Primavera hitleriana di Eugenio Montale: là «un messo infernale» si aggira con «i mostri nella sera l della loro tregenda», mentre comincia a riaffacciarsi la sperata palingenesi, il «respiro di un’alba» «bianca ma senz’ali di raccapriccio», donata dal sacrificio cristiano-cliziano.
 Gadda e Montale avevano vissuto sul campo, con spirito patriottico, la Grande Guerra: lo scrittore fu fatto prigioniero sull’Isonzo e deportato a Celle; il poeta ebbe il ruolo di sottotenente in Valmorbia, «terra dove non annotta». Ma qual era stato il loro atteggiamento nei confronti del fascismo, nella successiva epoca dello «spasimo bellicista»? Di stentorea condanna, si è detto, soprattutto nel biennio 1938-1939, con qualche vacillamento agli albori. E dunque con un’avversione conquistata nel tempo. Sul modello dei parallelismi plutarchei Pier Giorgio Zunino, già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino, ricostruisce in Gadda, Montale e il fascismo le analoghe vicende del lombardo e del genovese, raccontando gli entusiasmi nazionalistici bruciati, la crescente «apatia» e, infine, l’aperta ostilità al «sudicio Poffarbacco». «Per vie misteriose le vite di Gadda e di Montale – osserva l’autore nell’introduzione – ebbero modo di incrociarsi mostrando di avere in comune più di qualche tratto (…). Qui se ne additerà per intanto uno decisivo, e cioè la diuturna lotta per tentare di preservare spazi di autonomia a favore della loro vocazione letteraria rispetto alle necessità di vita che li costrinsero di frequente ad accettare lavori che nulla avevano a che fare con ciò che chiamavano lo “studio”, cioè la tradizione culturale che essi consideravano la premessa essenziale della loro attività letteraria. (…) Sotto diversi riguardi il confronto con il fascismo fu il comune basso continuo che animò due vite che cercarono, quale più quale meno, di affrancarsene».
Gadda e Montale avevano vissuto sul campo, con spirito patriottico, la Grande Guerra: lo scrittore fu fatto prigioniero sull’Isonzo e deportato a Celle; il poeta ebbe il ruolo di sottotenente in Valmorbia, «terra dove non annotta». Ma qual era stato il loro atteggiamento nei confronti del fascismo, nella successiva epoca dello «spasimo bellicista»? Di stentorea condanna, si è detto, soprattutto nel biennio 1938-1939, con qualche vacillamento agli albori. E dunque con un’avversione conquistata nel tempo. Sul modello dei parallelismi plutarchei Pier Giorgio Zunino, già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino, ricostruisce in Gadda, Montale e il fascismo le analoghe vicende del lombardo e del genovese, raccontando gli entusiasmi nazionalistici bruciati, la crescente «apatia» e, infine, l’aperta ostilità al «sudicio Poffarbacco». «Per vie misteriose le vite di Gadda e di Montale – osserva l’autore nell’introduzione – ebbero modo di incrociarsi mostrando di avere in comune più di qualche tratto (…). Qui se ne additerà per intanto uno decisivo, e cioè la diuturna lotta per tentare di preservare spazi di autonomia a favore della loro vocazione letteraria rispetto alle necessità di vita che li costrinsero di frequente ad accettare lavori che nulla avevano a che fare con ciò che chiamavano lo “studio”, cioè la tradizione culturale che essi consideravano la premessa essenziale della loro attività letteraria. (…) Sotto diversi riguardi il confronto con il fascismo fu il comune basso continuo che animò due vite che cercarono, quale più quale meno, di affrancarsene».
Se Gadda in Argentina sembra non disdegnare la trazione antibolscevica del fascismo «visto da lontano», in contrasto con il neutralismo del «bojaccio» Giolitti (salvo poi ricredersi nel periodo romano con il regime «visto da vicino»), Montale firma già nel ‘25 il Manifesto degli intellettuali antifascisti, redatto da Croce. (Nei ricordi di Eugenio figura lo stentoreo «Te lo sei meritato» del padre Domenico – detto Domingo – al ceffone ricevuto da uno squadrista per non aver salutato con rispetto il «cencio nero». Peraltro, in una lettera del ‘23 a un amico scrive: «La rivoluzione sono disposta a farla dentro di me tutti i giorni; ma fuori preferisco non bere olio di ricino o buscare legnate»).
Eugenio fu assunto come direttore del Gabinetto Vieusseux nel ‘29 dal podestà di Firenze, il conte Senatore Giuseppe della Gherardesca, perché sprovvisto della tessera del PNF. Verrà rimosso nel ‘38 per lo stesso motivo. Nel ‘33 era scoppiato il thunderbolt con l’italianista americana dalle «pupille d’acquamarina», Irma Brandeis che in poesia diventerà Clizia, visiting angel, «messaggera accigliata», tornata in Europa un’ultima volta prima della Seconda guerra mondiale proprio nel ‘38 per coordinare le operazioni di raduno degli ebrei a Lussino e a Parigi. Esistenze in rotta di collisione, dissonanze che toccano qui il punto focale. Zunino sottolinea come per Gadda e Montale «i giorni bui dell’autunno 1938» creino la mitologia di un antifascismo più concettuale che d’azione: con l’aria infetta che aleggia nella Cognizione del dolore e nel Pasticciaccio. E la durissima epigrafe del poeta barocco francese d’Aubigné ad aprire Finisterre (pubblicata in Svizzera nel ‘43): «Le loro mani servono soltanto a perseguitarci».
 Sociologia del giornalismo
Sociologia del giornalismo Comunicare
Comunicare L’architetto e l’oracolo
L’architetto e l’oracolo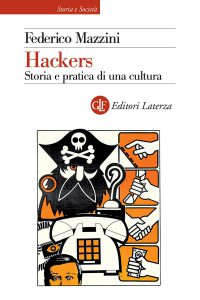 Hackers
Hackers La maschera dei classici
La maschera dei classici
 Lessico della storia culturale
Lessico della storia culturale Senza intellettuali
Senza intellettuali
 11 maggio 1860
11 maggio 1860 Terra irredenta, terra incognita
Terra irredenta, terra incognita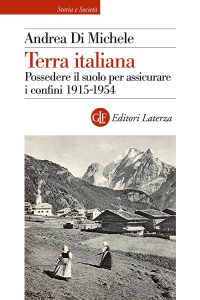 Terra italiana
Terra italiana La resistenza lunga
La resistenza lunga Mussolini racconta Mussolini
Mussolini racconta Mussolini Storia passionale della guerra partigiana
Storia passionale della guerra partigiana I carnefici del Duce
I carnefici del Duce Un manager del Terzo Reich
Un manager del Terzo Reich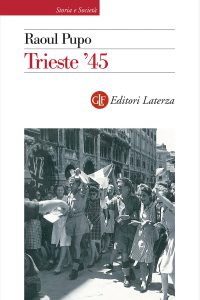 Trieste ’45
Trieste ’45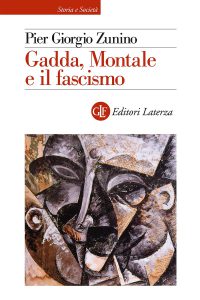 Gadda, Montale e il fascismo
Gadda, Montale e il fascismo L’Italia e la sua Costituzione
L’Italia e la sua Costituzione La diplomazia del terrore
La diplomazia del terrore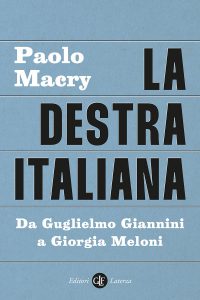 La destra italiana
La destra italiana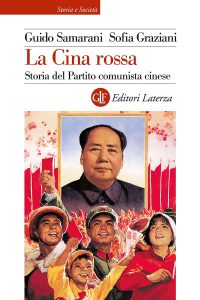 La Cina rossa
La Cina rossa Storia degli Stati Uniti
Storia degli Stati Uniti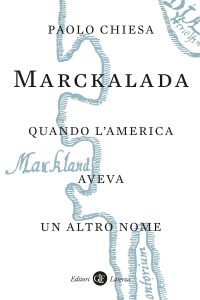 Marckalada
Marckalada Sulle orme del sacro
Sulle orme del sacro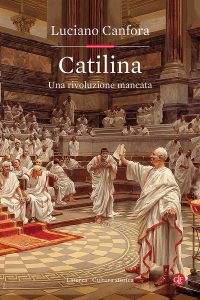 Catilina
Catilina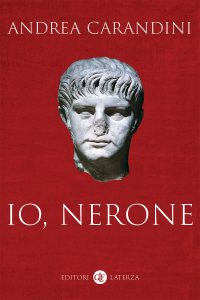 Io, Nerone
Io, Nerone Il riposo dell’imperatore
Il riposo dell’imperatore I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie
I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie La prima guerra mondiale della storia
La prima guerra mondiale della storia