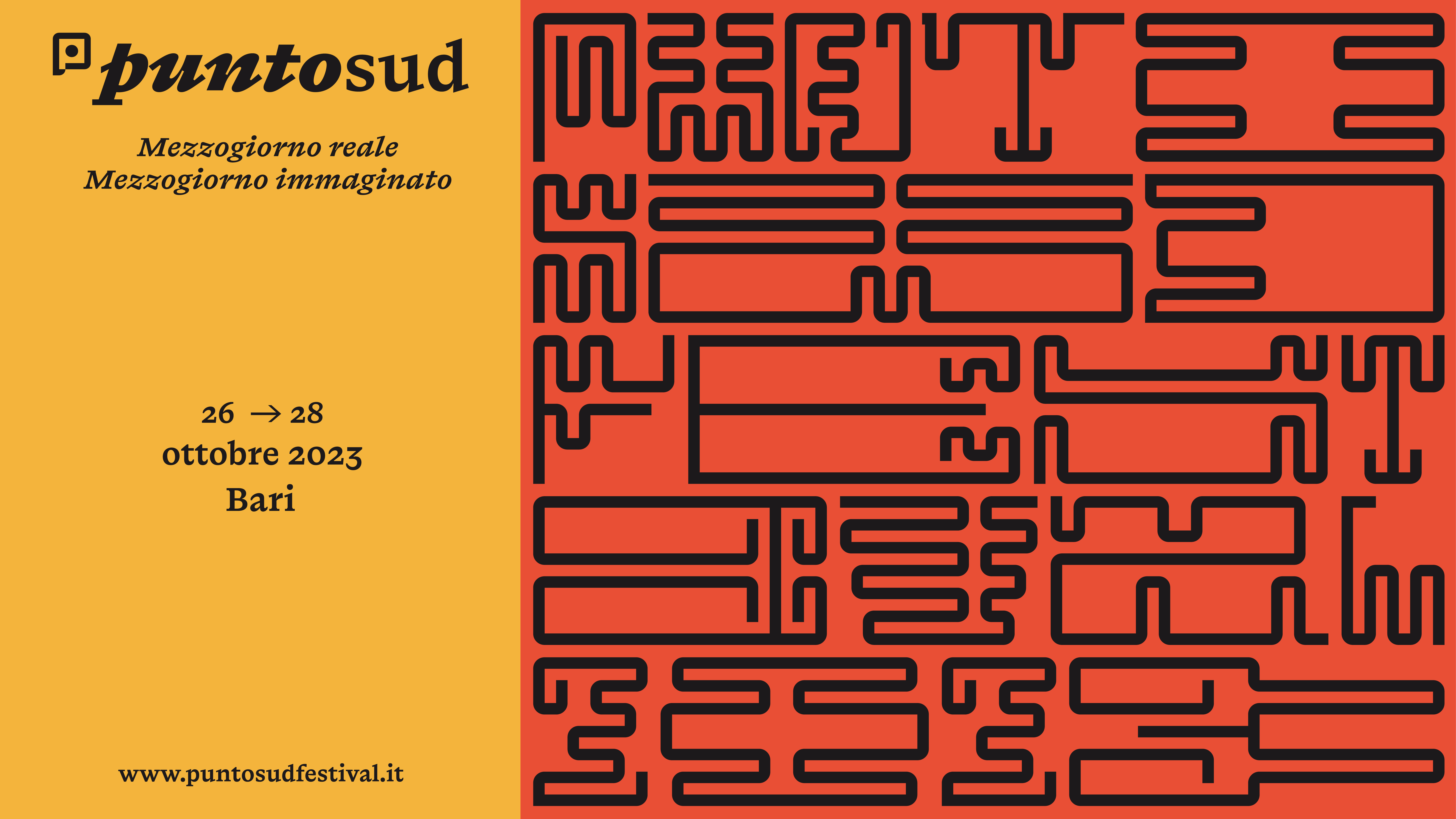marzo 2025
8 marzo 2025, ore 18.00 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Roma, Ubik Casalpalocco
9 marzo 2025, ore 16.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Galeata, Museo Civico
10 marzo 2025, ore 19.00 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Bisceglie, Vecchie segherie
11 marzo 2025, ore 18.30 | C. Greppi, Figlia mia | Bari, Libreria Laterza
12 marzo 2025, ore 18.00 | C. Saraceno, La famiglia naturale non esiste | Torino, Circolo dei Lettori, Sala Grande. Con Laura Onofri, Andrea Malaguti, Pierluigi Dovis
13 marzo 2025, ore 18.30 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Conversano, Libreria Bloombook (con Fondazione Di Vagno)
14 marzo 2025, ore 18.30 | Giuseppe Laterza | Villorba, Libreria Lovat
17 marzo 2025, ore 18.00 | C. Greppi, Figlia mia | Milano, Libreria Egea in coll. con Gariwo
18 marzo 2025, ore 17.30 | L. Pepe, Sparta | Reggio Emilia, Aula Magna Manodori di Unimore, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9. ‘I martedì della LUC’. Con Andrea Casoli
18 marzo 2025, ore 18.30 | C. Saraceno, La famiglia naturale non esiste | Milano, Libreria del Convegno con Maria Novella De Luca
18 marzo 2025, ore 17.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Bologna, Museo ebraico
19 marzo 2025, ore 18.00 | M. Binaghi, La Svizzera è un paese neutrale (e felice) | Roma, Ambasciata svizzera
20 marzo 2025, ore 18.00 | C. Greppi, Figlia mia | Padova, Palazzo Santo Stefano. Con Irene Barichello (Libreria Feltrinelli)
20 marzo 2025, ore 18.30 | S. Ballestra, Una notte nella casa delle fiabe | Bari, Libreria Laterza
20 marzo 2025, ore 17.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Siena, Accademia degli Intronati con Duccio Balestracci
20 marzo 2025, ore 17.45 | L. Pepe, Sparta | Todi, Festival Umbria antica
21-23 marzo 2025 | Libri come, Roma: gli appuntamenti con gli autori e le autrici Laterza
21 marzo 2025, ore 18.00 | S. Ballestra, Una notte nella casa delle fiabe | Terlizzi, Libreria Un panda sulla luna
21 marzo 2025, ore 18.30 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Lamezia, Terme Libreria Ubik
22 marzo 2025, ore 18.30 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Milano, Cascina cuccagna
22 marzo 2025, ore 19.00 | S. Ballestra, Una notte nella casa delle fiabe | Bisceglie, Le vecchie segherie
24 marzo 2025, ore 21.00 | F. Geda, La casa dell’attesa | Torino, Circolo dei lettori, Sala Grande
25 marzo 2025, ore 18.00| L. Pepe, Sparta | Reggio Calabria, Libreria Ubik
25 marzo 2025, ore 18.30 | F. Geda, La casa dell’attesa | Padova, Auditorium del centro San Gaetano
25 marzo 2025, ore 16.30 | M.G. Muzzarelli, La senora | Bologna, Centro culturale san Martino
26 marzo 2025, ore 18.00 | F. Geda, La casa dell’attesa | Bari, Ex Palazzo delle Poste
26 marzo 2025, ore 9.00 | L. Pepe, Sparta | Reggio Calabria, Liceo
26 marzo 2025, ore 16.00 | Alessandro Barbero, Come finiscono le guerre | Torino, Biennale democrazia, Teatro Carignano, con Manuela Ceretta
26 marzo 2025, ore 18.00 | M. Bortolato – E. Vigna, Oltre la vendetta | Firenze, Libraccio con David Allegranti
27 marzo 2025, ore 14.30 | lectio | Andrea Graziosi, Le origini storiche della guerra in Ucraina | Torino, Biennale democrazia, Polo del 900. Introduce Ottavia Giustetti
27 marzo 2025, ore 15.00 | Chiara Colombini e Carlo Greppi, La resistenza italiana tra guerra e pace. A ottant’anni dalla liberazione | Torino, Biennale democrazia, Teatro Carignano. Coordina Silvia Truzzi
27 marzo 2025, ore 17.30 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo | Perugia, Università per Stranieri (in coll. con Libreria Feltrinelli) con Armando Spataro
27 marzo 2025, ore 17.30 | lectio | Stefano Liberti, Tropico mediterraneo | Torino, Biennale democrazia, Politecnico
27 marzo 2025, ore 18.00 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Città di Castello, Libreria Paci La Tifernate
27 marzo 2025, ore 19.00 | F. M. Nimbi, Sex positive | Roma, Mercato centrale, Spazio Fare
27 marzo 2025, ore 21.00 | lectio | Adriano Favole, Fare la pace con la natura | Torino, Biennale democrazia, Teatro Gobetti. Con Lucilla G. Moliterno
27 marzo 2025, ore 21.00 | lectio | Laura Pepe, Le guerre persiane e l’invenzione dell’identità | Torino, Biennale democrazia, Aula Magna Cavallerizza Reale. Introduce Gustavo Zagrebelsky
28 marzo 2025, ore 17.00 | lectio | Alessandro Colombo, Scenari di guerra, spiragli di pace | Torino, Biennale democrazia. Accademia delle Scienze. Introduce Chiara Maritato
28 marzo 2025, ore 17.00 | L. Pepe, Sparta | Catania, Catania Libri
28 marzo 2025, ore 17.30 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Perugia, Libreria Feltrinelli
28 marzo 2025, ore 17.30 | lectio | Alessandro Vanoli, Tra Oriente e Occidente. Conflitti e prospettive dello spazio mediterraneo | Torino, Biennale democrazia. Politecnico
28 marzo 2025, ore 18.30 |L. Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido | Mel (Belluno), Palazzo delle Contesse
29 marzo 2025, ore 10.00 | G. van Straten, La ribelle | Santa Croce sull’Arno, Palazzo Vettori
29 marzo 2025, ore 12.00 | lectio | Fabio Armao, Capitalismi e guerra | Torino, Biennale Democrazia. Accademia delle Scienze. Introduce Annalisa Camilli
29 marzo 2025, ore 16.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Fossano, Palazzo Vescovile
29 marzo 2025, ore 16.00 | G. van Straten, La ribelle | Pontremoli, Teatro della Rosa
29 marzo 2025, ore 17.00 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Città di Castello, Museo Malakos
29 marzo 2025, ore 15.30 | Benedetta Tobagi, Memoria e conflitto politico nell’Italia repubblicana, ieri e oggi | Torino, Biennale democrazia. Teatro Carignano
29 marzo 2025, ore 16.00 | Anna Foa, Lo sguardo dell’altro. Israele e Palestina, dall’interno | Torino, Biennale democrazia. Teatro Gobetti. Con Paola Caridi
29 marzo 2025, ore 18.00 | M. Prignano, Antipapi. Una storia della Chiesa | Genova, Museo Diocesano di Genova (Libreria San Paolo). Con Antonio Musarra
29 marzo 2025, ore 18.30 | Giorgia Serughetti, Guerre culturali | Torino, Biennale democrazia. OGR. Con Guido Vitiello, coordina Maddalena Cannito
30 marzo 2025, ore 18.30 | Franco Cardini, Guerre dell’Occidente. Guerra all’Occidente | Torino, Biennale democrazia. Teatro Gobetti
30 marzo 2025, ore 17.30 | F. Canaccini, Sacre ossa | Cuneo, Museo Diocesano San Sebastiano
30 marzo 2025, ore 17.00 | L. Suardi, Il discorso perfetto | Cervo, Castello dei Clavesana, Rassegna Cervo Blu d’inchiostro. Con Giorgio Durante
febbraio 2025
1 febbraio 2025, ore 11.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Tarquinia, Sala consiliare
1 febbraio 2025, ore 18.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Orbetello, Fattoria La Parrina (Libreria Bastogi)
1 febbraio 2025, ore 17.00 | M. Binaghi, La Svizzera è un paese neutrale (e felice) | Mendrisio, Libreria Al Ponte
4 febbraio 2025, ore 18.00 | dialogo | Giuseppe Laterza | Bologna, Libreria CoopAmbasciatori. Con Giorgio Zanchini
4 febbraio 2025, ore 18.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Reggio Emilia, Libreria dell’Arco Coop. Con Alberto Palladini
4 febbraio 2025, ore 20.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Iseo, Sala Civica Castello Oldofredi
14 febbraio 2025, ore 17.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Grosseto, Libreria delle Ragazze
14 febbraio 2025, ore 18.30 | G. van Straten, La ribelle | Roma, Spazio Sette. Con Dacia Maraini
14 febbraio 2025, ore 18.30 | F. Canaccini, Sacre ossa | Trieste, Antico Caffè San Marco
14 febbraio 2025, ore 19.30 | F. M. Nimbi, Sex positive | Torino, Sala Albertina, Vol.To (Anlaids)
15 febbraio 2025, ore 11.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Udine, Libreria Friuli. Con Alvise Casella
15 febbraio 2025, ore 17.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Cervignano, Ufficina
17 febbraio 2025, ore 18.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Roma, Libraccio. Con Marco Bartoli
17 febbraio 2025, ore 18.00| F. Cardini, I confini della storia | Roma Teatro Manzoni con Sergio Valzania
19 febbraio 2025, ore 18.00 | G. van Straten, La ribelle | Bologna, CoopAmbasciatori. Con Marcello Fois
19 febbraio 2025, ore 19.00 | S. Pollo, Considera gli animali | Milano, Libreria del Convegno. Con Paola Fossati
21 febbraio 2025, ore 12.00 | G. Barbujani, L’alba della storia | Firenze, tourismA, Palazzo dei Congressi Auditorium
21 febbraio 2025, ore 18.00| V. Lomellini, Non si tratta con i terroristi | Bergamo, Incrocio Quarenghi. Con Michele Brunelli
21 febbraio 2025, ore 18.30 | D. Salomoni, Leonesse | Bari, Libreria Laterza
21 febbraio 2025, ore 20.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Ozzano, Biblioteca comunale (ANPI). Autrice collegata da remoto
22 febbraio 2025, ore 14.00 | F. Cenerini, Messalina | Firenze, tourismA, palazzo dei Congressi Auditorium
22 febbraio 2025, ore 16.00 | G. van Straten, La ribelle | Cerreto Guidi, Villa Medicea. Con Cecilia Maffei
22 febbraio 2025, ore 18.00 | G. Barone, L’isola-mondo | Ragusa, Circolo nautico. Con Salvatore Iudice
23 febbraio 2025, ore 10.00 | G. Traina, La prima guerra mondiale della storia | Firenze, tourismA, Palazzo dei Congressi Auditorium
23 febbraio 2025, ore 11.30 | I. Eramo, Il mondo antico in 20 stratagemmi | Firenze, tourismA, Palazzo dei Congressi spazio libri
23 febbraio 2025, ore 11.00 | S. Pollo, Considera gli animali | Reggio Emilia, Finalmente domenica! Ridotto del Teatro Municipale Valli. Con Marina Lalatta Costerbosa
23 febbraio 2025, ore 12.30 | L. Pepe, Sparta | Firenze, tourismA. Palazzo dei Congressi spazio libri
24 febbraio 2025, ore 18.00 | G. van Straten, La ribelle | Firenze, Museo Novecento. Con Stefano Massini
26 febbraio 2025, ore 18.30 | L. Pepe, Sparta | Bari, Libreria Laterza
gennaio 2025
15 gennaio 2025, ore 18.00 | G. Patota, A tu per tu con la Commedia | Roma, Teatro Manzoni
16 gennaio 2025, ore 18.00 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo | Martina Franca, Sala Consiliare del Palazzo Ducale. Interviene Armando Spataro
17 gennaio 2025, ore 19.00 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | San Donà di Piave, Libreria Raggiungibile
18 gennaio 2025, ore 18.00 | incontro con Giuseppe Laterza | Bergamo, Libreria Incrocio Quarenghi
18 gennaio 2025, ore 10.30 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Mestre, Emeroteca dell’Arte. Rassegna Ad Alta Voce. (Mondadori Bookstore)
19 gennaio 2025, ore 16.00 | P.G. Ardeni, Le classi sociali in Italia oggi | Roma, Spazio Sette. Con Marino Sinibaldi e Luciana Castellina
20 gennaio 2025, ore 18.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Palermo, Libreria Modus vivendi. Cantieri culturali della Zisa
20 gennaio 2025, ore 19.00 | F. M. Nimbi, Sex positive | Milano, Libreria del Convegno
20 gennaio 2025, ore 18.00 | F. Cardini, I confini della storia | Taranto, Libreria Dickens
21 gennaio 2025, ore 19.00 | F. Cardini, I confini della storia | Bisceglie, Libreria Vecchie segherie
21 gennaio 2025, ore 11.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Mussomeli, Liceo Virgilio
22 gennaio 2025, ore 8.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Palermo, Liceo Garibaldi
22 gennaio 2025, ore 11.00 | F. Cardini, I confini della storia | Bari, Liceo Marco Polo
22 gennaio 2025, ore 18.00 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Roma, Moby dick
22 gennaio 2025, ore 18.30 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Roma, Spazio Sette con Margherita Schirmacher
22 gennaio 2025, ore 18.30 | F. Cardini, I confini della storia | Bari, Libreria Laterza. Con Luciano Canfora
23 gennaio 2025, ore 18.30 | F. M. Nimbi, Sex positive | Roma, Ostello bello
24 gennaio 2025, ore 18.00 | F. Cardini, I confini della storia | Firenze, Libraccio
24 gennaio 2025, ore 20.45 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo | Milano, Circolo PD Monte Stella. Con Armando Spataro e Matteo Mauri
25 gennaio 2025, ore 16.00 | A. Foa (da remoto), Il suicidio di Israele | Grosseto, Palazzo della Provincia. in coll. con ANPI, Donne in nero, Assopace Palestina
25 gennaio 2025, ore 11.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Modena, Archivio di Stato. Con Alberto Palladini
25 gennaio 2025, ore 18.00 | F. Canaccini, Sacre ossa | Castiglione del Lago, Libreria Libri parlanti
27 gennaio 2025, ore 18.00 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Roma, Libraccio
28 gennaio 2025, ore 17.30 | P.G. Ardeni, Le classi sociali in Italia oggi | Roma, Camera dei Deputati, sala Berlinguer. Con Stefano Fassina, Elisabetta Piccolotti, Gilda Sportiello, Arturo Scotto
28 gennaio 2025, ore 18.00 | L. Canfora, La grande guerra del Peloponneso | Bologna, Salaborsa (Librerie Coop). Con Davide Conti
28 gennaio 2025, ore 18.15 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Locarno, Biblioteca cantonale, sala Conferenze
28 gennaio 2025, ore 18.30 | S. Ballestra, Una notte nella casa delle fiabe | Roma, Libreria Tra le righe
28 gennaio 2025, ore 20.30 | F. Cardini, I confini della storia | Cesano Maderno, Auditorium. Con Massimo Cacciari
29 gennaio 2025, ore 18.00 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Padova, Libreria delle Donne
30 gennaio 2025, ore 16.00 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo |Palermo, Istituto Gramsci con Armando Spataro
30 gennaio 2025, ore 18.00 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Palermo, Libreria Modusvivendi
30 gennaio 2025, ore 18.00 | dialogo | A. Foa, Il suicidio di Israele |Roma, Sede Polo Civico Esquilino
30 gennaio 2025, ore 18.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Bari, Libreria Laterza
30 gennaio 2025, ore 11.00 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Fasano, IISS Leonardo Da Vinci, Presìdi del Libro
31 gennaio 2025, ore 18.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Putignano, Biblioteca comunale
31 gennaio 2025, ore 18.00 | L. Canfora, La grande guerra del Peloponneso | Taranto, Sala degli Specchi (libreria Feltrinelli). Con Fulvio Colucci
31 gennaio 2025, ore 18.00 | M. Prignano, Antipapi. Una storia della Chiesa | Roma, Arciconfraternita dei bergamaschi, via di Pietra 70. Con Antonio Musarra
dicembre 2024
3 dicembre 2024, ore 20.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Mogliano Veneto Centro Pastorale
4-8 dicembre 2024 | Più Libri Più Liberi: gli appuntamenti Laterza
4 dicembre 2024, ore 18.00 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Pisa, Duomo Grand Hotel
4 dicembre 2024, ore 18.00 | E. Bruck-A. Riccardi, Oltre il male | Roma, Sala Benedetto XIII, via San gallicano 250 cn Aldo cazzullo, Donatella Di Cesare, Anna Foa, Giorgio Zanchini
4 dicembre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Pisa, Circolo Arci Alberone
4 dicembre 2024, ore 18.30 | G. Alfani, Come dèi fra gli uomini | Milano, Centro Congressi di Palazzo Invernizzi. Corso Venezia, 32
5 dicembre 2024, ore 17.30 | G. Alfani, Come dèi fra gli uomini | Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, aula 3
5 dicembre 2024, ore 17.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Rovigo (online), Circolo 2 Giugno – ARCI
4 dicembre 2024, ore 18.00 | D. Salomoni, Leonesse | L’Aquila, Libreria Colacchi. Con Amedeo Feniello
5 dicembre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Perugia, Café Timbuctu
6 dicembre 2024, ore 18.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Roma, ‘Guerre suicide’. Teatro Manzoni con Siegmund Ginzberg
6 dicembre 2024, ore 18.00 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Napoli, Scugnizzo Liberato. Con C. Raimo, Pietro Savastio, Anna Fava
6 dicembre 2024, ore 17.30 | F. Fiore, L’affaire Matteotti | Torino, Istoreto
6 dicembre 2024, ore 18.00 | S. Ballestra, Una notte nella casa delle fiabe | Napoli, Punk Tank Café
6 dicembre 2024, ore 18.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Marsala, Rassegna ‘Conversazioni al Parco’. Parco Archeologico di Lilibero. Con Francesco Bertolino
7 dicembre 2024, ore 11.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana, Prima Sala Monumentale
9 dicembre 2024, ore 16.00 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Firenze, Aula 203 del Polo didattico dell’Università di Firenze, in via Laura 48 (II piano). Con Gianfranco Bandini, Monica Galfré, Gianmario Leoni, Christian Raimo
10 dicembre 2024, ore 17.30 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Reggio Emilia, I martedì della LUC. Aula Magna Manodori, Unimore, Palazzo Dossetti. Con Mirco Carrattieri
10 dicembre 2024, ore 18.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Napoli, Laterzagorà. Con Pasquale de Sena
10 dicembre 2024, ore 18.00 | S. Pareschi, Fra le righe | Torino, Circolo dei lettori
10 dicembre 2024, ore 17.30 | F. Rutelli, Città vince città perde | Colleferro, Biblioteca Morandi (Libreria Catena)
11 dicembre 2024, ore 18.00 | M. Prignano, Antipapi. Una storia della Chiesa | L’Aquila, Libreria Colacchi. Con Amedeo Feniello
11 dicembre 2024, ore 18.00 | C. Giorgi, Salute per tutti | Milano, Casa della cultura. Con Vittorio Agnoletto, Sergio Bologna, Pino Landonio, Maria Elisa Sartor
11 dicembre 2024, ore 18.30 | S. Velotti, Sotto la soglia del controllo | Roma, Palazzo delle Esposizioni. Con Andrea Cortellessa, Carla Subrizi
12 dicembre 2024, ore 18.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Voghera, Associazione culturale Voghera
12 dicembre 2024, ore 18.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Pisa, Libreria Pellegrini
12 dicembre 2024, ore 21.00 | G. Sallusti, Nella terra dei ciliegi | Roma, Libreria Altroquando. Con Graziano Graziani
13 dicembre 2024, ore 16.00 | M.G. Muzzarelli, La senora | Modena, Archivio di Stato. Con Alberto Palladini
19 dicembre 2024, ore 17.00 | Reti d’Europa, a cura di Silvia Mantini | L’Aquila, Libreria Colacchi. Con Massimo Carlo Giannini, Gaetano Sabatini, Silvia Mantini. Modera Angela Ciano
novembre 2024
6 novembre 2024, ore 16.00 | F. Rutelli, Città vince città perde | Firenze, Accademia delle Arti e del Disegno
7 novembre 2024, ore 18.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Busto Arsizio, Glocal Festival, Galleria Boragno (Libreria Boragno)
7 novembre 2024, ore 18.30 | S. Pareschi, Fra le righe | Roma, Libreria Tomo con Tommaso Pincio
8 novembre 2024, ore 18.00 | R. De Monticelli, Umanità violata | Bergamo, Libreria Incrocio Quarenghi. Con Barbara Malvestiti
8 novembre 2024, ore 18.30 | F. Rutelli, Città vince città perde | Roma, Libreria Nuova Europa I Granai
8 novembre 2024, ore 20.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Prato, Centro Pecci Books Festival
9 novembre 2024, ore 18.00 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Torino, Rivalta Binaria
9 novembre 2024, ore 17.00 | F. Rossi, Intelligenza artificiale | Padova, Libraccio Con Geppino Pucci
11 novembre 2024, ore 15.30 | M. Prignano, Antipapi. Una storia della Chiesa | Roma, Istituto storico per il Medioevo. Con Paravicini Bagliani e Emanuela Prinzivalli
11 novembre 2024, ore 17.30 | P.G. Ardeni, Le classi sociali in Italia oggi | Trieste, Libreria Lovat
11 novembre 2024, ore 18.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Bari, Libreria Laterza. Con Silvia Godelli
11 novembre 2024, ore 19.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Roma, Medfilm festival
11 novembre 2024, ore 19.00 | F. Rossi, Intelligenza artificiale | Milano, Libreria del Convegno. Con Oreste Pollicino
12 novembre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Torino, Libreria Trebisonda. Con Rosita Di Pieri
13-17 novembre 2024 | Scrittorincittà: gli appuntamenti Laterza
13 novembre 2024, ore 18.00 | conferenza | S. Pareschi, Fra le righe | Lugano, Libreria Waelti
14-17 novembre 2024 | Bookcity Milano: gli appuntamenti Laterza
15 novembre 2024, ore 18.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Bergamo, Libreria Incrocio Quarenghi. Con Giuseppe Laterza
15 novembre 2024, ore 18.30 | F. M. Nimbi, Sex positive | Roma, Libreria Tomo. Con Angela Rafanelli
18 novembre 2024, ore 12.30 | G. Alfani, Come dèi fra gli uomini | Padova, Università, Corso di Laurea in Storia
20 novembre 2024, ore 17.00 | R. De Monticelli, Umanità violata | Roma, Villa Mirafiori Aula V
20 novembre 2024, ore 20.30 | E. Camanni, La montagna sacra | Pordenone, Auditorium Vendramini
20 novembre 2024, ore 18.30 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Foggia, Festival Questioni meridionali
20 novembre 2024, ore 19.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Roma, Libreria Giufà con Marino Sinibaldi
20 novembre 2024, ore 20.30 | E. Camanni, La montagna sacra | Pordenone, Auditorium Vendramini
21 novembre 2024, ore 11.00 | E. Camanni, La montagna sacra | Pordenone, Auditorium Liceo Grigoletti
21 novembre 2024, ore 17.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Roma, Casa della Memoria con Pupa Garribba, Marino Sinibaldi, Roberto Reali
21 novembre 2024, ore 18.00 | V. Lomellini, Non si tratta con i terroristi | Padova, Libreria Feltrinelli
21 novembre 2024, ore 18.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Milano, Libreria Cortina
21 novembre 2024, ore 18.30 | lezione | L. Canfora, Le parole della storia – Guerra | Bari, Libreria Laterza
21 novembre 2024, ore 21.00 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo | Lodi, Sala Rivolta, Teatro Alle Vigne, via Cavour 66. Interviene Armando Spataro (con libreria Sommaruga)
22 novembre 2024, ore 18.00 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Pietrasanta, Croceverde
22 novembre 2024, ore 21.00 | P. Genovesi, Specie aliene | Moncalieri, Cascina Le Vallere
23 novembre 2024, ore 17.30 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Cagli, Teatro comunale. Con Matteo Cavezzali
23 novembre 2024, ore 17.30 | L. Canfora, La guerra del Peloponneso | Reggio Emilia, Teatro Ariosto, Fondazione I teatri
23 novembre 2024, ore 21.00 | D. Salomoni, Leonesse | Caselette, Sala 150
23 novembre 2024, ore 16.45 | R. De Monticelli, Umanità violata | Firenze, L’eredità delle donne, Manifattura tabacchi. Il Mondo è in fiamme: dialogo con Natahalie Tocci. Modera Davide Lerner
25 novembre 2024, ore 18.00 | D. Salomoni, Leonesse | Castiglione del Lago, Libreria Libri parlanti con Comune
25 novembre 2024, ore 18.30 | M.G. Muzzarelli, La senora | Bari, Libreria Laterza
25 novembre 2024, ore 18.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Milano, Piccolo Teatro, Chiostro
25 novembre 2024, ore 18.30 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Torino, Aula magna Istituto Itis Avogadro (Libreria Il Ponte sulla dora)
26 novembre 2024, ore 17.30 | P.G. Ardeni, Le classi sociali in Italia oggi | Bologna, Sala Tassinari, Piazza Maggiore 1. Con Stefano Fassina
26 novembre 2024, ore 18.00 | L. Pepe, Sparta | Milano, Libreria l’Accademia. Con Laura Suardi
26 novembre 2024, ore 17.30 | E. Bruck-A. Riccardi, Oltre il male | Roma, Società Dante Alighieri, Palazzo Firenze. Con Francesca Romana de’ Angelis. Modera Alessandro Masi. Per partecipare, scrivere a eventi@dante.global
26 novembre 2024, ore 21.00 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Vimercate, Libreria Il gabbiano
27 novembre 2024, ore 18.00 | A. Viola, Chiedi a una pianta | Padova, Libreria Feltrinelli. Con Umberto Castiello
27 novembre 2024, ore 19.00 | V. Lomellini, Non si tratta con i terroristi | Preganziol, Sala Consiliare
27 novembre 2024, ore 20.00 | F. M. Nimbi, Sex positive | Roma, Glamorize. 692 Secret Garden, via Tuscolana
ottobre 2024
1 ottobre 2024, ore 17.30 | A. Feniello, Omicidio a Lombard Street | Londra, The Roasing, 31 Churton Steet
3 ottobre 2024, ore 17.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Pisa, Pisa Book Festival
3 ottobre 2024, ore 18.00 | A. Vettese, La rivolta del corpo | Napoli, Campania Libri, MADRE
3 ottobre 2024, ore 18.30 | F. Rossi, Intelligenza artificiale | Roma, Libreria Tomo. Con Diletta Huyskes. In occasione della presentazione della nuova serie, FiliRossi, la casa editrice offrirà un piccolo brindisi
3 ottobre 2024, ore 18.30 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Roma, Libreria Feltrinelli Argentina. Dialogo con Gaja Cenciarelli, Paolo Di Paolo, Maura Gancitano
4 ottobre 2024, ore 21.00 | R. De Monticelli, Umanità violata | Castellina marittima, Ecomuseo dell’alabastro (in collaborazione con Arci)
4 ottobre 2024, ore 17.30 | C. Raimo, Alfabeto della scuola democratica | Ferrara, Festival Internazionale. Ex Teatro Verdi. Con Franco Lorenzoni, Roberta Passoni
4 ottobre 2024, ore 11.00 | G. Alfani, Come dèi fra gli uomini | Milano, Fondazione Feltrinelli
4 ottobre 2024, ore 18.00 | F. Rossi, Intelligenza artificiale | Pisa, Aula Magna storica dell’Università
4 ottobre 2024, ore 19.00 | lectio Carmine Pinto | Napoli, Campania Festival
5 ottobre 2024, ore 11.00 | G. Mendicino, Conrad | Pisa, Pisa Book Festival
5 ottobre 2024, ore 15.00 | A. Musarra, 1492 | Pisa, Pisa Book Festival
5 ottobre 2024, ore 11.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Ferrara, Festival Internazionale, Apollo 2
5 ottobre 2024, ore 17.00 | F. Rossi, Intelligenza artificiale | Lucca, Pianeta terra festival
5 ottobre 2024, ore 17.45 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Lucca, Pianeta Terra festival
5 ottobre 2024, ore 20.30 | G. Sibilla, L’industria della canzone | Napoli, Campania Festival
6 ottobre 2024, ore 10.00 | A. Favole, La vita selvatica | Lucca, Pianeta terra festival. Con Emanuela Evangelista
6 ottobre 2024, ore 11.00 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Lucca, Pianeta Terra festival
7 ottobre 2024, ore 19.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Roma, Libreria Panisperna. Con Lino Lombardi
9 ottobre 2024, ore 18.00 | D. Salomoni, Leonesse | Firenze, Libraccio
9-13 ottobre 2024 | Immagimondo, Lecco: gli appuntamenti Laterza
11 ottobre 2024, ore 11.30 | F. Rutelli, Città vince città perde | Milano, Triennale Sala Agorà. Con Leopoldo Destro, Magda Antonioli. Coordina Ferruccio de Bortoli
12 ottobre 2024, ore 10.00 | A. Favole, La vita selvatica | Pistoia, Libreria Lo Spazio
12 ottobre 2024, ore 12.00 | P. Genovesi, Specie aliene | Padova, Cicap festival
12 ottobre 2024, ore 17.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Seregno, foyer dell’Auditorium (libreria Ubik). Con Roberto Galliani e Carmela Tandurella
12 ottobre 2024, ore 18.30 | C. Greppi, storie che non fanno la Storia | Bari, Libreria Laterza
13 ottobre 2024, ore 18.00 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Belluno, Palazzo Bembo, Sala dell’affresco
14 ottobre 2024, ore 10.30 | C. Greppi, storie che non fanno la Storia | Gioia del Colle, Liceo Canudo
14 ottobre 2024, ore 18.45 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Brescia, Libreria Rinascita. Con Pietro Gorlani
16 ottobre 2024, ore 16.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Napoli, Università Federico II. Aula ovale Dipartimento di Scienze sociali. Con Silvia Semenzin e Leopoldina Fortunati
16 ottobre 2024, ore 21.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Cesano Maderno, Le voci della storia. Con Franco Cardini
17 ottobre 2024, ore 21.00 | R. De Monticelli, Umanità violata | Cesano Maderno, Le voci della storia. Auditorium Disarò. Con Franco Cardini e Eva Musci
17 ottobre 2024, ore 18.30 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Cascina (Libreria Pellegrini)
17 ottobre 2024, ore 19.30 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Lecce, Conversazioni sul futuro. Officine Culturali Ergot. Con Giovanni Coppini
18 ottobre 2024, ore 18.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Pisa, Cinema Lumiere (Libreria Pellegrini). Con Carmelo Calabrò
19 ottobre 2024, ore 11.00 | P. Guerrieri – P. C. Padoan, Europa sovrana | Treviso, Festival della Statistica e della Demografia
19 ottobre 2024, ore 17.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Firenze, Istituto storico della Resistenza
19 ottobre 2024, ore 19.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Roma, Inquiete Festival, Tuba. Con Emanuela Anechoum e Valeria Montebello
20 ottobre 2024, ore 18.00 | R. De Monticelli, Umanità violata | Milano, Fabbrica dell’Esperienza. Con Chantal Meloni
21 ottobre 2024, ore 17.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Napoli, Laterzagorà. Con Lea Nocera
22 ottobre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Roma, Libreria Tra le righe
23 ottobre 2024, ore 17.00 | S. Cassese, Le strutture del potere | Roma, Festival della Diplomazia. Esperienza Europa-David Sassoli, piazza Venezia 6
23 ottobre 2024, ore 19.00 | F. M. Nimbi, Sex positive | Bisceglie, Vecchie segherie
24 ottobre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Montescudaio, Bibere (Libreria Lucarelli di Cecina)
24 ottobre 2024, ore 18.30 | F. M. Nimbi, Sex positive | Bari, Libreria Laterza. Con Alessandra Foglianese
25 ottobre 2024, ore 18.00 | F. M. Nimbi, Sex positive | Firenze, Libraccio. Con Alessia Dulbecco
28 ottobre 2024, ore 18.00 | A. Foa, Il suicidio di Israele | Roma, Fondazione La Malfa. Con Giorgio La Malfa e Laura Mirakian
28 ottobre 2024, ore 18.00 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Bologna, Libreria CoopAmbaciatori. Con Maria Chiara Rioli
29 ottobre 2024, ore 18.00 | Zagrebelsky, Spataro, Pallante, Loro dicono, noi diciamo | Milano, Camera del Lavoro, sala Buozzi. Intervengono gli autori e Maria Agostina Cabiddu. Saluti di Luca Stanzione. Modera Massimo Giannini
29 ottobre 2024, ore 18.00 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Bergamo, Libreria Incrocio Quarenghi. Con Andrea Valesini
30 ottobre 2024, ore 18.45 | S. Pareschi, Fra le righe | Brescia, Libreria Rinascita
settembre 2024
19-25 settembre 2024 | Lectorinfabula, Conversano
24 settembre 2024, ore 18.00 | S. Pareschi, Fra le righe | Legnano, Libreria Nuova Terra
24 settembre 2024, ore 16.00 | G. Caravale, Senza intellettuali | Firenze, Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri di Palazzo Strozzi
24 settembre 2024, ore 18.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Castelgomberto, Villa da Schio
24 settembre 2024, ore 18.00 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Bari, Libreria Laterza
25 settembre 2024, ore 18.30 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Taranto Libreria Dickens
25 settembre 2024, ore 10.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Forlì, Festival del Buonvivere. Auditorium Chiesa di San Giacomo. Con Paolo Rambelli
26 settembre 2024, ore 18.30 | S. Liberti, Tropico mediterraneo | Forlì, Festival del buon vivere, Arena. Con Corrado Ravaioli
25 settembre 2024, ore 17.00 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Bologna, Aula colonne, Dipartimento delle Arti, Università
25 settembre 2024, ore 19.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Macomer, Festival Forse alla Luna
26 settembre 2024, ore 18.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Villacidro, Festival della Fondazione Giuseppe Dessì
26 settembre 2024, ore 18.30 | Alessandro Vanoli, ‘Di venti, di bussole e di rotte sbagliate’ | Torino, Torinospiritualità. Accademia delle Scienze
27 settembre 2024, ore 19.00 | S. Pareschi, Fra le righe | Varese, Libreria degli Asinelli
28 settembre 2024, ore 17.00 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Forlì, Sala Campostrino
29 settembre 2024, ore 17.30 | P. Pileri, Dalla parte del suolo | Cremona, Sala Zanoni
30 settembre 2024, ore 18.00 | A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre | Pisa, Cinema Lumiere
agosto 2024
2 agosto 2024, ore 21.00 | F. Fiore, L’affaire Matteotti | San Benedetto del Tronto
10 agosto 2024, ore 20.45 | E. Camanni, La montagna sacra | Cogne, Sala consiliare del Comune
luglio 2024
3 luglio 2024, ore 18.30 | L. Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido | Firenze, Estate fiorentina, Giardino dell’Orticoltura (Libreria On the Road)
5 luglio 2024, ore 18.00 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | L’Aquila, Auditorium (Libreria Colacchi)
5 luglio 2024, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Grado, Rassegna Libri e Autori Velarium della spiaggia GIT
7 luglio 2024, ore 21.00 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Bari, Lungomare di Libri
10 luglio 2024, ore 17.30 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Firenze, Festival “manicomio addio!”, Biblioteca Luzi
11 luglio 2024, ore 18.30 | F. Fiore, L’affaire Matteotti | Roma, Festa dell’Unità a Caracalla. Con Valerio Renzi
14 luglio 2024, ore 18.30 | L. Colantoni, Lungo la corrente | Roma, Festa dell’Unità a Caracalla. Con Simone Dei Pieri
21 luglio 2024, ore 18.00 | G. Mendicino, Conrad | Cortina d’Ampezzo, Museo Rinaldo Zardini. Una Montagna di Libri, con Francesco Chiamulera
23 luglio 2024, ore 19.00 | L. Colantoni, Lungo la corrente | Roma, Piazza Gianicolo. Con Davide De Gennaro
25 luglio 2024, ore 17.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Cortina d’Ampezzo, Grand Hotel Savoia. Una Montagna di Libri, con Francesco Chiamulera
26 luglio 2024, ore 18.00 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Cogne, Festival Gran Paradiso, Maison de la Grivola
giugno 2024
1 giugno 2024, ore 16.00 | P. Guerrieri – P. C. Padoan, Europa sovrana | Torino, Festival di Economia, Circolo dei Lettori. Con Giorgio Barba Navaretti
1 giugno 2024, ore 17.30 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Castelmuzio, nell’ambito di CastelLibro (Libraccio Firenze)
2 giugno 2024, ore 19.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Castelmuzio, nell’ambito di CastelLibro (Libraccio Firenze)
3 giugno 2024, ore 17.45 | L. Ferrajoli, Giustizia e politica | Ferrara, Libraccio
4 giugno 2024, ore 17.30 | S. Cassese, Le strutture del potere | Roma, Palazzo delle Esposizioni
5 giugno 2024, ore 18.00 | E. Camanni, La montagna sacra | Pisa, Sede CAI, Corte Sanac 40 (in coll. con Libreria Pellegrini)
6 giugno 2024, ore 18.00 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Palermo, Una Marina di Libri
6 giugno 2024, ore 20.30 | P. Morando, Prima di piazza Fontana | Reggio Emilia, Casa Bettola
6 giugno 2024, ore 19.00 | M. Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli | Rovereto, Libreria Arcadia
6 giugno 2024, ore 18.00 | R. Bizzocchi, Romanzo popolare | Santena, Associazione Amici di Camillo Cavour
6 giugno 2024, ore 20.30 | spettacolo | Alessandro Vanoli | Lugano, Festival Echi di Storia. Teatro Studio Foce
7 giugno 2024, ore 11.30 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Lugano, Festival Echi di Storia. Asilo Ciani
7 giugno 2024, ore 16.00 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Udine, Loggia del Lionello
7 giugno 2024, ore 18.30 | dialogo | Carlo Greppi | Lugano, Festival Echi di Storia, Asilo Ciani
7 giugno 2024, ore 21.00 | M. Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli | Monticello Brianza, Tracce della Storia, Villa Greppi
8 giugno 2024, ore 18.00 | dialogo | Marcello Flores | Lugano, Festival Echi di Storia, Asilo Ciani
8 giugno 2024, ore 19.00 | F. Zuolo, Disobbedire | Andria, Festival della Disperazione
9 giugno 2024, ore 11.30 | lectio | Luigi Mascilli Migliorini | Lugano, Festival Echi di Storia, Biblioteca cantonale
10 giugno 2024, ore 21.00 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Vicenza, Una Basilica di Libri
10 giugno 2024, ore 18.00 | O. De Napoli, Selvaggi criminali | Napoli, Mondadori Bookstore
11 giugno 2024, ore 21.00 | M. Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli | Firenze, Le piazze dei libri (Libraccio). Con Sandra Landi e Letizia Fuochi
12 giugno 2024, ore 18.30 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Roma, Libreria Spaziosette. Con Davide Conti
12 giugno 2024, ore 19.00 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Firenze, Le piazze dei libri (Libraccio)
13 giugno 2024, ore 17.30 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Teramo, Corte interna della Biblioteca Melchiorre Delfico (Fondazione Einaudi Abruzzo)
13 giugno 2024, ore 19.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Roma, Horti incontri, piazza Vittorio. Con Sofia Viscardi e Silvia Semenzin
14 giugno 2024, ore 19.00 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Firenze, Le piazze dei libri, piazza s. Maria Novella (Libreria Malaparte)
14 giugno 2024, ore 20.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Bologna, giardini di Porta Saragozza
14 giugno 2024, ore 18.00 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Pisa, Festival della Fiducia. Con Luca Del Re (Libreria Pellegrini)
14 giugno 2024, ore 19.00 | G. Mendicino, Conrad | Conegliano, Conversazioni nel Chiostro, Convento di San Francesco (Libreria Tra Le Righe)
15 giugno 2024, ore 11.30 | B. Tobagi, Le stragi sono tutte un mistero | Lodi
15 giugno 2024, ore 21.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Ragusa, A tutto volume
16 giugno 2024, ore 21.00 | E. Traverso, Gaza davanti alla storia | online/Roma, Festival letteratura sociale (autore collegato da remoto)
16 giugno 2024, ore 19.00 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Andria, Festival della Disperazione
16 giugno 2024, ore 19.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Andria, Festival della Disperazione
17 giugno 2024, ore 17.30 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Benevento, Palazzo Paolo V, sala dell’Antico Teatro. Con Giuseppe Maria Berruti, Clemente Mastella, Aldo Policastro. Saluti: Stefania Pavone
17 giugno 2024, ore 18.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Bari, Libreria Laterza. Con Donatella Loiacono e Andrea Piva
18 giugno 2024, ore 18.30 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Foggia, Cortile del Museo di Storia naturale (Libreria Ubik)
15-22 giugno 2024 | Gli appuntamenti Laterza al Salerno Letteratura Festival
19 giugno 2024, ore 18.30 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Firenze, Libreria Malaparte. Con Carolina Natoli
20 giugno 2024, ore 19.00 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Milano, Libreria del Convegno
21 giugno 2024, ore 21.00 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Vicenza, Una basilica di libri. Con Alessandro Marzo Magno
22 giugno 2024, ore 18.30 | G. Mendicino, Conrad | Roma, Festival Letteratura di Viaggio, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana
22 giugno 2024, ore 21.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Bisceglie, Vecchie segherie
23 giugno 2024, ore 17.30 | A. Favole, La vita selvatica | Roma, Festival Letteratura di Viaggio, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana
24 giugno 2024, ore 18.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Treviso, Libreria Feltrinelli Festival Robe da mati
24 giugno 2024, ore 19.00 | C. Bottici, Manifesto anarca-femminista | Matera, con Non una di meno Matera (Libreria dell’Arco)
25 giugno 2024, ore 18.30 | C. Bandinelli, Le postromantiche | Genova, Rassegna ‘Libri fuori’, piazza san Donato. Con Filippo D’Angelo
26 giugno 2024, ore 21.30 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Fano, Passaggi Festival con Graziano Leoni
27 giugno 2024, ore 18.00 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Bari, Teatro Kursaal santa Lucia. Con Michele Emiliano, Michele Laforgia, Francesco Paolo Sisto. Modera Michele Pennetti
28 giugno 2024, ore 18.30 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Perarolo, Serre di Palazzo Lazzaris
maggio 2024
2 maggio 2024, ore 21.15 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Macerata, Festival Macerataracconta. Teatro della Filarmonica. Con Marino Sinibaldi
6 maggio 2024, ore 17.00 | S. Cassese, Le strutture del potere | Roma, Biblioteca Camera dei Deputati con Ernesto Galli della Loggia, Gianni Letta, Enrico Mentana e Alessandra Sardoni
6 maggio 2024, ore 18.00 | F. Cardini, La deriva dell’Occidente | Roma, Feltrinelli Appia. Con Elena Basile, modera Alessandro Zardetto
6 maggio 2024, ore 18.00 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Milano, FDN – Road to Europe, sede di Assolombarda in Via Pantano, 9. Con Francesco Paolo Sisto
7 maggio 2024, ore 18.00 | M. Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli | Firenze, Libraccio
8 maggio 2024, ore 17.30 | M. Franzinelli, Croce e il Fascismo | Rovigo, Sala consiliare della provincia
7-12 maggio 2024 | Festival Vicino/Lontano: gli eventi Laterza
9-13 maggio 2024 | Salone internazionale del libro di Torino: gli appuntamenti Laterza
10 maggio 2024, ore 18.30 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Londra, Istituto Italiano di Cultura. Con John Dickie
10 maggio 2024, ore 20.30 | A. Favole, La vita selvatica | Mondovì, Caffè sociale
10 maggio 2024, ore 18.00 | M. Franzinelli, Croce e il Fascismo | Milano, Libreria Claudiana. Con Sandro Gerbi
13 maggio 2024, ore 21.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Lodi, (con Libreria Sommaruga) Sala Granata, Biblioteca Laudense
14 maggio 2024, ore 18.00 | A. Feniello, Omicidio a Lombard Street | Napoli, Laterzagorà
14 maggio 2024, ore 18.00 | A. Vanoli, L’invenzione dell’Occidente | Bologna, Salaborsa (con Librerie coop)
15 maggio 2024, ore 18.00 | A. Feniello, Omicidio a Lombard Street | L’Aquila, Libreria Colacchi
16 maggio 2024, ore 18.00 | E. Camanni, La montagna sacra | Cuneo, Anteprima Scrittorincittà, Cuneo Montagna Festival. Con Raffaele Riba
16 maggio 2024, ore 18.00 | A. Martini, Fascismo immaginario | Livorno, Libreria Feltrinelli
20-26 maggio 2024 | èStoria: gli eventi Laterza
27 maggio 2024, ore 18.00 | M. Ferraris, Imparare a vivere | Udine, Torre Santa Maria. Con Damiano Catone e Luca Taddio
27 maggio 2024, ore 18.30 | A. Somma, Abolire il lavoro povero | Padova, Libreria ItalyPost
27 maggio 2024, ore 18.00 | T. Montanari, Le statue giuste | Brescia, Chiesa di San Cristo in via Piamarta (Libreria Rinascita)
27 maggio 2024, ore 14.00 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Roma, La Sapienza, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
29 maggio 2024, ore 18.00 | A. Feniello, Omicidio a Lombard Street | Bari, Libreria Laterza, in coll. con I mercoledì della storia
30 maggio 2024, ore 18.30 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Firenze, Giardino dei Ciliegi. Con Anastasia Barone, Giada Bonu, Anna Lavizzari
aprile 2024
4 aprile 2024, ore 16.30 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Palermo, Anticipazione ‘Una Marina di Libri’, Facoltà di Scienze Politiche
4 aprile 2024, ore 17.00 | T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil | Venezia, Letture Cafoscarine, online
5 aprile 2024, ore 18.00 | G. Mendicino, Conrad | Padova, Libreria Feltrinelli. Con Sara Zanferrari
5 aprile 2024, ore 19.00 | L. Tripaldi, Gender tech | Milano, Libreria Alaska. Con Arianna Mainardi
6 aprile 2024, ore 16.30 | A. Martini, Fascismo immaginario | Verona, Via Cantarane. Con Dennis Turrin
8 aprile 2024, ore 18.00 | N. Bobbio, Lezioni sulla guerra e sulla pace | Torino, Circolo dei Lettori, Sala Grande. Con Tommaso Greco, Andrea Malaguti, Gustavo Zagrebelsky. Interviene Andrea Bobbio. Coordina Giuseppe Laterza
10 aprile 2024, ore 17.00 | F. Cardini, La deriva dell’Occidente | Roma, Advant Sala conferenze
11 aprile 2024, ore 18.00 | E. Camanni, La montagna sacra | Parma, Feltrinelli
11 aprile 2024, ore 19.00 | I. Eramo, Il mondo antico in 20 stratagemmi | Legnano, La Storia tra le righe
12 aprile 2024, ore 17.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Forlì, “Archeologia in dialogo”, Circolo Aurora
12 aprile 2024, ore 21.00 | A. Favole, La vita selvatica | Bussero, Associazione Chiaroscuri
12 aprile 2024, ore 18.30 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Modena, Chiesa della Madonna del Voto, con Libreria Coop
13 aprile 2024, ore 11.00 | A. Favole, La vita selvatica | Bologna, Festival di Antropologia
13 aprile 2024, ore 18.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Como, Libreria Ubik. Con Alberto Schiavone
14 aprile 2024, ore 11.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Procida, Coffee House
16 aprile 2024, ore 18.00 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Bari, Libreria Laterza
16 aprile 2024, ore 16.00 | L. Ferrajoli, Giustizia e politica | Rimini, Centro Congressi SGR di Rimini – Sala Energia
17 aprile 2024, ore 18.00 | E. Camanni, La montagna sacra | Torino, Libreria OOLP
17 aprile 2024, ore 18.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Verona, Libreria Feltrinelli in collaborazione con il Circolo dei Lettori
17 aprile 2024, ore 18.00 | G. Mendicino, Conrad | Levico Terme, la Piccola Libreria
18 aprile 2024, ore 9.00 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Cassano, Festival CassanoScienza
18 aprile 2024, ore 18.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Bari, Libreria Laterza
18 aprile 2024, ore 18.45 | E. Camanni, La montagna sacra | Cirié, Libreria Ca’Libro
18 aprile 2024, ore 21.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Bisceglie, Vecchie Segherie
19 aprile 2024, ore 18.00 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Palermo, Libreria Europa. Con Simona Conigliaro e Giuseppe Marsala
19 aprile 2024, ore 18.30 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Matera, Libreria dell’Arco
19 aprile 2024, ore 18.30 | A. Marzo Magno, Casanova | Belluno, Libreria Mondadori con Michela Fregona
20 aprile 2024, ore 18.00 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Montebelluna, Villa Bonetti
20 aprile 2024, ore 18.30 | A. Feniello, Omicidio a Lombard Street | Pistoia, Libreria Lo Spazio
20 aprile 2024, ore 17.00 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Roma, Auditorium Parco della Musica, Festival delle Scienze, Auditorium Arte. Con Devis Bellucci. Modera Roberta Fulci
20 aprile 2024, ore 18.30 | M. Ferraris, Imparare a vivere | Bergamo, Fiera Librai. Con Telmo Pievani
22 aprile 2024, ore 18.30 | V. Furlanetto, Cento giorni che non torno | Milano, Feltrinelli via Sabotino. Con Gherardo Colombo, Claudio Jampaglia. Modera Danilo De Biasio
22 aprile 2024, ore 18.30 | M. Franzinelli, Croce e il Fascismo | Roma, Libreria Nuova Europa I Granai
23 aprile 2024, ore 18.30 | E. Camanni, La montagna sacra | Torino Libreria Binaria. Con Maurizio Dematteis
23 aprile 2024, ore 18.00 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Roma, Fondazione Einaudi. Con Giuseppe Benedetto, Pierluigi Battista, Marco Follini, Clemente Mastella
26 aprile 2024, ore 21.00 | A. Favole, La vita selvatica | Boves, Associazione Totem e Tabù
27 aprile 2024, ore 16.30 | E. Gentile, “In democrazia il popolo è sempre sovrano. Falso!” | Crema, Libreria Cremasca
29 aprile 2024, ore 18.00 | A. Martini, Fascismo immaginario | Verona, Libreria Feltrinelli
30 aprile 2024, ore 16.00 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Trento, MontagnaLibri-TrentoFilmFestival. Salotto letterario, piazza Duomo. Con Fabrizio Torchio
30 aprile 2024, ore 18.00 | M. Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli | Lucca, Libreria Feltrinelli
30 aprile 2024, ore 18.00 | A. Martini, Fascismo immaginario | Padova, Libreria Feltrinelli
30 aprile 2024, ore 18.30 | F. Barbera, Le piazze vuote | Genova, Giardini Luzzati
marzo 2024
1 marzo 2024, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Udine, Libreria Moderna
1 marzo 2024, ore 19.00 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Barcellona, Libreria Italiana Le nuvole
1 marzo 2024, ore 17.30 | S. Colarizi, La resistenza lunga | Bassano del Grappa, Biblioteca Civica
1 marzo 2024, ore 21.00 | A. Iannace, Storia della terra | Torino, CAI Uget. Con Enrico Camanni e Luca Martire
2 marzo 2024, ore 11.30 | E. Gobetti, I carnefici del Duce | Roma, Libreria Tomo con Ascanio Celestini
2 marzo 2024, ore 16.00 | S. Colarizi, La resistenza lunga | Vicenza, Porto Burci
3 marzo 2024, ore 11.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Vienna, Festival di Letteratura Italiana
4 marzo 2024, ore 18.30 | R. Morelli, Muovere merci | Padova, Italypost
4 marzo 2024, ore 18.00 | L. Scaraffia, Atti impuri | Torino, Circolo dei lettori, sala gioco
4 marzo 2024, ore 18.30 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Milano, Libreria Feltrinelli, piazza Piemonte. Con Claudio Sforza
5 marzo 2024, ore 18.00 | L. Scaraffia, Atti impuri | Novara, Circolo dei lettori
5 marzo 2024, ore 18.30 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Bologna, Salaborsa, con Librerie Coop. Con Nicola Borghesi e Alessandro Freno
6 marzo 2024, ore 14.30 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Roma, Lumsa
6 marzo 2024, ore 18.00 | M. Ferraris, Imparare a vivere | Bari, Libreria Laterza con Alessandro Laterza
7 marzo 2024, ore 18.00 | D. Bennato, La società del XXI secolo | Catania, Libreria Feltrinelli via Etnea
8 marzo 2024, ore 18.00 | G. Serughetti, La società esiste | Bologna, Salaborsa, con Librerie Coop. Con Emanuele Felice, Federica Mazzoni, Nicola Zingaretti
9 marzo 2024, ore 17.00 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Forni di Sopra, Municipio. Rassegna ‘Vicino Lontano Mont’. Con Paola Cosolo Marangon
11 marzo 2024, ore 18.00 | A. Martini, Fascismo immaginario | Verona, Libreria Feltrinelli
11 marzo 2024, ore 11.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bari, Università con Sindaco e presidente Regione Nicola Martinelli
11 marzo 2024, ore 18.00 | P. Macry, La destra italiana | Napoli, Teatro Bellini, A voce alta. Con Marcello Anselmo
11 marzo 2024, ore 18.00 | M. Ferraris, Imparare a vivere | Torino, Circolo dei lettori – sala grande. Con Carola Barbero
12 marzo 2024, ore 17.30 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Modena, Sala Ex Oratorio – Palazzo dei Musei. Con Massimiliano Panarari. Iniziativa in collaborazione con la Fondazione di Modena e Librerie Coop
13 marzo 2024, ore 17.30 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Trieste, Circolo della Stampa
13 marzo 2024, ore 18.00 | P. Nori, Una notte al Museo Russo | Parma, Libreria Feltrinelli, via Farini 17
14 marzo 2024, ore 18.00 | G. Caravale, Senza intellettuali| Chi sono oggi gli intellettuali? Incontro a partire dal libro | Milano, Fondazione Mondadori Laboratorio Formentini. Introducono la discussione, insieme all’autore: Gianni Cuperlo, Irene Graziosi, Luigi Mascheroni. Qui tutte le informazioni
14 marzo 2024, ore 18.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Milano, The Mill
14 marzo 2024, ore 18.45 | M. Montanari, Amaro | Brescia, Libreria Rinascita
15 marzo 2024, ore 17.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Todi, Festival dell’Umbria Antica
15 marzo 2024, ore 18.00 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Torino, Circolo dei Lettori – sala Gioco, rassegna ‘Femminile plurale’
16 marzo 2024, ore 12.00 | A. Carandini, Io Nerone | Todi, Festival dell’Umbria Antica
16 marzo 2024, ore 19.00 | S. Ballestra, La sibilla | Alessandria, Rassegna ‘Marzo donna’. In coll. con Comune e Ubik. Circolo Su Nuraghe (presentazione con aperitivo)
18 marzo 2024, ore 18.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Faenza, Biblioteca comunale. Interviene il sindaco Massimo Isola
19 marzo 2024, ore 18.30 | L. Scaraffia, Atti impuri | Roma, Spaziosette. Con Mons. Fisichella, Riccardo Di Segni e Luciano Violante
19 marzo 2024, ore 18.30 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Roma, Libreria Panisperna. Con Giosuè Calaciura
20 marzo 2024, ore 17.30 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Mestre, Museo M9
21 marzo 2024, ore 17.00 | A. Martini, Fascismo immaginario | Trento, FBK. Con Giorgio Lucaroni
22 marzo 2024, ore 18.30 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Alberobello, Bibliocenter. Ex Conceria, via Barsento 7. Introduce Emmanuel Piepoli, modera Barbara Cupertino, interviene Francesco Paolicelli
22-24 marzo 2024 | Libri come, Roma: gli appuntamenti con le autrici e gli autori Laterza
23 marzo 2024, ore 12.00 | R. Morelli, Muovere merci, muovere il mondo | Vicenza, Chiostri di Santa Corona
25 marzo 2024, ore 18.00 | G. Buccini, La Repubblica sotto processo | Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Con il Ministro Carlo Nordio, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Clementi. Modera Fiorenza Sarzanini
26 marzo 2024, ore 18.30 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Torino, Rassegna ‘Leggere le montagne’. Biblioteca Nazionale del CAI. Con Marco Cuaz e Pietro Crivellaro
27 marzo 2024, ore 18.30 | A. Favole, La vita selvatica | Torino, Libreria Binaria. Con Danilo Zagaria
28 marzo 2024, ore 18.00 | A. Zannini, Controstoria dell’alpinismo | Mestre, Museo del Novecento
28 marzo 2024, ore 18.30 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Bologna, CoopAmbasciatori. Con Alessandro Vanoli
febbraio 2024
2 febbraio 2024, ore 18.00 | P. Macry, La destra italiana | Bari, Fondazione Tatarella
2 febbraio 2024, ore 18.00 | T. Greco, Curare il mondo | Vibo Valentia, Libreria Cuori d’inchiostro
3 febbraio 2024, ore 16.00 | M. Pucciarelli, Guerra alla guerra | Baranzate, Ex Chiesetta
3 febbraio 2024, ore 17.00 | L. Mascilli Migliorini, 11 maggio 1860 | Caiazzo, Sala Conferenze del Centro Polivalente Culturale di Palazzo Mazziotti (con la Libreria Pacifico)
6 febbraio 2024, ore 16.00 | I. Eramo, Il mondo antico in 20 stratagemmi | Bologna, Biblioteca Galvani Pasolini. Con Giovanni Brizzi (in coll. con Librerie Coop)
6 febbraio 2024, ore 18.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Milano, Fondazione Corriere della Sera, sala Buzzati. Con Ferruccio de Bortoli, Sarah Varetto, Carlo Stagnaro
8 febbraio 2024, ore 16.30 | P. Macry, La destra italiana | Nola, sala il Cortile, circoscrizione di Piazzolla (con la Libreria Mondadori)
8 febbraio 2024, ore 17.00 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Roma, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Con Domenico Rizzo
8 febbraio 2024, ore 18.30 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Lecce, Libreria Liberrima
9 febbraio 2024, ore 11.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Bari, Dottorato di Ricerca in Lettere Lingue e Arti, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari
9 febbraio 2024, ore 14.30 | L. Canfora, Catilina | Milano, Libreria Leoncavallo – online (info: librerialeoncavallo@inventati.org). Con Sebastiano Taccola
9 febbraio 2024, ore 18.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Bari, Libreria Laterza
9 febbraio 2024, ore 18.00 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Catania, Libreria Mondadori. Con Caterina Andò
10 febbraio 2024, ore 17.30 | R. Morelli, Muovere merci | Trieste, Sala Conferenze, Comunità Greco-Orientale, Riva Tre Novembre 7. Con Giulio Mellinato e Pietro Spirito
15 febbraio 2024, ore 18.30 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Roma, Libreria Panisperna. Con Silvia Gallerano
16 febbraio 2024, ore 17.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Ferrara, Ibs Libraccio
16 febbraio 2024, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Roberti
17 febbraio 2024, ore 17.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Piacenza, Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi
19 febbraio 2024, ore 18.30 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Torino, Circolo dei Lettori, sala Grande. Con Stefania Ravazzi, Patrizia Lombardi, Stefano Lo Russo, Alberto Cirio. Modera Andrea Gavosto
19 febbraio 2024, ore 21.00 | A. Barbero, All’arme all’arme! I priori fanno carne! | Selvazzano, Rassegna ‘Una selva di Libri’. Con Valentina Barengo
22 febbraio 2024, ore 18.30 | T. Greco, Curare il mondo | Bari, Libreria Laterza
23-25 febbraio 2024 | Testo, Firenze: gli appuntamenti Laterza
23 febbraio 2024, ore 16.00 | T. Greco, Curare il mondo | Matera, Ordine degli avvocati, Palazzo di Giustizia
23 febbraio 2024, ore 21.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Lugo, Libreria Alfabeta
24 febbraio 2024, ore 18.00 | T. Greco, Curare il mondo | Matera, Libreria dell’Arco
24 febbraio 2024, ore 17.30 | A. Marzo Magno, Casanova | Ascoli, Libreria Rinascita
25 febbraio 2024, ore 11.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Reggio Emilia, Rassegna ‘Finalmente domenica!’
26 febbraio 2024, ore 18.00 | P. Martin, Storie di errori memorabili | Padova, Libreria Feltrinelli. Con Antonella Viola
26 febbraio 2024, ore 18.30 | G. Serughetti, La società esiste | Ivrea, Olivetti Leadership Institute
27 febbraio 2024, ore 17.00 | L. Mascilli Migliorini, 11 maggio 1860 | Roma, Fondazione Caetani
27 febbraio 2024, ore 21.00 | Witty Wheels, Che brava che sei! | online, Festival Filosofarti
27 febbraio 2024, ore 18.00 | S. Allievi, Governare le migrazioni. Si deve, si può | Verona, Libreria Feltrinelli
28 febbraio 2024, ore 17.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Bologna, Archiginnasio. Con Carlo Galli
29 febbraio 2024, ore 18.00 | A. Somma, Abolire il lavoro povero | Ferrara, Libraccio. Con Laura Calafà e Giovanni Verla
29 febbraio 2024, ore 18.00 | D. Salomoni, Francis Drake. Il corsaro che sfidò un impero | Roma, Biblioteca Casanatense, con gli studenti del Master in Comunicazione Storica dell’Università Roma Tre
gennaio 2024
10 gennaio 2024, ore 14.15 | F. Barbera, Le piazze vuote, G. Serughetti, La società esiste | Milano, Università Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Aula Pagani, Edificio U7 (piano III). Con Fabrizio Barca, Paolo Gerbaudo, Lavinia Bifulco, Emanuele Polizzi. Coordina Marina Calloni
16 gennaio 2024, ore 17.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Milano, Università Cattolica, sala Maria Immacolata. Con Maria Cristina Messa e Mario Monti
16 gennaio 2024, ore 17.30 | S. Allievi, Governare le migrazioni. Si deve, si può | Milano, Libreria Claudiana. Con Edoardo Vigna
16 gennaio 2024, ore 18.30 | F. Armao, Capitalismo di sangue | Milano, Ostello bello (associazione Sottosopra). Con Aldo Giannuli
17 gennaio 2024, ore 16.00 | S. Colarizi, La resistenza lunga | Roma, Quirinale, Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. Con Emilio Gentile e Luciano Zani
17 gennaio 2024, ore 18.30 | H. Sauer, L’invenzione del bene e del male | Roma, Zalib. Con Maura Gancitano
17 gennaio 2024, ore 18.30 | S. Mancuso, Fitopolis | Bologna, Fondazione MAST. Ingresso libero su prenotazione
17 gennaio 2024, ore 18.15 | E. Stolfi, Prima lezione di diritto romano | Brescia, Libreria Rinascita
19 gennaio 2024, ore 19.30 | M. Di Vito, La pista anarchica | Roma, Spazio anarchico Gruppo Bakunin
20 gennaio 2024, ore 17.30 | G. Brizzi, Imperium. Il potere a Roma | Piacenza, Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (in collaborazione con l’Associazione Storica e Archeologica Piacentina)
22 gennaio 2024, ore 18.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Pistoia
24 gennaio 2024, ore 15.00 | S. Cassese, Le strutture del potere | Viterbo, Università, Aula Magna (in collaborazione con Caffeina)
24 gennaio 2024, ore 18.00 | G. Caravale, Senza intellettuali | Torino, Circolo dei lettori, Sala grande. Con Juan Carlos De Martin e Chiara Saraceno
24 gennaio 2024, ore 17.30 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Roma, Camera di commercio con Maria Elena Boschi, Roberto Gualtieri, Gianni Letta. Modera Maria Latella
25 gennaio 2024, ore 14.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bologna, CIMET
25 gennaio 2024, ore 18.00 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Torino, Circolo dei Lettori. Con Enrico Manera
26 gennaio 2024, ore 18.00 | V. Roghi, La lettera sovversiva | Padova, la Feltrinelli, via San Francesco 7. Con Patrizia Tazza e Antonio Giacobbi
dicembre 2023
1 dicembre 2023, ore 18.00 | I. Eramo, Il mondo antico in 20 stratagemmi | Foggia, Libreria Velasquez
1 dicembre 2023, ore 18.00 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Padova, Libreria Feltrinelli. Con Azzurra Tafuro
1 dicembre 2023, ore 18.30 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Bitritto, Castello Svevo
2 dicembre 2023, ore 18.00 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Milano, Refettorio Ambrosiano. Con Agostino Picicco, Camillo de Milato. Modera Costanza Cavalli
2 dicembre 2023, ore 18.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Bari, Libreria Laterza
2 dicembre 2023, ore 18.00 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Modica, Libreria Mondadori
3 dicembre 2023, ore 16.30 | G. Traina, La prima guerra mondiale della storia | Torino, Festival del Classico
3 dicembre 2023, ore 19.00 | F. Cardini, La deriva dell’Occidente | Torino, Festival del classico, Sala Grande. Con Alessandro Aresu, Martin Wolf, Luciano Canfora. Coordina Beppe Severgnini
4 dicembre 2023, ore 20.45 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Cinisello Balsamo, Villa Casati Stampa (con ACLI)
6-10 dicembre 2023 | Più libri più liberi, Roma: gli appuntamenti con gli autori e le autrici Laterza
7 dicembre 2023, ore 11.00 | T. Greco, Curare il mondo | Siena, Università per stranieri. Con Tomaso Montanari
7 dicembre 2023, ore 16.00 | C. Bottici, Nessuna sottomissione | Roma, Università La Sapienza, Villa Mirafiori. Con Donatella Di Cesare, Caterina Botti e Federico Zappino. Organizzazione e info: caterina.botti@uniroma1.it
7 dicembre 2023, ore 17.30 | A. Marzo Magno, Casanova | Venezia, Ateneo Veneto, Sala Lettura. Con Michele Gottardi e Antonio Trampus
7 dicembre 2023, ore 18.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Firenze, Auditorium Polimoda, Manifattura Tabacchi
11 dicembre 2023, ore 17.30 | S. Ballestra, La sibilla | Milano, Camera del Lavoro (Fondazione Badaracco). Con Valeria Palumbo
12 dicembre 2023, ore 18.00 | M. Di Vito, La pista anarchica | Jesi, Palazzo dei Convegni. Con Roberto Gargamelli
13 dicembre 2023, ore 17.30 | A. D’Attorre, Metamorfosi della globalizzazione | Roma, Fondazione Nenni. Con Claudio Martelli, Stefano Fassina, Luciana Borsatti, Paolo Borioni. Modera Tiziana Buccico
13 dicembre 2023, ore 17.00 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Bologna, Biblioteca Walter Bigiavi, Aula seminari 4° piano. Con Pier Giorgio Ardeni, modera Paolo Manasse
14 dicembre 2023, ore 17.30 | G. Pastorella, Exit only | Lecce, Convitto Palmieri
15 dicembre 2023, ore 17.30 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Sestri Levante, Sala Bo, Palazzo Fascie (in collaborazione con Anpi)
16 dicembre 2023, ore 17.30 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Genova, Circolo Bianchini. Con Elisabetta Violani
17 dicembre 2023, ore 17.00 | L. Schettini, L’ideologia gender è pericolosa | Roma, Tuba
18 dicembre 2023, ore 17.00 | G. Samarani – S. Graziani, La Cina rossa. Storia del Partito comunista cinese | Milano, Istituto Confucio – online
19 dicembre 2023, ore 17.30 | C. Greppi, Un uomo di poche parole | Sestri Levante, Aula Magna IIS Natta Deambrosis (in collaborazione con Anpi)
19 dicembre 2023, ore 18.00 | G. Serughetti, La società esiste | Torino, Circolo dei Lettori, sala Gioco. Con Jacopo Rosatelli, Marco Revelli
novembre 2023
03 novembre 2023, ore 20.00 | C. Colombini, Anche i partigiani però… | Cagliari, Festival Mondo Eco. Casa Saddi
05 novembre 2023, ore 12.00 | F. Cardini, La deriva dell’Occidente | Torino, Circolo dei Lettori, Rassegna ‘Radici’. Con Giuseppe Culicchia. Introduce Elena Loewenthal
06 novembre 2023, ore 15.00 | T. Greco, Curare il mondo | Roma, LUMSA
06 novembre 2023, ore 18.00 | T. Greco, Curare il mondo | Roma, Libreria L’altracittà
07 novembre 2023, ore 18.00 | C. Bottici, Nessuna sottomissione | Bologna, Gender Bender Festival, Biblioteca Renzo Renzi
08 novembre 2023, ore 17.30 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Milano, Aula N14 Bocconi. Con Camilla Buzzacchi, Floriana Cerniglia, Giovanni Fattore, Alberto Zanardi
08 novembre 2023, ore 18.30 | F. Barbera, Le piazze vuote | Firenze, Manifattura Tabacchi con Massimo Bressan e Francesca Mazzocchi
09 novembre 2023, ore 17.30 | Medici con l’Africa Cuamm, Africa, andata e ritorno | Napoli, Centro culturale Officine Gomitoli
09 novembre 2023, ore 18.45 | G. Serughetti, La società esiste | Brescia, Libreria Rinascita
09 novembre 2023, ore 18.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Firenze, Libraccio. Con Eugenio Giani e Dario Nardella
09 novembre 2023, ore 18.30 | L. Tripaldi, Gender tech | Roma, Libreria Antigone
09 novembre 2023, ore 18.30 | E. Paolini – M.C. Paolini (Witty Wheels), Che brava che sei! | Bologna, Gender Bender Festival – DAS
09 novembre 2023, ore 21.00 | A. Barbero, All’arme all’arme! I priori fanno carne! | Lecco, Auditorium della Casa dell’economia
10 novembre 2023, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Verona, Libreria Feltrinelli con Anna Martellato
10 novembre 2023, ore 20.15 | E. Evangelista, Amazzonia | Roverè della Luna (TN), Circolo Culturale Ricreativo
10 novembre 2023 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Ragusa
12 novembre 2023, ore 17 .00 | A. Barbero, All’arme all’arme! I priori fanno carne! | Torino, OGR, Sala Fucine. Con Marco Zatterin
13 novembre 2023, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Padova Libreria Feltrinelli. Con Sara Zanferrari
13 novembre 2023, ore 18.30 | G. Serughetti, La società esiste | Milano, Feltrinelli piazza Duomo. Con Susanna Camusso e Mario Ricciardi
13 novembre 2023, ore 20.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Nove (VC)
14 novembre 2023, ore 20.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Modena
13-19 novembre 2023 | Bookcity Milano: gli appuntamenti Laterza
15 novembre 2023, ore 18.45 | F. Barbera, Le piazze vuote | Brescia, Libreria Rinascita
15 novembre 2023, ore 18.00 | F. Todero, Terra irredenta, terra incognita | Trieste, Libreria Ubik. Con Raoul Pupo
15 novembre 2023, ore 18.00 | C. Vercelli, Israele. Una storia in 10 quadri | Ferrara, MEIS, Leggere il presente
15 novembre 2023, ore 21.00 | S. Allievi, Governare le migrazioni. Si deve, si può | Trento, Bookique
15-19 novembre 2023 | Scrittorincittà, Cuneo: gli appuntamenti Laterza
16 novembre 2023, ore 18.45 | E. Evangelista, Amazzonia | Brescia, Libreria Rinascita
16 novembre 2023 | C. Greppi, Un uomo di poche parole | Firenze, Memoriale degli italiani di Auschwitz
16 novembre 2023, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Noale, Palazzo della Loggia. Con Sara Zanferrari
17 novembre 2023, ore 17.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Bergamo, Libreria Incrocio Quarenghi
17 novembre 2023, ore 18.00 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Roma, Ex Snia, Logos. Con Luca Casarotti. Coordina Luciano Governali
18 novembre 2023, ore 16.30 | S. Ballestra, La sibilla | Padova, Il libro nel bicchiere – Caffè Donna Paola. Con Morena Marsilio
18 novembre 2023, ore 18.00 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Torino, Arsenale della Pace SERMIG con Matteo Spicuglia
20 novembre 2023, ore 18.00 | Medici con l’Africa Cuamm, Africa, andata e ritorno | Bari, Libreria Laterza
20 novembre 2023, ore 21.00 | T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil | Torino, Circolo dei Lettori
21 novembre 2023, ore 17.30 | T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil | Genova, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (Libreria San Paolo)
22 novembre 2023, ore 15.30 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Torino, Biblioteca Civica Natalia Ginzburg (con CGIL Spi). Intervengono Vincenzo Santangelo e Barbara Berruti
24 novembre 2023, ore 18.30 | C. Bottici, Nessuna sottomissione | Firenze, L’eredità delle donne OFF. Caffè letterario Il Conventino, sala Artusi. Con Daniela Belliti e le conclusioni di Grazia Francescato
25 novembre 2023, ore 16.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Firenze, L’eredità delle donne. Con Edoardo Vigna
27 novembre 2023, ore 19.00 | Storia del mare: presentazione del podcast di Alessandro Vanoli | Roma, Zalib
28 novembre 2023, ore 17.30 | S. Perrella, Calvino | Palermo, Amici del libro a Salinas. Museo archeologico regionale Antonino Salinas
28 novembre 2023, ore 18.00 | S. Mancuso, Fitopolis | Milano, Feltrinelli piazza Piemonte. Con Paolo Cognetti
29 novembre 2023, ore 16.00 | Fare cose con le parole. Ricordando Carla Bazzanella | Università degli Studi di Torino, sede di Collegno Certosa. Padiglione IV, Aula Magna
29 novembre 2023, ore 18.00 | I. Eramo, Il mondo antico in 20 stratagemmi | Bari, Libreria Laterza
30 novembre 2023, ore 18.00 | A. Marzo Magno, Casanova | Vicenza, Baldilibri
30 novembre 2023, ore 18.00 | L. Tripaldi, Gender tech | Varese, Libreria degli Asinelli
ottobre 2023
2 ottobre 2023, ore 18.00 | C. Greppi, Un uomo di poche parole | Trieste, Università
3 ottobre 2023, ore 17.30 | L. Sansone, La Galassia Lombroso | Roma, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Con Emmanuel Betta e Marco D’Eramo
4 ottobre 2023, ore 17.30 | T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil | Pisa, Libreria Pellegrini. Con Giancarlo Gaeta e Silvia Guidi
5 ottobre 2023, ore 17.30 | J. Foot, Gli anni neri | Parma, Aula Magna Università
5 ottobre 2023, ore 17.00 | V. Lomellini, La diplomazia del terrore | Fondazione Einaudi [online]. Con Stefano Bianchini e Alessandro Brogi
6 ottobre 2023, ore 13.30 | A. Iannace, Storia della terra | Napoli, Campania Libri Festival
6 ottobre 2023, ore 11.30 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Narni, Festival di Sociologia
6 ottobre 2023, ore 18.00 | V. Santoni, Dilaga ovunque | Firenze, Galleria street levels
6 ottobre 2023, ore 18.00 | A. Iannace, Storia della terra | Roma, Libreria Borri Termini
7 ottobre 2023, ore 17.00 | S. Allievi, Governare le migrazioni. Si deve, si può | Padova, Fiera delle Parole
7 ottobre 2023, ore 18.00 | V. Santoni, Dilaga ovunque | Lupicciano, Rassegna Custodi della Terra
7 ottobre 2023, ore 18.00 | T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil | Torino, Giornate della legalità. Con Valeria Marcenò
8 ottobre 2023, ore 16.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Lucca, Pianeta Terra Festival. Con Alessandra Viola
11 ottobre 2023, ore 18.00 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Bari, Libreria Laterza
12 ottobre 2023, ore 17.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bolzano, Libreria Ubik. Con Daniel Alfreider. Modera Paolo Mantovan
12 ottobre 2023, ore 18.00 | G. Caravale, Senza intellettuali | Lecce, Conversazioni sul Futuro, Officine Cantelmo. Con Marino Sinibaldi, Luigi De Luca, Fabiana Cicirillo e Pierpaolo Lala
12 ottobre 2023, ore 19.00 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Giovinazzo, Sala San felice. Con Oscar Iarussi e Michele Sollecito
13 ottobre 2023, ore 14.30 | C. Greppi, Un uomo di poche parole | Padova, Cicap Fest
13 ottobre 2023, ore 18.00 | L. Tripaldi, Gender tech | Venezia, Libreria Toletta. Con Sara Deon
13 ottobre 2023, ore 18.00 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Bari, Libreria Laterza
14 ottobre 2023, ore 10.00 | P. Macry, La destra italiana | Napoli, Sabato delle idee, NapHub Spazio Eventi. Con Mauro Calise, Sebastiano Maffettone, Italo Bocchino. Modera Marco Demarco
14 ottobre 2023, ore 16.30 | V. Alfieri Fontana, Ero l’uomo della guerra | Lecce, Conversazioni sul Futuro. Con Marta Serafini, Mattia Epifani
14 ottobre 2023, ore 17.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bologna, Pandora festival, Coopambasciatori. Dialogano con l’autore Patrizio Bianchi, Gianpiero Calzolari e Maria Luisa Parmigiani
15 ottobre 2023, ore 11.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Reggio Emilia, Finalmente domenica! Teatro Valli
16 ottobre 2023 | F. Todero, Terra irredenta, terra incognita | Bolzano, Biblioteca Claudia Augusta
16 ottobre 2023, ore 20.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Novara, Oratorio PIME
17 ottobre 2023, ore 18.00 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Torino, Polo 900 Istoreto. Con Giovanni De Luna e Santo Peli
17 ottobre 2023, ore 18.30 | Medici con l’Africa Cuamm, Africa, andata e ritorno | Torino, Biblioteca civica Calvino. Con don Dante Carraro, Giuseppe Laterza e Fabio Geda
19 ottobre 2023, ore 19.30 | L. Tripaldi, Gender tech | Roma, 30 Formiche. Con Claudia Durastanti
19 ottobre 2023, ore 18.00 | Medici con l’Africa Cuamm, Africa, andata e ritorno | Padova, Centro culturale Altinate San Gaetano. Con Giuseppe Laterza e Dante Carraro
20 ottobre 2023, ore 11.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Treviso, Festival della Statistica
20 ottobre 2023, ore 17.30 | M. Mazzucato – R. Collington, Il grande imbroglio | L’Aquila, Palazzo Tre Marie. Con Mario Pianta
20 ottobre 2023, ore 18.00 | F. Todero, Terra irredenta, terra incognita | Udine, libreria Tarantola. Con Giampaolo Borghello e Raoul Pupo
21 ottobre 2023, ore 16.15 | L. Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido | Lecco, Immagimondo Festival, Sala Conferenze di Palazzo delle Paure. Con Tino Mantarro
23 ottobre 2023, ore 16.30 | E. Evangelista, Amazzonia | Roma, Camera dei Deputati, Sala Matteotti
23 ottobre 2023, ore 18.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Roma, Istituto Sturzo. Introduce Fabio Bistoncini. Interverranno con l’autore: Giancarlo Giorgetti, Beatrice Lorenzin, Carlo Calenda. Modera Marianna Aprile.
23 ottobre 2023, ore 18.00 | A. Carandini, Io Nerone | Bologna, Salaborsa (con libreria Coop). Con Angelo Panebianco e Tommaso Gnoli
24 ottobre 2023, ore 17.30 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia |Monopoli, con i Presìdi del Libro
24 ottobre 2023, ore 20.45 | C. Greppi, Un uomo di poche parole | Bergamo, Rassegna ‘Molte fedi’, Sala Gamma, Torre Boldone
24 ottobre 2023, ore 18.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Lanuvio
25 ottobre 2023, ore 17.30 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Milano, Camera del Lavoro, Sala Buozzi. Con Luca Stanzione, Stefano Fassina, Pierfrancesco Majorino, Giordana Pallone, Benedetta Liberali. Modera Marianna Bruno
26 ottobre 2023, ore 21.00 | F. Cardini, La deriva dell’Occidente | Cesano Maderno, Voci della Storia, Auditorium Disarò
27 ottobre 2023, ore 12.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bari, Punto Sud
27 ottobre 2023, ore 17.00 | C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana | Firenze, Memoriale delle deportazioni
27 ottobre 2023, ore 17.00 | G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo | Perugia, Umbrialibri, Palazzo Graziani, Sala delle Colonne
27 ottobre 2023, ore 17.30 | V. Lomellini, La diplomazia del terrore | Bassano del Grappa, Biblioteca civica
27 ottobre 2023, ore 18.00 | L. Tripaldi, Gender tech | Bologna, Libreria delle Donne
27 ottobre 2023, ore 18.00 | F. Terracina, Mal di Sicilia | Palermo, Libreria Modus Vivendi. Con Beatrice Agnello
27 ottobre 2023, ore 18.00 | P. Borruso, Debre Libanos | Parma, Biblioteca Cittadella Solidale
28 ottobre 2023, ore 19.00 | E. Evangelista, Amazzonia | Albano, Libreria Le Promesse
28 ottobre 2023, ore 16.00 | F. Barbera, Le piazze vuote | Ancona, Circolo operaio Arci ‘W. Germontari’. Con Vittorio Sergi, Nino Lucantoni, coordina Giovanni Fraticelli
30 ottobre 2023, ore 11.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Bologna, Università, lectio magistralis
30 ottobre 2023, ore 18.30 | S. Allievi, Governare le migrazioni. Si deve, si può | Milano, Teatro Parenti
30 ottobre 2023, ore 19.00 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Corato, Libreria Sonicart
31 ottobre 2023, ore 17.00 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Genova, Libreria Coop Porto Antico. Con Giovanni Toti e Marco Bucci
31 ottobre 2023, ore 18.30 | E. Giovannini, I ministri tecnici non esistono | Genova, Festival della Scienza
settembre 2023
28 settembre 2023, ore 17.30 | V. Lomellini, La diplomazia del terrore | Fano, Rassegna La storia ritrovata. Mediateca Montanari. con Anna Tonelli
28 settembre 2023, ore 18.00 | R. Bizzocchi, Romanzo popolare. Come i Promessi sposi hanno fatto l’Italia | Sondrio, Sala Fabio Besta – Banca Popolare di Sondrio
28 settembre 2023 17.30 | G. Viesti, Contro la secessione dei ricchi. Un progetto per spaccare l’Italia | Chieti, Sala Cascella, Camera di Commercio
29 settembre 2023, ore 20.45 | G. Barbujani, Come eravamo | Brescia, Rassegna Libri in movimento
30 settembre 2023, ore 15.00 | V. Santoni, Dilaga ovunque | Pisa, Pisabook Festival