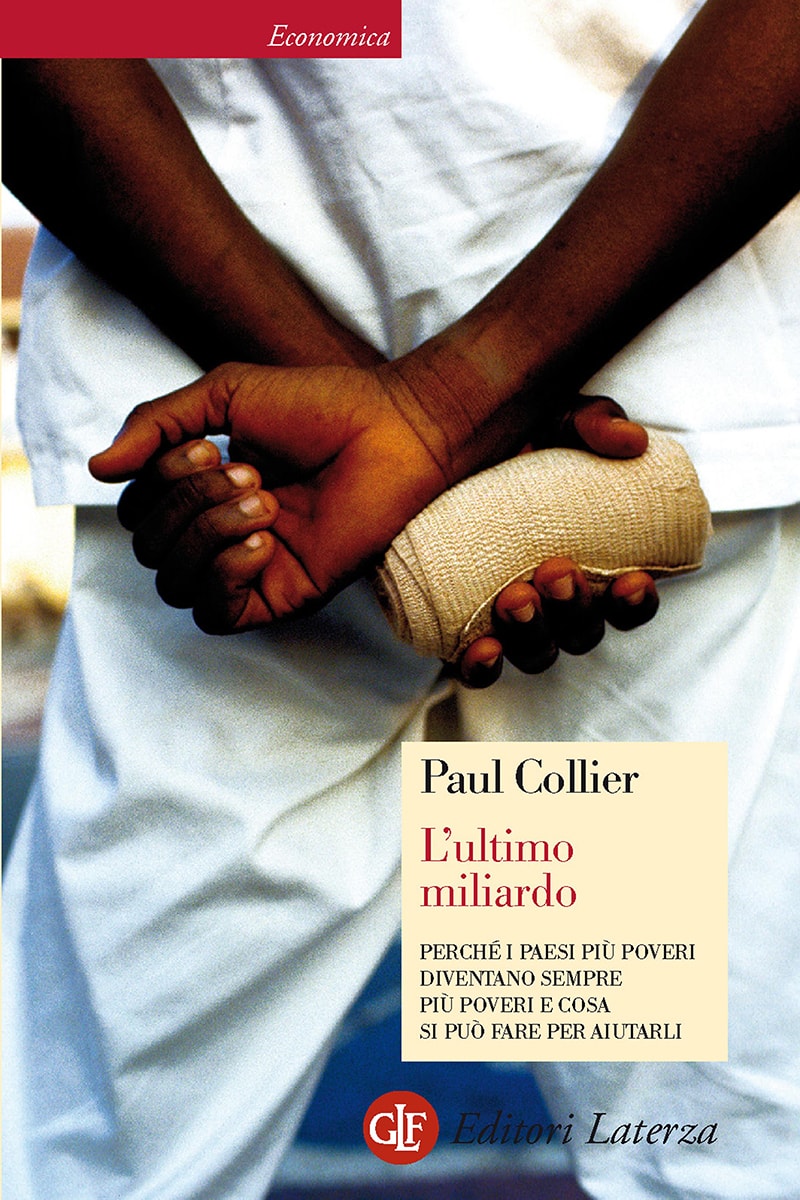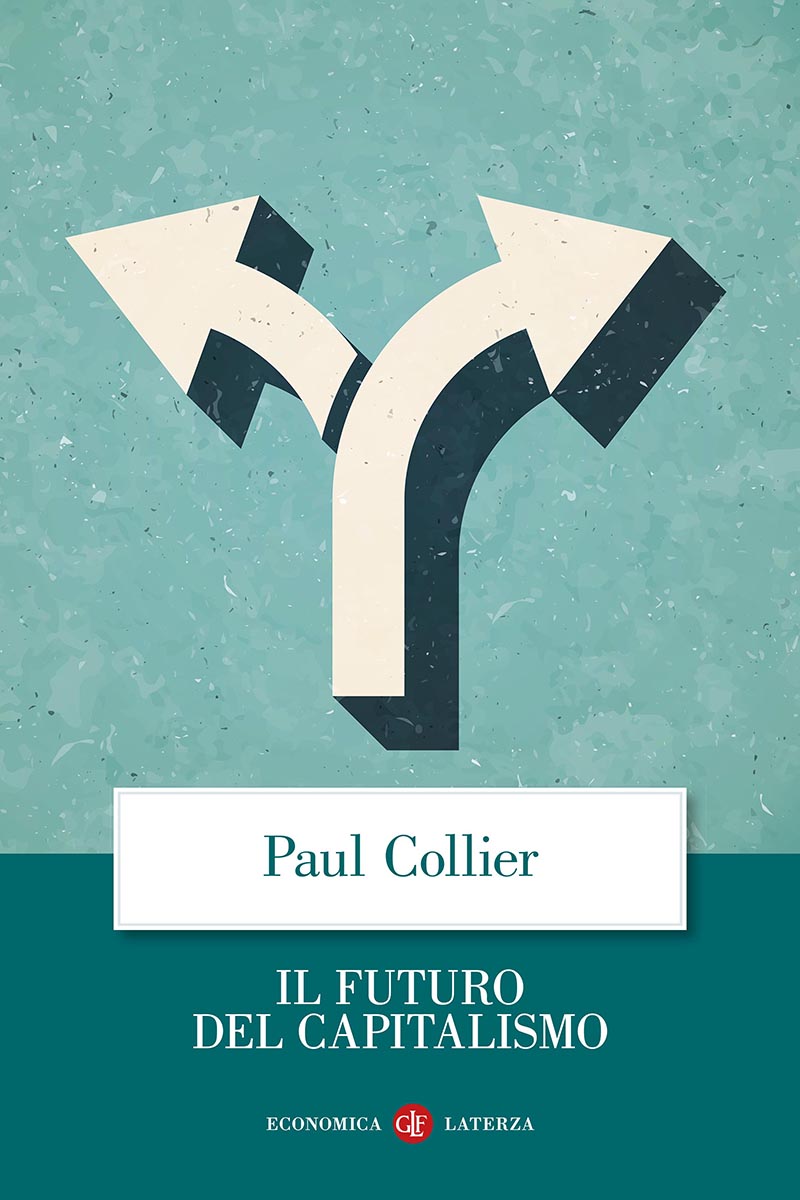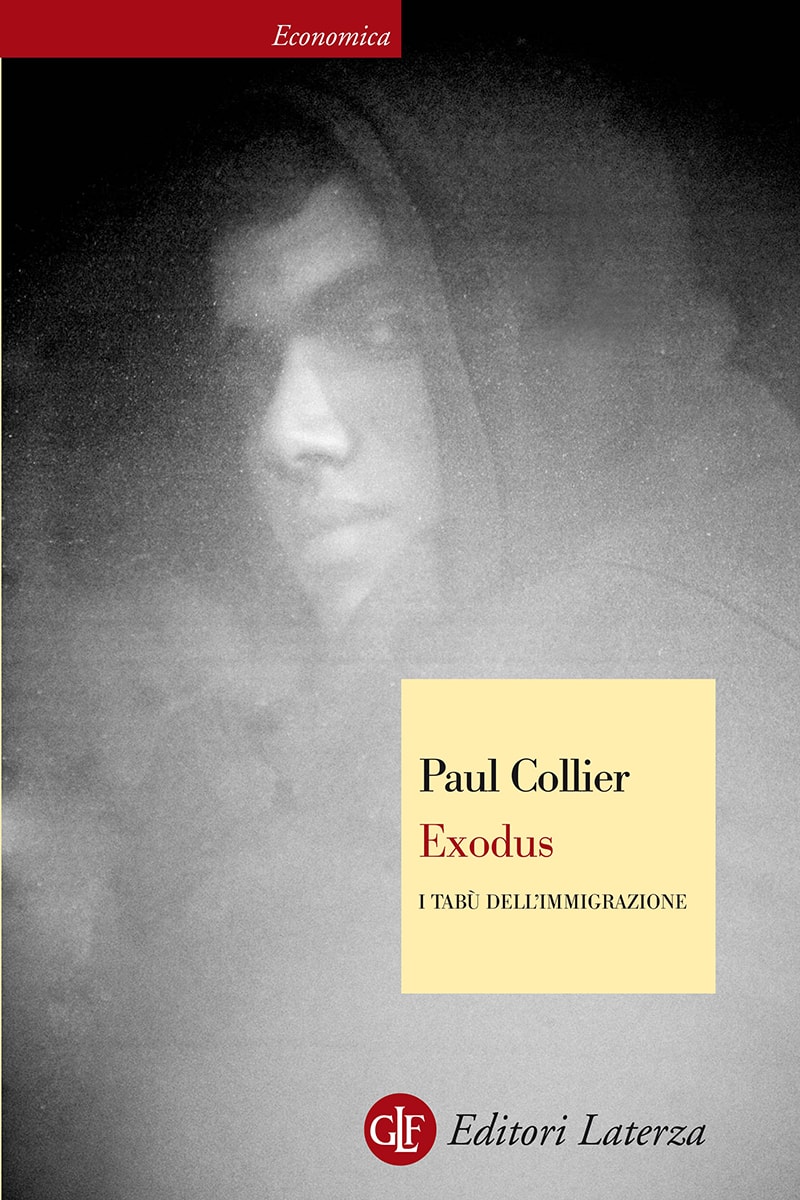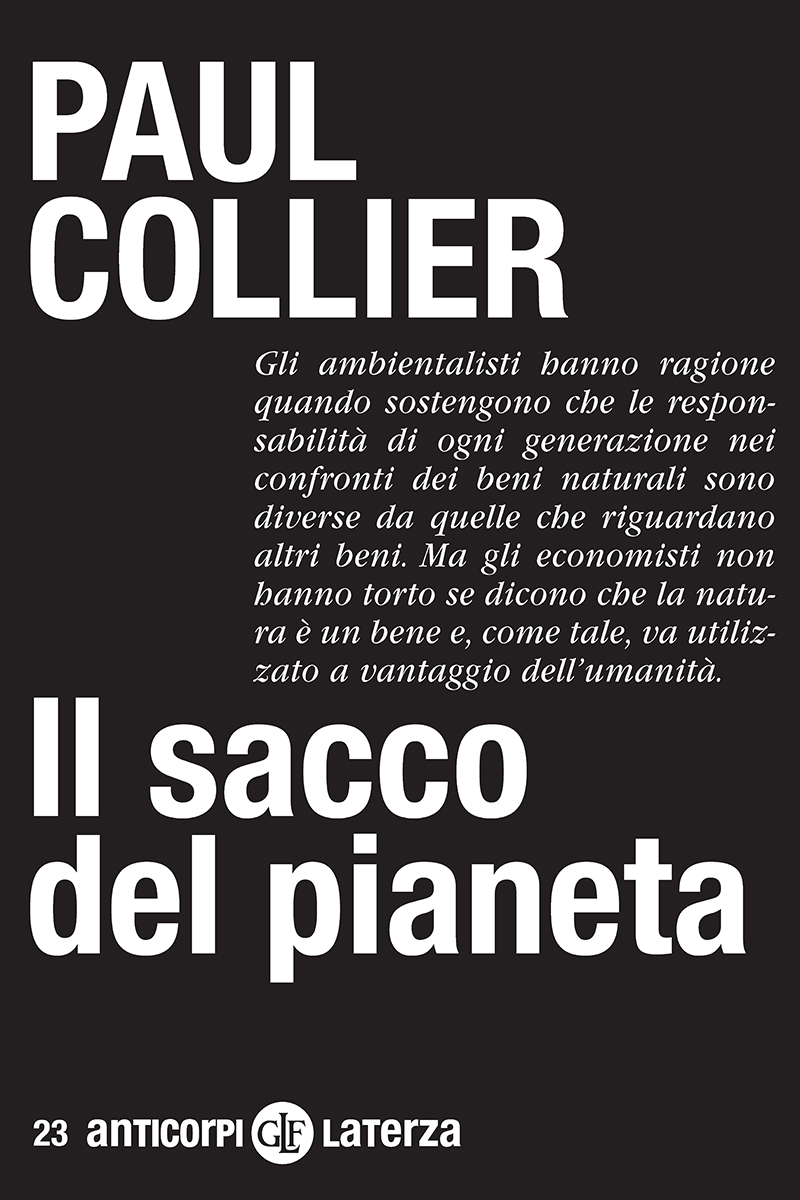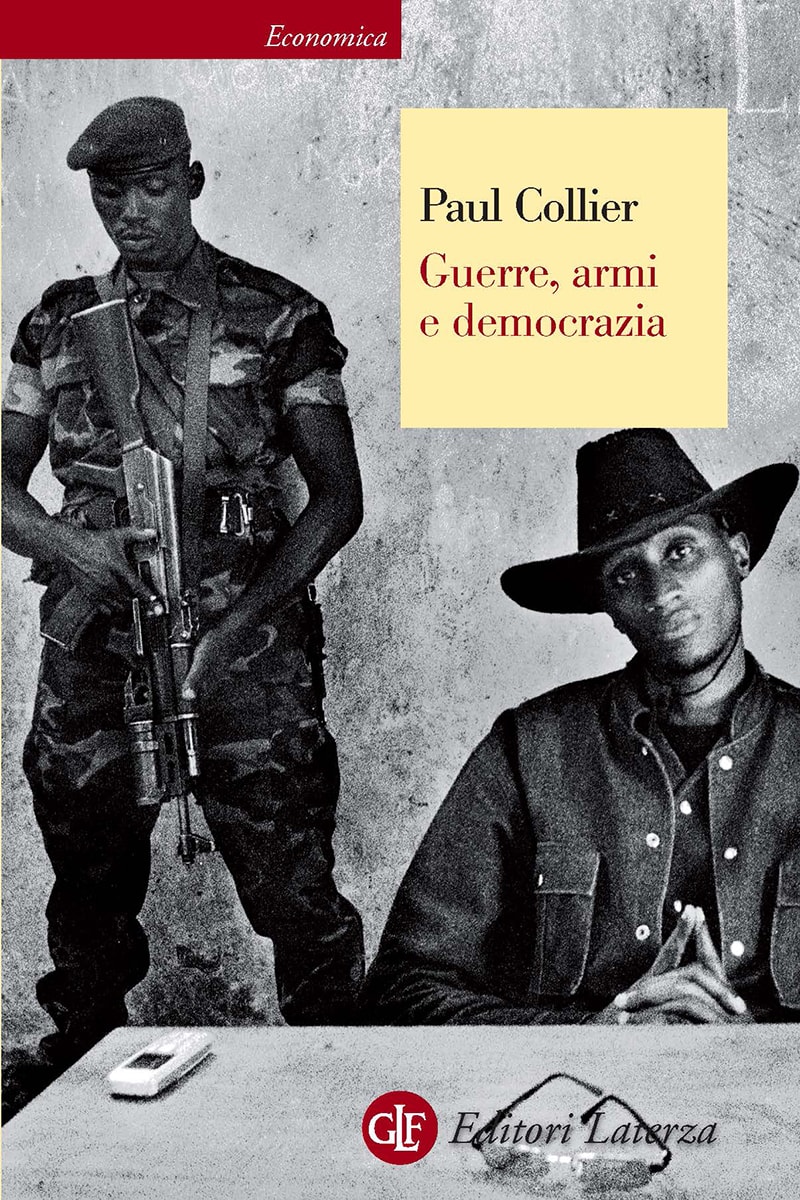Prefazione
Nel 1968 studiavo a Oxford. Ricordo che avevo aderito a un gruppo chiamato gli Studenti
socialisti rivoluzionari di Oxford, un nome che oggi suona più ridicolo di una parodia.
Ma in quel periodo sembrava tutto facile. Quando mi sono laureato, volevo mettere
la mia formazione economica al servizio dell’Africa. I nuovi paesi africani non disponevano
di mezzi sufficienti, e pochi africani avevano seguito il tipo di studi che io avevo
appena completato. In quegli anni, molti studenti di Oxford avevano legami familiari
con l’Africa, in quanto i loro padri erano stati amministratori delle colonie. Non
era il mio caso: mio padre era un macellaio dello Yorkshire. Ma in parte quei legami
coloniali devono avermi un po’ contagiato: il padre di un mio amico era stato il governatore
generale di un piccolo paese chiamato Nyasaland, sul quale mi documentai a fondo.
Quel che avevo letto mi spinse ad andarci. Ribattezzato Malawi, era il paese più povero
del continente. È più facile cambiare il nome che cambiare il paese: a distanza di
trentacinque anni, il Malawi è ancora spaventosamente povero come allora. Dubito che
la situazione sarà molto diversa tra altri trentacinque anni, a meno che... Questo
libro parla proprio di quell’«a meno che».
Il Malawi non è cambiato molto negli ultimi trentacinque anni, e per alcuni aspetti
neanche io: continuo a lavorare sull’Africa, oggi come professore a Oxford. Nel frattempo,
sono stato professore a Harvard e ho diretto l’ufficio ricerche della Banca Mondiale,
dove sono stato chiamato da Joe Stiglitz proprio per concentrare l’attenzione sui
paesi più poveri. Difatti il mio primo incarico è stata una missione in Etiopia insieme
a Joe. Mi ero appena sposato, e quel viaggio è stato la mia luna di miele, solo che
la trascorsi con Joe invece che con mia moglie. Per fortuna, lei si mostrò comprensiva
– che fosse per pura coincidenza o per l’attrazione reciproca tra spiriti affini,
dopo l’università mia moglie aveva lavorato nel Malawi.
Questo libro parla dei Malawi e delle Etiopie sul nostro pianeta, di quella minoranza
di paesi in via di sviluppo agli ultimi gradini del sistema economico globale. Alcuni
di essi, come il Malawi, sono sempre stati tra gli ultimi. Altri, tra cui la Sierra
Leone, un tempo erano meno poveri dell’India e della Cina. I paesi che oggi sono agli
ultimi posti si distinguono non soltanto perché sono i più poveri ma anche perché
non sono riusciti a crescere. Non seguono lo schema di sviluppo della maggior parte
dei paesi; vanno alla deriva. A mano a mano che l’India e la Cina hanno cominciato
a crescere seriamente insieme ad altri paesi nelle stesse condizioni, il quadro complessivo
della povertà è diventato sempre più confuso, lasciando nell’ombra i casi divergenti.
È vero che alcuni paesi devono stare relativamente peggio perché altri stiano relativamente
meglio, ma il declino di quelli che oggi si situano ai gradini più bassi non è soltanto
relativo: spesso è assoluto. Molti di loro non restano semplicemente indietro, stanno
anche crollando.
Negli ultimi anni, gran parte del mio lavoro si è concentrato sulle guerre civili.
Volevo capire perché i conflitti tendessero sempre più a coinvolgere i paesi africani
a basso reddito. Progressivamente, ho elaborato la nozione di «trappola del conflitto»;
in breve, determinate circostanze economiche rendono un paese incline alla guerra
civile e, una volta avviato il conflitto, la spirale della violenza diventa una trappola
da cui è difficile uscire. Ho capito che la trappola del conflitto poteva essere una
spiegazione per quei paesi che oggi sono il fanalino di coda dell’economia mondiale.
Ma c’era anche dell’altro. Il Malawi non ha conosciuto conflitti dall’indipendenza
a oggi, eppure non si è sviluppato. Lo stesso vale per il Kenya e per la Nigeria,
paesi sui quali ho scritto dei libri in momenti diversi della mia carriera, e che
non si assomigliavano tra loro, né somigliavano al Malawi. Non penso neanche che la
povertà costituisca di per sé una trappola. Questi casi di mancato sviluppo si sono
verificati sullo sfondo del successo dello sviluppo mondiale e la maggior parte delle
popolazioni sta effettivamente uscendo dalla povertà. Nel 1980 la povertà ha cominciato
a diminuire a livello mondiale per la prima volta nella storia. Inoltre, tali casi
non riguardano esclusivamente l’Africa. Il mancato sviluppo si è verificato anche
altrove: vedi Haiti, il Laos, la Birmania e i paesi dell’Asia centrale, di cui l’Afghanistan
è l’esempio più clamoroso. Data la diversità di situazioni, è impossibile trovare
un’unica spiegazione che vada bene per tutti.
Una delle ragioni del grande successo di tante teorie che attribuiscono questo fallimento
a un unico fattore è che oggi gli studiosi universitari tendono a specializzarsi:
sono preparati a generare raggi di luce intensi ma circoscritti. Tuttavia nel corso
della mia carriera ho scritto libri sullo sviluppo rurale, sui mercati del lavoro,
sulle crisi macroeconomiche, sugli investimenti e sui conflitti. E, come ho detto,
per un certo periodo ho lavorato per Joe Stiglitz, che si interessava davvero di tutto
e su quasi tutto aveva qualcosa di brillante da dire. Questa ampiezza di interessi
ha i suoi vantaggi. Alla fine, ho capito che esistono quattro diverse trappole che
spiegano la situazione dei paesi che oggi costituiscono il fanalino di coda. Nell’insieme,
la loro popolazione si aggira intorno al miliardo di persone. Se nessuno interviene,
nel corso del prossimo ventennio questo gruppo divergerà progressivamente dal resto
dell’economia mondiale, formando un ghetto di miseria e di scontento.
I problemi che colpiscono quei paesi sono molto diversi da quelli che abbiamo affrontato
negli ultimi quarant’anni nei cosiddetti «paesi in via di sviluppo» – espressione
che indica in sostanza tutti i paesi tranne quelli più avanzati, che rappresentano
soltanto un sesto della popolazione mondiale. Finora abbiamo definito i paesi in via
di sviluppo in maniera da comprendervi cinque dei sei miliardi degli individui che
abitano il pianeta. Ma questi paesi non sono tutti uguali. Quelli in cui lo sviluppo
è fallito si trovano ad affrontare problemi irrisolvibili, che non riguardano quelli
che invece stanno andando avanti. In realtà, abbiamo percorso la parte più facile
dello sviluppo mondiale; quella che ci resta per completare il lavoro è la più difficile.
Eppure dobbiamo completarlo, perché in un mondo agiato sarà sempre più impossibile
tollerare l’esistenza di un ghetto povero in cui vive un miliardo di persone.
Purtroppo non si tratta soltanto di elargire denaro a quei paesi. Se così fosse, sarebbe
relativamente semplice, perché non sono tanti. Fatte salve alcune eccezioni degne
di nota, le politiche degli aiuti non funzionano granché da quelle parti, perlomeno
le politiche adottate in passato. Il cambiamento nelle società più arretrate deve
partire soprattutto dall’interno; non possiamo imporlo noi. In tutte quelle società
esiste un conflitto tra individui coraggiosi, che vogliono il cambiamento, e un intreccio
di interessi che lo ostacola. Finora, ci siamo perlopiù limitati ad assistere a questo
conflitto. Possiamo fare molto di più per sostenere i riformatori. Ma a tal fine dobbiamo
ricorrere a strumenti – interventi militari, la determinazione di standard internazionali
e politiche commerciali – che fino ad oggi sono stati utilizzati per altri scopi.
Le agenzie che controllano questi strumenti non conoscono i problemi di questo «ultimo
miliardo» di persone e non se ne interessano. Dovranno imparare, e i governi dovranno
imparare a coordinare un’ampia gamma di politiche.
Queste idee aprono nuovi orizzonti, che vanno al di là delle divisioni politiche.
La sinistra scoprirà che gli approcci che ha sempre scartato, come gli interventi
militari, il commercio e gli incentivi alla crescita, sono mezzi indispensabili per
raggiungere gli obiettivi che persegue da tempo. La destra scoprirà che, a differenza
della sfida della riduzione della povertà globale, il problema dell’«ultimo miliardo»
non potrà risolversi automaticamente con la crescita mondiale, e che la negligenza
di oggi diventerà l’incubo di domani per la sicurezza del mondo che lasceremo ai nostri
figli. Possiamo venire a capo di questo problema; anzi, dobbiamo. Ma per riuscirci
dobbiamo far convergere i nostri sforzi su un unico obiettivo.
A questo scopo è necessario cambiare il modo di pensare, non soltanto delle agenzie
di sviluppo ma anche dell’elettorato, le cui opinioni definiscono la gamma di azioni
possibili. In assenza di un elettorato informato, i politici continueranno a servirsi
dell’«ultimo miliardo» esclusivamente per i loro servizi fotografici, invece di promuoverne
l’autentica trasformazione. L’obiettivo di questo libro è quello di far cambiare il
modo di considerare tali problemi; è stato scritto per essere letto, quindi ho evitato
le note a piè di pagina e tutto il noioso apparato tradizionale dei testi accademici.
Ho cercato di renderne piacevole la lettura. Ma non crediate che ciò che ho da dire
sia soltanto frutto di immaginazione. Il mio libro si basa su una montagna di documenti
tecnici, pubblicati su riviste specializzate e sottoposti a valutazioni indipendenti.
Ne elenco alcuni alla fine del libro.
La ricerca, spesso, somiglia a un’inchiesta. Si parte da una domanda a cui sembra
impossibile rispondere: quanti aiuti finiscono nella spesa militare, o quanti capitali
africani hanno lasciato il continente? Come si fa a rispondere a queste interrogazioni?
Chiedendo a ciascun esercito del Terzo Mondo dove abbia preso i soldi? Bussando alle
porte delle banche svizzere per chiedere informazioni sui conti africani aperti presso
di loro? Esiste un altro modo di ottenere le risposte, ed è la statistica. Ciò contrasta
con le immagini riduttive che spesso sintetizzano ciò che pensiamo di sapere del mondo.
Ad esempio, l’immagine della ribellione è spesso associata a Che Guevara, il cui poster
campeggiava sulle pareti delle stanze degli studenti della mia generazione. Quel poster
esprimeva il nostro pensiero. Le nostre nozioni in merito ai problemi dei paesi più
poveri sono piene zeppe di immagini del genere: non soltanto di ribelli valorosi,
ma anche di bambini che muoiono di fame, di aziende spietate, di politici corrotti.
Siete prigionieri di quelle immagini, ma finché lo sarete voi, lo saranno anche i
politici, in quanto fanno ciò che volete voi. Io vi porterò oltre le immagini. In
qualche caso le distruggerò. E, per farlo, mi servirò dell’evidenza statistica.
Per realizzare le mie ricerche mi sono avvalso dell’aiuto di alcuni giovani collaboratori,
molti dei quali incontrerete nelle pagine che seguono. Una di loro, Anke Hoeffler,
ha fornito un contributo essenziale a gran parte di questo lavoro. Collaboriamo da
dieci anni, secondo un copione in cui io faccio la parte del professore terribilmente
puntiglioso, mentre Anke riesce malgrado tutto a non perdere la pazienza e ad andare
avanti. Se volete farvi un’idea, forse un po’ esagerata, di come lavoriamo, pensate
alla coppia formata dall’ispettore Morse e dal suo assistente Lewis nella famosa serie
di romanzi di Colin Dexter. Come nel loro caso, anche il nostro lavoro di indagine
spesso comporta una serie di false partenze. Tuttavia, benché anch’io – come Morse
– risieda a Oxford, contrariamente a lui lavoro con un gruppo decisamente internazionale.
Come avrete capito, Anke è tedesca. Ma ci sono anche Måns, svedese; Lisa, francese;
Steve, americano di origine irlandese; Cathy, afroamericana; Victor, che viene dalla
Sierra Leone; e Phil, australiano. È solo una parte di un lungo elenco, ma serve a
dare un’idea. Tutti hanno in comune una grande pazienza, che li rende scrupolosi fino
alla nausea, e un cervello che ha consentito loro di specializzarsi in ambiti difficili
e padroneggiarli. Senza di loro questo libro non sarebbe esistito, poiché non sarebbero
esistiti i risultati su cui basare questa storia. Questo libro è un po’ come la figura
che appare quando si uniscono tra loro tutti i puntini. Ma ogni puntino è una storia
a sé. Benché non sia un testo che parli di ricerca, mi auguro che strada facendo possiate
farvi un’idea di come si faccia ricerca al giorno d’oggi, e dell’entusiasmo che si
prova quando si viene a capo di questioni impossibili.
1. Ritardo e crollo: l’ultimo miliardo
Il Terzo Mondo si è ristretto. Per quarant’anni la sfida dello sviluppo ha messo un
mondo ricco, abitato da un miliardo di persone, di fronte a un mondo povero, con cinque
miliardi di persone. Gli «obiettivi di sviluppo del millennio», fissati dalle Nazioni
Unite con l’intento di seguire l’andamento dello sviluppo fino al 2015, sono l’espressione
di questa visione. Tuttavia nel 2015 dovremo prendere atto del fatto che una simile
concezione è superata. La maggior parte di quei cinque miliardi di persone, circa
l’80%, vive in paesi che in realtà si stanno sviluppando, spesso ad un ritmo incredibilmente
sostenuto. La vera sfida dello sviluppo è costituita dalla presenza, in fondo alla
fila, di un gruppo di paesi rimasti indietro e che, in molti casi, stanno crollando.
I paesi che fanno da fanalino di coda convivono con il XXI secolo ma la loro realtà
assomiglia a quella del XIV: guerre civili, epidemie, ignoranza. Sono concentrati
soprattutto in Africa e in Asia centrale, ma ce ne sono anche altri sparsi qua e là.
Persino durante gli anni Novanta del secolo scorso – considerati, col senno di poi,
come il decennio d’oro tra la fine della guerra fredda e l’11 settembre – il reddito
dei paesi appartenenti a questo gruppo è calato del 5%. Dobbiamo imparare a invertire
le cifre a cui siamo abituati: ci sono in tutto cinque miliardi di persone che vivono
già adesso in condizioni agiate, o che perlomeno hanno imboccato la strada giusta,
e un miliardo di persone che invece rimangono inchiodate in fondo alla fila.
Si tratta di un problema serio, che non riguarda soltanto quel miliardo di persone
che vivono e muoiono in condizioni da XIV secolo. Riguarda anche noi. Il mondo del
XXI secolo, con il suo benessere materiale, i viaggi globali e l’interdipendenza economica,
è destinato a diventare sempre più vulnerabile nei confronti di queste vaste isole
dominate dal caos. E ci riguarda adesso. A mano a mano che aumenta la distanza tra
l’ultimo miliardo e un’economia mondiale sempre più sofisticata, l’integrazione non
diventerà più facile, ma più difficile.
Eppure, tanto il business dello sviluppo quanto il brusio che lo circonda negano l’esistenza
di questo problema. Il business dello sviluppo è gestito dalle agenzie per gli aiuti
e dalle imprese che si aggiudicano i contratti per la realizzazione dei progetti,
le quali si opporranno a questa tesi con la tenacia tipica delle burocrazie che si
sentono minacciate, dato che la situazione attuale è di loro gradimento. Un concetto
di sviluppo che abbraccia cinque miliardi di persone consente loro di essere presenti
ovunque o, a essere più onesti, ovunque tranne che a fianco dell’ultimo miliardo.
Nelle retrovie, le condizioni sono piuttosto dure. Tutte le agenzie di sviluppo hanno
difficoltà a inviare il proprio personale in Ciad o nel Laos; le sedi più ambite sono
quelle di paesi come il Brasile o la Cina. La Banca Mondiale possiede grandi uffici
in tutti i principali paesi a medio reddito ma non ha un singolo dipendente nella
Repubblica Centrafricana. Non aspettatevi quindi che il business dello sviluppo riveda
spontaneamente i propri orientamenti.
Il brusio che circonda lo sviluppo è prodotto da rockstar, personaggi famosi e ong. Bisogna ammettere che hanno il merito di richiamare l’attenzione sulla piaga dell’ultimo
miliardo. È grazie alle loro voci che l’Africa figura nell’agenda del G8. Però esse
devono inevitabilmente trasmettere messaggi semplici, animati dal bisogno di slogan,
di immagini, e dalla rabbia. Purtroppo, sebbene la situazione drammatica di questi
paesi si presti a facili moralismi, non si può dire altrettanto delle risposte. Si
tratta di un problema che deve essere affrontato contemporaneamente da politiche di
intervento diverse, alcune delle quali contrarie al senso comune. Non chiedete a questi
paladini di formulare un’agenda di questo tipo: a volte sono un po’ troppo emotivi
e non usano la testa.
Che dire dei governi dei paesi più arretrati? Le condizioni generali in cui versano
quei paesi sono all’origine degli estremismi. In alcuni casi, i loro leader sono psicopatici
impadronitisi del potere con le armi; in altri, si tratta di truffatori che lo hanno
comprato e in altri ancora di individui coraggiosi che cercano, contro tutte le avversità,
di costruire un futuro migliore. Persino le moderne forme di governo adottate da alcuni
di quegli Stati sono una facciata, come se i loro leader recitassero un copione. Essi
siedono ai tavoli dei negoziati internazionali, come la World Trade Organization (wto), l’Organizzazione mondiale del commercio, ma non hanno nulla da negoziare. Continuano
a occupare il loro seggio persino quando le loro società si dissolvono: il governo
della Somalia ha continuato per anni ad essere «rappresentato» a livello ufficiale
sulla scena internazionale anche se non era più in carica nel paese. Dunque, non aspettatevi
che i governi dei paesi più arretrati si uniscano per mettere a punto un’agenda pratica:
sono divisi tra banditi ed eroi, e alcuni di questi eroi non contano praticamente
nulla. Se vogliamo che il mondo del futuro sia vivibile, è necessario che gli eroi
vincano la loro battaglia. Ma i banditi possiedono le armi e il denaro e finora, di
solito, hanno avuto la meglio. E continuerà ad andare così se non cambieremo radicalmente
il nostro approccio.
Tutte le società erano povere in passato. La maggior parte di esse sta riuscendo a
sconfiggere la povertà; perché altre non ce la fanno? La risposta sta nelle trappole.
La povertà non è una trappola di per sé, altrimenti saremmo ancora tutti poveri. Cercate
di immaginare per un istante lo sviluppo come una serie di scivoli e di scale. Nel
mondo moderno globalizzato esistono delle scale favolose; la maggior parte delle società
le sta utilizzando. Ma ci sono anche alcuni scivoli, e alcune società si sono imbattute
proprio in quelli. I paesi che stanno in fondo alla fila rappresentano una minoranza
sfortunata, ma sono bloccati.
Le trappole e i paesi che ci sono caduti
Supponiamo che il vostro paese sia maledettamente povero, con un’economia pressoché
stagnante e poche persone istruite. Non dovete sforzarvi molto per immaginare una
situazione di questo tipo: è quella in cui vivevano i nostri antenati. Il duro lavoro,
le scelte oculate e l’intelligenza permettono a una società di tirarsene fuori un
po’ alla volta, a condizione di non finire in una trappola. Le trappole dello sviluppo
sono diventate un argomento alla moda nei dibattiti accademici, generando una contrapposizione
alquanto prevedibile tra destra e sinistra. La destra tende a negarne l’esistenza,
sostenendo che qualsiasi paese può sconfiggere la povertà attraverso l’adozione di
opportune politiche di intervento. La sinistra tende a ritenere che il capitalismo
globale racchiuda in sé il germe di una trappola del genere.
Il concetto di «trappola dello sviluppo» è noto da molto tempo e di recente è stato
associato al lavoro dell’economista Jeffrey Sachs, il quale si è dedicato a studiare
le conseguenze della malaria e di altri problemi sanitari. La malaria condanna i paesi
alla povertà e, a causa della povertà, il potenziale mercato per un vaccino non è
tanto allettante da spingere le società farmaceutiche a realizzare gli ingenti investimenti
necessari nel campo della ricerca. Questo libro parla di quattro trappole a cui non
è stata prestata molta attenzione: la trappola del conflitto, quella delle risorse
naturali, quella della mancanza di accessi diretti al mare, unita alla presenza di
vicini poco raccomandabili, e infine la trappola della cattiva governance in un paese piccolo. Come molti paesi in via di sviluppo che stanno ottenendo buoni
risultati, tutti quelli presi in esame in questo libro sono poveri. La loro caratteristica
comune è di essere caduti in una o nell’altra di queste trappole. Tuttavia non è impossibile
evitarle e, col tempo, alcuni paesi sono riusciti a liberarsene e hanno iniziato a
recuperare il ritardo. Purtroppo, ultimamente questo processo di recupero ha subito
una battuta d’arresto. I paesi che sono sfuggiti alle trappole soltanto nell’ultimo
decennio si sono trovati di fronte a un nuovo problema: il mercato globale di oggi
è molto più ostile nei confronti dei nuovi arrivati di quanto non fosse negli anni
Ottanta del Novecento. Può darsi che tali paesi abbiano perso il treno e oggi siano
finiti in una specie di limbo in cui la crescita è vincolata a fattori esterni; sarà
questo l’argomento della mia discussione sulla globalizzazione. Quando le isole Mauritius
si sono liberate dalle trappole, negli anni Ottanta del secolo scorso, sono balzate
a un livello di reddito medio; quando, due decenni dopo, anche il vicino Madagascar
è riuscito a fare altrettanto, non c’è stato nessun balzo.
La maggior parte dei paesi è riuscita a evitare le trappole che costituiscono l’argomento
di questo libro. Ma ci sono caduti alcuni paesi che nell’insieme raggiungono una popolazione
di circa un miliardo di persone. Questa affermazione si basa su alcune definizioni.
Ad esempio, una delle trappole riguarda l’assenza di sbocchi sul mare – benché questa
non sia una trappola di per sé. Ma quando si può dire che un paese è privo di accessi
al mare? Si potrebbe pensare che per rispondere a questa domanda sia sufficiente consultare
un atlante. Che dire allora dello Zaire che, dopo il disastroso regno del presidente
Mobutu, ha comprensibilmente cambiato il suo nome in Repubblica Democratica del Congo?
Quel paese è potenzialmente privo di sbocchi ma possiede una minuscola striscia di costa. E il Sudan è dotato
di coste, ma la maggior parte della sua popolazione vive molto lontano da esse.
Per definire le trappole ho dovuto tracciare delle linee in un certo senso arbitrarie,
e ciò crea delle zone grigie. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo è chiaramente
avviata sulla strada del successo, mentre altri si stanno altrettanto chiaramente
avviando verso ciò che potremmo chiamare un buco nero. Su alcuni, tuttavia, è davvero
difficile pronunciarsi. Forse Papua Nuova Guinea ha imboccato la strada del successo;
me lo auguro ed è così che l’ho classificata. Ma alcuni esperti che conoscono bene
quel paese scuoterebbero il capo in segno di incredulità davanti alla mia affermazione.
È inevitabile che i giudizi espressi in questo libro suscitino delle critiche. Ma
le critiche non potranno screditare la tesi di base: ovvero il fatto che esiste un
buco nero e che molti paesi ci stanno incontestabilmente finendo dentro, invece di
puntare al successo. Troverete tutti i miei giudizi esposti con cura all’interno di
queste pagine. Per il momento, vi basti sapere che le linee che ho tracciato sono
più che plausibili.
In base al modo in cui ho tracciato quelle linee risulta che nel 2006 circa 980 milioni
di persone vivono nei paesi in trappola. Poiché si tratta di popolazioni in crescita,
nel momento in cui leggerete il mio libro questa cifra avrà sfiorato il miliardo.
Il 70% di queste persone vive in Africa, e la maggior parte degli africani vive in
paesi che sono caduti in una delle quattro trappole che ho indicato. Pertanto, l’Africa
è il cuore del problema. Il resto del mondo lo ha notato. Pensate a come sono cambiate
le commissioni internazionali per lo sviluppo. La prima fu istituita nel 1970, sotto
la guida di un ex capo del governo canadese; la Commissione Pearson ha inquadrato
i problemi dello sviluppo in un’ottica globale. Ad essa è succeduta, nel 1980, una
commissione guidata da un ex cancelliere tedesco; la Commissione Brandt ha adottato
la stessa prospettiva globale. Nel 2005, quando il britannico Tony Blair ha deciso
di istituire una Commissione per lo sviluppo, l’ottica si è ristretta all’Africa:
si trattava di una Commissione per l’Africa, non per lo sviluppo. Nel 2006 il presidente tedesco Horst Köhler ha deciso di organizzare
anch’egli un evento a favore dello sviluppo. Non potendo limitarsi a seguire le orme
di Tony Blair (cioè istituire un’altra Commissione per l’Africa a distanza di un anno
soltanto), ha deciso di organizzare un forum, ma pur sempre un forum per l’Africa. In realtà, l’Africa e il Terzo Mondo non sono sinonimi. Il Sudafrica, ad esempio,
non rientra nel novero dei paesi più arretrati: è evidente che non versa nelle stesse
disperate condizioni del Ciad. Al contrario, la situazione di gran parte dei paesi
dell’Asia centrale che non hanno uno sbocco sul mare somiglia in modo preoccupante
a quella del Ciad. Quindi i paesi dell’ultimo miliardo non formano un gruppo facilmente
etichettabile dal punto di vista geografico. Quando voglio adoperare un’etichetta
geografica, parlo di «Africa +», con il + che indica luoghi come Haiti, Bolivia, i
paesi dell’Asia centrale, Laos, Cambogia, Yemen, Birmania o Corea del Nord. Si tratta
di paesi ancora imprigionati in una delle quattro trappole, oppure che ne sono usciti
troppo tardi.
Ho individuato cinquantotto paesi che rientrano in questo gruppo, tutti accomunati
da una caratteristica: sono piccoli. Nell’insieme, la loro popolazione è inferiore
a quella dell’India o della Cina. Poiché anche il loro reddito pro capite è molto
basso, il reddito del paese tipico è trascurabile, essendo inferiore a quello della
maggior parte delle città del mondo ricco. Siccome nessun paese anela a far parte
di questa cerchia, e siccome quando si stigmatizza un paese si rischia di fare delle
profezie che poi possono avverarsi, non stilerò alcun elenco. Fornirò piuttosto un
gran numero di esempi per ciascuna delle quattro trappole.
Dunque, come vanno le cose per chi vive in quei paesi? Esaminiamo innanzitutto il
modo in cui vive, o meglio, muore quel miliardo di persone. L’aspettativa media di
vita è di cinquant’anni, mentre negli altri paesi in via di sviluppo arriva a sessantasette
anni. Il tasso di mortalità infantile – la percentuale di bambini che muoiono entro
il quinto anno di vita – è pari al 14%, mentre negli altri paesi in via di sviluppo
è del 4%. Il 36% dei bambini presenta i sintomi della malnutrizione cronica, contro
il 20% negli altri paesi in via di sviluppo.
Il ruolo della crescita nello sviluppo
Il divario tra questo «ultimo miliardo» e il resto del mondo in via di sviluppo è
sempre esistito oppure è una conseguenza delle quattro trappole indicate? Per scoprirlo,
dobbiamo disaggregare le statistiche che si adoperavano in passato per descrivere
tutti i paesi cosiddetti «in via di sviluppo». Ecco un esempio ipotetico. Prosperia
è una grande economia, che cresce a un tasso del 10%, ma il paese ha una popolazione
assai ridotta. Catastrofia è una piccola economia, che decresce al tasso del 10% ma
ha una popolazione molto numerosa. L’approccio classico – quello adottato ad esempio
dal Fondo monetario internazionale nel suo documento di riferimento, il World Economic Outlook – consiste nel fare la media dei dati che si riferiscono alle dimensioni dell’economia
di un paese. In base a tale approccio, la grande economia in crescita di Prosperia
fa deviare la media verso l’alto con la conseguenza che i due paesi, presi nel complesso,
risultano in crescita. Il fatto è che questo sistema descrive la situazione con riferimento
al reddito medio unitario, non all’individuo medio. La maggior parte dei redditi si
trova a Prosperia, ma la maggior parte degli individui si trova a Catastrofia. Se
vogliamo spiegare come vive l’individuo medio nei paesi dell’ultimo miliardo dobbiamo
lavorare su dati basati non sul reddito di un paese ma sulla sua popolazione. È importante?
Direi di sì, se riteniamo che i paesi più poveri si stiano allontanando dagli altri,
come sostiene questo libro: facendo la media in base al reddito, infatti, si tagliano
fuori i paesi più poveri come irrilevanti. Ciò che accade ai loro abitanti non conta
granché, proprio perché sono poveri: il loro reddito è trascurabile.
Quando facciamo una media appropriata dei dati, cosa scopriamo? I paesi in via di
sviluppo che non fanno parte dell’ultimo miliardo – cioè i quattro miliardi che stanno
nel mezzo – hanno registrato una crescita rapida e in costante accelerazione del reddito
pro capite. Esaminiamo un decennio alla volta. Durante gli anni Settanta del secolo
scorso sono cresciuti del 2,5% l’anno, dato promettente ma non eccezionale. Durante
gli anni Ottanta e Novanta il loro tasso di crescita è salito al 4% annuo. Nei primi
anni del XXI secolo la crescita ha subito un’ulteriore accelerazione, attestandosi
sul 4,5%. Questi tassi di crescita possono non apparire sensazionali ma non hanno
precedenti nella storia e indicano che i bambini di quei paesi vivranno in modo completamente
diverso dai loro genitori. Persino laddove la popolazione è ancora povera, le società
sono autorizzate a sperare: il tempo è dalla loro parte.
Cosa dire, invece, del miliardo che resta indietro? Esaminiamo anche in questo caso
un decennio alla volta. Durante gli anni Settanta il reddito pro capite di queste
persone è cresciuto dello 0,5% l’anno, quindi con un leggero miglioramento in termini
assoluti ma a un ritmo appena percettibile. Data l’elevata volatilità del reddito
individuale che caratterizza quelle società, è probabile che la lieve tendenza generale
al miglioramento sia stata annullata proprio dall’alto grado di rischio individuale.
L’andamento generale della società sarà stato influenzato dai timori individuali di
un crollo piuttosto che dalla speranza di un miglioramento esteso a tutta la società.
Ma negli anni Ottanta le cose sono andate molto peggio, con un calo dello 0,4% l’anno. In termini assoluti, alla fine degli anni Ottanta quei paesi sono
tornati alla situazione del 1970. Se foste vissuti in quelle società durante l’intero
ventennio, sapreste che l’unica esperienza economica è stata quella della volatilità
individuale: alcune persone sono andate su, altre sono andate giù. È mancata una ragione
di speranza collettiva. Poi sono arrivati gli anni Novanta. Oggi quel periodo è considerato
il decennio d’oro tra la fine della guerra fredda e l’11 settembre, il decennio del
cielo senza nubi e del boom dei mercati. Non è stato tanto d’oro per quell’ultimo
miliardo di individui: il loro tasso di declino assoluto è sceso allo 0,5% l’anno.
Alla fine del millennio erano quindi più poveri di quanto non fossero nel 1970.
Questi risultati deprimenti sono soltanto un prodotto dei dati? Io ritengo, al contrario,
che probabilmente le difficoltà oggettive nel raccogliere i dati economici nei paesi
più poveri abbiano nell’insieme indotto a sottovalutare il loro declino. Infatti i
dati relativi ai paesi che sono davvero crollati non sono utilizzabili. Ad esempio,
il declino previsto per i paesi più arretrati negli anni Novanta non tiene conto di
ciò che sarebbe potuto accadere in Somalia e in Afghanistan. Ma escludere quei paesi
equivale a dare per scontato che i loro risultati coincidano esattamente con la media
del gruppo, e sarei a dir poco sorpreso se ciò fosse vero; tenderei a pensare che
siano stati di gran lunga peggiori. Nei primi quattro anni del decennio attuale la
crescita dei paesi più arretrati è salita all’1,7% circa, sempre molto inferiore a
quella del resto del mondo in via di sviluppo, ma decisamente migliore in termini
assoluti. Purtroppo, il miglioramento attuale è probabilmente imputabile agli effetti
a breve termine dell’individuazione di nuove risorse e alle alte quotazioni mondiali
delle risorse naturali, di cui i paesi più arretrati sono esportatori. Ad esempio,
l’economia che è cresciuta maggiormente tra tutti i paesi più arretrati è quella della
Guinea Equatoriale, un piccolo paese che vive di colpi di Stato e corruzione, al largo
delle cui coste sono stati scoperti da poco alcuni giacimenti petroliferi, che oramai
ne determinano il reddito. Per riassumere – quand’anche volessimo ritenere promettenti
questi ultimi dati, il che a mio parere sarebbe fuorviante –, resta il fatto che financo
nella fase di massima espansione la crescita dei paesi più arretrati rimane molto
più lenta persino rispetto alla fase di crescita meno brillante nel resto del mondo
in via di sviluppo, una situazione che li riporta indietro agli anni Settanta.
Pensate agli effetti di queste due tipologie di tassi di crescita. Durante gli anni
Settanta tra la crescita dei paesi più arretrati e quella degli altri paesi in via
di sviluppo si registrava uno scarto di due punti percentuali l’anno. Quindi, anche
allora, la caratteristica principale dell’«ultimo miliardo» era il divario, non lo
sviluppo. Ma la situazione ha iniziato presto a peggiorare in modo preoccupante. Durante
gli anni Ottanta lo scarto è salito al 4,4% annuo, e nel corso degli anni Novanta
è aumentato ulteriormente fino a raggiungere un impressionante 5% l’anno. Esaminando
i tre decenni nel complesso, osserviamo che la realtà di quelle società è stata segnata
da un divario ragguardevole e sempre più marcato. Considerato il potere dei tassi
di crescita composti, le differenze tra l’ultimo miliardo e il resto del mondo in
via di sviluppo finiranno rapidamente per generare due mondi diversi. Anzi, questo
divario ha già relegato la maggior parte dei paesi più arretrati agli ultimi posti
della graduatoria mondiale.
Le cose non sono sempre andate così. Prima che la globalizzazione offrisse enormi
opportunità alla Cina e all’India, questi due paesi erano più poveri rispetto a molti
fra quelli che sono rimasti intrappolati. Ma la Cina e l’India si sono svincolate
in tempo per imporsi nei mercati mondiali, mentre altri paesi inizialmente meno poveri
non ci sono riusciti. Negli ultimi due decenni ciò ha prodotto un modello di crescita
che non è affatto chiaro. Alcuni paesi inizialmente poveri stanno crescendo molto
bene, e ciò indurrebbe a pensare che non esista un vero problema: quelli dove vive
il miliardo di persone più povere sembrano crescere alla stessa velocità degli altri.
Nel corso dei prossimi vent’anni, tuttavia, la vera natura del problema verrà alla
luce, perché i paesi che attraversano una fase di stagnazione o di declino sono in
questo momento proprio quelli più poveri. L’individuo medio che vive nelle società
dell’ultimo miliardo oggi ha un reddito pari soltanto a un quinto scarso di quello
del suo omologo che vive negli altri paesi in via di sviluppo e questo divario è destinato
ad aggravarsi col passare del tempo. Per farvi un’idea della situazione, provate a
immaginare un miliardo di persone bloccate su un treno in salita ma che scivola lentamente
all’indietro. Nel 2050 il divario di sviluppo non separerà più il miliardo di ricchi
dei paesi più avanzati dai cinque miliardi dei paesi in via di sviluppo, ma il miliardo
in trappola dal resto dell’umanità.
Sin qui ho affrontato il problema dei paesi più arretrati in termini di tassi di crescita:
in termini assoluti il loro tasso di crescita è stato negativo; in termini relativi,
decisamente inferiore a quello del resto del mondo in via di sviluppo. Oggi, tuttavia,
il dibattito è incentrato sulla riduzione della povertà e sugli altri «obiettivi di
sviluppo del millennio», non sui tassi di crescita. Molte delle persone che si occupano
seriamente di sviluppo preferiscono parlare di obiettivi quali la scolarizzazione
delle bambine piuttosto che di crescita. Personalmente condivido il loro entusiasmo
per la scolarizzazione delle bambine e, di fatto, per tutti gli altri obiettivi. Ma
non condivido il disagio nei riguardi della crescita. All’epoca in cui dirigevo l’ufficio
ricerche della Banca Mondiale, lo studio più controverso che abbiamo pubblicato si
intitolava Growth Is Good for the Poor (La crescita fa bene ai poveri). Alcune ong lo trovarono inaccettabile e quella è stata l’unica volta in cinque anni che Jim
Wolfensohn, il presidente della Banca, telefonò per manifestarmi la sua preoccupazione.
Eppure, il principale problema dei paesi più arretrati è che non sono cresciuti. Il
fallimento del processo di crescita in queste società deve diventare la nostra priorità
più alta, e il risanamento di questa situazione deve diventare la principale sfida
dello sviluppo. Affinché le politiche del mondo ricco siano maggiormente orientate
al sostegno della crescita in queste società, avremo bisogno di tutto il potere di
lobby di coloro che si adoperano per i poveri del mondo. Bisogna quindi che queste
persone guardino la crescita con occhi diversi.
Non voglio assolutamente sostenere che dovremmo disinteressarci del modo in cui cresce
un’economia. Ad esempio, la crescita della Guinea Equatoriale produce benefici soltanto
per un gruppo ristretto della popolazione, ma si tratta di un caso eccezionale; normalmente
la crescita produce effetti positivi per la gente comune. La diffidenza esagerata
nei confronti della crescita da parte di chi si occupa di sviluppo si esprime attraverso
gli aggettivi di cui oggi è solitamente caricata la parola crescita. In generale, nei documenti strategici questa parola compare oramai soltanto nell’espressione
«crescita sostenibile, a favore dei poveri». Eppure è indubbio che il problema dell’ultimo
miliardo non deriva dal tipo di crescita sbagliata, ma dall’assenza di qualunque crescita. La diffidenza nei confronti della crescita ha inavvertitamente
pregiudicato l’avvio di un’autentica riflessione strategica. Ricordo la volta in cui
uno dei maggiori esperti mondiali di banche si è rivolto a me perché gli era stato
chiesto di fornire una consulenza a uno dei paesi in questione. Egli si stava scervellando
per riuscire a dimostrare che la riforma del sistema bancario avrebbe direttamente
aiutato le persone più povere del paese, perché si rendeva conto che, se non fosse
riuscito a dimostrarlo, il suo parere non sarebbe stato preso in considerazione. Era
convinto che l’argomento, ben più autorevole, secondo cui la riforma avrebbe aiutato
il processo di crescita, non sarebbe stato apprezzato. L’avvio di un processo di crescita
in quei paesi sarà comunque difficile, anche senza questo genere di ostacoli.
Non riusciremo a lasciarci la povertà alle spalle fintanto che i paesi più arretrati
non inizieranno a crescere, e la soluzione non è trasformarli in una copia di Cuba.
Cuba è un paese stagnante, a basso reddito, egualitario, dotato di buoni servizi sociali.
I paesi più arretrati riuscirebbero a risolvere i loro problemi emulando Cuba? A mio
parere, la stragrande maggioranza delle persone che vivono lì – e, di fatto, anche
a Cuba – lo considererebbero un ulteriore fallimento. Ritengo che sviluppo significhi
far sperare alla gente comune che i propri figli vivranno in una società al passo
con il resto del mondo. Togliete alla gente questa speranza e le persone intelligenti
utilizzeranno le proprie energie non per contribuire allo sviluppo della loro società
ma per fuggire – come hanno fatto un milione di cubani. Mettersi al passo significa
aumentare drasticamente la crescita dei paesi che oggi sono il fanalino di coda. Il
fatto che la stagnazione duri da tanto tempo ci fa capire che sarà difficile. Cosa
possiamo fare oltre a preoccuparci?
Oltre il cuore: accettare la complessità
Il problema dell’ultimo miliardo è grave, ma si può risolvere. È assai meno scoraggiante
di tutti i problemi drammatici che sono stati superati nel corso del XX secolo: malattie,
fascismo e comunismo. Ma, come tutti i problemi molto gravi, è complicato. Il cambiamento
dovrà partire dall’interno delle società dei paesi più arretrati, ma le nostre politiche
potrebbero contribuire ad aumentare le probabilità di successo di tali sforzi, che
di conseguenza avrebbero maggiori probabilità di essere intrapresi.
Avremo bisogno di una serie di strumenti di intervento concreto per incoraggiare i
paesi più arretrati a imboccare la strada del cambiamento. Finora abbiamo usato male
gli strumenti disponibili, quindi c’è un ampio margine di miglioramento. Il principale
ostacolo è costituito dal fatto che questi strumenti pratici chiamano in causa diverse
agenzie governative, che non sempre sono propense a collaborare. Tradizionalmente
il settore dello sviluppo è gestito dalle agenzie per gli aiuti, che occupano gli
ultimi gradini della scala gerarchica di quasi tutti i governi. Il Dipartimento della
Difesa statunitense non seguirà mai il parere dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale
di quel paese. Il ministero britannico per il Commercio e l’Industria non darà mai
ascolto al Dipartimento per lo sviluppo internazionale. Per armonizzare la politica
di sviluppo di un paese sarà necessario adottare un approccio che si può definire
«trasversale» [whole-of-government approach]. Per realizzare un simile grado di coordinamento è necessario che i capi di governo
concentrino la loro attenzione su questo problema. E dato che il successo non dipende
unicamente da ciò che gli Stati Uniti o qualsiasi altra nazione fanno a titolo individuale,
sarà necessaria l’azione congiunta dei principali governi.
L’unica sede in cui i capi dei principali governi si incontrano regolarmente è il
G8. La ricerca di una soluzione al problema dell’ultimo miliardo è un argomento ideale
per il G8, ma ciò significa che si dovrà utilizzare tutta la gamma degli strumenti
di intervento concreto a disposizione, superando quindi l’agenda di Gleneagles del
2005, che consisteva in un impegno a raddoppiare i programmi di aiuti. L’Africa è
stata nuovamente inserita nell’agenda del G8 del 2007, il cui incontro si è tenuto
in Germania (Heiligendamm, 6-8 giugno). «Africa +» dovrebbe rimanere a pieno titolo
nell’agenda del G8 fintanto che i paesi più arretrati non saranno definitivamente
usciti dalle trappole dello sviluppo.
Obiettivo di questo libro è proprio quello di proporre un’agenda operativa per il
G8.
2. La trappola del conflitto
Tutte le società sanno cos’è il conflitto; è inerente alla politica. Il problema che
distingue i paesi più poveri dagli altri non è il conflitto politico bensì la forma
che assume. Alcuni di essi sono prigionieri di una fitta trama di violente minacce
interne contro il governo. Talvolta la violenza si protrae, e in tal caso si parla
di guerra civile; altre volte si esaurisce rapidamente, e si parla allora di colpo
di Stato. Queste forme di conflitto politico sono entrambe costose e possono avere
la tendenza a ripetersi. Sono in grado di costringere un paese nella morsa della povertà.
Le guerre civili
Il 73% della popolazione dei paesi più poveri è stato recentemente coinvolto in una
guerra civile, o lo è tuttora. Molti altri paesi sono stati colpiti da guerre civili
a un certo punto della loro storia – gli Stati Uniti nel XIX secolo, la Russia all’inizio
del XX e la Gran Bretagna nel XVII – ma, come dimostrano questi esempi, le guerre
non sono necessariamente delle trappole. Le guerre civili americana, russa e britannica
sono state spaventose ma si sono concluse alquanto rapidamente e non si sono ripetute.
Nei paesi a basso reddito, invece, le probabilità che il conflitto si trasformi in
una trappola sono molto più elevate. Ho fatto questa scoperta lavorando insieme ad
Anke Hoeffler, che un tempo era una mia studentessa di dottorato e oggi è una collega.
La tesi di dottorato di Anke aveva come oggetto le fonti della crescita, argomento
in voga in quel periodo tra gli economisti. Uno dei fattori che notoriamente ostacolano
la crescita è la guerra. Mentre riflettevo sul lavoro di Anke mi è venuto in mente
che sarebbe stato interessante rovesciare i termini della questione: invece di spiegare
se un paese cresce rapidamente o lentamente a seconda che sia in guerra o in pace,
avremmo potuto cercare di stabilire se la propensione alla guerra si possa spiegare
in termini di differenze di crescita.
Le cause delle guerre civili
Dunque, cosa provoca una guerra civile? I movimenti ribelli giustificano le loro azioni
in base a una sfilza di denunce: repressione, sfruttamento, esclusione. Gli accademici
politicamente schierati intervengono puntualmente con i loro cavalli di battaglia,
in cui i ribelli fanno sempre la parte degli eroi. Personalmente, diffido delle denunce
perché le ritengo un’argomentazione di comodo. Capire le cause di una guerra civile
è difficile: gli storici non riescono neanche a trovare un accordo sulle cause della
prima guerra mondiale. La maggior parte delle guerre ha diversi livelli di causalità:
personalità, odi, errori. L’approccio che abbiamo adottato punta a tentare di spiegare
le guerre civili in un’ottica statistica, esaminando una serie di possibili cause:
sociali, politiche, geografiche ed economiche.
La prima tappa di ogni indagine statistica, e senz’altro la più importante, è la raccolta
di dati affidabili. Abbiamo trovato un elenco esauriente delle guerre civili presso
l’Università del Michigan, che da molto tempo è la principale banca dati mondiale
per questo tipo di questioni politiche. Secondo la definizione data dall’Università
del Michigan, una guerra civile è un conflitto interno in cui muoiono almeno 1.000
persone durante i combattimenti, e in cui ognuna delle parti subisce perlomeno il
5% di perdite. (Uno dei vantaggi del ricorso a parametri stabiliti è che non si è
tentati di manipolare le definizioni in modo da raggiungere i risultati sperati.)
Mentre la cifra di 1.000 vittime è arbitraria, il senso di questo limite è che esiste
realmente una grande differenza tra una violenza comunitaria di scarso rilievo, in
cui, ad esempio, rimangono uccise cinquanta persone, e una guerra che miete migliaia
di vittime. Abbiamo in seguito confrontato la lista delle guerre civili con una grande
quantità di dati socioeconomici, per paese e per anno, allo scopo di tentare di individuare
i fattori che incidono sulla probabilità che, nell’arco di un periodo di cinque anni,
si verifichi una guerra civile nel paese preso in esame.
Il nostro lavoro ha suscitato non poche critiche. In parte perché chi studia i conflitti
a livello accademico tende a essere politicamente impegnato e a condividere le pesanti
accuse formulate dai vari movimenti ribelli, i quali spesso, per contrastare i governi,
adottano misure estreme che di fatto possono rivelarsi deplorevoli. Per questi accademici,
l’idea stessa di indagare statisticamente sull’esistenza di un nesso tra il valore
oggettivo delle accuse e la propensione alla ribellione equivale più o meno a un insulto,
poiché essi sanno che esiste. È vero che in qualche occasione abbiamo gettato benzina sul fuoco: abbiamo
intitolato uno dei nostri studi Greed and Grievance (Ingordigia e accuse) e un altro Doing Well out of War (Stare bene con la guerra), insinuando che le motivazioni dei ribelli potrebbero
verosimilmente non essere più eroiche di quelle dei governi contro cui si battono.
L’ala meno politicizzata della professione accademica, tuttavia, ha preso sul serio
il nostro lavoro e vi ha spesso fatto riferimento. Siamo riusciti a farci ascoltare
dal mondo politico – io sono stato invitato a parlare davanti all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite – e siamo apparsi sui media.
Ci è stato anche chiesto di utilizzare il nostro modello per prevedere dove sarebbe
scoppiata la prossima guerra civile – a quanto pare la cia aveva mostrato un certo interesse. Ma non siamo mai stati tanto ingenui da accettare.
Le nostre previsioni avrebbero potuto essere utilizzate per bollare, danneggiandoli,
proprio quei paesi che io volevo aiutare; avrebbero addirittura rischiato di diventare
delle profezie condannate ad avverarsi. Di fatto, il nostro modello non può essere
utilizzato per fare previsioni. Ci può dire quali sono i tipici fattori strutturali che determinano la propensione alla
guerra civile e – cosa talvolta più interessante – quelli che non sembrano avere una
grande incidenza. A partire da queste osservazioni, può dirci quale tipo di paese
è più a rischio. Ma non può dirci se in Sierra Leone scoppierà un’altra guerra civile
l’anno prossimo. Ciò dipende da una miriade di eventi a breve termine.
Il primo nesso che abbiamo riscontrato è quello che collega il rischio di guerra al
livello di reddito iniziale. È molto più probabile che la guerra civile scoppi nei
paesi a basso reddito: dimezzando il reddito iniziale di un paese raddoppia il rischio
di guerra civile. Qualcuno potrebbe chiederci se non abbiamo confuso le causalità
– forse è la guerra che impoverisce un paese, e non la povertà a renderlo incline
alla guerra? In realtà, queste due relazioni coesistono contemporaneamente. Se la
guerra civile riduce il reddito, è vero che il basso reddito aumenta il rischio di
guerra civile. La prova più evidente di questa affermazione è data dal fatto che durante
il periodo coloniale molti paesi hanno vissuto per decenni in condizioni di pace forzata;
la decolonizzazione pressoché contemporanea di molti paesi con livelli di reddito
molto diversi tra loro ha consentito di sperimentare naturalmente gli effetti del
reddito sulla guerra civile.
Il rapporto tra basso reddito e guerra civile potrà apparire scontato – basta leggere
i giornali per osservare che i paesi dove è in atto un conflitto sono molto probabilmente
poveri – ma non tutti i teorici della guerra civile hanno fondato il loro lavoro su
dati empirici. Alcuni sociologi, in particolare quelli più impegnati politicamente,
sanno cosa vogliono vedere in una guerra civile e fanno in modo di riuscirci.
Quali sono gli altri fattori che rendono un paese incline alla guerra civile? La crescita
lenta o, peggio, la stagnazione o il declino. Approssimativamente, qualsiasi paese
a basso reddito affronta ogni cinque anni un rischio di guerra civile pari a circa
il 14%. Per ogni punto percentuale di aumento della crescita, il rischio si riduce
di un punto. Quindi, se un paese cresce del 3%, il rischio passa dal 14 all’11%; se
l’economia decresce del 3%, il rischio sale al 16%. Anche su questo punto qualcuno
potrebbe obiettare che abbiamo invertito le causalità: non potrebbe essere, invece,
che la prospettiva di una guerra civile provochi il declino? Dopo tutto, quando nell’aria c’è odore
di guerra civile gli investitori scappano e l’economia entra in crisi. Sembra che
sia il declino a provocare la guerra ma in realtà è la prospettiva di una guerra a
provocare il declino. A questa obiezione si può rispondere esaminando un fattore che
incide sulla crescita ma non ha legami diretti con la guerra civile, per vedere se
gli effetti che ne derivano rendono più o meno probabile il conflitto. Nei paesi a
basso reddito, il livello delle precipitazioni atmosferiche (troppa pioggia o troppo
poca) incide sulla crescita economica, ma non incide direttamente sul rischio di guerra
civile – nel senso che i presunti ribelli non dicono: «Piove, annulliamo la rivolta».
Gli effetti delle precipitazioni sulla crescita sono quindi privi di ambiguità: non
sono causati dalla prospettiva di una guerra civile. Eppure, i problemi di crescita
causati dalle oscillazioni del livello delle precipitazioni rendono molto più probabile
la guerra civile.
Di conseguenza, se il basso reddito e la crescita lenta rendono un paese incline alla
guerra civile, è opportuno tentare di capire perché. Potrebbero esserci molte spiegazioni.
La mia idea è che almeno in parte ciò sia dovuto al fatto che basso reddito significa
povertà, e crescita lenta significa disperazione. Gli uomini giovani, reclutati dagli
eserciti dei ribelli, sono merce a buon mercato in un contesto di povertà disperata.
La vita stessa è una merce a buon mercato, e unirsi a un movimento di ribelli dà a
questi giovani una piccola occasione per arricchirsi. Nel 2002, uno sparuto gruppo
di ribelli delle Filippine è riuscito a rapire alcuni turisti stranieri. Una francese
che apparteneva al gruppo dei turisti rapiti ha raccontato in seguito di aver aiutato
i rapitori a scrivere le loro richieste alle autorità. «Cosa volete che scriva?»,
aveva chiesto. «Un milione di dollari a turista», le avevano detto. Lei lo aveva scritto
e poi aveva chiesto: «Qualcos’altro?». Lunga pausa, poi un pensiero politico: «Cacciare
il sindaco di Jolo». Ultima richiesta: «Due orologi da sub». Quella era la lista delle
rivendicazioni «assolutamente giustificate» di quel particolare gruppo di ribelli.
Il rapimento di turisti era semplicemente un mezzo sgradevole ma necessario per garantire
la giustizia sociale. Ad ogni modo, gli Stati Uniti rifiutarono di pagare per l’ostaggio
americano ma i governi europei pagarono, utilizzando come tramite il colonnello Gheddafi,
e nel giro di poco tempo si moltiplicarono a dismisura gli aspiranti ribelli. Questo
tipo di reclutamento finalizzato alla ribellione somiglia un po’ all’adesione alle
gang della droga negli Stati Uniti. Uno studio oggi molto noto su una gang di Chicago
aveva evidenziato che i giovani erano interessati a entrare nell’organizzazione e
disposti a lavorare praticamente gratis perché intravedevano una modesta opportunità
di guadagnare un sacco di soldi se fossero riusciti a risalire la scala gerarchica.
Va detto inoltre che se l’economia è debole, è probabile che sia debole anche lo Stato,
e quindi la ribellione non è difficile. Il leader dei ribelli Laurent Kabila, mentre
avanzava con le sue truppe attraverso lo Zaire per impadronirsi del potere, aveva
detto a un giornalista che la rivolta nello Zaire era facile: bastavano 10.000 dollari
e un telefono satellitare. A parte l’evidente esagerazione di quell’affermazione,
egli aveva aggiunto che gli abitanti dello Zaire erano talmente poveri che con 10.000
dollari si poteva assoldare un piccolo esercito. E il telefono satellitare? Ecco,
questo ci porta al terzo e ultimo fattore economico che incide sul rischio di guerra
civile: le risorse naturali.
La dipendenza dalle esportazioni di materie prime – petrolio, diamanti e affini –
accresce notevolmente il rischio di guerra civile. Ecco perché Kabila aveva bisogno
di un telefono satellitare: per concludere affari con le compagnie di estrazione.
Al momento del suo arrivo a Kinshasa, egli aveva a quanto pare già negoziato contratti
per 500 milioni di dollari. Ci sono stati diversi casi in cui le compagnie internazionali
hanno anticipato ingenti somme ai movimenti ribelli, in cambio di concessioni per
le risorse nel caso di vittoria. A quanto pare è così che Denis Sassou-Nguesso, l’attuale
presidente della Repubblica del Congo (da non confondere con la Repubblica Democratica
del Congo, ex Zaire) è salito al potere. Pertanto, le risorse naturali aiutano a finanziare
i conflitti e talvolta contribuiscono persino a provocarli. Un esempio è quello dei
conflict diamonds, ovvero i diamanti commercializzati illegalmente per finanziare le guerre. Le Nazioni
Unite li definiscono come «diamanti che provengono da aree controllate da forze o
fazioni opposte ai governi legittimamente e internazionalmente riconosciuti e che
sono utilizzati per finanziare azioni militari». Nel caso dei conflict diamonds, l’azione di sensibilizzazione condotta dalla ong Global Witness ha dato i suoi frutti. Dopo avere per lungo tempo negato l’esistenza
del problema, De Beers, il principale produttore mondiale di diamanti, ha introdotto
una serie di sorprendenti innovazioni che hanno contribuito ad affrontare la questione
alle radici, trasformando l’azienda in un modello di responsabilità imprenditoriale.
Quindi, il basso reddito, la crescita lenta e la dipendenza dalle materie prime rendono
un paese incline alla guerra civile, ma è lecito affermare che siano queste le vere cause della guerra civile? Ho spesso sentito parlare di «cause primarie». Si fa grande
uso di questa espressione in molte conferenze a cui sono invitato a partecipare. È
impressionante notare con quanta facilità si riesca a prevedere la presunta causa
primaria quando già si conosce il cavallo di battaglia dell’oratore. Se questi si
occupa di disuguaglianze di reddito, dirà che è quella la motivazione dei ribelli;
chi invece è fortemente impegnato nel campo dei diritti politici sosterrà che i ribelli
si stanno battendo per la democrazia; se un relatore ha dei nonni che in passato sono
emigrati per sfuggire a un regime oppressivo, penserà, ricordando i racconti dei suoi
parenti, che gli eredi di quelli che non sono emigrati subiscano identiche pressioni.
A parziale conferma, i discorsi accusatori delle fazioni ribelli non fanno che alimentare
tali preoccupazioni, di fatto infiammando la fantasia dei loro difensori, che si immaginano
in cima alle barricate col mitra spianato. Purtroppo, è impossibile fidarsi dei discorsi
dei ribelli che dicono di battersi per la giustizia sociale: cos’altro vi aspettate
che dicano?
Le donazioni delle comunità della diaspora sono state tra le principali fonti di finanziamento
dei movimenti ribelli, che hanno quindi imparato a sfruttare le pubbliche relazioni.
L’esercito repubblicano irlandese (ira) è stato finanziato anche dagli americani di origine irlandese, e non solo – a quanto
pare alcune armi utilizzate dall’ira venivano dal dipartimento di polizia di Boston (anche se, non appena gli americani
hanno capito cosa sia veramente il terrorismo, con gli attentati dell’11 settembre
2001, la situazione è cambiata). Le Tigri Tamil hanno ottenuto finanziamenti dai Tamil
del Canada; la bomba che nel 1996 ha provocato oltre 1.400 tra morti e feriti nella
capitale dello Sri Lanka, Colombo, è stata pagata con denaro prelevato da un conto
corrente canadese. Gli albanesi sparsi nei paesi dell’Unione Europea hanno finanziato
l’esercito di liberazione del Kosovo, un gruppo che è stato erroneamente ritenuto
un movimento serio da alcuni politici europei, finché non gli si è presentata l’occasione
di uccidere. Il gruppo più organizzato di tutti è stato il Fronte di liberazione popolare
eritreo, che ha finanziato la guerra per trent’anni, e nel 1992 ha vinto. L’Eritrea
oggi è un paese indipendente. Ma la guerra ha davvero liberato il popolo eritreo?
Nel settembre del 2001, dopo un’inutile guerra internazionale con l’Etiopia, metà
dei membri del governo eritreo ha scritto al presidente, Isaias Afeworki, chiedendogli
di riflettere seriamente sul suo sistema autocratico di governo. Afeworki ha riflettuto
e li ha fatti rinchiudere tutti in carcere. In seguito, ha istituito la leva di massa
per tutti i giovani eritrei. L’esercito etiope è stato smobilitato, quello eritreo
no. Può darsi che giovani eritrei siano arruolati nell’esercito tanto per proteggere
il presidente dalle proteste, quanto per difendere il paese dall’Etiopia. Molti giovani
hanno abbandonato il paese. Mentre scrivo, il governo è in procinto di espellere gli
osservatori di pace internazionali, presumibilmente per essere libero di riprendere
la guerra. È valsa davvero la pena sopportare trent’anni di guerra civile per ottenere
una simile liberazione? Uno degli effetti collaterali della guerra è che l’Etiopia
ha perso l’accesso al mare (aspettate di arrivare al capitolo 4 per vedere con quali
conseguenze).
Forse sarete anche disposti ad accettare il fatto che le fazioni ribelli sappiano
manipolare le pubbliche relazioni e strumentalizzino le loro rivendicazioni ma sicuramente
pensate che le loro accuse siano fondate. A volte lo sono, perché certi governi possono
essere davvero terribili. Ma è vero che la ribellione scaturisce sempre da rivendicazioni
fondate? Gli esempi non sono tanto numerosi come potreste pensare. Prendiamo la repressione
dei diritti politici. I politologi hanno misurato questo tipo di situazione, attribuendo
un punteggio annuale a ogni governo. Non esiste praticamente alcun rapporto tra la
repressione politica e il rischio di guerra civile. Prendiamo la discriminazione economica
o politica contro le minoranze etniche. Due politologi di Stanford, Jim Fearon e David
Laitin, l’hanno misurata per oltre duecento etnie minoritarie in tutto il mondo. Non
hanno trovato nessun rapporto tra il grado di repressione politica di un determinato
gruppo e il rischio di guerra civile. La probabilità di ribellione delle minoranze
etniche è identica, a prescindere dal grado di discriminazione cui sono sottoposte.
Fearon e Laitin hanno condotto lo stesso studio per le rivalità interetniche e anche
qui non hanno individuato alcun rapporto. Anke Hoeffler e io abbiamo analizzato l’effetto
della disuguaglianza di reddito e, con sommo stupore, non siamo stati in grado di
trovare un nesso. Abbiamo anche studiato la storia coloniale di ciascun paese. Non
abbiamo trovato nessun rapporto tra il rischio di guerra civile e l’ex potenza coloniale,
né il periodo di tempo trascorso dall’indipendenza. Sono addirittura arrivato a mettere
in dubbio l’affermazione, apparentemente ineccepibile, secondo cui i conflitti di
oggi affondano le loro radici nella storia. È vero che molte zone oggi teatro di un
conflitto ne hanno già subito uno nel lontano passato; di solito, i protagonisti odierni
puntano molto su questo fattore e non è raro che un leader ribelle scateni i disordini
proprio richiamandosi al passato. Ciò non significa, tuttavia, che il conflitto passato
sia la causa di quello attuale, né che la storia ci condanni a essere prigionieri
del conflitto. La maggior parte delle zone che oggi vivono in pace ha conosciuto la
guerra civile in un determinato periodo storico. È vero piuttosto che determinate
condizioni economiche si prestano a essere sfruttate da politici di bassa lega, che
costruiscono il loro successo sull’odio.
Detto questo, non voglio esagerare, né tanto meno assolvere i governi colpevoli di
discriminazioni o repressioni. Le vere rivendicazioni devono essere ascoltate, a prescindere
dal fatto che possano o meno scatenare una rivolta, eppure troppo spesso ciò non accade.
La triste realtà è che, a quanto pare, le rivendicazioni sono abbastanza comuni. Di
solito i ribelli hanno qualcosa di cui lamentarsi, e in caso contrario l’inventano.
Troppo spesso accade che chi è veramente in condizioni di inferiorità non ha modo
di ribellarsi; si limita a soffrire in silenzio. Analizzando la storia, il peggiore
caso di discriminazione etnica che mi viene in mente è quello che si è verificato
dopo l’invasione normanna dell’Inghilterra. I normanni, un piccolo gruppo di violenti
vichinghi di lingua francese, uccisero l’élite inglese, si impadronirono di tutte
le terre e ridussero in schiavitù il 98% della popolazione locale per due secoli.
Durante quel periodo, scoppiarono numerose guerre civili. Nessuna fu scatenata dai
servi della gleba inglesi per rovesciare i padroni normanni. Tutte quelle guerre scoppiavano
tra baroni normanni, che cercavano di arraffare sempre più ricchezze.
Una rivendicazione sacrosanta rappresenta per una fazione ribelle ciò che l’immagine
rappresenta per un’impresa. Ma ogni tanto è possibile fare luce su una ribellione
tanto da andare al di là dell’immagine. Nelle Fiji, ad esempio, l’immigrazione indianaha
modificato l’equilibrio demografico e alla fine gli indiani, più istruiti e più ricchi,
sono diventati una piccola maggioranza; nel 1999 hanno eletto un primo ministro indiano,
Mahendra Chaudhry. Le Fiji sono il principale esportatore mondiale di mogano e, poco
dopo il suo insediamento, il governo di Chaudhry ha deciso di affidare le piantagioni
statali di mogano a un’impresa internazionale. Tra i vari concorrenti c’erano la Commonwealth
Development Corporation, un’organizzazione non-profit britannica, con una grande esperienza
di lavoro nei paesi in via di sviluppo, e un’azienda privata statunitense. Come normalmente
accade in questi casi, ciascun concorrente si è appoggiato a imprenditori locali per
presentare la propria offerta e, in un clima di accesa competizione, il governo ha
assegnato il contratto alla Commonwealth Development Corporation. Un mese dopo, il
leader di un gruppo di ribelli locale, George Speight – che per inciso era l’imprenditore
assunto come consulente dall’azienda statunitense –, ha dato il via alla lotta armata
contro il nuovo governo. Lo slogan di Speight, «le Fiji ai fijiani», aveva un forte
impatto emotivo, ma siamo sicuri che Speight fosse animato unicamente dal desiderio
di giustizia sociale? Suppongo che lo slogan «Assegniamo l’appalto del mogano agli
americani» non avrebbe scosso gli animi tanto quanto l’allusione a una battaglia in
difesa degli oppressi.
Che dire della Sierra Leone? La Sierra Leone è un piccolo e poverissimo paese con
un indice di sviluppo umano (calcolato in base ai dati relativi all’aspettativa di
vita, all’alfabetizzazione e al reddito) tra i più bassi del mondo e i suoi abitanti
hanno certamente un sacco di motivi per lamentarsi. Il leader dei ribelli, Foday Sankoh,
è quasi riuscito a impadronirsi del potere – le sue forze erano talmente superiori
a quelle governative che egli ha ottenuto condizioni straordinariamente vantaggiose,
tra cui l’incarico di vicepresidente. Contro ogni previsione, Sankoh ha rifiutato;
il suo obiettivo non era diventare la seconda carica del paese. Egli ha dato chiaramente
a intendere di volere piuttosto dirigere il settore governativo incaricato di gestire
le proficue concessioni di diamanti della Sierra Leone. E la ribellione di Sankoh
non è stata esattamente un’eroica battaglia armata. Le sue reclute preferite erano
giovani adolescenti tossicodipendenti, facilmente controllabili e privi di scrupoli
morali. La loro strategia prediletta era diffondere il terrore tra la popolazione
civile, nel caso tagliando mani e piedi agli abitanti dei villaggi, bambini inclusi.
Passiamo ora a un’altra mistificazione, quella secondo cui tutte le guerre civili
scaturiscono dal conflitto etnico. Può sembrarci scontato se ci basiamo sulla lettura
dei giornali, ma personalmente ho iniziato ad avere dei dubbi. La maggior parte delle
società che vivono in pace sono formate da diverse etnie. E uno dei pochi paesi a
basso reddito completamente omogeneo dal punto di vista etnico, la Somalia, è stato
dilaniato da una guerra civile sanguinosa, seguita dalla dissoluzione totale e protratta
delle istituzioni governative. Statisticamente, non esistono molte prove dell’esistenza
di un nesso tra la diversità etnica e la propensione alla guerra civile. Esistono
in compenso alcuni effetti: nelle società in cui un gruppo è tanto consistente da
costituire la maggioranza della popolazione, ma in cui coesistono anche altri gruppi
importanti – parliamo allora di «supremazia etnica» – i rischi sono effettivamente
maggiori. Pensiamo al Ruanda e al Burundi, teatro di un sanguinoso conflitto di massa
tra hutu e tutsi, e all’Iraq, diviso tra sunniti, sciiti e curdi. Può darsi che in
quei paesi l’etnia dominante cerchi di imporre ovunque il suo potere, come può darsi
anche che le minoranze sappiano di non poter contare sul governo della maggioranza
per quanto riguarda la difesa dei loro interessi e quindi cerchino di prevenirne il
predominio tentando a loro volta di imporsi. Ma questo effetto non è tanto esteso
e la maggior parte delle società dei paesi più arretrati sono troppo diversificate
per consentire a un dato gruppo di imporre la propria supremazia fino a quel punto.
I membri di etnie diverse potranno non provare simpatia gli uni per gli altri, e scambiarsi
animatamente reciproche accuse, ma c’è una bella differenza tra antipatia etnica e
guerra civile.
Cos’altro rende un paese incline alla guerra civile? La geografia ha una certa incidenza.
Un paese immenso, la cui popolazione è disseminata lungo i confini, come la Repubblica
Democratica del Congo (ex Zaire), oppure un paese dotato di vaste regioni montuose,
come il Nepal, sono più a rischio di paesi piccoli, piatti, densamente popolati, probabilmente
perché gli eserciti ribelli dispongono di maggiori spazi per costituirsi e per nascondersi.
Perché le guerre civili durano tanto?
Abbiamo parlato delle cause delle guerre civili. Ma cosa accade dopo lo scoppio di
una guerra civile? Innanzitutto sembrerebbe fondamentale capire cosa determini la
fine del conflitto, ma non sempre è facile; spesso i conflitti di questo tipo si interrompono
temporaneamente per poi riprendere in un momento successivo. In questi casi bisogna
parlare di un’unica guerra civile oppure di due guerre con una pace fallita nel mezzo?
Non esiste una risposta esatta, dipende dalle opinioni, e le opinioni incideranno
sui risultati. Ancora una volta, abbiamo utilizzato parametri fissati da altri, per
evitare di farci influenzare dai nostri pregiudizi.
Ancora una volta, abbiamo a che fare con il basso reddito. Più il reddito di un paese
è basso all’inizio di un conflitto, più il conflitto è destinato a durare. Abbiamo
anche riscontrato che le guerre tendono a durare più a lungo se alcuni prodotti importanti
esportati dai paesi in guerra aumentano di valore; può darsi che in quel caso diventi
più facile finanziare la guerra. Il conflitto in assoluto più finanziato dalle risorse
naturali è stato quello dell’Angola in cui la fazione ribelle, l’Unione nazionale
per l’indipendenza totale dell’Angola (unita), si finanziava con i diamanti, mentre le forze governative, il Movimento popolare
per la liberazione dell’Angola (mpla), si finanziavano con il petrolio. L’evoluzione del conflitto è stata pesantemente
influenzata dal rapporto tra il prezzo del petrolio e quello dei diamanti. Il leader
dell’unita, Jonas Savimbi, inaspriva lo scontro quando aumentavano i guadagni derivanti dalla
vendita di diamanti e i prezzi del petrolio erano a livelli bassissimi. Il suo declino
è iniziato con l’impennata dei prezzi del petrolio e con l’avvio di un’azione internazionale
mirata a impedirgli l’accesso al mercato mondiale dei diamanti. Ma per conoscere la
storia degli interventi internazionali bisogna aspettare la Parte quarta.
Le guerre civili tendono a durare a lungo. In media un conflitto internazionale, di
per sé abbastanza sgradevole, dura circa sei mesi. Si possono causare un sacco di
danni in sei mesi. Ma in media una guerra civile dura dieci volte di più, e può essere
ancora più lunga se al momento dello scoppio il paese è povero. In parte simili conflitti
tendono a prolungarsi perché entrano a far parte della normalità. Entrambi i fronti
sviluppano interessi che possono sopravvivere soltanto durante la guerra. Dati gli
ingenti costi di una guerra, dovrebbe essere possibile trovare un accordo che soddisfi
tutti, ma spesso i ribelli decidono di continuare a combattere piuttosto che correre
il rischio di farsi convincere con l’inganno a firmare un accordo di pace che il governo
potrebbe in seguito rinnegare.
Dopo avere analizzato le cause dello scoppio di una guerra civile e la sua durata,
ci siamo concentrati su ciò che accade quando la guerra finisce. Come ho già fatto
notare, la fine di una guerra spesso non significa la fine del conflitto; una volta
concluso, le probabilità che il conflitto riprenda sono molto alte. Inoltre, nei paesi
che hanno fatto l’esperienza di una guerra civile il rischio di esplosione di un nuovo
conflitto è praticamente raddoppiato. Appena metà dei paesi usciti
...