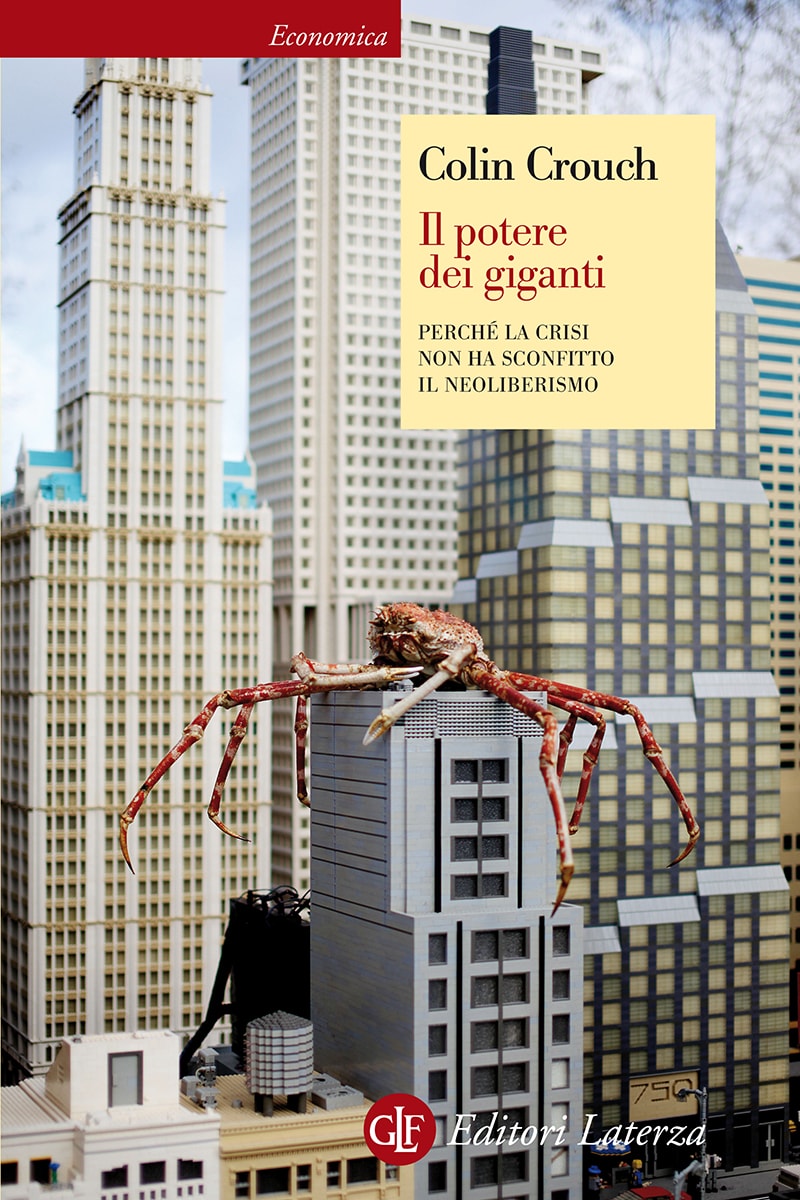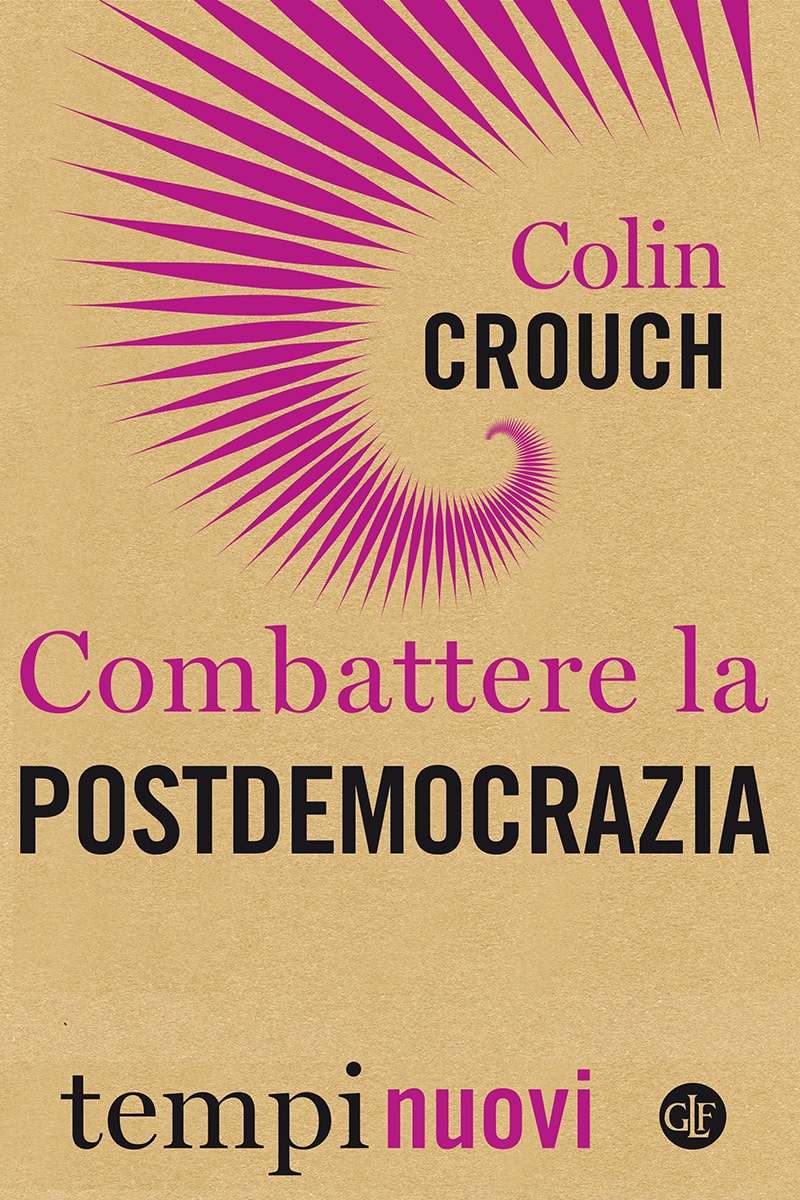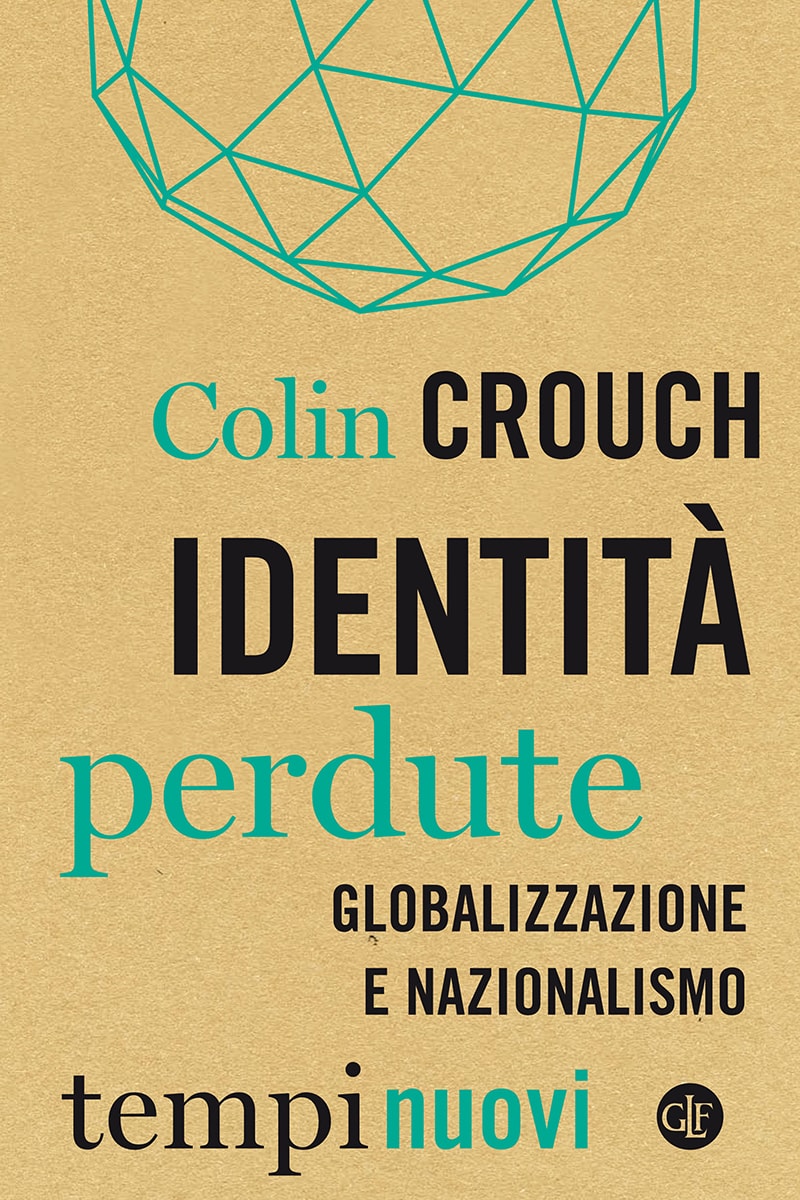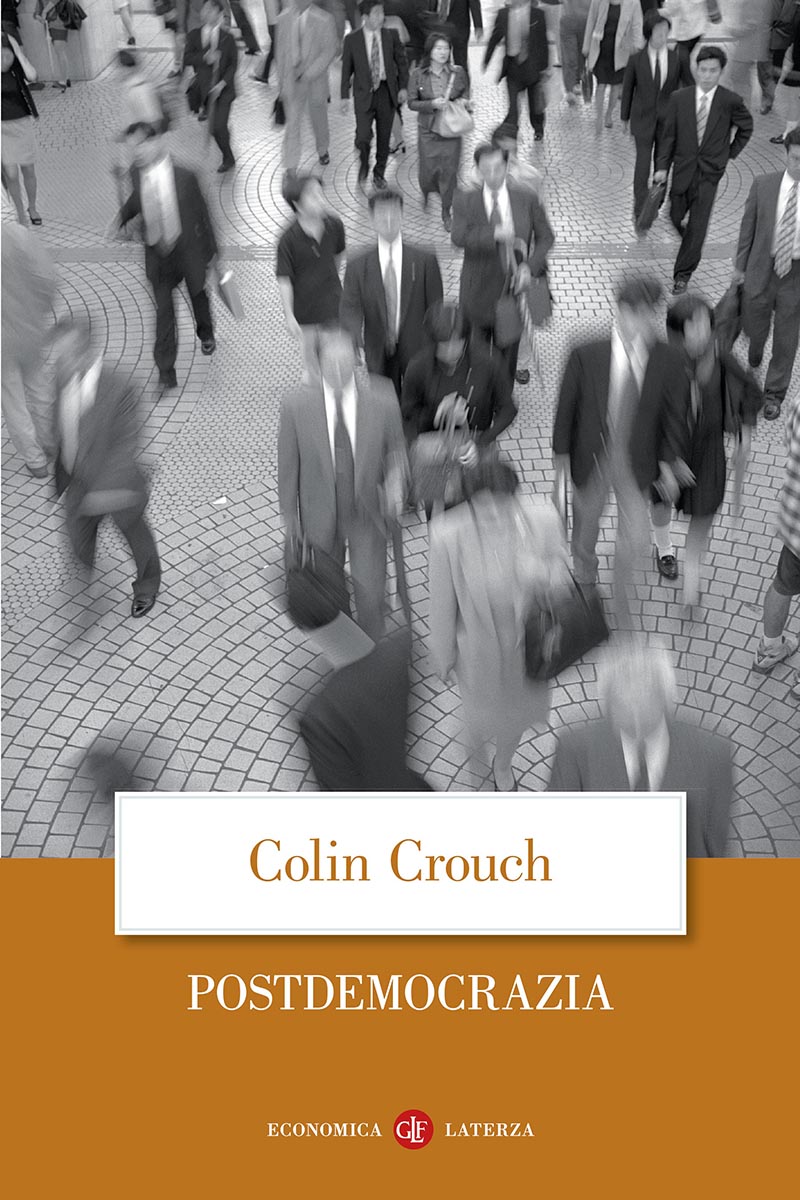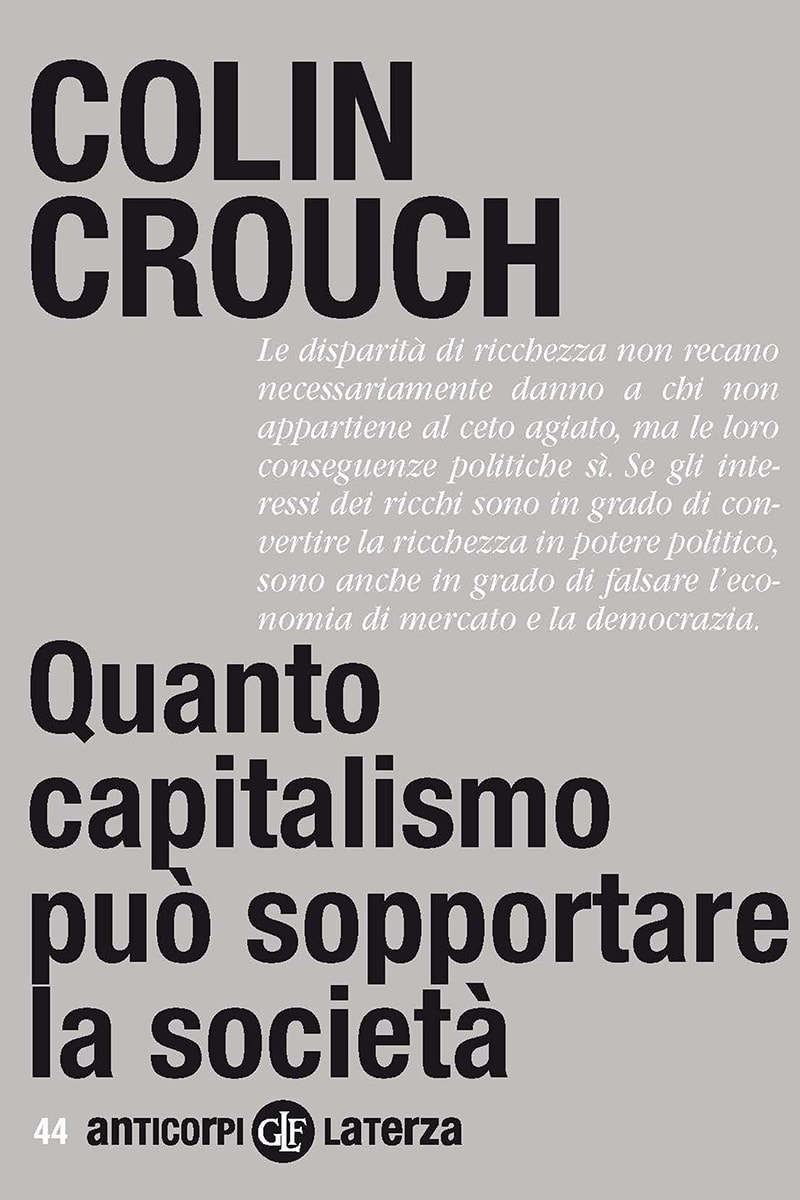Prefazione
Il crollo finanziario del 2008-2009 è parso mettere in crisi il sistema di idee economiche
che dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso è stato dominante nel mondo occidentale
e in molte altre parti del pianeta, generalmente compendiato nel termine “neoliberismo”.
Termine che comprende numerosi filoni e “marchi”, accomunati da un’idea di fondo:
che la libertà dei mercati (dei luoghi, cioè, in cui gli individui massimizzano i
propri interessi materiali) sia il mezzo migliore per appagare le aspirazioni dell’uomo,
e che i mercati siano sempre preferibili agli Stati e alla politica, i quali nel migliore
dei casi sono inefficienti, nel peggiore mettono a repentaglio la libertà.
Il crollo finanziario che ha coinvolto le maggiori banche del mondo ha messo in dubbio
queste idee. Le banche, impegnate a massimizzare i loro profitti, operano nel più
puro dei mercati: com’è possibile che non contribuiscano sempre e comunque ad accrescere
il benessere complessivo dell’uomo? Com’è possibile che gli odierni mercati finanziari
– forse la forma più sofisticata di mercato della storia umana – siano incappati in
una crisi tanto vasta, se la teoria economica più avanzata aveva dimostrato che i
mercati finanziari liberalizzati si correggono da sé? Perché le banche si sono rivolte
ai governi chiedendo di salvarle con somme di denaro ingenti, se gli stessi governi
asseriscono di essere molto meno efficienti delle imprese sul mercato, e di dover
ridurre al minimo i propri interventi sul mercato? E perché i governi hanno accettato
le richieste delle banche? È vero o no che le grandi banche sono “troppo grandi per
fallire”, e che quando hanno problemi i governi e i contribuenti devono correre in
loro aiuto? Se è vero, non significa forse ammettere che il funzionamento del mercato
va incontro a limiti molto seri, e che il neoliberismo vacilla nei suoi presupposti
di fondo?
Nel 1936 George Dangerfield scrisse un volume sulla “strana morte dell’Inghilterra
liberale” (The Strange Death of Liberal England) per spiegare come mai le idee politiche e il partito che verso la fine dell’Ottocento
avevano avuto un ruolo dominante in Inghilterra pochi anni dopo, all’inizio del Novecento,
fossero crollati. Oggi Dangerfield dovrebbe spiegare non i motivi per cui il neoliberismo in crisi è destinato a morire, ma esattamente l’opposto:
come mai esso stia riemergendo, dal collasso finanziario, politicamente più forte
che mai. La crisi finanziaria ha riguardato le banche e i loro comportamenti, ma la
soluzione in molti paesi è stata individuata in un definitivo ridimensionamento del
welfare state e della spesa pubblica. Il tema non riguarda un solo paese, poiché il neoliberismo
è un fenomeno internazionale, o meglio globale. Ci troviamo così oggi a dover spiegare
la “strana” morte mancata del neoliberismo.
Al cuore dell’enigma c’è il fatto che il neoliberismo realmente esistente, a differenza
di quello ideologico puro, non è favorevole come dice di essere alla libertà dei mercati.
Esso, al contrario, promuove il predominio delle imprese giganti nell’ambito della
vita pubblica. La contrapposizione tra Stato e mercato, che in molte società sembra
essere il tema di fondo del conflitto politico, occulta l’esistenza di questa terza
forza, più potente delle altre due e capace di modificarne il funzionamento. Agli
inizi del ventunesimo secolo la politica, proseguendo una tendenza iniziata già nel
Novecento e accentuata anziché attenuata dalla crisi, non è affatto imperniata sullo
scontro tra questi tre soggetti, ma piuttosto su una serie di confortevoli accomodamenti
tra di loro. Uno dei principali obiettivi di questo libro è chiarire perché un dibattito
politico che continui a ruotare intorno allo Stato e al mercato eluda le questioni
implicate da questo importante fenomeno.
Il potere politico dell’impresa appare in tutta evidenza nell’eccezionale attività
delle lobbies soprattutto nel Congresso americano ma anche in molte altre istituzioni legislative
ed esecutive. Ed è visibilissimo pure nella capacità delle imprese transnazionali
(transnational corporations, Tnc) di scegliere su scala mondiale i paesi con il regime
giuridico più favorevole (regime shopping) per localizzarvi i propri investimenti. Tali fenomeni sono ulteriormente rafforzati
da altri fattori. Il primo è la tendenza crescente dei governi a subappaltare molte
delle loro attività a imprese private, che si trovano così coinvolte nella definizione
di politiche pubbliche. Il secondo è lo sviluppo della cosiddetta “responsabilità
sociale dell’impresa”, un processo in base al quale le aziende si assumono compiti
che vanno al di là della loro pura attività economica, trovandosi, ancora una volta,
a fare politiche pubbliche. Il terzo fattore è quello che abbiamo segnalato all’inizio:
la crisi finanziaria degli anni 2008-2009 non ha minimamente messo in discussione
il ruolo dei giganti aziendali, specialmente finanziari, nella società contemporanea,
ma piuttosto non ha fatto altro che accrescerne il potere.
Ho già affrontato in parte alcuni di questi argomenti nel volume Postdemocrazia (Laterza, 2005), in cui indicavo nel potere dell’impresa globale uno dei tanti fattori
che, a mio avviso, stanno contribuendo a svuotare la nostra democrazia. Gli ulteriori
sviluppi di alcuni di quei fattori richiedono di approfondire questo tema, e in particolare
di analizzare i riflessi per la democrazia e per la politica del fatto che molte grandi
imprese non sono più solo centri di pressione potenti, ma partecipano al processo
politico dall’interno, con un ruolo importante: un fenomeno su cui nessuna teoria
economica o politica si sofferma o prende posizione, ma che costituisce una realtà
centrale della nostra vita pubblica.
Di questi sviluppi non è vittima solo la democrazia, ma anche il mercato. Ciò appare
a prima vista sorprendente, dal momento che gran parte del dibattito politico non
distingue minimamente tra mercato e imprese. Ma è proprio da questa mancata distinzione
che derivano parecchi nostri problemi, mentre il conflitto tra “Stato e mercato”,
che assorbe tanta della nostra attenzione, è sostanzialmente superato. Anziché parlare
di confronto triangolare tra Stato, mercato e grande impresa, preferirei parlare di
“confortevole adattamento”. Questo, in parte perché le grandi imprese hanno tutto
l’interesse ad amalgamare tutti e tre gli elementi, in parte perché l’unica alternativa
a un qualche tipo di accomodamento sarebbe una società assolutamente immiserita, in
cui uno o più di questi tre elementi sia talmente danneggiato da perdere la propria
funzione. Basta rifletterci un momento per capire quanto diverrebbe difficile, in
questa eventualità, la nostra vita.
Questo libro, dunque, non intende minimamente sostenere che dobbiamo liberarci della
grande impresa. I vari sostenitori del liberalismo jeffersoniano e del marxismo, che
hanno cercato un esito del genere, fanno parte di un passato ormai superato. Piuttosto,
questo libro guarda a una quarta forza – le voci vivaci ma flebili della società civile
–, non per cancellare quella confortevole triangolazione, ma per portarne alla luce
i misfatti e gli abusi, per sottoporli a critica e tenerli sotto pressione. Questa
impostazione non promette certo un ordine sociale diverso dal capitalismo imperniato
sulla grande impresa, ma, se le nostre società rimarranno aperte e vigili, potrà migliorare
la vita molto più di quanto possano fare gli Stati e le grandi imprese lasciati a
se stessi.
Non ci resta dunque che parafrasare Andrew Marvell: «Così, visto che non possiamo
fermare la grande impresa, / Noi la faremo correre».
Su questo libro
Gran parte della letteratura su questi temi è scritta dal punto di vista di chi vuol
mostrare come il mondo potrebbe essere cambiato dall’autore stesso (se ne avesse l’opportunità),
oppure dai leader politici cui si rivolge. Ma pochissime persone sono in condizione
di cambiare il mondo, e, di quelle poche, molte vorrebbero cambiarlo in peggio. Esiste
invece una platea molto più ampia, fatta di persone costrette a vivere meglio che
possono nel mondo così com’è. Questo libro è scritto per loro. Postdemocrazia nacque da un opuscolo da me scritto per la Fabian Society, intitolato Coping with Post-Democracy. Il titolo del libro fu semplificato, ma aveva la stessa intenzione: come vivere
in un mondo che per la gente comune è quasi totalmente incontrollabile. Il libro attuale
è un seguito di Postdemocrazia, si sovrappone ad esso per alcuni temi ed è indirizzato agli stessi lettori.
Come Postdemocrazia, anche questo non è uno studio accademico, ma si rivolge a un pubblico generale.
È stato perciò alleggerito del pesante fardello di bibliografie e note a piè di pagina
(che in un lavoro scientifico non possono mancare), e si conclude con pochi riferimenti
bibliografici che costituiscono suggerimenti per ulteriori letture sui temi trattati.
Alcuni capitoli sono tentativi di dar conto, in forma più accessibile, del mio lavoro
accademico; in particolare:
– i capitoli 2 e 4 attingono al mio capitolo Marketization, in M. Flinders et al. (a cura di), The Oxford Handbook of British Politics, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 879-895 (testo utilizzato con l’autorizzazione
dell’editore);
– il capitolo 3 riutilizza il mio capitolo The Global Firm: The Problem of the Giant Firm in Democratic Capitalism, in D. Coen (a cura di), The Oxford Handbook of Business and Government, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 148-72 (testo utilizzato con l’autorizzazione
dell’editore);
– il capitolo 5 è largamente basato sul mio articolo Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime, «The British Journal of Politics and International Relations», 11/3 (2009), pp.
382-399;
Avvertenze
– il capitolo 6 si rifà in parte al mio articolo Modelling the Firm in its Market and Organizational Environment: Methodologies for
Studying Corporate Social Responsibility, «Organization Studies», 27/10 (2007), pp. 1533-1551;
– il capitolo 7 riprende parzialmente il mio capitolo Privates, Publics and Values, in J. Benington e M. Moore (a cura di), Public Value: Theory and Practice, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
I. Il cammino del neoliberismo fino alla crisi attuale
Il neoliberismo, come vedremo dettagliatamente più avanti, assunse una posizione dominante
in coincidenza con l’inflazione degli anni Settanta del Novecento, quando la teoria
rivale che l’aveva preceduto, nota come gestione keynesiana della domanda, andò fortemente
in crisi. Poiché quella crisi ebbe un effetto pressoché letale per il modello keynesiano,
potevamo aspettarci che la crisi attuale portasse con sé la fine della supremazia
neoliberista e la nascita di un nuovo modello. Invece, le cose non sono andate così.
Ma se la crisi degli anni Settanta condusse non a semplici aggiustamenti, ma a un
vero e proprio tracollo del keynesianesimo, non fu perché le sue idee fossero sbagliate,
ma perché il modello keynesiano era orientato soprattutto sugli interessi dei lavoratori
manuali della società industriale occidentale – una classe storicamente in declino
e che andava perdendo la sua forza sociale. Le forze maggiormente avvantaggiate dal
neoliberismo – prime fra tutte le imprese globali, soprattutto del settore finanziario
– mantengono invece praticamente inalterata la loro importanza. Le banche sono emerse
dalla crisi del 2008-2009 più forti di prima, sebbene quest’ultima fosse stata provocata
proprio dai loro comportamenti: anzi, sono ritenute talmente importanti per l’economia
di questo inizio di secolo da dover essere protette dalle loro stesse follie, mentre
la maggior parte degli altri settori colpiti dalla crisi è rimasta priva di protezione
e i servizi pubblici ne sono usciti decisamente malconci e hanno subito pesanti tagli.
Gli ingenti bonus pagati ad alcuni dirigenti delle banche sono stati al centro del dibattito seguito
alla crisi, ma si è continuato a pagarli asserendo che fossero necessari per riportare
alla solvibilità il settore finanziario – e con esso interi Stati –, sebbene quei
premi venissero in parte pagati con i soldi dei contribuenti, attraverso i salvataggi.
Il settore finanziario ha dimostrato come il resto della società dipenda dal suo funzionamento,
soprattutto nel mondo anglo-americano in cui questa forma particolare di attività
bancarie si è particolarmente sviluppata. Protetta anche quando vengono tagliati gli
altri settori, e in particolare i servizi pubblici, la finanza avrà un ruolo sempre
più rilevante nella struttura economica dei paesi anglosassoni.
Tuttavia, prima di analizzare le implicazioni di questi dati di fatto per la pretesa
neoliberista di mettere al centro di tutto la libertà dei mercati, daremo un’occhiata
più da vicino al neoliberismo: che cos’è, e da dove viene? Nei capitoli 2, 3 e 4 ci
soffermeremo poi sulla consueta contrapposizione tra Stato e mercato e sull’emergere
della grande impresa come elemento fondamentale che in questo processo ne modifica
la natura. Nel capitolo 5 torneremo ad analizzare in dettaglio il passaggio dal modello
keynesiano al neoliberismo nelle sue implicazioni più ampie e illustreremo i motivi
per cui la grande impresa è emersa dall’ultima crisi come la vera istituzione-chiave.
Nel capitolo 6 esamineremo il profilo politico delle società in cui le grandi imprese
hanno assunto una importanza centrale sul piano politico e ci soffermeremo sul concetto
di corporate social responsibility, mentre nel capitolo 7 ci concentreremo su un tema già affacciatosi nei capitoli
precedenti: quale posto spetta, nel rapporto tra mercato, Stato e grande impresa,
ai valori, e soprattutto a quelli che riguardano le questioni pubbliche e collettive?
Nel capitolo finale ci si chiederà che cosa possiamo fare di fronte a tutto questo.
Il neoliberismo: le origini e la sua falsa partenza
Molti dei termini che oggi usiamo in riferimento alla vita pubblica contengono i prefissi
“neo”, new o “post”: neoliberal, neoliberista, neoconservatore, New Labour, postindustriale, postmoderno, postdemocratico. Vogliamo mostrarci pienamente impegnati
in un fondamentale cambiamento sistemico, ma, non conoscendo realmente la nostra nuova
condizione, per autodefinirci facciamo riferimento a ciò che ci lasciamo alle spalle
(“post”) o a ciò che ha un vago sentore di rinnovamento e di innovazione (“neo”).
Il neoliberismo è uno di questi concetti. Per averne una prima comprensione dobbiamo
sapere che cosa è (o era) il liberalismo e che cosa indica il prefisso.
Il “liberalismo”, come tutti i termini politici, ha un significato mutevole. Al giorno
d’oggi tende sempre più verso la sinistra politica man mano che ci si sposta verso
occidente. In Europa, e soprattutto negli Stati ex socialisti, viene associato a partiti
politici che sostengono una rigorosa applicazione alla vita economica dei principi
di mercato (politicamente associati quasi sempre alla destra) e ampie libertà civili
(associate perlopiù alla sinistra). Negli Stati Uniti il termine si ricollega in generale
a una sinistra politica che condivide l’impegno europeo per le libertà civili e si
oppone strenuamente a qualsiasi esercizio di potere politico da parte delle religioni
organizzate, ma che in fatto di mercato ha un orientamento totalmente opposto: i liberal americani, infatti, di solito sono convinti fautori dell’intervento statale nell’economia
– il contrario di ciò che il termine significava storicamente.
Per comprendere questa complessità dobbiamo risalire al Sei-Settecento, quando la
critica al blocco di potere formato da monarchi, aristocrazia, papa e vescovi si diffuse,
prima in Europa e poi in Nord America. Quei poteri non ammettevano in linea di principio
che gli individui fossero titolari di diritti; erano solo disposti ad accordar loro
privilegi e specifiche libertà (al plurale), da loro revocabili allo stesso modo in
cui erano stati da loro concessi. Lo scontro avvenne inizialmente sul piano delle
idee ed ebbe come posta in gioco la libertà di pensiero, ma la ricchezza delle classi
borghesi, sviluppatasi con i commerci e poi con l’industria, creò una base di potere
alternativa alla Chiesa e allo Stato monarchico. La richiesta borghese di liberare
i mercati dalla stretta delle autorità secolari e religiose che rilasciavano monopoli
commerciali in cambio di denaro si saldò alla generale rivendicazione del diritto
di libertà come caratteristica unica e indivisibile, che nessuno aveva il potere di
concedere ed era insita nell’uomo. In un mondo in cui i poteri della Chiesa, dello
Stato e della proprietà fondiaria non potevano essere semplicemente cancellati, la
realizzazione della libertà si tradusse in pratica nel tentativo di operare delle
separazioni: dello Stato dall’economia, della Chiesa dalla politica; di tutti i vari
ambiti, compresa la famiglia, dal giudizio morale sullo stile di vita individuale.
Di conseguenza, la vita venne a suddividersi in compartimenti separati, con l’effetto
di limitare il raggio d’azione del potere e di ottenere la libertà individuale.
Secondo i conservatori questo processo condannava gli individui alla solitudine, all’anomia
e all’assenza di una morale comune, e spingeva alla deriva una società sempre più
frammentata. Alla fine dell’Ottocento il diritto di proprietà borghese, e con esso
il diritto liberale di possedere fabbriche e altre basi dell’attività economica e
di utilizzare manodopera salariata, era divenuto a sua volta fonte di dominio e potere.
A questo punto, gli operai e gli altri soggetti la cui esistenza era controllata dai
datori di lavoro, per controbilanciare il potere di questi ultimi, iniziarono a guardare
allo Stato, il quale progressivamente si trasformò in senso democratico. Parecchi
osservatori sociali iniziarono a lamentare il primato assoluto dei valori del mercato
e del denaro su ogni altro aspetto della vita sociale. La tradizione liberale si divise
in due.
Una prima corrente, d’ispirazione sociale, si concentrò sui diritti – compreso il
diritto delle masse lavoratrici a uscire dalla povertà – e finì, paradossalmente,
per fare sempre più affidamento sul vecchio nemico dei liberali: lo Stato. Spesso
questi liberali si ritrovarono in scomoda compagnia dei socialisti che intendevano
utilizzare il potere statale per abolire il diritto capitalistico di proprietà. Un’altra
corrente guardava invece all’economia, ponendo l’accento soprattutto sulla libertà
di proprietà e di mercato. I liberali di questo tipo finirono per trovarsi sempre
più in sintonia con i loro antichi avversari conservatori, i fautori del vecchio regime,
nella difesa dell’autorità e della proprietà da ogni genere di attacco, soprattutto
se proveniente dalla democrazia. Lo Stato democratico dominato da una classe operaia
priva di proprietà sembrava mettere a repentaglio la separazione tra economia e Stato,
che era il pilastro sia del concetto di libertà sia del funzionamento efficiente del
mercato. Una ulteriore complicazione era dovuta al fatto che liberali di orientamento
sociale, socialisti e conservatori si trovavano talvolta d’accordo nel denunciare
il trionfo del materialismo e l’assenza di valori morali provocata dal capitalismo
e dal liberismo economico. Questi diversi orientamenti teorici o politico-pratici
liberali presero così vie separate, pur con accenti diversi a seconda dei luoghi.
Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, il contesto dell’originaria contrapposizione
tra liberalismo e Stato era ormai molto cambiato. Alla fine degli anni Venti l’economia
capitalistica liberale, basata su un livello minimo di intervento statale, era sembrata
naufragare nel momento in cui il mondo precipitò in una depressione di vasta portata.
Negli anni Trenta erano emersi tre approcci economici alternativi, apparentemente
più efficienti e orientati allo sviluppo: il comunismo nell’Unione Sovietica, il fascismo
in Germania e in Italia e le varie combinazioni tra gestione pubblica della domanda
e iniziative di welfare state negli Stati Uniti, nei paesi scandinavi e per un breve periodo in Francia. Questi
tre approcci, per quanto diversi, avevano in comune un ricorso al potere dello Stato
diverso da quello previsto dal liberalismo classico. Dopo la guerra e la sconfitta
(quasi totale) del fascismo, lo Stato sovietico estese il proprio dominio su mezza
Europa, esercitando un potere dittatoriale ma dimostrando anche, almeno come sembrò
all’epoca, una discreta competenza economica; di lì a poco, avrebbe trovato uno scomodo
e temporaneo alleato politico nel regime affermatosi nel paese più popoloso del mondo,
la Cina. In Europa occidentale, America settentrionale, Giappone, India e Australasia,
invece, l’approccio americano-franco-scandinavo caratterizzato dall’intervento economico
e sociale dello Stato democratico nell’ambito di una economia decisamente capitalistica
guadagnò il consenso di quasi tutte le sfumature dell’opinione politica e intellettuale,
pur assumendo una grande varietà di forme. L’originaria visione liberale di una economia
regolata dal mercato con intervento minimo da parte dello Stato pareva ormai sepolta.
Il liberalismo poteva sopravvivere nella sua versione sociale: come rivendicazione
dei diritti e della libertà, ma senza quella che a suo tempo era stata una sua componente
fondamentale: la rivendicazione del diritto di possedere beni e disporne senza interferenze
da parte dello Stato.
Torneremo su questi interventi statali: ma prima dobbiamo analizzare che cosa era
accaduto, nel frattempo, alle idee economiche liberiste. Esse in realtà non erano
scomparse. I ricchi, sempre disponibili a finanziare progetti intellettuali e a foraggiarne
gli autori negli anni duri, conservarono la fiducia in un modello basato su diritti
di proprietà illimitati, scarsa regolamentazione e tasse leggere. Inoltre, quando
diventò di pubblico dominio la verità sulle condizioni di vita e sull’assenza di libertà
nei paesi dell’Europa orientale, essa divenne per tutti un monito costante sui rischi
del potere statale. Questa sensibilità si sviluppò soprattutto negli Stati Uniti,
dove l’antica eredità della dominazione inglese e della corruzione politica dilagante
nel periodo successivo all’indipendenza avevano alimentato un generale sospetto nei
confronti dello Stato, dando vita a una corrente di idee che assimilava al comunismo
qualsiasi intervento governativo nell’economia e nella società. Negli anni Cinquanta
le campagne all’insegna dell’intolleranza promosse in America a nome dello Stato dal
senatore Eugene McCarthy puntarono energicamente ad epurare la vita pubblica da chiunque
fosse anche solo sospettato di inclinazioni comuniste. La difesa del liberismo economico
poteva anche diventare molto illiberale. E così, negli Stati Uniti il termine liberal subì un capovolgimento semantico, finendo per designare i sostenitori del welfare state e, in generale, dell’intervento economico dello Stato.
Ma il contrattacco del liberismo economico era iniziato già in precedenza. Prima ancora della caduta di Hitler un gruppo di
liberali tedeschi e austriaci aveva iniziato a riflettere sulla costruzione di un
nuovo ordine economico postbellico in Germania, che avrebbe dovuto riportare in auge
la borghesia imprenditoriale, oppressa, secondo loro, allo stesso modo dal comunismo,
dal fascismo e dalle politiche interventiste dello Stato democratico. Questi pensatori,
pur non negando legittimità, in linea di principio, all’intervento statale, pensavano
che il governo dovesse avere come compito primario la salvaguardia dell’economia di
mercato, di cui erano convinti fautori. Ai loro occhi la concorrenza tra tante imprese
aveva importanza fondamentale per garantire l’efficienza del mercato, la libertà di
scelta del consumatore e la sopravvivenza di una borghesia che né doveva perdere il
suo posto ed essere sospinta in un proletariato anticapitalista, né doveva acquisire
i poteri del big business, delle imprese gigantesche che sostenevano Hitler. Questi liberali tedeschi temevano
che un processo competitivo in cui chi vince prende tutto ed è libero di assorbire
i concorrenti fosse destinato a porre termine alla concorrenza e a condurre al trionfo
della grande impresa, e guardavano perciò con favore alla legislazione antitrust americana, all’uso cioè del potere statale per limitare la quota di mercato di una
singola impresa e proteggere la concorrenza dalle sue stesse conseguenze. Il sistema
da essi propugnato non era una totale libertà di mercato, ma una forma di liberismo
economico (definito Ordoliberalismus) che assegnava alla legge il compito di garantire la concorrenza. Il perno di questa
impostazione era una concezione “sociale” del “mercato”: ed “economia sociale di mercato”
divenne appunto il nome dato alla sua incarnazione concreta nella maggior parte della
storia politica postbellica della Repubblica federale tedesca. Con un ennesimo capovolgimento
di significato di un termine politico quello stesso concetto, nato dalla reazione
liberista all’interventismo dello Stato sociale, finì per essere utilizzato negli
anni Ottanta per designare lo Stato sociale interventista.
In realtà, secondo questo nuovo filone del liberismo economico lo Stato, e in particolare
la legge, doveva limitarsi esclusivamente a garantire il funzionamento delle forze
di mercato, evitando di perseguire altre finalità. Queste idee presero piede anche
negli Stati Uniti, dove i loro autori furono chiamati neoliberal, perché in quel paese il liberalismo in quanto tale aveva assunto un significato
totalmente diverso. Questo filone si è sviluppato in numerose varianti e sfumature,
ma se si vuole coglierne l’essenza occorre guardare soprattutto a questa sua preferenza
di fondo per il mercato come mezzo (alternativo allo Stato) per risolvere problemi
e perseguire finalità umane.
A questo punto dobbiamo analizzare come questo rilancio del liberalismo si trasferì
dal terreno ideale a quello politico-pratico, e a tal fine prenderemo in esame gli
altri approcci di politica sociale ed economica sviluppatisi dopo la Seconda guerra
mondiale.
Il momento della socialdemocrazia
Il comunismo o socialismo di Stato, il fascismo e il liberismo economico rappresentano
sistemi di orientamento politico definiti in termini molto chiari. Gli approcci emersi
nel mondo occidentale durante o subito dopo la Seconda guerra mondiale erano molto
più variegati, impegnati com’erano a cercare un compromesso tra i principali antagonisti,
ciascuno ormai convinto dell’impossibilità di prendere il sopravvento sugli avversari
e di garantire a priori la superiore efficacia delle proprie politiche. Recentemente
è diventato di moda associare a queste alternative i concetti di “economia sociale
di mercato” e “socialdemocrazia”. In realtà non solo la prima espressione, come si
è già osservato, ma anche la seconda costituiva un totale ribaltamento del significato
originario: alla fine dell’Ottocento si erano infatti autodefiniti “socialdemocratici”
i movimenti anticapitalistici della classe operaia, che utilizzavano anche altri termini,
come “socialista”, “comunista” e “lavoratori” – tutte parole usate in modo più o meno
intercambiabile da movimenti che in origine avevano elaborato strategie per eliminare
il capitalismo e sostituirlo in una prima fase con la proprietà statale e poi con
una visione vagheggiata di proprietà diffusa, destinata a porre fine persino allo
Stato.
Dopo la Rivoluzione russa del 1917 i partiti che in tutto il mondo si erano alleati
con la nuova dirigenza sovietica assunsero tutti o quasi la qualificazione “comunista”.
Perché gli altri termini acquisissero una connotazione diversa si dovette attendere
fino agli anni Cinquanta, quando in Svezia e in Germania i partiti dei lavoratori
(denominati, guarda caso, “socialdemocratici”) abbandonarono formalmente l’obiettivo
del superamento del capitalismo e dichiararono di voler agire nel quadro di una economia
prevalentemente imperniata sulla proprietà privata. Nel 1959 i socialdemocratici tedeschi
adottarono persino lo slogan So viel Markt wie möglich; so viel Staat wie nötig (“Più mercato possibile, e tutto lo Stato che occorre”). Altri partiti erano approdati,
di fatto, alla stessa posizione, ma per molto tempo non lo ammisero apertamente (il
partito laburista britannico lo fece solo negli anni Novanta). Il termine “socialdemocratico”
finì per indicare una politica moderata di centrosinistra. Esso era ancora associato
a un particolare tipo di partito politico, ma negli anni Novanta, come la sua ex rivale
– l’“economia sociale di mercato” – finì per designare, genericamente, una impostazione
politica che occupava un’area del vasto spazio intermedio tra mercato puro ed economia
statale. Dal 1950 in poi, per un quarto di secolo circa, gran parte dello spettro
politico, almeno nei paesi dell’Europa occidentale, poteva essere fatto rientrare
nel terreno che oggi molto genericamente si definisce socialdemocratico. Tuttavia
ovunque (a parte il Nord Europa) è accaduto raramente che i partiti socialdemocratici
avessero il controllo del governo.
Pertanto l’aggettivo “socialdemocratico”, alla stregua di “conservatore” o “liberale”,
sta a indicare da una parte partiti politici o altre organizzazioni formali, dall’altra
anche – in senso molto più ampio – un complesso di idee, di approcci politici e di
mentalità.
In quest’ultima accezione il termine “socialdemocrazia” indica oggi qualsiasi strategia
che cerchi di combinare potere dello Stato e mercato per realizzare una economia che massimizzi l’efficienza ma eviti i principali
choc (provocati dall’uomo), perseguendo alcune finalità sociali ritenute difficilmente
realizzabili attraverso il solo mercato e limitando le disuguaglianze prodotte dal
mercato stesso. Talvolta (anche se forse meno spesso di quanto si pensi) si crea una
tensione tra gli obiettivi della efficienza e della riduzione delle disuguaglianze;
ma in ogni caso i due obiettivi sono interdipendenti. Nei paesi caratterizzati da
disuguaglianze estreme mancano sia quella vasta base di consumatori abbienti in grado
di sostenere la domanda di beni e servizi, sia un numero adeguato di persone che godano
di sicurezza economica sufficiente a sviluppare gli atteggiamenti critici e innovativi
da cui dipendono il dinamismo e la stessa efficienza. Si deve all’interdipendenza
di quei due obiettivi se la socialdemocrazia ha potuto realizzare un ampio ventaglio
di compromessi sociali, e si deve alla loro tensione se nel ventesimo secolo, e ancora
all’inizio del ventunesimo, i limiti del mercato e dell’intervento regolatore dello
Stato sono diventati il principale tema di conflitto politico.
Se tra Ottocento e inizio Novecento le élite avevano una visione negativa e pessimistica
della democrazia, era perché non riuscivano a individuare un modo per diffondere il
benessere di massa abbastanza rapidamente da evitare che la furia di una plebe famelica
smantellasse il sistema imperniato sui diritti di proprietà. Le élite più ottimiste,
ad esempio in Gran Bretagna, riponevano le proprie speranze in una graduale e simultanea
espansione della proprietà e dei diritti di cittadinanza e puntavano a favorire la
prima attraverso gli aumenti salariali, la stabilità dei lavoratori specializzati,
l’aumento del numero degli impiegati e fenomeni come il movimento delle cooperative
edilizie, volte a diffondere gradualmente la proprietà immobiliare.
Ma il problema non era solo che i lavoratori erano poveri e non avevano proprietà.
Essi erano afflitti anche dalla precarietà dovuta alle vistose fluttuazioni dell’economia.
La politica di assistenza sociale di fine Ottocento, iniziata in Germania e gradualmente
diffusasi in Francia, nell’Impero austro-ungarico, in Gran Bretagna e in altri paesi,
cercò di arginare l’insicurezza istituendo tutele di tipo assicurativo in caso di
perdita del reddito per disoccupazione, malattia o vecchiaia. Erano politiche limitate
per ambizioni, ampiezza e risultati, ma furono i primi tasselli di quella che sarebbe
diventata la socialdemocrazia.
Queste tendenze indebolirono la fiducia nel liberismo economico. Ma prima occorre
ricordare la risposta al problema della povertà – risposta più concreta e più compatibile
con il liberismo – emersa agli inizi del Novecento dal sistema di produzione di massa
dell’industria manifatturiera, inizialmente associata soprattutto alla fabbrica di
automobili americana Ford. Grazie alla tecnologia e all’organizzazione del lavoro
era possibile accrescere la produttività dei lavoratori non specializzati, in modo
da abbassare i costi di produzione dei beni, favorire un aumento dei salari e accrescere
il potere d’acquisto dei lavoratori. Il produttore e il consumatore di massa nacquero
contemporaneamente, ed è significativo che questo avanzamento avvenisse nel paese
che più di ogni altro, in quel periodo, si avvicinò a un’idea base di democrazia (per
quanto limitata in chiave razziale). La democrazia e la tecnologia contribuirono alla
costruzione del modello. Tuttavia, il tema dell’insicurezza macroeconomica (cioè al
livello dell’economia generale) rimase in tutta la sua gravità, come dimostrò nel
1929 il crollo di Wall Street, pochi anni dopo l’avvento del modello fordista. Il
problema di come conciliare l’instabilità del mercato con l’esigenza di stabilità
dei consumatori-elettori rimase irrisolto. Ciò rafforzò, in gran parte d’Europa, sia
le tendenze favorevoli al comunismo e al fascismo, sia quelle più moderate e coerenti
con la democrazia, che sostenevano la necessità di interventi pubblici per salvare
i mercati dal rischio evidente che si autodistruggessero.
Alla fine della Seconda guerra mondiale le élite di tutte le società in via di industrializzazione
avevano capito chiaramente che aver tentato di servirsi del fascismo per difendere
il diritto di proprietà dalla democrazia era stato un errore disastroso. Capitalismo
e democrazia dovevano essere interdipendenti, almeno in quelle parti del mondo in
cui non era facile soffocare i movimenti popolari. La spirale virtuosa innescata dal
modello fordista della tecnologia della produzione di massa, che stimolò un aumento
dei salari, e quindi dei consumi di massa e della domanda di beni prodotti in serie,
rappresentò una parte della risposta. L’approccio di più ampio respiro della politica
sociale che stava emergendo proprio allora in Scandinavia e in Gran Bretagna con il
welfare state fu invece la risposta al problema dell’insicurezza. Lavoratori-consumatori fiduciosi
e sicuri non erano una minaccia per il capitalismo e aprivano possibilità di espansione
dei mercati e dei profitti su una scala senza precedenti. Il capitalismo e la democrazia
divennero interdipendenti.
Nel promuovere questo nuovo modello, un ruolo fondamentale ebbe anche quella che è
universalmente nota come “gestione keynesiana della domanda”, dal nome dell’economista
inglese John Maynard Keynes (sebbene le idee siano state elaborate da diversi gruppi
di economisti britannici e svedesi). Il nuovo approccio fu applicato soprattutto nei
paesi scandinavi, in Gran Bretagna, in Austria e, in misura minore, negli Stati Uniti,
ma fu adottato anche da organismi internazionali come la Banca Mondiale, e per trent’anni
divenne l’ortodossia in tutto l’Occidente capitalistico: nei periodi di recessione,
quando la fiducia scendeva, i governi si indebitavano per stimolare l’economia attraverso
la spesa pubblica, mentre nelle fasi di inflazione, quando la domanda si surriscaldava,
tagliavano la spesa pubblica, restituivano il denaro preso a prestito e riducevano
la domanda aggregata. Il modello presupponeva bilanci pubblici di dimensioni cospicue,
affinché le loro variazioni avessero effetti significativi sull’economia di un paese.
In alcuni paesi, come in Gran Bretagna, ciò fu possibile solo con il forte aumento
delle spese militari dovuto alla Seconda guerra mondiale. Le guerre precedenti avevano
visto crescere molto la spesa statale, che tuttavia a guerra finita si sgonfiava ogni
volta. Alla fine della Seconda guerra mondiale le cose cambiarono: le spese militari
furono sostituite dalla spesa per il nuovo welfare state in pieno sviluppo.
Il modello keynesiano proteggeva la gente comune dalle oscillazioni improvvise del
mercato che fino allora ne avevano reso precaria l’esistenza, e attenuando le fluttuazioni
del ciclo economico diffuse una fiducia crescente, spingendo a consumare in massa
i prodotti di un’industria di massa altrettanto ottimista. La disoccupazione scese
a livelli molto bassi. Il welfare state non si limitò a fornire ai governi strumenti di gestione della domanda, ma portò
con sé anche servizi reali in ambiti estranei al mercato ma importantissimi per la
vita delle persone. La teoria keynesiania non era ostile ai mercati o al capitalismo.
La gestione indiretta della domanda, insieme con il welfare state, proteggeva il resto dell’economia capitalistica dai crolli della fiducia, da un
controllo eccessivamente dirigistico dei mercati e dagli attacchi di forze politiche
ostili, e metteva al riparo la vita dei lavoratori dall’imprevedibile andamento del
mercato. Fu un vero e proprio compromesso sociale.
Un’ultima componente del modello di gestione della domanda sviluppatosi nel dopoguerra
fu il sistema di relazioni industriali di stampo neocorporativo. Questo aspetto non
era stato previsto da Keynes, mancò quasi totalmente negli Stati Uniti e fu presente
solo sporadicamente in Gran Bretagna, ma ebbe un ruolo fondamentale nell’Europa settentrionale,
in Olanda e in Austria. In un contesto di relazioni industriali neocorporative, i
sindacati e le associazioni dei datori di lavoro cercano di evitare che i loro accordi
abbiano effetti inflazionistici, per salvaguardare i prezzi soprattutto dei prodotti
destinati all’esportazione. Ciò è possibile solo se queste organizzazioni hanno sulle
imprese e sui lavoratori autorità sufficiente a garantire il rispetto sostanziale
dell’accordo. Questo genere di negoziazione collettiva aveva particolare importanza
in paesi abbastanza piccoli con una economia fortemente dipendente dal commercio con
l’estero. L’unico paese di grandi dimensioni con un assetto del genere era la Germania,
in cui le esportazioni avevano la priorità rispetto alla crescita del mercato interno
e il movimento sindacale era dominato da un’unica grande organizzazione per i settori
della siderurgia e dell’impiantistica, particolarmente sensibili al prezzo delle esportazioni.
Per riassumere, ecco quali furono gli ingredienti principali dell’ordine socioeconomico
che finì per essere genericamente chiamato “socialdemocratico”:
– gestione keynesiana della domanda: l’azione di governo non punta a distruggere i
mercati, ma a sostenerli in modo da evitare espansioni o depressioni eccessive e autodistruttive;
– welfare state forte: gli individui usufruiscono di servizi in natura e non solo mediati dal mercato,
e dunque percepiscono voci di reddito indipendenti dall’andamento del mercato o dalla
proprietà, che ne diversificano le opportunità di vita anziché lasciare che esse vengano
determinate esclusivamente dal mercato;
– relazioni industriali neocorporative (in alcuni casi): si tenta di bilanciare la
libertà di organizzazione dei lavoratori e l’esigenza di un funzionamento efficiente
dei mercati del lavoro.
Che cosa è andato storto, allora?
La seconda occasione del neoliberismo
L’economia keynesiana aveva un tallone di Achille: le tendenze inflazionistiche del
modello, dovute al suo meccanismo a senso unico azionato dalla politica. I paesi che
adottarono politiche keynesiane senza un solido sistema neocorporativo – in primis Gran Bretagna e Stati Uniti, ma dagli anni Settanta anche Francia e Italia – si trovarono
esposti a forti ondate inflazionistiche. In questi paesi, vari gruppi di lavoratori,
per proteggersi dall’inflazione, chiedevano aumenti salariali senza il controllo di
sindacati neocorporativi attenti al probabile effetto di questo genere di concorrenza,
per cui ogni aumento salariale non faceva che provocare ulteriori aumenti dei prezzi.
In un mercato totalmente libero, un simile comportamento sarebbe stato punito dal
calo della domanda conseguente all’aumento dei prezzi, e dunque dalla disoccupazione.
In linea di principio, lo Stato keynesiano, di fronte al rischio di inflazione, avrebbe
potuto ridurre la spesa pubblica e/o aumentare le tasse per ridurre la spinta all’aumento
dei prezzi. Ma ciò lo avrebbe costretto a tagliare la spesa in servizi pubblici e
ad accettare un moderato aumento della disoccupazione per evitare il peggio (ossia
la recessione che segue a una fase inflazionistica). Nella realtà, i governi intervenivano
quasi sempre “troppo poco e troppo tardi”, per sottrarsi alle sgradevoli conseguenze
politiche della disoccupazione e dei tagli alla spesa pubblica.
Queste insufficienze nella gestione della domanda di fronte all’aumento dei prezzi
verificatosi negli anni Settanta per le materie prime e soprattutto, nel 1973 e nel
1978, per il petrolio finirono per essere considerate un problema insormontabile.
L’inflazione che colpì i paesi sviluppati dell’Occidente, pur trascurabile rispetto
a quella sperimentata negli anni Venti in Germania o più recentemente in varie parti
dell’America Latina e dell’Africa, era considerata inaccettabile. I responsabili politici
furono persuasi dagli esperti economici ad abbandonare il modello keynesiano per adottare
un approccio più rigido. La piena occupazione fu derubricata da obiettivo politico
diretto a conseguenza indiretta del risanamento economico; i governi e le banche centrali
si concentrarono sul mantenimento della stabilità dei prezzi e sulla lotta all’inflazione.
Più in generale, vasti settori di opinione ritennero fallito tutto l’esperimento socialdemocratico
della gestione dei mercati mediante intervento pubblico: non si poteva fare affidamento
sui governi, troppo attenti alla popolarità immediata, per risanare l’economia e lasciare
che il mercato facesse il suo lavoro, premiando il successo, punendo il fallimento
e lasciando scegliere i consumatori. Come si vede, dunque, la sfida intellettuale
neoliberista si preparava da tempo.
Inizialmente il cavallo di battaglia neoliberista fu la richiesta ai governi di una
politica macroeconomica che si limitasse a controllare il livello dei prezzi gestendo
la massa monetaria: un approccio chiamato, per questo, “monetarismo”. Qualcuno si
chiese se in un mondo in cui le carte di credito divenivano sempre più importanti
bastasse controllare l’offerta effettiva di moneta per limitare la domanda, o se l’offerta
di moneta misurasse in modo attendibile la liquidità disponibile ai consumatori. Questi
dibattiti sono ormai pressoché dimenticati, e lo stesso vale per il termine “monetarista”.
Ce ne dovremo ricordare tuttavia quando esamineremo ciò che accadde al credito nei
successivi trent’anni di neoliberismo. Quest’ultimo in realtà, come vedremo nel
...