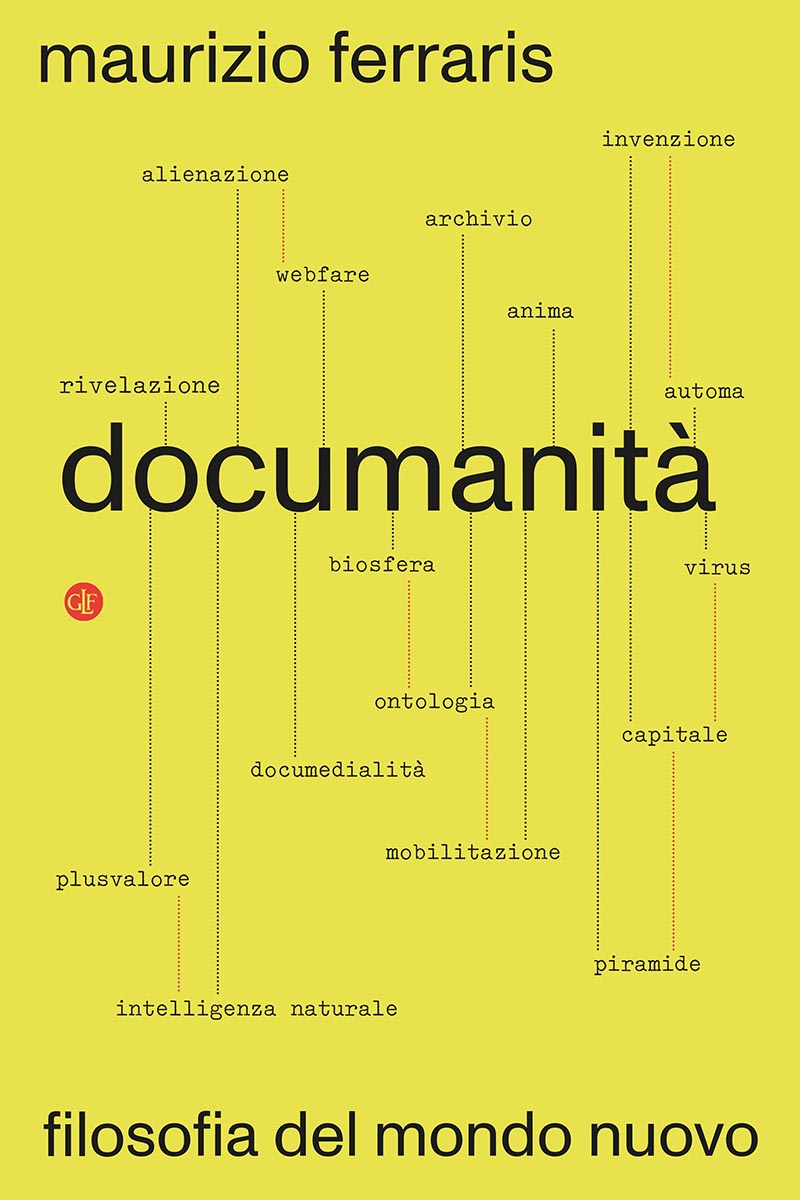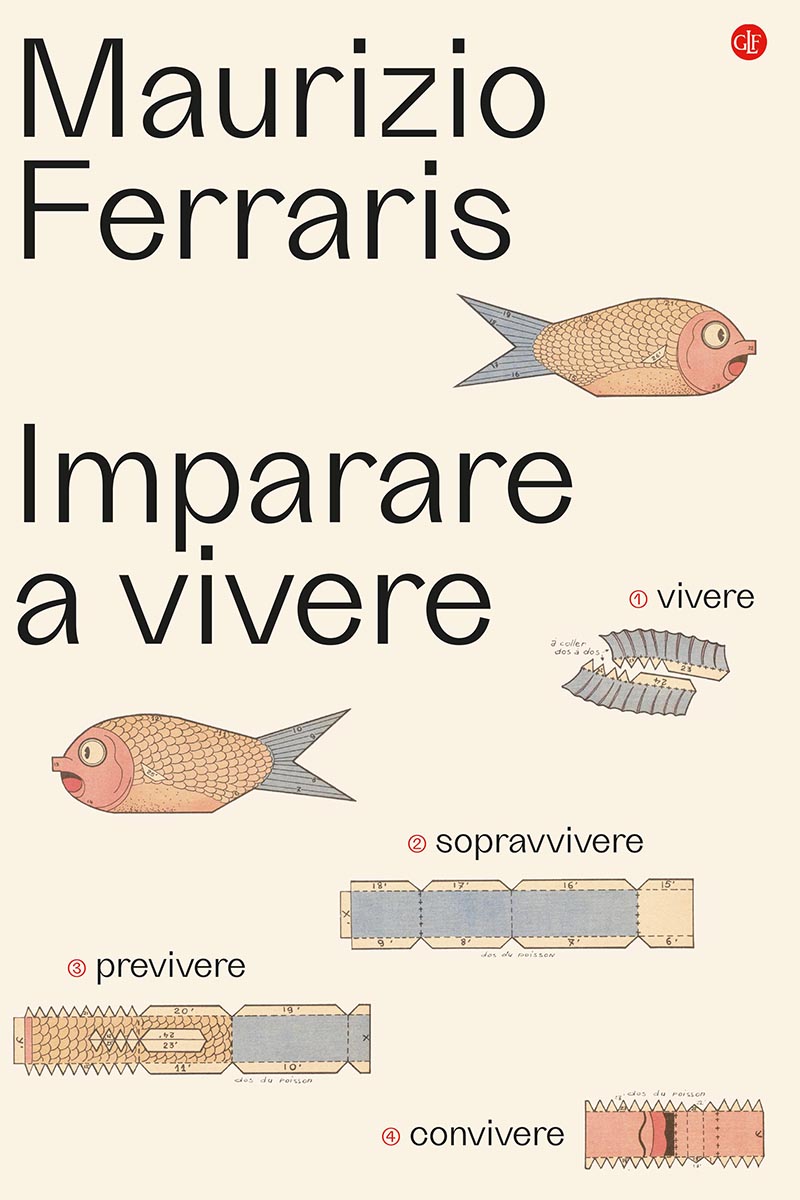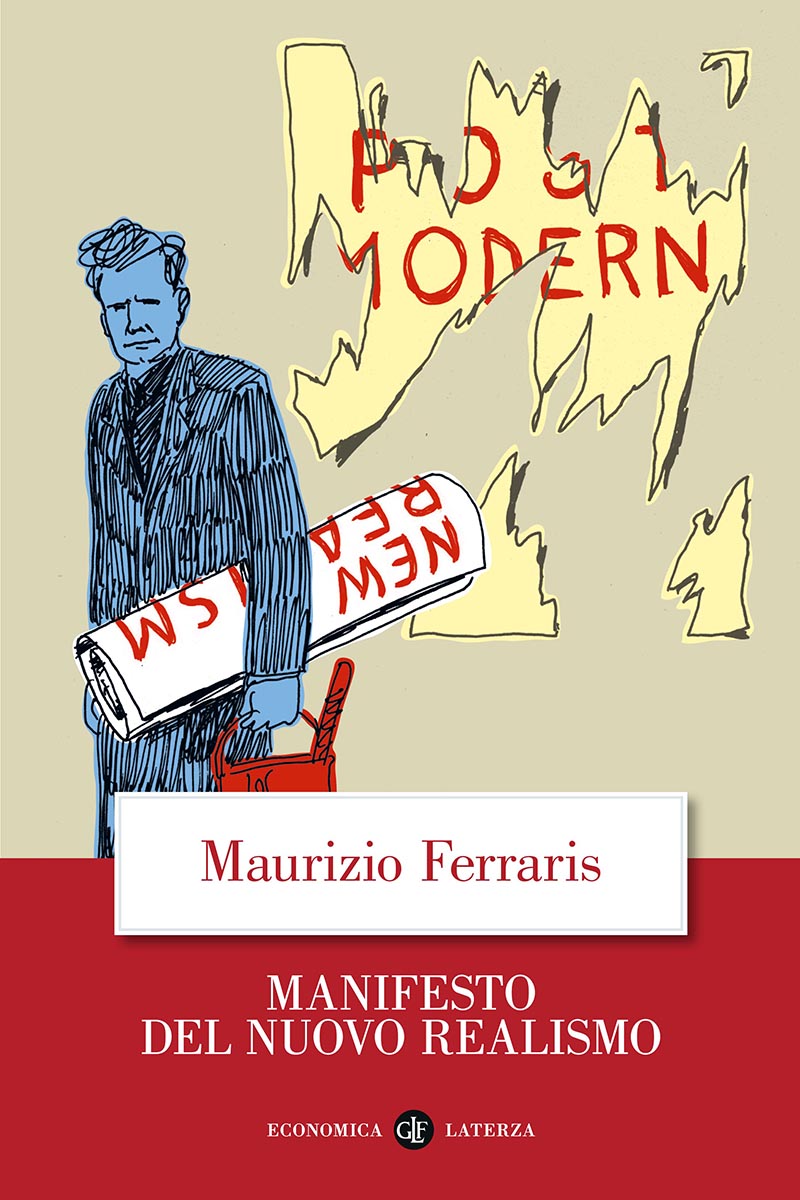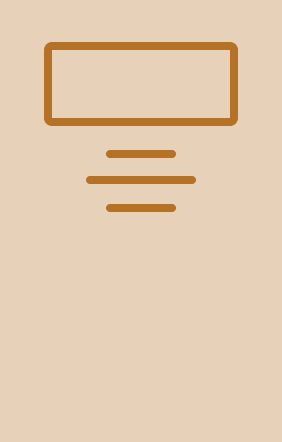Mobilitazione totale
Forse per la prima volta nella storia del mondo l’assoluto è nelle nostre mani. Ma avere il mondo in mano è anche, e automaticamente, essere in mano al mondo.
Un fatto è certo. Il panopticon esiste, ed è il web: un panopticon singolare, cieco, e con al posto di controllo non un essere umano ma una memoria infinita, e con un sapere che è essenzialmente burocratico. Tutto questo urta frontalmente con quanto ci era stato detto all’apparire del web, e cioè che i nuovi media avrebbero portato emancipazione, e tendenzialmente una riduzione del lavoro. Per quello che abbiamo visto sin qui, il web non è emancipazione ma mobilitazione. Non si limita a fornire ai suoi utenti nuove possibilità informative ed espressive; diviene lo strumento di trasmissione di responsabilità e ordini finalizzati al compimento di azioni. Trasformando ogni contatto in una richiesta che esige una risposta individuale, il web è un grande apparato su cui non tramonta mai il sole, in cui si lavora senza neppure sapere di stare lavorando. La risposta fondamentale che vuole il web è quella suggerita dallo smartphone quando si digita la s: “Sto arrivando!”.