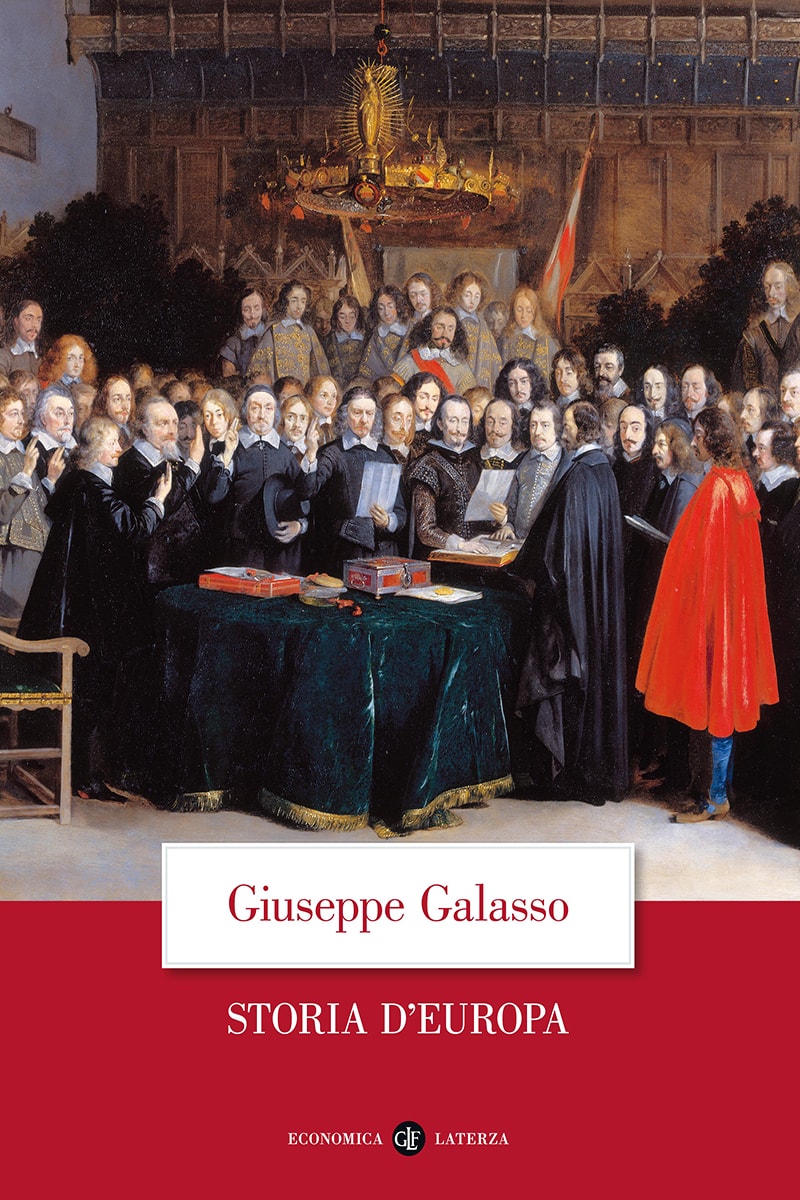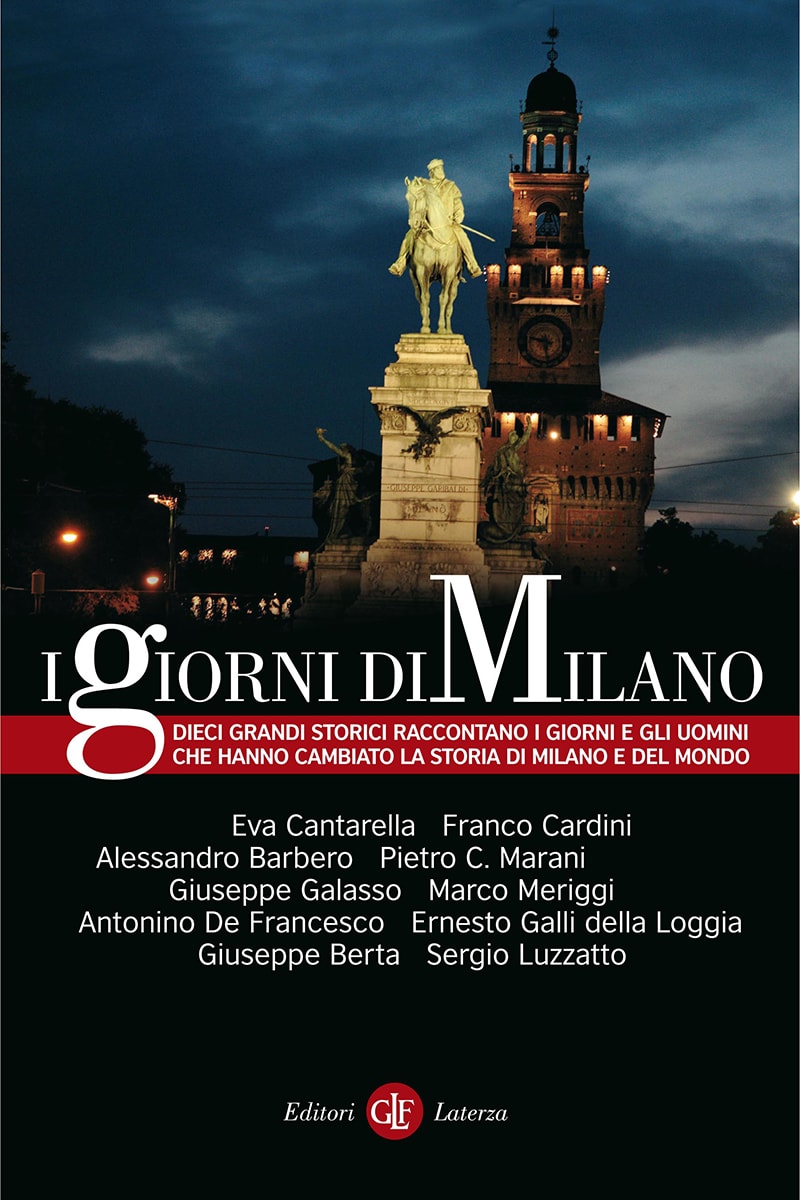Storia della storiografia italiana
Dalle cronache alle più impegnative scritture storiche medievali, l’Italia si dimostra un laboratorio di innovazioni e riflessioni di grande spessore nel contesto europeo. La storiografia umanistica e storici come Machiavelli e Guicciardini non sorgono, quindi, come estemporanee novità, e neppure è casuale il magistero italiano nell’Europa del Rinascimento. Questo alto profilo viene in parte disperso nella ‘decadenza’ italiana, finché con Vico, Muratori, Giannone si riapre una nuova grande stagione. Dal Risorgimento alla Repubblica il corso della storiografia italiana si fa molteplice e differenziato, in collegamento crescente con i paralleli sviluppi europei. Nel ’900 la storiografia italiana è poi sempre più ricca di voci e di esperienze, che ne fanno un documento notevole della cultura contemporanea, pur mantenendo sempre una sua originale cifra di interessi e di metodi.
Un ritratto d’autore del volto cangiante della storiografia italiana. Un profilo che definisce la fisionomia e la metodologia dello scrivere di storia nel nostro paese, sottolineandone l’organico rapporto con l’insieme della vita civile e culturale.
Rassegna stampa
-
Storia della storiografia italiana
Galasso: la storia è in crisi ma è ancora maestra di vita
-
Storia della storiografia italiana
Galasso e il laboratorio della storia
di C. Ocone
-
Storia della storiografia italiana
Sulla scia di De Sanctis e Muratori
di A. Feniello
-
Storia della storiografia italiana
Identità e pluralità che fondano l'Italia
di L. Mascilli Migliorini