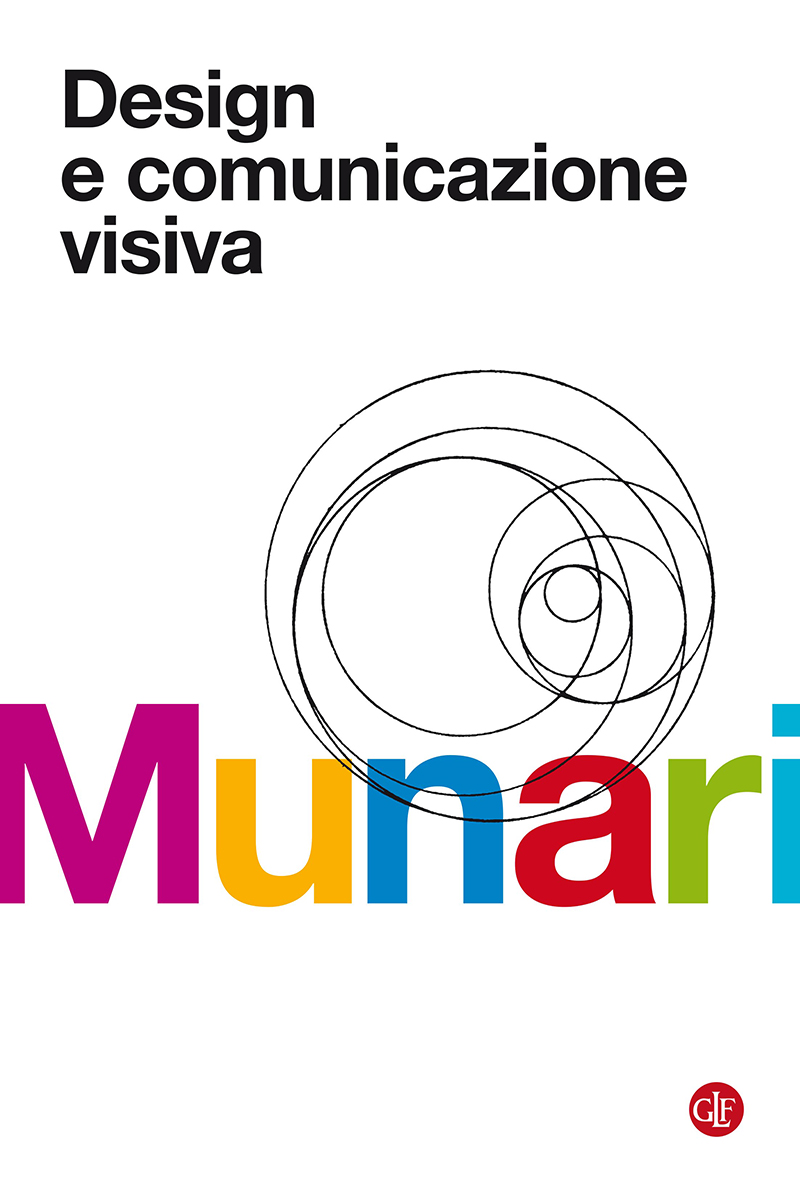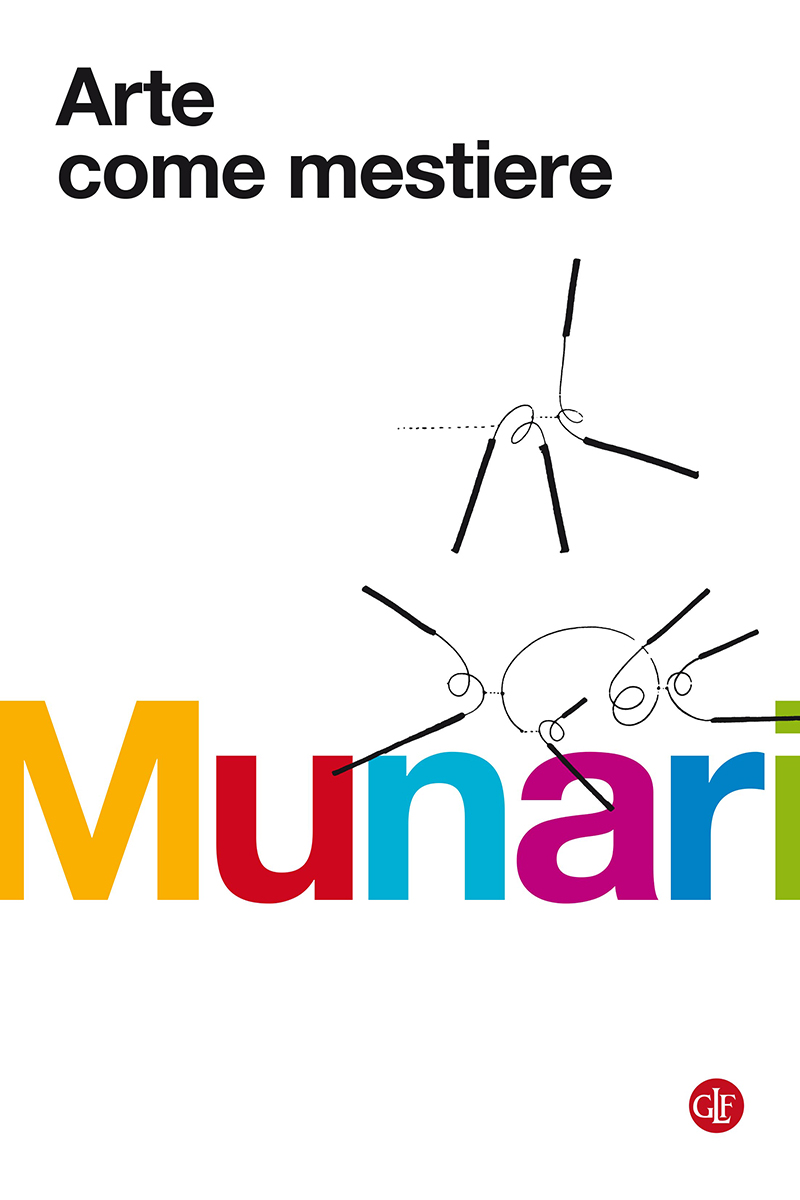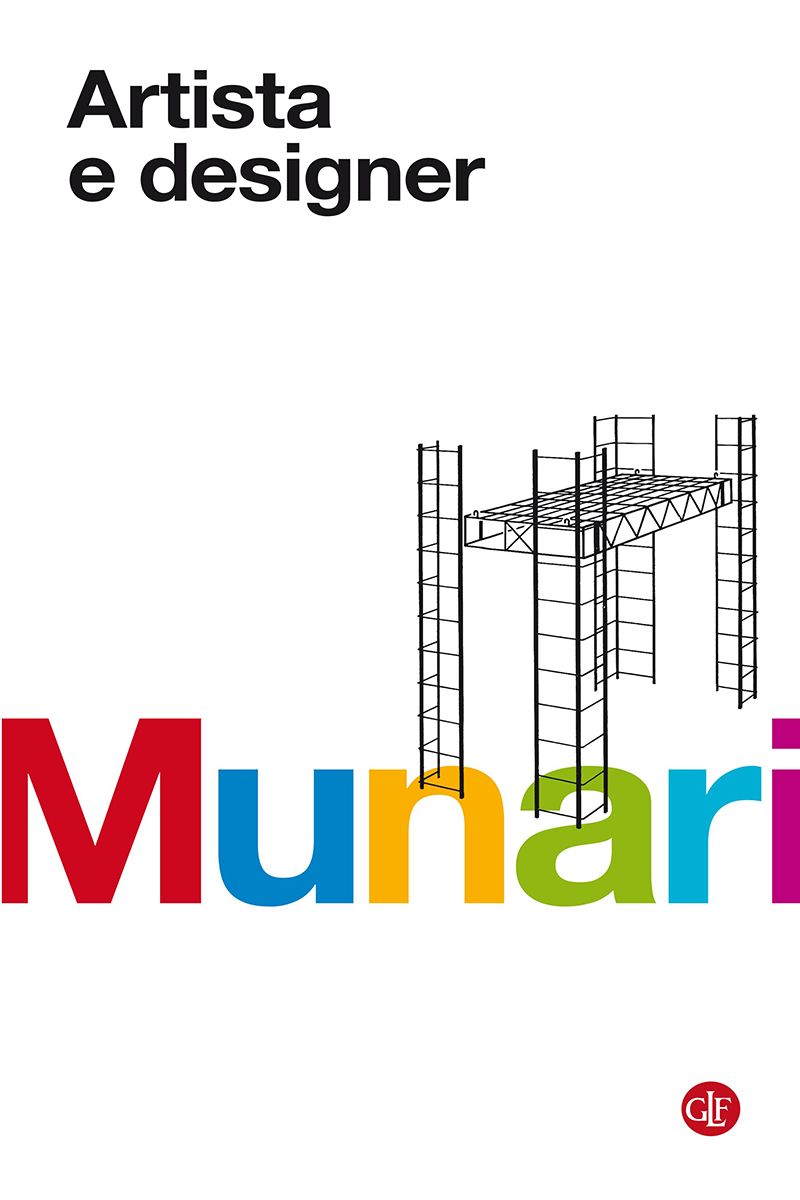Design e comunicazione visiva
Contributo a una metodologia didattica
«Conoscere la comunicazione visiva è come imparare una lingua, una lingua fatta solo di immagini che hanno lo stesso significato per persone di qualunque nazione e quindi di qualunque lingua.»
Che cosa è la grafica? Chi sono i designer? Come funziona la loro logica creativa? Quale uso fanno delle tecniche e dei materiali? Un maestro del design italiano ha scritto il più divertente manuale per comprenderne i principi, le leggi e le possibili realizzazioni.