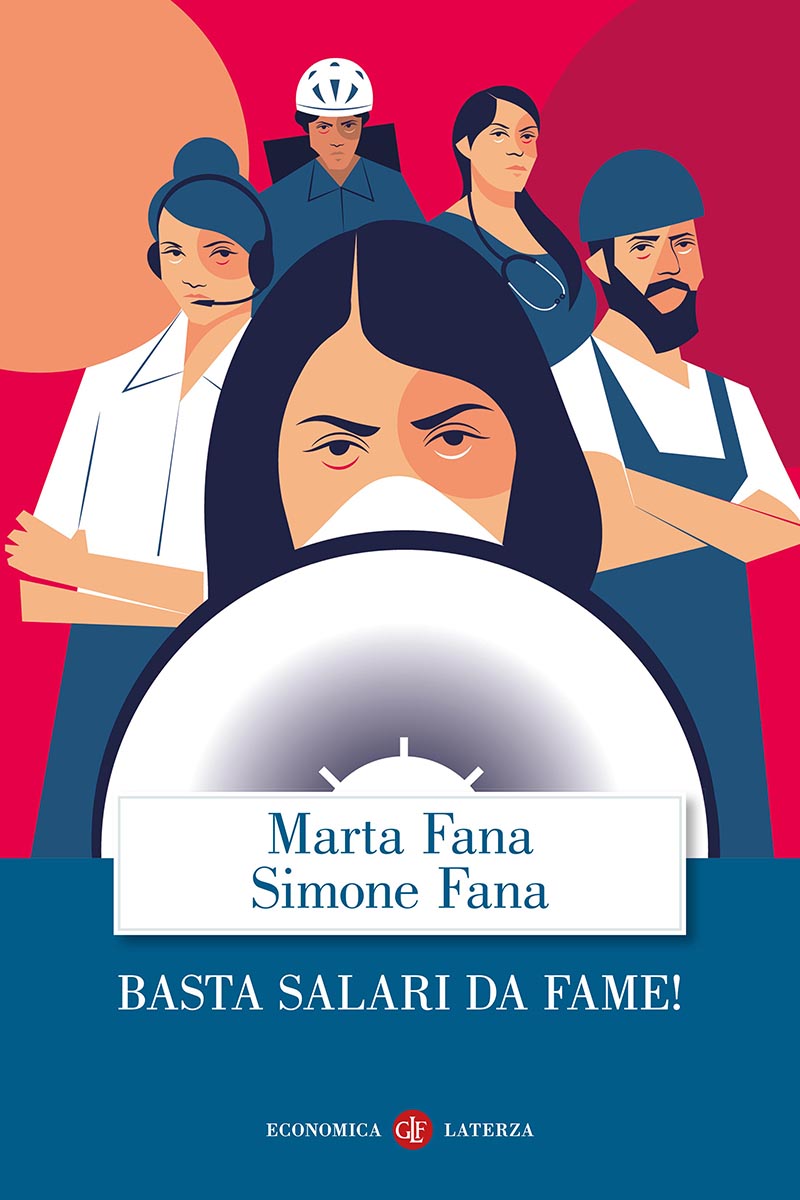Ma il marxista, per giudicare una situazione,
deve procedere non dal possibile, ma dal reale.
Lenin, Lettere sulla tattica
Non si può andare alla deriva senza un sogno.
Paco Roca, Il faro
Introduzione
Mese dopo mese, i giornali pullulano dei piagnistei di imprenditori che non trovano
lavoratori disposti a farsi sfruttare. “Offro un posto, tanti rispondono, ma nessuno vuole faticare davvero”, titolava a fine 2018 il “Corriere della Sera”. “Cerco baristi e panettieri ma non li trovo” rispondeva “Repubblica” facendo eco al proprietario di una panetteria di Milano,
lo stesso per cui “I voucher per noi erano perfetti, il personale era in regola e
lavorava per le ore necessarie e nei momenti di maggior bisogno”, senza poter accumulare
contributi, con una paga oraria di appena 7,5 euro netti. Ma, ancora: “I giovani rinunciano
all’Expo, una generazione non abituata al lavoro”, tuonava in un video Aldo Grasso,
tacendo sul fatto che per 1.400 euro lordi, meno di mille netti, quei lavoratori erano
chiamati a turni infiniti, weekend compresi: disponibilità totale.
È questa l’Italia del lavoro raccontata dall’alto, da giornali che sapientemente tifano
per il Made in Italy, senza dire però che quel modello è fatto di catene di appalto
e subappalto dove i lavoratori guadagnano una manciata di euro l’ora, per qualche
mese, di contratto in contratto, in una staffetta che toglie il sonno, ma solo a chi
deve farla, non a chi la comanda. Gli stessi giornali che, di fronte all’esplodere
del caporalato in tutti i settori, lungo tutta la penisola, tacciono perché non sta
bene gettare fango su chi fa grande l’Italia – nei fatti sempre più piccola e irrilevante
– e poi però ogni anno evade decine di miliardi di euro di contributi sociali ai lavoratori,
non investe né in sicurezza sul lavoro né in innovazione, ma in yacht ed emissari
verso i paradisi fiscali.
Meno di frequente, per usare un eufemismo, quelle stesse pagine raccontano una realtà
molto più diffusa, quella delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti questi
lavoratori: quelli che hanno salari orari di tre, quattro, sei euro lordi l’ora, quelli
costretti al lavoro gratuito come se non ci fosse un domani, a un tirocinio a 400
euro al mese pure se dura 40 ore la settimana e non si vede traccia di formazione,
che ricevono rimborsi spese che non bastano neppure per ripagare l’abbonamento ai
mezzi pubblici. Lavoratori e lavoratrici che quotidianamente affrontano giornate che
non terminano mai perché bisogna fare uno, due, tre lavori per riuscire a mettere
insieme il pranzo con la cena. Fatti che caratterizzano il nostro paese ma che vengono
derubricati da analisi sciatte che si ostinano a scaricare sui lavoratori le cause
della loro stessa miseria: è colpa dei lavoratori se sono poveri e sfruttati, perché
non sono abbastanza competenti e/o perché non sono disposti a farsi sfruttare di più.
Oppure, come va di moda in questi ultimi tempi, perché hanno la possibilità di guadagnare
tra i 70 e i 400 euro col reddito di cittadinanza. Come se con quella miseria si potesse
vivere in modo dignitoso.
La colpa è sempre dei lavoratori e delle lavoratrici. Non soltanto scansafatiche,
o choosy – per citare uno dei peggiori ministri del Lavoro, Elsa Fornero –, ma anche ipocriti,
perché “se i locali fossero a Londra avrebbero la fila di ragazzi, anche laureati,
italiani” per un posto da cameriere o lavapiatti. Parola di Ferruccio de Bortoli,
ex direttore del “Corriere della Sera” ma anche del “Sole 24 Ore”. Parole al vento
e altrettanto false, perché negli ultimi anni l’occupazione è cresciuta di più proprio
nei settori della ristorazione e del turismo, ma soprattutto perché, di fronte a un
livello di emigrazione che ricorda il dopoguerra – due milioni solo dal Sud negli
ultimi quindici anni –, bisognerebbe cominciare a fare autocritica quando non si è
disposti almeno a portare rispetto per chi, pur di sopravvivere, lascia tutto e va
in un altro paese. Al palo sono rimasti invece i salari, dei camerieri ma pure degli
operai metalmeccanici, degli insegnanti, dei medici, dei giornalisti a cottimo delle
grandi testate che sentenziano sulle nostre vite e sulle nostre scelte. Questo dovrebbe
essere il problema all’ordine del giorno, non che un laureato – o anche un non laureato
– rivendichi il sacrosanto diritto a non lavorare per una paga da fame. Ma forse il
problema, nostro, è anche che questo diritto lo rivendichiamo troppo poco e con troppa
poca forza, almeno in questi tristi anni.
Questo dovrebbe invece essere il problema, perché negli ultimi decenni ci è stato detto che bisognava rendere il mercato
del lavoro più flessibile e abbassare i salari per aumentare la competitività delle
aziende: l’abbiamo fatto, ma non è successo nulla perché le aziende hanno preferito
intascare i risparmi sul lavoro per godersi una rendita sulle spalle dei lavoratori,
piuttosto che investire.
Così si preferisce ricordare il biennio 1992-1993 solo per Tangentopoli e la conseguente
fine della prima Repubblica – che in fondo non è mai morta –, oppure per il Trattato
di Maastricht, che tutti pensano sia stato imposto dall’alto mentre invece venne deciso dadentro. E in pochi tendono a ricordarsi che proprio in quel biennio fu firmato un patto
per i redditi e la competitività che ha decretato il declino dei salari negli anni
a seguire fino ad oggi, meccanismo decisivo prima e dopo la svalutazione che porterà
nei mesi successivi alla firma del Trattato di Maastricht.
Allo stesso modo, si preferisce considerare il breve ma intenso periodo storico che
va dal secondo dopoguerra all’inizio degli anni Settanta un fulmine a ciel sereno
che fece grande l’industria italiana nel mondo. Senza ricordare che la via all’industrializzazione
fu cavalcata tenendo bassi i salari e alto lo sfruttamento, dentro e fuori le fabbriche.
Però quello è anche il periodo in cui uomini e donne tornarono a riprendersi la scena
da protagonisti, strappando coi denti condizioni di vita migliori per tutti, lottando
a muso duro per conquistare il diritto di vivere in un paese democratico. Dove “democrazia” non
era e non avrebbe mai potuto essere solo mettere una x su una scheda elettorale, ma era il diritto a ottenere migliori condizioni di lavoro
e salari più alti, a poter prendere parte alle scelte aziendali, a estendere queste
condizioni oltre i luoghi di lavoro dentro tutta la società, dal diritto all’istruzione,
alla sanità. Un pezzo di società, la classe lavoratrice, si organizza e avanza in
modo più o meno compatto, ma determinato. La democrazia però va bene fintanto che
non intacca i privilegi dei pochi che ne godono davvero; quando la maggioranza vera
della società, i lavoratori e le lavoratrici, irrompono sulla scena, rivendicando
non solo il pane e le rose, ma pure il riposo, allora la democrazia va meno bene.
La storia politica della questione salariale non segue una traiettoria lineare, scritta
nelle sue premesse e nei suoi esiti: è un processo che nel tempo ha visto ribaltati
vincitori e vinti. È una questione che non ha mai abbandonato la storia d’Italia e
che in questi ultimi decenni torna a prendersi il centro della scena.
Di fronte a un ribaltamento della storia, di come vanno le cose e di come sono andate
non per un evento imprevisto, ma per un susseguirsi di scelte deliberate tese a favorire
i profitti più che la dignità del lavoro; di fronte ai fatti che ormai mordono la
cronaca e non c’è alibi che tenga – non è colpa della rigidità del mercato del lavoro,
dei sindacati, degli immigrati o della tecnologia – la classe dirigente italiana,
quella che decide delle scelte aziendali e politiche ormai da troppi decenni, fa spallucce,
si chiude in un cinismo quasi volgare.
Oggi in Italia si guadagna meno di trent’anni fa, a parità di professione, a parità
di livello di istruzione, a parità di carriera. Vale per tutti, tranne per quella
minoranza che sta in alto. Non è una casualità, né un fatto nuovo. Perché la questione
salariale nel nostro paese, ma non solo, è un pezzo di storia politica che può essere
raccontata con le retoriche di chi continua a comandare o dalla viva voce di quanti
quel comando lo subiscono sulla propria carne viva. Abbiamo quindi deciso di ripercorrerla,
connettendo il filo che lega il passato con il presente, dove il futuro appare una
proiezione di un tempo lontano, ma il cui volgere non è affatto scontato.
Il nostro punto di partenza è il dopoguerra, quando la frantumazione del lavoro e
le condizioni di sfruttamento intensivo, dentro e fuori i settori privilegiati della
nuova industrializzazione, erano la norma. Per due decenni uomini e donne, dalle campagne
alle città, tornarono a unirsi in organizzazioni politiche e sindacali, a fare inchieste,
a denunciare, a lottare per un salario minimo dignitoso. La crisi internazionale di
metà anni Settanta fu colta come momento propizio per sferrare un duro colpo a quella
maggioranza che pareva indomita, accerchiandola con una retorica che attribuiva agli
aumenti salariali la causa della galoppante inflazione e la perdita di competitività
e, di fatto, decretando la sconfitta di quel movimento. Su queste basi ideologiche
furono portate avanti le politiche di austerità sia monetaria che fiscale, permettendo
alle imprese di procedere alle proprie ristrutturazioni fatte di esternalizzazione
e frantumazione dei processi produttivi. Un meccanismo che nel tempo, dai primi del
Novecento fino ai giorni nostri, caratterizza la strategia aziendale di protezione
dei profitti e gestione del ciclo economico, facendo del costo del lavoro un fattore
variabile su cui scaricare il rischio aziendale e le fluttuazioni della domanda interna
ed esterna.
Ma è grazie all’ingente apparato retorico e ideologico, a corredo di tale offensiva,
che i salari tornarono ad essere l’agnello da sacrificare in nome dell’interesse aziendale,
eretto ad unico interesse nazionale. Se ne convinsero persino i sindacati, accettando
non soltanto di congelare i salari ma anche di assestarsi lungo una dinamica di compatibilismo
con le richieste del mercato. Non più agente politico che morde e attacca, ma soggetto
che smussa gli angoli e cura le ferite più laceranti di un processo trentennale di
riforma del lavoro che si è spinto talmente oltre da aver istituzionalizzato anche
il lavoro gratuito, considerandolo pratica del tutto normale. Nonostante tutto questo,
le aziende continuano tenacemente a esigere sconti fiscali, sgravi e ovviamente salari
più bassi. In un paese che conta il 14% di forza lavoro in condizioni di povertà lavorativa,
dove il 30% dei giovani occupati non guadagna più di 800 euro al mese – come ha dichiarato
l’Inps – e dove ex ministri dello Sviluppo economico sbandierano tra le virtù del
Made in Italy quanto poco vengono pagati i laureati italiani rispetto ai colleghi
europei.
Milioni di persone sono già vittime di queste politiche che rischiano di coinvolgere
strati sempre più ampi della società, perché l’avidità dei profitti non guarda in
faccia nessuno e sfrutta tutti i meccanismi di oppressione di cui dispone per costringere
a una condizione di vulnerabilità sempre più individui e famiglie, di qualsiasi genere,
età ed etnia. Ma per farlo ha bisogno che la possibile unità di questa parte della
società venga quotidianamente celata e la frantumazione sfruttata a proprio vantaggio,
facendo credere che le identità dei singoli lavoratori siano irriducibilmente distinte
e non possano coalizzarsi. Quando la frammentazione interna al mondo del lavoro non
è sufficiente a contenere il conflitto sociale, bisogna trovare comunque argomenti
che spostino il centro dell’attenzione dalle sue vere cause, da chi sfrutta e decide
di sfruttare. Da qui il mito della tecnologia che separa i bravi, meritevoli di salari
elevati, da quelli poco produttivi, che invece non hanno diritto che a salari da fame.
Ma, anche questa volta, la teoria a monte di una retorica sempre più diffusa si rivela,
quando non del tutto inefficace, parziale e incompleta a spiegare i divari salariali
esistenti. E allora è giusto andare a guardare oltre, scoprire e riscoprire quali
teorie riescono a dare spiegazioni soddisfacenti dei fatti che accadono nella società,
in che modo è possibile e doveroso aggiornarle e/o contestualizzarle meglio. Ad esempio,
a qualcuno potrà sembrare sorprendente, ma ad altri no, che il problema non sia la
tecnologia in sé ma il suo governo: chi ha il potere di comandare quali macchine e
in che modo queste devono entrare nei processi produttivi, affiancarsi e/o sostituire
i lavoratori, e quali? È una scelta politica, non tecnica.
Le pagine che seguono non hanno alcuna pretesa di esaustività sulla storia anche attuale
della questione salariale. Hanno però come obiettivo la ricostruzione, seppure parziale,
di un pezzo della nostra storia attraverso le immagini del passato e i numeri del
presente, analizzati con gli occhi di chi crede che una battaglia non combattuta è
una battaglia persa in partenza. Ma per lottare bisogna sapersi riappropriare di strumenti
teorici e retorici che permettano di avanzare e di costituire un fronte più vasto
possibile, sapendo che le condizioni attuali non sono sicuramente favorevoli.
Siamo partiti qualche anno fa con l’idea che l’Italia aveva bisogno di una campagna
a tutto spiano contro il lavoro povero in tutte le sue forme, dagli appalti al lavoro
gratuito, dai tirocini al demansionamento. Crediamo sia necessario dire senza mezzi
termini che nessun lavoratore, neppure part time, può essere povero, può cioè guadagnare
meno di mille euro al mese. Niente di rivoluzionario, ma si tratta di un primo obiettivo
– per quanto moderato – che sfida l’aumento delle disuguaglianze che dai luoghi di
lavoro e non lavoro si estendono a tutta la società. Nell’ultimo anno, per una forma
più o meno ossessiva rispetto alle urgenze ma anche alle carenze politiche, abbiamo
iniziato a pensare che la questione del salario minimo anche in Italia avrebbe potuto
rappresentare un passo importante per quella battaglia. Consapevoli però che il salario
minimo non è positivo di per sé, ma lo diventa quando riesce a incidere e migliorare
le condizioni di tutti i lavoratori, partendo dai tanti, troppi, che oggi vivono in
stato di povertà pur lavorando regolarmente nel rispetto dei contratti collettivi
vigenti. È uno strumento capace di mettere il bastone tra le ruote a chi pensa di
poter rimanere a galla a colpi di esternalizzazioni e lavoro in affitto. Un risultato
non scontato, ma che dipende da quanto siamo pronti a strappare ancora una volta al
fronte padronale, ad attaccare su quel che ci spetta non accontentandoci di quello
che sono disposti a regalarci, senza timore di indebolire alcuna struttura intermedia.
Così abbiamo scelto di entrare anche nel dibattito contingente che contrappone il
salario minimo alla contrattazione collettiva, mostrando come questa paura appare
fondata solo in un contesto in cui si avalla la frantumazione del mondo del lavoro,
permettendo alle aziende di individualizzare i rapporti lavorativi. Un dibattito importante,
ma che abbiamo scelto di affrontare con autonomia, confrontandoci con quanto avviene
nel resto del mondo, nei paesi a noi più vicini, ma anche in quelli apparentemente
più lontani, dove vigono sistemi diversi di fissazione dei salari, studiando il modo
in cui questi riescono a reagire alle crisi e al governo delle crisi.
Siamo fermamente convinti che lo strumento salariale è un meccanismo e non può in
nessun caso risolvere da solo molte altre questioni dirimenti, a partire dalla democrazia
nei luoghi di lavoro, nell’organizzazione del lavoro, nelle scelte strategiche dell’azienda.
Allo stesso tempo, esso non può essere barattato con maggiori livelli di sfruttamento,
allungamento dei tempi di lavoro, detassazioni di alcun genere a favore delle imprese.
Rimane appunto un pezzo utile da accompagnare ad altre rivendicazioni, come la sicurezza
nei luoghi di lavoro la cui assenza provoca oggi circa tre morti al giorno, il rispetto
dei contratti vigenti, i controlli contro l’evasione contributiva. Ma, insomma, in
qualche modo bisogna pure iniziare, e crediamo sia importante partire da qualcosa
che possa unire la classe lavoratrice nell’obiettivo di stare tutti un po’ meglio,
di recuperare una boccata di ossigeno senza il quale la resistenza viene a mancare.
I capitoli che compongono questo libro vanno usati come pezzi di un attrezzo, un marchingegno
fatto di parti più o meno indipendenti tra di loro che se messe assieme provano a
restituire le ragioni di una storia ancora tutta da scrivere, in cui la classe lavoratrice
può e deve assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo da protagonista e non
da comparsa.
***
Ci sentiamo in dovere di ringraziare alcune persone che hanno contribuito con enorme
tensione intellettuale, fatta di critiche e commenti, alla realizzazione di questo
libro, sia dal punto di vista materiale sia da quello, non meno importante, morale.
Senza il loro apporto molto sarebbe stato perduto, così come mai avremmo avuto il
coraggio di iniziare senza la fiducia di Giovanni Carletti. Un ringraziamento particolare
va a Giacomo Gabbuti per l’inesauribile stimolo intellettuale, che ci ha consentito
di perfezionare la struttura del testo con la sensibilità di un grande storico dell’economia
e con l’empatia di un amico. Un enorme ringraziamento lo dobbiamo a Davide Villani,
per averci costretto a misurarci con rigore sulle questioni più problematiche e sulla
forma complessiva del testo. Un ringraziamento sentito a Michele Filippini e Carmine
Tomeo, che ci hanno aiutato a mettere a fuoco dinamiche storico-politiche con la cura
dei dettagli. Grazie ad Alessandra Di Bartolomeo, per aver letto e commentato parti
del testo. Un immenso ringraziamento ad Alessandra e Davide, per essere stati al nostro
fianco nelle serate più lunghe, mettendo da parte un po’ della loro stanchezza quotidiana
per regalarci quella serenità e quell’affetto necessari ad affrontare questa avventura
editoriale e umana.
Infine un ringraziamento a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiamo incontrato
in questi anni. A loro dedichiamo questo libro, con la speranza che le parole che
seguono possano incrociarsi con le lotte per liberare il futuro dalla cappa dello
sfruttamento.
Eventuali sviste, errori e imprecisioni sono di esclusiva responsabilità degli autori.
Viaggio al centro della terra
Nel 2012, duecento lavoratori dei fast food della città di New York decisero di scioperare
rivendicando un salario minimo di 15 dollari l’ora e i diritti sindacali. Era l’inizio
della campagna del Fight for $ 15,che dalle strade di New York si estende oggi a circa trecento città nel mondo. Non
più soltanto lavoratori dei fast food, ma anche collaboratori domestici, insegnanti,
personale impiegato negli aeroporti e commessi nel commercio al dettaglio. Lo scontro
in atto è chiaro per questi lavoratori e lavoratrici: le aziende che li assumono guadagnano
miliardi, mentre loro, che creano il valore di quelle stesse aziende, sono pagati
pochi spiccioli. I salari a cui hanno diritto non garantiscono neppure la sussistenza:
non bastano a pagare le bollette o l’affitto, mentre i loro boss continuano ad acquistare
proprietà, anche milionarie: basti pensare a McDonald’s, contro cui ebbe inizio la
protesta. Dall’altra parte della barricata i manager di McDonald’s hanno proposto
una soluzione apparentemente facile: se il salario non è sufficiente interviene lo
Stato, che paga con i programmi contro la povertà che negli Stati Uniti vengono comunemente
chiamati food stamps. Formalmente è il Supplemental Nutrition Assistance Program che fornisce voucher per l’acquisto di generi alimentari alle famiglie con un reddito
sotto la soglia di povertà.
È qui che cade la maschera del capitalismo come sistema di libertà in cui ognuno paga
e riceve quel che si merita dentro il mercato. Il costo economico e sociale dell’accumulazione
dei profitti di pochi viene scaricato sulle casse dello Stato, e cioè sulle tasche
degli altri lavoratori che pagano la maggior parte delle tasse. Dal furto salariale
dentro i luoghi di lavoro al furto sociale che impatta su tutta la società. La lotta
dei lavoratori per ottenere aumenti del salario minimo si presenta allora come lotta
politica, portata nel cuore dei meccanismi di produzione e distribuzione del reddito;
ed è una lotta che passo dopo passo porta alla vittoria. Ad oggi, grazie agli scioperi,
ai picchetti, alla sensibilizzazione, il movimento è riuscito ad aumentare il salario
di circa 22 milioni di lavoratori solo negli Stati Uniti e questo – dicono dal sito
di Fight for $ 15 – “perché i lavoratori sono stati uniti e hanno agito come un sindacato”.
Azioni collettive che sfidano il processo di individualizzazione a cui il neoliberismo
costringe fette sempre più larghe della società. Di fronte al disciplinamento e alla
competizione tra lavoratori indotta dai premi di produzione, dal lavoro a cottimo,
dalla retorica della meritocrazia, la classe lavoratrice ritrova sé stessa come corpo
sociale capace di incidere e indirizzare la politica. Non a caso l’obiettivo di un
salario minimo di almeno 15 dollari l’ora è assunto e ribadito da Bernie Sanders e
da tutto il gruppo dei Democratici socialisti d’America (Dsa), tra cui l’astro nascente
del neosocialismo statunitense, Alexandria Ocasio-Cortez. Proprio la giovane deputata
al Congresso si è fatta portavoce della campagna #RaiseTheWage, impegnata a sfatare molte delle narrazioni in campo, prima tra tutte quella sui
beneficiari di un eventuale aumento del salario a 15 dollari: non si tratta solo di
giovani alle prime esperienze sul mercato del lavoro – una discriminazione anagrafica
che già di per sé non può essere accettabile –, magari con un lavoro part time. Della
platea complessiva il 56% è composta da donne, il 55% sono lavoratori e lavoratrici
con un contratto a tempo pieno. Lottano contro un sistema abominevole che si basa
sul principio delle mance, lo stesso che da noi viene sostenuto dai giovani manager
delle piattaforme di consegne a domicilio.
I lavoratori per cui sono previste le mance hanno un salario minimo di 2,25 dollari
l’ora, secondo quanto riporta il sito Raise the Minimum Wage. Una miseria. Ma grazie
alla determinazione di Fight for $ 15, il tema dell’aumento del salario minimo negli Stati Uniti ha assunto un ruolo centrale
nel dibattito pubblico. Dalle strade al Congresso, fino ad arrivare alle università,
dove sempre più ricercatori sono alle prese con studi meticolosi per analizzare i
possibili effetti di un aumento così cospicuo nei livelli salariali. Dalla storica
Berkeley fino alla London University, torme di studiosi sfornano dati e risultati
che sostengono la proposta: il miglioramento salariale è inequivocabile e il rischio
di una perdita di posti di lavoro ampiamente messo in discussione. Lo scorso luglio
il Congresso ha approvato il Raise the Wage Act grazie al voto favorevole della nuova maggioranza democratica. Il testo non è ancora
legge, dovrà passare lo scoglio del Senato, a maggioranza repubblicana, e verrà probabilmente
affossato. Nonostante questa consapevolezza, la battaglia continua e continuerà. Sembrano
risuonare in queste lotte le parole scritte da Mario Tronti nel 1970, in Marx a Detroit, a proposito della classe lavoratrice americana: “La tradizione di organizzazione
degli operai americani è la più politica del mondo, perché la carica delle loro lotte
è la più vicina alla sconfitta economica dell’avversario, la più prossima non alla
conquista del potere per costruire sul vuoto un’altra società, ma all’esplosione del
salario per rendere subalterno il capitale con i capitalisti dentro questa stessa
società”1.
Sono tantissime le mobilitazioni di massa per gli aumenti salariali e vanno ben oltre
gli Stati Uniti. In Bangladesh2, secondo paese al mondo per volume di esportazioni del settore tessile – e infatti
è lì che multinazionali come H&M, Tesco, Walmart hanno, negli ultimi anni, delocalizzato
per poter sfruttare manodopera a basso costo –, un duro sciopero ha coinvolto circa
cinquantamila lavoratori e lavoratrici di quel settore, costringendo decine di fabbriche
a bloccare la produzione. Il governo ha risposto aumentando il salario minimo, ma
non abbastanza da scongiurare lo stato di povertà: secondo i lavoratori, l’aumento
del 50% del salario minimo riesce appena a coprire l’inflazione e l’aumento del costo
della vita, a partire dal prezzo degli affitti.
La libera circolazione dei capitali, che continuano a spostarsi nei paesi a basso
costo del lavoro, non interessa solo l’Asia ma tocca molto anche l’Est europeo, diventato
territorio colonizzato e satellite delle multinazionali ma anche delle aziende manifatturiere
del nostro continente. Un’ondata di mobilitazione per l’aumento dei salari minimi
ha interessato tra gli altri la Romania, terra di conquista privilegiata. Non soltanto
le donne dell’industria tessile, ma anche, se non soprattutto, i lavoratori del settore
energetico. Per due mesi hanno scioperato quelli di Electrolux3 resistendo a minacce e intimidazioni padronali, le stesse di sempre: chiusura degli
stabilimenti e licenziamento per tutti. Hanno resistito e vinto un aumento di 2 lei
(circa 0,50 euro) per ora lavorata. A giugno scorso è stata la volta degli operai
della Electroaparataj, azienda una volta pubblica e ormai totalmente privatizzata.
Le minacce ricevute da quei lavoratori non hanno fatto che aumentare la solidarietà
di classe da parte di quelli di altri settori. Bisogna continuare a lottare uniti,
dicono i sindacalisti rumeni, perché non è accettabile che per ogni euro prodotto
il 60% vada in profitti e solo il 40 in salari. Scioperare non è un vezzo, è l’espressione
più compiuta di uno scontro di classe reale.
Così è un po’ ovunque. Nel 2016 i lavoratori indiani furono protagonisti del più grande
sciopero della storia – 180 milioni di aderenti, 150 “secondo la questura” – con una
chiara rivendicazione: aumento del salario minimo mensile a 280 dollari con adeguamento
all’inflazione. Record battuto nel 2019, in una clamorosa protesta contro le politiche
antisindacali del governo Modi. Numeri non eguagliati nella confinante Cina, dove
tuttavia il movimento operaio conduce sistematicamente una lunga battaglia per migliorare
le condizioni di vita e lavoro. L’esperienza cinese ha, come spesso avviene, qualcosa
da aumentare. Ad esempio, nel 20104 gli operai del settore automobilistico iniziarono a scioperare dopo l’aumento del
salario minimo come contro-risposta ai datori di lavoro. Le imprese, pur di non pagare
gli aumenti salariali, decisero allora di ridurre tutti i sussidi, assimilabili al
nostro welfare aziendale. Una reazione inaccettabile per i lavoratori, in quanto lo
scambio welfare-salario non può essere la leva variabile a disposizione del padronato.
Un tema, questo, che entra fortemente nella questione salariale italiana, dove da
troppi anni ormai le esigue conquiste salariali si realizzano principalmente sulla
contrattazione integrativa e il welfare aziendale. Così come vi rientra un’altra parte
di questa storia, che continua con il tentativo della direzione aziendale di dividere
il fronte operaio offrendo aumenti soltanto ad alcuni gruppi di lavoratori interni
alla fabbrica. Inaccettabile ancora una volta: gli aumenti devono essere generalizzati
a tutti i lavoratori. Erga omnes. Un concetto tanto ripetuto quanto nei fatti disconosciuto nel mondo del lavoro italiano,
e non solo.
La lotta per il salario non può limitarsi solo all’ottenimento di migliori retribuzioni.
Ma soprattutto non si conclude con lo scambio di altri diritti sociali o sindacali.
È una battaglia che si unisce alla rivendicazione per una gestione più democratica
dell’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi nel loro complesso. Non basta
aumentare i salari ma bisogna rimettere in discussione l’intero processo di sfruttamento:
non a caso, in un contesto che si fa sempre più standardizzato fino al comando attraverso
gli algoritmi, il problema non è solo il salario, sempre troppo basso, ma l’unilateralità
delle scelte strategiche dell’azienda: gli obiettivi, le modalità, i tempi e la quantità
del lavoro. Così la questione salariale è assunta come meccanismo utile dentro un
processo di riforma che tenda a un reale rivolgimento dei rapporti di forza nei luoghi
di lavoro e nella società tutta.
Le prime lotte:
dal dopoguerra allo sviluppo economico
Finita la guerra e sconfitto il regime fascista, l’Italia entra nella fase della ricostruzione,
sulla spinta dell’eroismo dimostrato durante la Resistenza e grazie al lucido protagonismo
di un nuovo ceto politico che condurrà il paese nei decenni successivi. Dalla tensione
tra le aspettative rivoluzionarie alimentate dalla lotta antifascista e il calcolo
politico imposto dalle condizioni dell’epoca passeranno le scelte principali del dopoguerra
italiano. L’antifascismo aveva mobilitato energie, aveva segnato il carattere e la
cultura politica di una generazione di militanti, ma non aveva modificato i rapporti
di potere nel paese. La ricostruzione doveva spegnere il clima rivoluzionario e operare
riforme graduali che sollevassero l’Italia dalla miseria.
Gli anni Cinquanta vedono il passaggio da un contesto produttivo prevalentemente basato
sull’agricoltura a un assetto industriale, nonostante i lavoratori dell’industria
siano già, ai tempi del sorpasso – dell’industria sull’agricoltura –, meno di quelli
del settore servizi. Come mostrano i dati ricostruiti dai ricercatori della Banca
d’Italia, Claire Giordano e Francesco Zollino, il picco della quota di lavoro nell’industria
si ha nel 1973 ed è pari al 36,9% contro il 45,7% dei servizi1. Gli aiuti economici erogati dagli Stati Uniti d’America con il Piano Marshall consentono
alle autorità politiche italiane di finanziare ingenti programmi di investimenti in
opere pubbliche e nella costruzione dell’industria statale. In questa direzione prende
avvio un piano di intervento pubblico che consente l’aumento della dotazione di capitale
statale nell’Iri (Istituto per la ricostruzione industriale) e la formazione di imponenti
investimenti che vedranno la formazione di Finsider (Società finanziaria siderurgica)
e poi dell’Eni (Ente nazionale degli idrocarburi). Viene avviato un processo di riconversione
tecnologica che coinvolge settori trainanti dell’economia nazionale come la siderurgia,
la chimica e l’industria automobilistica. Unitamente alle imprese ad alto contenuto
di capitale, l’Italia conosce in questi anni la crescita delle ditte produttrici di
beni di consumo (frigoriferi, televisori, mobili per ufficio) concentrate nel Nord
e votate alle esportazioni2.
Dal 1951 al 1964 la popolazione attiva del Nord occupata in agricoltura passa dal
25% al 13%, nelle regioni del Centro dal 44,3% al 23,3%3. Una storia raccontata dalle statistiche ufficiali, che disegnano lo sfondo di un
paese in trasformazione. Una cornice in cui si svolge tutta intera un’altra storia,
quella della lotta di classe in Italia e in Occidente. Gli anni della ricostruzione
sono il tempo delle scelte politiche che cambieranno pelle all’Italia nata dalla Resistenza
antifascista. Nella politica di moderazione salariale promossa dalla Dc nel 1947,
la successiva sconfitta del Fronte democratico popolare (comunisti e socialisti) alle
elezioni del 1948 e l’egemonia del blocco centrista all’alba del boom economico spezzano
il filo che legava la Resistenza al mito rivoluzionario. Anni che hanno un tempo storico
più lungo, che hanno un seguito di storia.
Sono gli anni dell’isolamento del movimento operaio nelle fabbriche, nelle campagne,
nel paese. Isolamento contro cui si batte il Piano del Lavoro di Giuseppe Di Vittorio,
segretario nazionale della Cgil, lanciato nel 1949 per risolvere il grande problema
della disoccupazione in Italia, della miseria che divorava il Mezzogiorno e che produceva
più di cinque milioni di lavoratori marginali e più di due milioni di disoccupati.
È l’iniziativa politica di un sindacato che prova a ritrovare nelle grandi questioni
nazionali la leva per costruire alleanze oltre la classe lavoratrice, in quell’idea
che era del Pci di un blocco sociale che unificasse classe operaia e ceti medi. Accanto
a questo livello di politica dall’alto, a questa grande iniziativa che si gioca tra
i partiti e le istituzioni, vivono lotte che scuotono le campagne del Sud e le fabbriche
del Nord. Lotte furibonde, per aumentare i salari e per riprendersi le terre, contro
l’ipersfruttamento, contro il dominio del cottimo, per la gestione cooperativa dei
grandi latifondi.
Nel 1946, nella piana di Milazzo, in provincia di Messina, ha luogo il primo sciopero
delle gelsominaie: contadine che raccoglievano i gelsomini usati per la produzione
dei profumi delle donne benestanti dell’epoca. Erano braccianti cottimiste, pagate
25 lire a chilo raccolto. Ventimila tra Messina e Reggio Calabria. Uno sciopero che
col passare dei giorni riuscì a portare per le strade siciliane non solo le gelsominaie,
ma anche le raccoglitrici di olive dei Nebrodi, le cavatrici di agrumi di Barcellona
Pozzo di Gotto e le incartatrici di Capo d’Orlando, sempre nel Messinese4. Al centro delle rivendicazioni “un salario minimo giornaliero e la stabilità dell’occupazione
nel periodo della raccolta, per un minimo di 90 giorni consecutivi”5.
A guardare bene il seguito di questa storia, nelle difficoltà che il Piano del Lavoro
di Di Vittorio deve affrontare per avviare una trasformazione dei rapporti di forza
nella società italiana, troviamo le prime tracce della grande questione salariale.
Nella relazione di Vittorio Foa, altro protagonista di quel periodo, preparata per
un convegno del 1975 a Modena si legge:
Alla mobilitazione del disoccupato non ha corrisposto la mobilitazione dell’operaio
stabilmente occupato; la controparte è stata il governo e non il capitale. [...] Non
mi interessa qui il rapporto sociologico fra distinte categorie come occupati e disoccupati;
mi interessa la strategia del movimento operaio: se in questa strategia manca il rapporto
diretto tra operaio e padrone, cioè manca la lotta salariale, l’unità del proletariato
resta una affermazione verbale6.
La proposta di un minimo salariale che Giuseppe Di Vittorio aveva presentato nel lontano
1954 viene abbandonata per lasciare spazio al primato della lotta contro la disoccupazione
e al tentativo di uscire dall’isolamento politico. A questa scelta il blocco capitalistico
guidato dalla Dc si contrappone puntando alla divisione della classe lavoratrice,
da Nord a Sud. Il governo dei flussi migratori e la timida e incompleta riforma agraria,
che lascia intatti i rapporti di forza tra contadini e blocco agrario, vengono utilizzati
come armi politiche per sedare le lotte contadine che si svolgono tra la fine degli
anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. Alla grande manovra di stabilizzazione del
consenso seguono repressioni violente. Gli anni Cinquanta sono anche il tempo dei
licenziamenti di massa, specie nell’industria del Nord. Le lotte operaie da offensive
diventano rapidamente lotte “difensive”.
Il 9 gennaio 1950 a Modena la polizia uccide sei operai in seguito a una manifestazione
organizzata contro i licenziamenti in una grande fabbrica cittadina. A un decennio
di distanza, il 7 luglio del 1960, a Reggio Emilia, sotto il governo presieduto dal
democristiano Fernando Tambroni, cinque operai vengono uccisi dalle forze dell’ordine
dopo uno sciopero per protesta contro le violenze subite durante le manifestazioni
dei giorni precedenti. I fatti di Modena e Reggio Emilia segnano indelebilmente le
coscienze degli operai che saranno l’avanguardia delle lotte degli anni successivi.
Un decennio si chiude per dare spazio a un altro tempo della vita politica e civile
dell’Italia. In mezzo, non dimentichiamolo mai, ci sono storie di sangue nelle fabbriche
e nelle piazze, c’è l’isolamento politico del movimento operaio a cui seguirà un ripensamento
strategico del Pci e della Cgil, culminato a metà degli anni Cinquanta con il “ritorno
alla fabbrica” come spazio privilegiato di azione, da cui ripartire per ricostruire
a fatica l’unità della classe lavoratrice.
L’espansione economica a cui si assiste in questi anni non sarà, quindi, indolore.
L’azione congiunta che vede protagonisti la borghesia del Nord e il blocco agrario
nel Sud si reggerà sulla lucida regia politica del governo a guida Dc. Da questo disegno
strategico prende forma la struttura dell’economia nazionale, caratterizzata dalla
presenza di settori produttivi trainati dalla domanda di investimenti interni e dalla
crescita di imprese che soddisfano soprattutto la domanda estera. Il processo di sviluppo
economico si svolge all’interno degli squilibri economici tra il Nord e il Sud del
paese7 – che avevano subito un’accelerazione cospicua nel periodo fascista –, tra un Mezzogiorno
ancora alle prese con ritardi nella formazione di un assetto industriale in linea
con le tendenze europee e un Settentrione che si avvicina ai ritmi di sviluppo delle
aree più industrializzate del Nord Europa. Il 1951 è l’anno in cui la distanza tra
reddito pro capite nel Meridione e nel Nord-Ovest rispetto alla media nazionale è
maggiore: da allora il Sud recupera sensibilmente in termini di condizioni di vita8, ma lo fa dentro uno schema di sviluppo costantemente diseguale, con l’industria
concentrata nel Nord orientale e occidentale. Come ha evidenziato Augusto Graziani,
la scelta di accrescere le esportazioni nasceva da un disegno preciso. C’era la necessità
di finanziare la domanda di materie prime e beni strumentali di cui il paese era in
larga parte carente e di potenziare allo stesso tempo l’industria italiana nel nuovo
mercato comune europeo, che prende forma nel 1957, qualche anno dopo la nascita della
Ceca (Comunità europea per il carbone e per l’acciaio)9.
Ma c’era anche, e noi diremo soprattutto, la necessità di contenere le rivendicazioni
salariali della classe lavoratrice, di ristabilire i rapporti di potere nei luoghi
di lavoro, di dividere il fronte operaio dalle lotte contadine, puntando su un modello
competitivo che si reggeva su bassi salari e alta offerta di lavoro. È quanto viene
sottolineato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori
italiani10 del 1954 (la prima e anche l’ultima inchiesta generale sul lavoro nella storia repubblicana)
secondo cui
i salari minimi specialmente per quanto riguarda i braccianti meridionali sono senz’altro
da considerarsi insufficienti rispetto alle necessità vitali del lavoratore, inferiori
al valore reale del lavoro compiuto, inadeguati alle condizioni prevalenti nel paese,
quanto ad alimentazione, alloggio, conforto e sicurezza. [...] Anche se i lavoratori
delle campagne pagano in genere prezzi meno elevati dei lavoratori di città per il
loro vitto e alloggio, va rilevato però che essi hanno meno vantaggi e comodità, usufruendo
in misura minore degli altri di certi servizi scolastici, medici, nonché delle misure
di sicurezza sociale e di protezione del lavoratore.
Dichiarazioni che entrano con forza nel dibattito contemporaneo a sfidare chi11, ancora oggi, si richiama alle gabbie salariali, cioè alla diversificazione dei salari
tra Nord e Sud, alludendo a un potere d’acquisto superiore per i lavoratori delle
regioni meridionali rispetto a quelli del Nord Italia. Tuttavia la questione dei bassi
salari e della presenza di effettive gabbie salariali emerge anche a parità di settore
economico nelle diverse regioni e riguarda allo stesso tempo, sebbene in forme differenti,
sia i lavoratori fissi e dei settori industriali, sia tutti i rapporti particolari
di lavoro, quali quello a domicilio, i cottimisti e i lavoratori in appalto e subappalto,
diramazioni affluenti del manifatturiero.
Tra il 1953 e il 1959 il valore aggiunto aumenta del 35%12, mentre la quota distribuita sotto forma di salari rimane ferma al 72,4%13, mostrando come il regime di accumulazione dell’industria italiana è favorito dall’ampio
differenziale tra quel che i lavoratori producono e quel che poi le aziende intascano.
A suffragare questa caratteristica strutturale dello sviluppo del paese concorrono
i dati che riguardano l’andamento del reddito da lavoro dipendente e quello dei consumi
privati. Negli anni dal 1951 al 1959 la quota di reddito complessivamente prodotto
che va al lavoro dipendente sul totale del reddito prodotto aumenta di appena un punto
percentuale. L’accumulazione dei profitti è ottenuta con tecniche di produzione volte
a frantumare l’organizzazione del lavoro e dividere il fronte operaio.
I ricorsi alle esternalizzazioni di fasi di lavorazione, alla gestione unilaterale
degli appalti, al lavoro a domicilio, sino alla costituzione di false cooperative
di manodopera, divengono tasselli fondamentali per indebolire le organizzazioni sindacali
e ostacolare la formazione di legami di solidarietà nella classe lavoratrice. Di questa
epoca restano le immagini in bianco e nero scolpite nella memoria della generazione
nata tra le due guerre: i contadini del Sud assoldati dai caporali nelle piazze delle
città per lavori saltuari nei grandi latifondi o le donne chine su un telaio fino
a tarda notte nella propria abitazione per integrare il salario misero delle vecchie
famiglie operaie. Immagini che tornano a colori attraversando il paese dalla pianura
padana a quella di Gioia Tauro, dove vecchie e nuove forme di sfruttamento raccontano
di un passato che è presente e, senza una travolgente inversione di marcia, anche
futuro.
È proprio contro questi dispositivi che in quel lontano dopoguerra si concentra l’offensiva
del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, fino a imporre un nuovo corso al
diritto del lavoro dell’Italia repubblicana, disinnescando i meccanismi di divisione
della forza lavoro e di individualizzazione dei rapporti a favore dei margini di profitto.
Nel 1960 viene approvata la legge n. 1369 che sancisce il divieto di intermediazione
e di interposizione nelle prestazioni di lavoro. Dietro questa formula giuridica dal
carattere apparentemente astratto ruota la storia delle relazioni di lavoro nel dopoguerra.
Con quel divieto si mette, infatti, la parola fine alle pratiche di sfruttamento che
avevano caratterizzato i contesti produttivi negli anni Cinquanta. L’obiettivo della
norma era colpire una prassi comune alle imprese, nei diversi settori dell’economia
italiana, che si servivano di una fitta rete di intermediari per appaltare fasi di
lavorazione in modo da eludere le proprie responsabilità economiche e sociali. Da
quel 1960 ad oggi la storia non ha avuto un cammino lineare, il progresso delle condizioni
materiali della classe lavoratrice è stato interrotto, le libertà delle imprese di
adoperare qualsiasi meccanismo di assoggettamento e divisione della classe lavoratrice
sono ristabilite. Ieri come oggi, i lavoratori si organizzano e lottano per emanciparsi
nel saliscendi della storia.
Il ciclo di lotte operaie che si apre alla fine degli anni Cinquanta e si chiude nei
primi anni Sessanta può essere considerato l’inizio di una nuova epoca nella storia
della lotta di classe in Italia e nel mondo. I conflitti operai avevano vissuto altre
fasi di sviluppo negli ultimi decenni del XIX secolo e all’inizio del successivo,
agli albori del processo di industrializzazione e negli anni seguenti alla prima guerra
mondiale.
Gli anni Sessanta segnano un mutamento qualitativo nel rapporto tra sviluppo economico
e lotte operaie, ma la storia di quel periodo nasce fuori dal perimetro della fabbrica
e nelle zone a forte specializzazione agricola. I lavoratori edili, ad esempio, danno
vita a una piattaforma per il “salario minimo annuo” che garantisca reddito anche
per i periodi di inattività e malattia. Così si apre il conflitto che si dirama nella
società, negli spazi di vita fuori dai luoghi di lavoro. Dalla fabbrica alla società,
si dirà. E le risorse? Ce le mettono i padroni. Sul fronte manifatturiero, le trasformazioni
intervenute nell’organizzazione della produzione avevano comportato il consolidamento
dei grandi complessi industriali, i metodi di lavoro avevano conosciuto un cambio
di passo verso la razionalizzazione delle mansioni e dei ritmi di lavoro. Il capitalismo
occidentale dei primi anni Sessanta si identifica con l’immagine imponente della grande
fabbrica fordista14, concentrata territorialmente in vasti insediamenti, e con la formazione di oligopoli
nei settori chiave dell’economia nazionale. Le trasformazioni negli assetti produttivi
e nell’organizzazione del lavoro cominciano a palesare le contraddizioni tra l’incessante
incremento dei ritmi di produzione e l’alto saggio di sfruttamento della forza lavoro.
A quest’altezza dello sviluppo capitalistico si collocano le prime rivendicazioni
della classe lavoratrice manifatturiera e non. Nel suo punto più avanzato, gli Stati
Uniti d’America, la lotta dei lavoratori dell’acciaio15 si propaga in tutto il continente. Da Birmingham a Detroit, da Chicago a Denver la
classe operaia americana chiede meno ore di lavoro e più salario. Queste parole d’ordine
caratterizzano l’insieme delle rivendicazioni operaie nel triennio 1960-1962. Non
è un caso che salario e orario di lavoro costituiscano il cuore della piattaforma
rivendicativa delle lotte operaie. Il conflitto che si apre riguarda direttamente
la condizione operaia nel luogo di lavoro. Non c’è più mediazione che tenga, la divisione
tra chi decide e chi subisce si fa chiara, limpida, evidente. Questo salto nel vivo
del processo di sfruttamento non si limita ad investire il fronte padronale, ma penetra
direttamente nel rapporto tra operai e sindacati. Le lotte si articolano dentro e contro l’organizzazione brutale della fabbrica, ma al tempo stesso si assiste ai tentativi
delle organizzazioni sindacali e politiche di mediare il conflitto, di ricondurlo
a sentieri conosciuti.
Non è più tempo di sacrifici in nome di un benessere che non arriva mai, è tempo di
conquiste sul campo. C’è un salto di spontaneità delle lotte che costringe i partiti
e i sindacati a rivedere la propria strategia. Una vera e propria irruzione della
classe operaia come soggetto generale che abbraccerà tutto il decennio Sessanta. Non
più merce di scambio, mera quantità da dosare nel processo produttivo, ma soggetto
autonomo, con un punto di vista di parte. La lotta per il salario diventa centrale,
perché nella richiesta di aumenti salariali si riconosce il conflitto irriducibile
tra due parti, cade la maschera dell’interesse comune tra capitale e lavoro. Dietro
il rapporto tra salari e profitti ci sono, quindi, interessi inconciliabili. Da una
parte chi dipende dal salario, dall’altra chi dipende dal profitto. Da qui si snoda
il seguito della storia. L’impresa fordista diventa teatro di un conflitto permanente
tra due parti, una contro l’altra, ognuna con la propria strategia e la propria tattica.
Classe contro classe: non più operai contro padroni, ma classe lavoratrice contro
classe capitalistica. A quest’altezza del rapporto tra lotte operaie e sviluppo capitalistico
si svolge una storia che fa epoca.
Aumentano le ore di sciopero, i conflitti di lavoro bloccano la produzione dei grandi
complessi industriali. L’onda delle mobilitazioni operaie si diffonde a macchia d’olio
nel Vecchio Continente, l’Europa conosce un ciclo di conflittualità mai visto prima.
Colonia, Manchester, Lione, Torino divengono in poco tempo i centri in cui si snoda
il conflitto operaio. Le aziende automobilistiche, le grandi centrali siderurgiche
assistono a blocchi della produzione, l’insubordinazione operaia non conosce confini,
dispiegando la propria forza contro il controllo pervasivo della fabbrica moderna.
In Italia il conflitto si concentra nelle grandi fabbriche del Nord-Ovest: gli scioperi
cominciano nel 1960, prima alla Lancia e poi all’Alfa Romeo per coinvolgere persino
la Fiat, fino a quel momento estranea al clima conflittuale che montava nel resto
delle fabbriche dell’Italia del Nord.
Gli scontri di piazza Statuto a Torino nel 1962 rappresentano il punto più alto dello
scontro di classe e assumeranno un ruolo decisivo nel cambiare il volto del paese.
La violenza padronale degli anni Cinquanta aveva lasciato aperte le ferite nella classe
lavoratrice. La risposta dei primi anni del decennio successivo porta con sé i segni
di quella storia, che restano indelebili nella memoria degli operai. Le statistiche
confermano l’intensità delle lotte, il numero di conflitti nell’industria manifatturiera
nel triennio 1960-1962 rispetto al triennio precedente passa da 900 mila a oltre un
milione e 700 mila. Una tendenza analoga riguarda le ore di lavoro perse: da 16 milioni
a 58 milioni16. Un ciclone che abbatte le certezze del decennio precedente. Da adesso in poi si
deve fare i conti con una classe lavoratrice agguerrita, che non si fa domare, pronta
a tutto pur di prendersi potere nella fabbrica e nella società. L’immagine dell’Italia
degli anni Cinquanta proiettata nel benessere del boom economico lascia spazio a quella
conflittuale degli anni successivi.
La crescita quantitativa della classe operaia industriale è un fattore di assoluta
rilevanza. Già nel 1961 l’incremento del numero di operai occupati nell’industria
è di circa un milione e 200 mila rispetto al 195117. La concentrazione numerica nelle grandi fabbriche del Nord contribuisce a un’intensa
socializzazione della condizione di lavoro che si estende alla vita fuori dalle fabbriche.
Una socializzazione che unisce gli operai settentrionali e la massa operaia del Mezzogiorno,
che non ha dimenticato lo sfruttamento e la repressione delle lotte contadine e porta
con sé questo moto di rivolta, questa sete di giustizia. Come hanno scritto David
Broder e Giacomo Gabbuti, le lotte operaie nel triangolo industriale costituivano
“il collante ideologico per altre lotte, nel tentativo di superare la storica divisione
(espressa soprattutto durante il fallimento del biennio rosso) tra gli operai nell’industria
fordista e il resto del paese”18. L’alto livello dei prezzi in rapporto alle basse paghe orarie contrae il potere
d’acquisto e l’accesso ai consumi e accentua i problemi della vita quotidiana. Le
condizioni fatiscenti delle abitazioni, la scarsa produzione di servizi sociali, le
difficoltà di integrazione nei nuovi assetti urbani amplificano la frustrazione tra
le masse operaie.
I primi anni Sessanta sembrano riportare la prospettiva storica al decennio 1910-1920,
un salto nel passato, nel grande passato delle lotte operaie. Un filo di storia che
attraversa mezzo secolo, che ritorna ad accendere la speranza di una trasformazione
in grande del corso della storia. Futuro che torna al passato e passato che si fa
futuro.
La permanenza di settori meno produttivi (agricoltura e distribuzione) con una bassa
dinamica della produttività mantiene il livello dei prezzi dei beni di consumo troppo
alto rispetto ai salari monetari. Ad appesantire questa condizione di deprivazione
contribuiscono i metodi di organizzazione del lavoro, l’intensificazione dei turni,
la diffusione del cottimo come metro di misurazione del salario: tutto questo stride
con le promesse luccicanti del miracolo economico. Alle motivazioni interne che alimentano
le mobilitazioni si accompagnano fattori esterni collegati all’abolizione delle barriere
doganali, alla costruzione del mercato comune europeo e all’alta mobilità della forza
lavoro. Queste condizioni creano effetti di trascinamento che propagano le lotte operaie
in tutta Europa.
L’aumento dei salari è il principale obiettivo che spinge gli operai a ricorrere a
cicli intensi di mobilitazione. L’abolizione del cottimo e del salario di rendimento
(schema salariale che prevede aumenti in ragione della produttività oraria) si unisce
alla richiesta di poter contrattare le condizioni di lavoro a livello aziendale. Con
l’accordo del 1962 tra sindacati metalmeccanici e l’Intersind (rappresentante sindacale
dell’industria pubblica) viene riconosciuta per la prima volta la contrattazione aziendale19. È un salto della classe lavoratrice nel governo della fabbrica, in quel passaggio
da sfruttati a produttori mai del tutto compiuto. I risultati del conflitto non si
faranno attendere, la quota del reddito destinata al lavoro dipendente passerà dal
42% del 1959 al 46% nel 1963, anno che chiude il grande ciclo di mobilitazione operaia.
Una tendenza analoga avranno i salari monetari nell’industria manifatturiera che cresceranno
con ritmi annui sostenuti nel triennio in esame: del 7% nel 1961, del 15,3% nel 1962
sino ad arrivare al 16,8% nel 196320. Una tendenza opposta guiderà l’andamento dei margini di profitto, che nell’industria
manifatturiera si ridurranno del 20% nel triennio21. L’incremento del salario reale tocca il suo livello più alto proprio nel 1963, con
una crescita rispetto all’anno precedente dell’8,17%. L’andamento più contenuto del
salario reale è determinato dal trasferimento dei costi di produzione sul livello
dei prezzi. La relazione tra lotte operaie, aumento dei salari e crescita dell’inflazione
sarà il meccanismo su cui si svolgerà tutto intero il rapporto di classe in Italia
sino alla fine degli anni Settanta. Ce ne renderemo conto dopo.
La risposta padronale all’attacco portato dalle lotte operaie ai margini di profitto
non si fa attendere. La nuova coalizione di centro-sinistra guidata da Aldo Moro e
dal leader del Partito socialista italiano Pietro Nenni rinuncia alle riforme sociali
promesse e cede ai ricatti del fronte industriale. Sarà Guido Carli, l’allora presidente
della Banca d’Italia, a inaugurare una politica deflazionistica, apportando una stretta
creditizia con l’obiettivo di garantire il recupero del profitto22. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare l’andamento dei salari sotto i livelli
di produttività: in termini assoluti i salari possono pure aumentare, ma mai intaccando
il livello dei profitti, in modo da ridurre l’inflazione e rilanciare le esportazioni
per riequilibrare la bilancia dei pagamenti (il rapporto tra entrate e uscite derivanti
dagli scambi con l’estero), costantemente in deficit negli anni del conflitto operaio.
La deflazione si tradurrà in una stretta creditizia paragonabile a quella messa in
campo nel 1947 da Luigi Einaudi, figura di garanzia degli equilibri politici ed economici
dell’immediato dopoguerra.
Il meccanismo dello sviluppo subisce un rapido arresto. La caduta degli investimenti
privati produce in pochi mesi una crescita dei licenziamenti e una riorganizzazione
dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro. L’assalto operaio al profitto d’impresa
viene arginato con le armi del capitalismo maturo: il controllo del ciclo economico
si opera attraverso la leva della politica monetaria. Si assiste in questi anni a
una novità nella gestione delle crisi che ritornerà negli anni successivi. Il conflitto
sociale non può essere più addomesticato con le armi tradizionali delle imprese. I
licenziamenti e l’impiego delle forze dell’ordine non saranno più sufficienti a fermare
l’avanzata della classe lavoratrice. Si deve agire a un livello più alto, c’è bisogno
dell’iniziativa politica, dell’intervento dello Stato. Si afferma una relazione sempre
più evidente tra ciclo economico e intervento politico, tra capitale e Stato, con
buona pace di chi continua a vedere il capitalismo come un sistema che funziona solo
grazie all’iniziativa delle imprese e al mito del “mercato”. Nella realtà, la sfera
economica e quella politica sono indissolubilmente interconnesse.
Gli effetti della politica deflazionistica sull’occupazione e la redistribuzione del
reddito tra le classi sociali, lavoratori e borghesia, comporteranno la perdita di
circa 400 mila posti di lavoro nell’industria manifatturiera. I rapporti di forza
vengono ristabiliti. Dal 1964 al 1967 il recupero del profitto (che aumenta di due
punti percentuali)23 segue due strade: da una parte si avvia la riorganizzazione del modello di produzione
con l’introduzione di processi di automazione che intensificano il controllo dell’impresa
sul processo di lavoro e dall’altra si assiste a una politica di integrazione degli
operai in fabbrica mediante la sperimentazione di nuovi assetti di relazioni industriali.
Il primo processo è comune a buona parte dei paesi a capitalismo avanzato, il disciplinamento
della forza lavoro è garantito dall’introduzione di tecniche moderne di controllo
dei tempi. L’incremento della produttività oraria è legato all’intensificazione dei
ritmi di lavoro e alla dipendenza del salario dai livelli di produzione.
Il cottimo, ovvero la massima variabilità del salario rispetto agli obiettivi della
produzione decisi dal nuovo management industriale, è lo strumento più diffuso per
frantumare l’organizzazione operaia, indebolendo i meccanismi di solidarietà interni
alla classe lavoratrice. Lo sviluppo tecnico diventa funzionale a rimuovere la combattività
operaia nei luoghi di lavoro, parcellizzando le mansioni e il contenuto del lavoro,
individualizzando lo schema salariale sul contributo del singolo lavoratore al processo
di produzione. L’obiettivo è quello di garantire l’integrazione della classe lavoratrice
nell’azienda, coinvolgendo la parte ritenuta più affidabile del sindacato nelle politiche
di investimento dell’impresa. Il tentativo è evidente: spezzare sul nascere forme
di riconoscimento autonomo della classe operaia e subordinare gli interessi dei lavoratori
a quelli dell’impresa. Una strategia che incrocia il comune sentire dell’area cattolica
del sindacato italiano, la Cisl, e la sensibilità della coalizione di governo, sempre
più caratterizzata dal ruolo della Dc.
Ma la tregua non durerà molto: nel biennio 1967-1968 riemergono i segnali di una ripresa
della conflittualità operaia. Il contesto internazionale conosce una fase nuova nelle
ondate di mobilitazione. Dagli Stati Uniti si diffonde un clima di contestazione contro
l’ordine capitalistico che raccoglie istanze diverse: dalla rivolta razziale alle
mobilitazioni dei giovani nelle università, sino ai nuovi conflitti che attraversano
i luoghi di lavoro. La contestazione alla guerra del Vietnam segna l’apice di questa
nuova ondata di protesta; il movimento pacifista coagula settori diversi della società
americana, costruendo un fronte largo di opposizione. L’eco delle mobilitazioni attraversa
l’Atlantico e arriva in Europa. Il “maggio francese”, che vede l’alleanza tra classe
lavoratrice e movimento studentesco, è il momento più intenso dell’ondata di contestazione
che scompagina i sogni tranquilli della borghesia europea. Il 1968 porta con sé trasformazioni
che vanno oltre il rapporto di sfruttamento nelle fabbriche: è una contestazione antiautoritaria
che travalica i confini produttivi. Si tratta anche di una rivoluzione nei costumi,
nelle relazioni di genere, nel rapporto con la famiglia. L’immaginario non è più dominato
dall’operaio-massa alla catena di montaggio. Nuovi soggetti sociali emergono. Gli
studenti prendono d’assalto le università, l’immagine in bianco e nero del paese bigotto
e conservatore lascia il passo ai colori dei figli dei fiori, al ritmo infuocato del
rock ’n’ roll.
L’eredità di quell’ondata di rivolta è ancora tutta da capire fino in fondo, nelle
sue declinazioni politiche e culturali: porterà con sé un retaggio vasto e contraddittorio
che è compito degli storici sciogliere. Ma in Italia dopo il 1968 ci sarà il 1969:
un’ondata di mobilitazioni operaie senza precedenti, con una forte carica di antagonismo
nei luoghi di lavoro. Un ritorno in grande del conflitto operaio. Le ore perdute per
conflitti nell’industria manifatturiera superano i 200 milioni contro i 113 milioni
del 1962; la durata media dei conflitti sfiora le 100 ore mentre nel ’62 non era andata
oltre le 60 ore24. Il nuovo ciclo di mobilitazione contiene rivendicazioni nuove rispetto al passato,
...