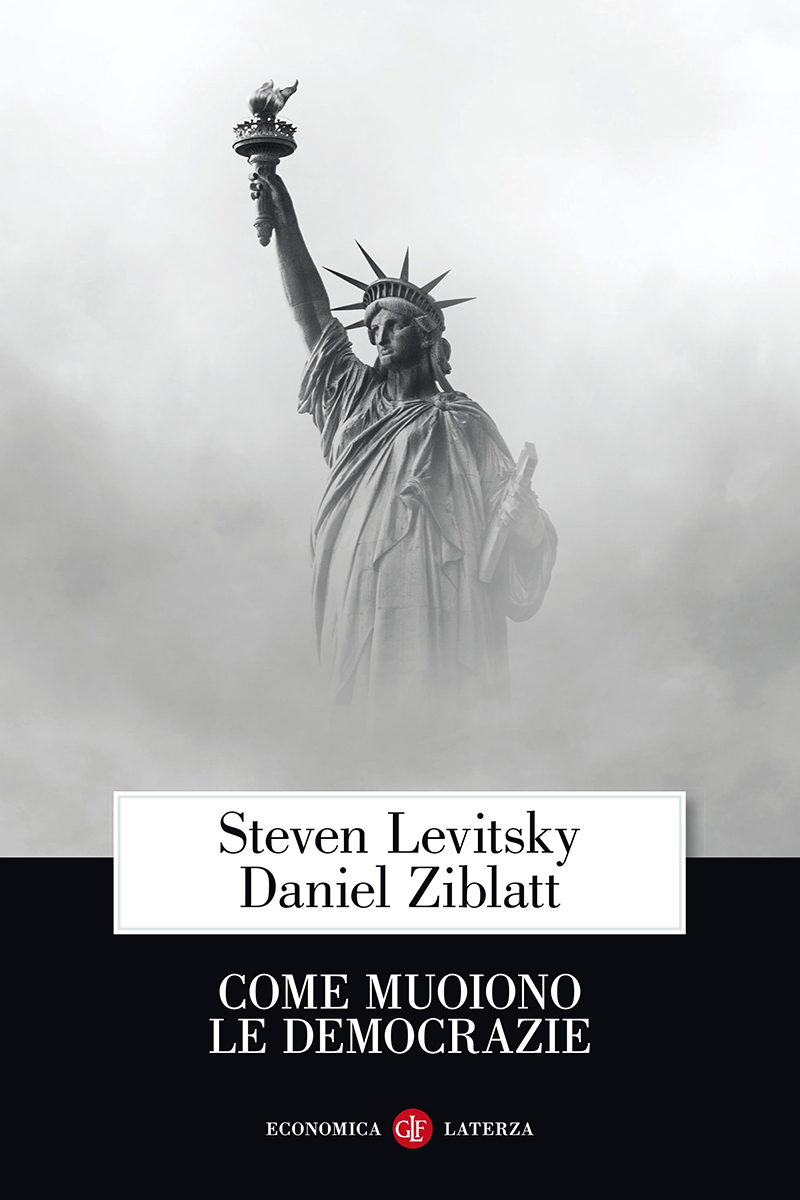La sfida populista e i suoi rimedi
di Sergio Fabbrini
Questo libro dovrebbe essere letto da tutti coloro che sono preoccupati per il futuro
della democrazia liberale. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt sono studiosi di Scienza
politica conosciuti e apprezzati dalla comunità scientifica internazionale. Insegnano
alla Harvard Kennedy School of Government. Il primo è specializzato in politica latino-americana,
il secondo in politica europea. Entrambi conoscono bene il loro paese, gli Stati Uniti.
Il libro è uno studio sulla politica contemporanea basato su una vasta conoscenza
storica e comparativa. In continuità con una solida tradizione anglosassone, è scritto
in modo comprensibile da un pubblico più largo dei soli specialisti. Peraltro, entrambi
gli autori contribuiscono al dibattito pubblico del loro paese attraverso articoli
pubblicati su quotidiani come il «New York Times». Lo fanno (come in questo libro) da studiosi che usano le loro conoscenze per spiegare
le tendenze della politica contemporanea, e non semplicemente per denunciarle.
Per i due studiosi di Harvard, la democrazia liberale è sfidata in quasi tutti i paesi
occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti, da un nuovo avversario politico che combina
populismo e nazionalismo. È stato l’arrivo di Donald Trump alla presidenza americana
ad aver legittimato e rafforzato l’avversario politico del liberalismo. Nel bene o
nel male, la politica americana condiziona gli sviluppi politici in altre parti del
mondo, dall’Europa all’America Latina. Tuttavia, il populismo da sempre si candida
ad essere un’alternativa al liberalismo, sia pratica che teorica1. Se con la fine della Guerra Fredda si era registrata una diffusione dei principi
dello Stato di diritto e della legittimazione elettorale del potere di governo, da
diversi anni questo processo è stato bruscamente interrotto. Se con la fine della
Guerra Fredda si era assestato un ordine liberale delle relazioni internazionali,
da diversi anni questo ordine è stato messo radicalmente in discussione, innanzitutto
dal paese (gli Stati Uniti) che l’aveva promosso2.
Il multilateralismo delle istituzioni internazionali e il pluralismo di quelle nazionali
sono stati sottoposti ad una critica feroce da parte di leader e gruppi politici che
rivendicano di parlare a nome di popoli nazionali che (si ritiene) siano stati imprigionati
da quelle istituzioni. Quei leader accettano la democrazia elettorale, ma non i vincoli
liberali sull’esercizio del potere politico. Se il liberalismo è una cultura di delimitazione
e controllo del potere politico3, i leader populisti emersi negli ultimi anni sono consapevolmente antiliberali o
illiberali. Essi usano la loro legittimazione elettorale per mettere in discussione
i vincoli liberali dello Stato di diritto, oltre ai rappresentanti associati a quest’ultimo.
Così, i leader populisti mobilitano il popolo (al singolare) contro le tradizionali
élites (politiche, economiche, amministrative, culturali) che hanno gestito la democrazia
liberale o che si sono alternate al governo di queste ultime, élites denunciate in toto come corrotte e autoreferenziali4. In tale processo, i leader populisti hanno riscoperto il concetto di nazione come
il luogo naturale di esistenza del popolo5, rilanciando così il nazionalismo come una sorta di nuova ideologia politica. «Prima
il mio paese o la mia gente» ha costituito la parola d’ordine di una mobilitazione
politica finalizzata a indebolire, all’interno dei singoli paesi, il pluralismo istituzionale,
oltre a quello sociale e culturale (se non anche quello religioso)6. E, al loro esterno, a indebolire il multilateralismo basato sul mutuo riconoscimento
di interessi nazionali diversi, con la relativa disponibilità ad accettare compromessi
tra di loro.
Le ragioni che hanno condotto all’affermazione di forze populiste e nazionaliste in
buona parte dei paesi democratici non costituiscono l’oggetto specifico dello studio
di Levitsky e Ziblatt. Essi prendono atto della sfida populista, la analizzano e quindi
indagano le sue possibili conseguenze. Dopo tutto, il dibattito sulle origini del
populismo è quanto mai aperto. È sufficiente ricordare le principali interpretazioni
della sua esplosione e diffusione. Per alcuni economisti7, il populismo è il risultato di un processo di globalizzazione non-governato e quindi
delle conseguenze sociali indotte dalla crisi di quel processo (con la crisi finanziaria
del secondo decennio dei Duemila). La crisi finanziaria ha accentuato le diseguaglianze
sociali interne ai paesi occidentali, nello stesso tempo in cui la globalizzazione
aveva condotto ad una riduzione delle diseguaglianze tra paesi occidentali e non occidentali.
Secondo questa interpretazione, il populismo è la reazione all’impatto della globalizzazione
(e della rivoluzione tecnologica da essa favorita) su ceti sociali privi degli strumenti
cognitivi per riqualificare la propria capacità lavorativa. Con la globalizzazione,
merci e beni prodotti a costi bassi nelle economie non occidentali sono entrati nei
mercati occidentali, mettendo in crisi le tradizionali attività produttive di questi
ultimi. Il populismo si è proposto come lo strumento politico con il quale i lavoratori
bianchi negli Stati Uniti o la classe operaia poco qualificata in Europa hanno cercato
di arrestare il declino della loro condizione economica, spingendo verso politiche
protezionistiche e redistributive.
Per alcuni scienziati politici, invece, il populismo riflette una crisi di identità
dei ceti sociali che hanno subìto il processo di globalizzazione8. Secondo questa interpretazione, il sostegno al populismo nasce da una perdita di
senso della vita di milioni di cittadini occidentali. Le diseguaglianze sociali sono
rilevanti ma in quanto accentuano la percezione di marginalizzazione sociale di importanti
settori delle società occidentali. In particolare, sono stati i processi di immigrazione
a portare in superficie la percezione di estraneazione, specialmente là dove i flussi
migratori provenivano da paesi di prevalente religione islamica9. È stata la minaccia identitaria che ha portato alla diffusione e alla persistenza
del populismo.
Vi è infine una terza interpretazione del populismo, elaborata da sociologi e scienziati
della comunicazione10. Secondo questa interpretazione, il populismo è il risultato di una trasformazione
epocale della comunicazione politica, dovuta alla diffusione di social mediache hanno superato i tradizionali canali informativi tra cittadini e potere, accentuando
un processo già in corso di disintermediazione sociale e culturale. Le società disintermediate
non hanno bisogno di passare attraverso la mediazione dei giornalisti per rapportarsi
con il potere. Così come non hanno bisogno della mediazione dei rappresentanti di
partiti o di associazioni di interesse per comunicare con il potere. Secondo questa
interpretazione, è stata la rivoluzione dell’informazione a creare le condizioni per
collegare direttamente il popolo ai leader populisti.
Che sia dovuto a ragioni economiche, oppure identitarie o ancora tecnologiche, il
populismo è divenuto un comportamento politico diffuso, un atteggiamento sociale che
ha scardinato i tradizionali sistemi politici ed economici che si erano consolidati
nel lungo secondo dopoguerra. Probabilmente, è stata la combinazione di tutti e tre
i fattori che ha fatto del populismo una forza politica elettoralmente competitiva.
Per la narrazione populista, la competizione non è più tra sinistra e destra, oppure
tra programmi e leadership politiche alternativi, ma tra un popolo sano e disinteressato
ed élites corrotte e interessate. Si tratta di una sfida esistenziale, piuttosto che
politica, alla democrazia liberale. I leader e i movimenti populisti non vogliono
solamente sostituire un partito o una coalizione di governo, ma mirano a mettere in
discussione un sistema rappresentativo che ha funzionato (questa è l’accusa) a sostegno
degli interessi esclusivi e privilegiati delle élites dominanti (di destra e di sinistra).
Di qui, la critica velenosa e costante ai detentori di posizioni di potere non elettive,
in quanto non legittimati dal popolo.
In realtà, quelle posizioni (nelle agenzie indipendenti, nell’amministrazione pubblica,
nei centri del sapere, nelle strutture associative) nascono dalla necessità di bilanciare
la spinta proveniente da maggioranze elettorali, così da impedire (come è avvenuto
più volte nel passato) la loro trasformazione in tirannie democratiche. Per i populisti,
la volontà popolare è incompatibile con la sua delimitazione costituzionale (oltre
che sociale e culturale)11. Il populismo vuole realizzare il vecchio sogno bolscevico che la cuoca debba governare.
La decisione politica, per il populismo, non richiede competenze tecniche, ma solamente
buon senso popolare. Naturalmente, non sarà mai una cuoca o un comico a governare,
ma leader che utilizzano l’una o l’altro per legittimare il proprio controllo del
potere. Una legittimazione elettorale che viene ritenuta sufficiente per rifiutare
i vincoli sui loro comportamenti, sia che essi provengano dall’ordine costituzionale
interno, oppure dagli accordi esterni tra paesi, o semplicemente dalla conoscenza
tecnica dei problemi. Il leader populista crede di non avere limiti, perché limiti
non deve avere il regime che vuole creare, la «popolocrazia»12.
È alta, dunque, la possibilità che i leader populisti diventino autoritari. Ed è qui
che il libro di Levitsky e Ziblatt mostra la sua utilità. I due studiosi introducono
quattro indicatori per valutare se il leader populista, una volta giunto al potere,
rappresenti o meno una minaccia autoritaria. Il primo indicatore riguarda il rapporto
tra il leader populista e le regole democratiche del gioco politico: le rifiuta o
con quale impegno le difende? Il secondo riguarda il rapporto tra il leader populista
e i suoi avversari politici: riconosce o meno la legittimità degli oppositori? Il
terzo riguarda il rapporto tra il leader populista e la violenza politica: la tollera
o addirittura la incoraggia? Il quarto riguarda il rapporto tra il leader populista
e la libertà di informazione: la riconosce e la preserva oppure la minaccia mettendo
in discussione le stesse libertà civili dei giornalisti?
Sulla base di questi indicatori, si possono registrare gradi diversi di predisposizione
autoritaria del leader populista, il quale o la quale può oscillare tra un polo di
piena predisposizione (su tutti e quattro gli indicatori) e un altro polo di limitata
tentazione autoritaria (manifestandosi solamente in uno di essi). Gli indicatori indicano
gli ambiti su cui vanno misurati (o considerati) i comportamenti dei leader populisti
al potere, così da comprendere il loro potenziale di autoritarismo. Se compariamo,
ad esempio, il presidente americano Donald Trump e il presidente turco Recep Tayyip
Erdoan, collocandoli nella scala tra basso (limitata predisposizione autoritaria) e alto
(considerevole predisposizione autoritaria), è plausibile giungere alla conclusione
che il secondo, più del primo, abbia finora mostrato una piena predisposizione autoritaria.
Infatti, la predisposizione autoritaria di Trump è bassa nel primo indicatore, in
quanto non ha formalmente rifiutato le regole del gioco democratico al punto da mettere
in discussione la stessa Costituzione o da ricorrere a strumenti extracostituzionali
per sospendere il processo democratico (come ha fatto invece Erdoan). La predisposizione autoritaria di Trump cresce nel secondo indicatore, continuando
a non riconoscere la legittimità politica dei suoi oppositori, al punto che non ha
mai accettato che la sua rivale del 2016 (la democratica Hillary Clinton) abbia ottenuto
la maggioranza del voto popolare o che il suo predecessore (il democratico Barack
Obama) fosse nato negli Stati Uniti. Naturalmente, tale predisposizione è ancora più
accentuata in Erdoan, che ha deciso di mettere i suoi avversari politici direttamente in prigione. La
predisposizione di Trump è bassa nel terzo indicatore, anche se non sono mancati apprezzamenti
o ammiccamenti nei confronti di gruppi politici violenti come il Ku-Klux Klan (mentre
Erdoan non ha avuto scrupoli a ricorrere alla violenza dei suoi sostenitori per neutralizzare
i gruppi di opposizione). Infine, la predisposizione autoritaria di Trump è in crescita
nel quarto indicatore, se si considerano le numerose e ricorrenti minacce indirizzate
ai giornalisti non allineati (mentre Erdoan ha chiuso giornali critici e imprigionato giornalisti indipendenti).
Se è evidente la differenza tra i due presidenti, tuttavia la predisposizione autoritaria
non va commisurata solamente rispetto all’obiettivo di rovesciare il regime democratico.
Infatti, i quattro indicatori ci consentono (anche) di capire come un leader populista
possa indebolire la democrazia senza necessariamente trasformarla in un sistema autoritario.
Ed è su questo piano che il libro di Levitsky e Ziblatt fornisce indicazioni importanti.
Le democrazie possono morire per (lente) trasformazioni interne, prima ancora che
per (subitanei) colpi di Stato, magari indotti dall’esterno. Le democrazie cominciano
a perire quando i principali leader politici, in particolare quelli con responsabilità
di governo, non sono disposti a difendere con determinazione le regole democratiche,
la legittimità dei loro oppositori, la civiltà dello scontro politico, la libertà
dell’informazione.
Nella scala usata dai politologi di Harvard, al di sotto di Erdoan vi sono innumerevoli leader che svuotano la democrazia liberale ogni giorno, senza
cambiarne la forma costituzionale. Oltre a Donald Trump, si pensi a Viktor Orbán,
Jarosaw Kaczyski, Matteo Salvini, Heinz-Christian Strache o Luigi Di Maio. Ognuno di loro ha simpatia
per l’uno o l’altro leader dei regimi autoritari (come il russo Vladimir Putin oppure
il venezuelano Nicolás Maduro), ma nessuno di loro è assimilabile a questi ultimi.
Ciò non significa che il loro comportamento sia accettabile, se si assume lo standard
di comportamento richiesto dalla democrazia liberale. Infatti, quei leader non nascondono
di voler andare oltre (o meglio, prima di) quest’ultima. Cioè di voler costruire una
democrazia illiberale, in cui il leader emerge sì dalle elezioni ma, una volta al
governo, non è più tenuto a rispettare i limiti nell’esercizio di quest’ultimo. Rimanendo
ai nostri indicatori, questi leader ritengono che le regole democratiche siano un
ingombro che impedisce al popolo di esercitare la sua volontà, che gli oppositori
siano l’espressione di una politica corrotta, che i gruppi violenti (espressi da movimenti
sociali o da club calcistici) non siano una minaccia, che i media indipendenti rappresentino
interessi economici antipopolari. Finora, nessun paese transatlantico si è trasformato
in un regime autoritario. Nondimeno, tendenze autoritarie sono riscontrabili (in gradi
diversi) in gran parte di essi. Le democrazie liberali, indebolite al loro interno,
fanno fatica a contrastare la sfida populista.
L’attacco populista alla democrazia liberale è risultato, se possibile, ancora più
insidioso all’interno dei paesi membri dell’Unione Europea (Ue). È stato in Europa
che il populismo, creando una santa alleanza con il nazionalismo, si è inequivocabilmente
presentato come un nuovo sovranismo. Cioè, come un movimento politico che ha l’obiettivo
di rimpatriare competenze che quei paesi avevano trasferito (volontariamente) a Bruxelles.
L’obiettivo delle forze sovraniste è dunque quello di svuotare dall’interno l’Ue,
indebolendo le norme giuridiche ed economiche che presiedono al suo funzionamento
come sistema sovranazionale. Visti i costi (politici, economici, sociali, culturali)
che il Regno Unito continua a pagare per la decisione di uscire dall’Ue (dopo il referendum
del giugno 2016 che era risultato favorevole alla Brexit), i partiti sovranisti non
si pongono più (o, almeno, per ora) il problema della secessione dall’Ue, ma perseguono
l’obiettivo molto più insidioso di neutralizzare i principi e i vincoli di quest’ultima
dall’interno. Conservando, però, tutti i vantaggi che derivano dall’appartenenza ad
un’organizzazione sovranazionale (come i fondi strutturali che hanno consentito, ai
paesi sovranisti dell’Est e del Sud dell’Europa, di sostenere le loro regioni più
povere).
Il rafforzamento delle sovranità nazionali consentirebbe, ai sovranisti dei paesi
europei, di perseguire con meno vincoli le loro strategie autoritarie (si pensi alla
Polonia, all’Ungheria, all’Austria ma anche all’Italia che è emersa dalle elezioni
del 4 marzo 2018). E l’indebolimento dell’Europa sovranazionale è a sua volta una
condizione per il rafforzamento del populismo nazionalista dei paesi occidentali e
del nazionalismo populista dei paesi orientali (dell’Ue). Dopo tutto, il processo
di integrazione sovranazionale nacque proprio dalle conseguenze drammatiche prodotte
dal nazionalismo e dal populismo nella prima metà del secolo scorso. L’addomesticamento
delle relazioni internazionali tra gli Stati europei fu considerato, dai padri fondatori
dell’integrazione europea, una condizione per contenere le spinte antidemocratiche
interne a quegli Stati, spinte esasperate dalle rivalità nazionaliste. Per questo
motivo fu creata un’organizzazione sovranazionale, dotata di istituzioni e giurisdizioni
indipendenti dagli Stati che la compongono, e non già una semplice organizzazione
internazionale dipendente verso gli Stati che ne fanno parte.
L’Ue si è configurata, sin dalle prime sentenze della Corte europea di giustizia degli
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, come una comunità di diritto. E, quindi,
come un sistema transnazionale di garanzia e promozione dei diritti individuali e
sociali. Basti pensare che il Trattato di Lisbona del 2009 ha riconosciuto la Carta
dei diritti fondamentali come un suo pilastro (carta elaborata alla fine degli anni
Novanta e quindi proclamataalla Conferenza intergovernativa che ha negoziato il Trattato di Nizza del 2001).
Per questo motivo, è stato detto che il progetto dell’integrazione europea è costitutivamente
antipopulista e liberale13.
La colla che tiene insieme i paesi europei è costituita dalla condivisione dei principi
propri del costituzionalismo liberale (tra cui il bilanciamento tra poteri e diritti),
anche se quei principi non sono stati codificati in una Costituzione formale. De facto, l’Europa integrata ha finito per seguire l’indicazione di James Madison (l’architetto
della Costituzione americana del 1787), secondo il quale le maggioranze hanno più
difficoltà a diventare tiranniche se si estendono le dimensioni della comunità politica
e si rafforzano i contropoteri sovranazionali. Come ha scritto nel saggio numero 10
del Federalista, «il rimedio che la repubblica offre per i mali più tipici del regime repubblicano
[la tirannia delle maggioranze] risiede [...] nell’ampiezza e nella struttura dell’Unione».
Tant’è che, anche nell’Ue, la spinta verso la tirannia della maggioranza in Stati
membri come l’Ungheria e la Polonia è stata contenuta da altri Stati, oltre che dalle
istituzioni sovranazionali. Nel settembre 2018, la Commissione europea, sostenuta
dal Parlamento europeo, si è rivolta alla Corte europea di giustizia affinché venisse
sanzionato il governo polacco per aver introdotto cambiamenti che mettono in discussione
l’indipendenza della Corte suprema di quel paese. Sempre nel 2018, la Commissione
ha avvertito l’Ungheria e, nel 2019, l’Austria che la loro legislazione sui cittadini
stranieri è discriminatoria, così violando i principi dello Stato di diritto. Si poteva
fare di più. Ma qualcosa è stato fatto.
Che cosa si deve fare di più per contrastare la spinta dei leader populisti a dar
vita a democrazie illiberali? Il libro di Levitsky e Ziblatt fornisce risposte di
grande respiro storico e ammirevole equilibrio politico. Innanzitutto, occorre la
consapevolezza, da parte dei guardiani del cancello (i gatekeepers) della democrazia, del pericolo rappresentato dal populismo. Quei guardiani sono
i partiti e i gruppi di interesse (associazioni imprenditoriali, sindacali, funzionali),
il cui compito deve essere quello di contrastare le forze populiste con determinazione
e ragionevolezza (ma senza adottarne lo stile incivile).
Non ci si può alleare con forze populiste, così pensando di controllarle. Come ci
ricorda la storia del secolo scorso, questi tentativi hanno prodotto conseguenze infelici
per la democrazia liberale. Ciò vale a livello nazionale come a livello sovranazionale.
I populisti vanno combattuti elettoralmente, rinnovando leadership politiche, programmi
sociali, stili comunicativi, ma senza sottomettersi alla loro carica iconoclastica.
Ciò riguarda soprattutto i partiti del conservatorismo democratico, dato che gran
parte delle forze populiste provengono dalla destra radicale. È necessario, per esempio,
che il Partito popolare europeo espella, dal suo interno, il gruppo parlamentare Fidesz
dell’ungherese Viktor Orbán; oppure che il Partito repubblicano statunitense prenda
le distanze dalle scelte illiberali di Donald Trump; o ancora che il centrodestra
italiano non si pieghi alla politica autoritaria di Matteo Salvini (e al suo stile
comunicativo fatto di offese e oltraggi ai suoi avversari, come all’ex ministro del
Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero).
A loro volta i partiti progressisti devono prendere atto che il lungo ciclo del secolo
socialdemocratico è terminato, con la sua visione teleologica che il futuro sarà necessariamente
migliore del presente. La globalizzazione, come l’integrazione europea, ha prodotto
conseguenze positive, ma anche non poche conseguenze negative. Quei processi hanno
creato ingiustizie economiche, insicurezze identitarie, imbarbarimenti culturali.
Conseguenze che vanno affrontate con riforme che facciano crescere l’economia ma anche
la sicurezza delle persone e delle loro comunità locali e nazionali. In secondo luogo,
il populismo va combattuto rafforzando i guardrails della democrazia, cioè quelle istituzioni e quelle pratiche che impediscono ad una
società di uscire di strada14.
Va riformata la democrazia rappresentativa per renderla più efficiente e legittima,
integrandola con le pratiche della democrazia diretta, ma senza concedere un millimetro
al populismo della cuoca al potere. È necessario difendere le istituzioni costituzionali
di garanzia, a cominciare dall’indipendenza del potere giudiziario, nondimeno responsabilizzandolo
nell’uso di quella indipendenza. È necessario rilanciare il progetto politico dell’Europa
integrata e le istituzioni internazionali multilaterali in quanto condizioni indispensabili
per garantire la pace tra i paesi e la libertà al loro interno.
Infine, il populismo va contrastato da un sistema informativo e da una società organizzata
che rifiutano di adattarsi alle false notizie o alle illusioni dell’incompetenza,
ma sono in grado di preservare il senso di verità e di dignità senza il quale la democrazia
liberale non può esistere. Le democrazie possono morireper tante ragioni, ci dicono Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Tra di esse, l’indifferenza
morale, la pigrizia intellettuale e l’opportunismo politico hanno sempre avuto un
posto speciale.
Introduzione
La nostra democrazia è in pericolo? È una domanda che non avremmo mai pensato di dover
porre. Siamo colleghi da quindici anni e ragioniamo, scriviamo e insegniamo agli studenti
la storia dei tracolli della democrazia in altri luoghi e in altri tempi: l’epoca
buia degli anni Trenta in Europa, la repressione degli anni Settanta in America Latina.
Abbiamo passato anni a condurre ricerche sulle nuove forme di autoritarismo che stanno
emergendo in tutto il mondo. Per noi, come e perché muoiono le democrazie è un’ossessione
professionale.
Ma ora ci troviamo a rivolgere l’attenzione al nostro stesso paese. Negli ultimi due
anni abbiamo visto esponenti politici dire e fare cose che negli Stati Uniti non hanno
precedenti, ma che in altri luoghi riconosciamo come segnali premonitori di crisi
democratiche. Siamo spaventati, al pari di molti altri americani, anche se cerchiamo
di rassicurarci raccontandoci che la situazione non può essere veramente così brutta, qui. Dopo tutto, anche se sappiamo che le democrazie sono sempre fragili, quella in cui
viviamo è riuscita in qualche modo a sfidare la forza di gravità. La nostra Costituzione,
la nostra fede nazionale nella libertà e nell’uguaglianza, la tradizionale solidità
della nostra classe media, i livelli elevati di ricchezza e di istruzione e l’ampiezza
e la diversificazione del settore privato: tutte queste cose dovrebbero immunizzarci
da un collasso della democrazia come è avvenuto in altri luoghi.
Eppure siamo preoccupati. I politici americani ormai trattano i loro rivali come nemici,
intimidiscono la stampa libera e minacciano di non riconoscere i risultati delle elezioni.
Cercano di indebolire i paraurti istituzionali della nostra democrazia, come i tribunali,
i servizi di intelligence e i comitati etici. L’America potrebbe non essere un caso
isolato. Gli studiosi sono sempre più preoccupati e temono che la democrazia sia sotto
attacco in tutto il mondo, perfino in luoghi dove la sua esistenza veniva da tempo
considerata come qualcosa di scontato: governi populisti hanno preso d’assalto le
istituzioni democratiche in Ungheria, Turchia e Polonia; forze estremiste hanno ottenuto
spettacolari avanzate elettorali in Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi e altri
paesi europei. E negli Stati Uniti, per la prima volta nella storia, un uomo senza
nessuna esperienza di cariche pubbliche, che dà pochi segnali di avere a cuore i diritti
costituzionali e che mostra chiare tendenze autoritarie è stato eletto presidente.
Che significa tutto questo? Stiamo assistendo al declino e alla caduta di una delle
democrazie più antiche e affermate del pianeta?
A mezzogiorno dell’11 settembre 1973, dopo mesi di tensioni crescenti nelle strade
di Santiago del Cile, aerei Hawker Hunter di fabbricazione britannica sorvolarono
il cielo della capitale per bombardare La Moneda, il palazzo in stile neoclassico
sede della presidenza del paese, al centro della città. Sotto quella pioggia di bombe,
La Moneda prese fuoco. Il presidente Salvador Allende, eletto tre anni prima a capo
di una coalizione di sinistra, era barricato all’interno. Il suo governo era stato
segnato da disordini sociali, crisi economica e paralisi politica. Allende aveva detto
che non avrebbe lasciato il posto prima di aver completato il suo lavoro: ma ora il
momento della verità era arrivato. Sotto il comando del generale Augusto Pinochet,
le forze armate stavano prendendo il controllo del paese. Nelle prime ore del mattino
di quel giorno fatidico, Allende aveva pronunciato parole di sfida in un messaggio
radio rivolto a tutta la nazione, nella speranza che i suoi tanti sostenitori scendessero
nelle strade per difendere la democrazia. Ma la resistenza non si materializzò mai.
Gli agenti della polizia militare che proteggevano il palazzo lo avevano abbandonato:
il suo messaggio radio fu accolto dal silenzio. Poche ore dopo, il presidente Allende
era morto. Ed era morta anche la democrazia cilena.
È questo quello che ci viene in mente quando pensiamo a una democrazia che muore:
uomini con i fucili spianati. Durante la Guerra Fredda, quando una democrazia cadeva,
tre volte su quattro la causa era un colpo di Stato. Erano morte in questo modo le
democrazie di Argentina, Brasile, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Perù,
Repubblica Dominicana, Thailandia, Turchia e Uruguay. Più recentemente, golpe militari
hanno rovesciato il presidente egiziano Mohammed Morsi, nel 2013, e il primo ministro
thailandese Yingluck Shinawatra, nel 2014. In tutti questi casi, la democrazia si
è dissolta in modo eclatante, attraverso la forza militare e la coercizione.
Ma c’è un altro modo per spezzare una democrazia, meno spettacolare ma altrettanto
distruttivo. Una democrazia può morire non per mano dei generali, ma per mano di un
leader eletto, un presidente o un primo ministro che sovvertono lo stesso processo
che li ha portati al potere. Alcuni di questi leader smantellano le istituzioni democratiche
rapidamente, come fece Hitler dopo l’incendio del Reichstag in Germania. Più spesso,
però, la democrazia viene corrosa lentamente, attraverso piccoli passi quasi impercettibili1.
In Venezuela, per esempio, Hugo Chávez era un outsider della politica che inveiva
contro l’élite corrotta al potere, promettendo di dare vita a una democrazia più «autentica»,
che usasse le enormi ricchezze petrolifere del paese per migliorare la vita dei poveri.
Sfruttando con abilità la rabbia dei venezuelani comuni, che in molti casi si sentivano
ignorati o bistrattati dai partiti politici tradizionali, Chávez fu eletto presidente
nel 1998. Come disse una donna del suo stesso Stato, il Barinas, la notte delle elezioni:
«La democrazia è infettata. E Chávez è il solo antibiotico che abbiamo»2.
Quando Chávez lanciò la rivoluzione promessa, lo fece in modo democratico. Nel 1999
convocò elezioni libere per una nuova assemblea costituente, dove i suoi alleati conquistarono
una maggioranza schiacciante, consentendo ai chavisti di scrivere da soli la nuova
Costituzione. Ma era una Costituzione democratica, e per rafforzarne la legittimità
nel 2000 si tennero nuove elezioni presidenziali e legislative, vinte anche stavolta
da Chávez e dai suoi alleati. Il populismo del presidente suscitò una forte opposizione
e nell’aprile del 2002 le forze armate tentarono un golpe ai suoi danni: ma il putsch fallì, consentendo a un Chávez trionfante di rivendicare una legittimazione democratica
ancora più forte.
Fu solo nel 2003 che Chávez fece i primi, chiari passi verso l’autoritarismo. Trovandosi
in calo di consensi, ritardò per un anno la convocazione di un referendum promosso
dall’opposizione per revocarlo dalla carica, fino a quando l’impennata dei prezzi
del petrolio non creò le condizioni per consentirgli di vincerlo. Nel 2004 il governo
mise all’indice quelli che avevano firmato la richiesta di destituzione e manipolò
la composizione della Corte suprema, ma la schiacciante rielezione di Chávez, nel
2006, gli permise di conservare una facciata democratica. Da quel momento il regime
chavista divenne più repressivo, chiudendo un’importante stazione televisiva, arrestando
o costringendo all’esilio politici di opposizione, giudici e giornalisti sulla base
di accuse dubbie ed eliminando il limite ai mandati presidenziali, per consentire
a Chávez di rimanere al potere a tempo indefinito. Quando Chávez, che ormai stava
morendo di cancro, fu rieletto nel 2012, le elezioni furono libere, ma non eque: il
chavismo controllava gran parte dei mezzi di informazione e sfruttava l’enorme apparato
del governo in proprio favore. Dopo la morte del presidente, un anno dopo, il suo
successore, Nicolás Maduro, vinse un’altra elezione discutibile e nel 2014 il suo
governo imprigionò uno dei principali leader dell’opposizione. Ma la travolgente vittoria
dell’opposizione alle elezioni legislative del 2015 sembrò smentire chi sosteneva
che il Venezuela non era più un paese democratico. Solo quando una nuova assemblea
costituente composta da un solo partito usurpò i poteri del Congresso, nel 2017, circa
vent’anni dopo la conquista della presidenza da parte di Chávez, quasi tutti hanno
riconosciuto che il paese sudamericano era diventato un’autocrazia.
È così che muoiono oggi le democrazie. Le dittature dichiarate, sotto forma di fascismo,
comunismo o regimi militari, sono scomparse in gran parte del mondo3. Ormai è raro che il potere venga conquistato attraverso un golpe militare o comunque
con la forza. Quasi tutti i paesi tengono regolarmente elezioni. Le democrazie muoiono
ancora, ma con altri mezzi. Dalla fine della Guerra Fredda a oggi, a determinare la
morte di una democrazia non sono quasi mai generali e soldati, ma gli stessi governi
eletti4. Come Chávez in Venezuela, altri leader eletti hanno sovvertito le istituzioni democratiche
in Georgia, Filippine, Nicaragua, Perù, Polonia, Russia, Sri Lanka, Turchia, Ucraina
e Ungheria. Oggi il tracollo di una democrazia comincia nelle urne.
La via elettorale per smantellare una democrazia è pericolosamente ingannevole. Con
un colpo di Stato classico, come nel Cile di Pinochet, la morte della democrazia è
immediata ed evidente per tutti: il palazzo presidenziale brucia, il presidente viene
ucciso, imprigionato o spedito in esilio, la Costituzione viene sospesa o stracciata.
Con la via elettorale, non succede niente del genere: non ci sono carri armati per
le strade, la Costituzione e le altre istituzioni nominalmente democratiche rimangono
al loro posto, la gente continua a votare; gli autocrati eletti conservano una facciata
di democrazia ma la svuotano di sostanza.
Molti sforzi dei governi per sovvertire la democrazia sono «legali», nel senso che
sono approvati dal Parlamento o accettati dai tribunali. A volte sono perfino presentati
come sforzi per migliorare la democrazia, rendendo il potere giudiziario più efficiente, combattendo la corruzione
o mettendo ordine nel processo elettorale. I giornali continuano a uscire, ma vengono
comprati o intimiditi per costringerli ad autocensurarsi. I cittadini possono continuare
a criticare il governo, ma spesso esponendosi al rischio di noie fiscali o problemi
legali di altro genere. Tutto questo semina la confusione tra la gente, che non si
rende conto immediatamente di quello che sta succedendo. Molti continuano a credere
di vivere in una democrazia: nel 2011, quando un sondaggio del Latinobarómetro chiese
ai venezuelani di assegnare un punteggio al loro paese tra 1 (Per nulla democratico)
e 10 (Completamente democratico), il 51 per cento diede un punteggio di 8 o addirittura
di più5.
Non essendoci un singolo momento – colpo di Stato, proclamazione della legge marziale,
sospensione della Costituzione – in cui il regime «varca» chiaramente il confine che
separa la democrazia dalla dittatura, viene meno l’elemento che fa scattare i campanelli
d’allarme nella società. Quelli che denunciano gli abusi del governo vengono liquidati
come esagerati, allarmisti. L’erosione della democrazia, per molti, è qualcosa di
impercettibile.
Quanto è vulnerabile la democrazia americana a una deriva di questo genere? Le fondamenta
della nostra democrazia sono sicuramente più solide di quelle del Venezuela, della
Turchia o dell’Ungheria. Ma lo sono abbastanza?
Per rispondere a questa domanda bisogna prendere le distanze dai titoli dei quotidiani
e dalle ultime notizie e allargare lo sguardo, ricavando insegnamento dalle esperienze
di altre democrazie in ogni parte del mondo e in tutti i momenti storici. Studiare
altre democrazie in crisi ci consente di capire meglio le sfide con cui è chiamata
a confrontarsi la nostra. Per esempio, basandoci sulle esperienze storiche di altre
nazioni abbiamo elaborato una cartina al tornasole per individuare gli aspiranti autocrati
prima che salgano al potere. Possiamo trarre insegnamento dagli errori commessi da
altri leader democratici del passato, che hanno aperto la porta ad aspiranti dittatori;
e possiamo trarre insegnamento anche, inversamente, dai metodi che in altre democrazie
si sono dimostrati utili per tenere gli estremisti lontano dal potere. Un approccio
comparato rivela anche come gli autocrati eletti, in diverse parti del mondo, adottino
strategie sorprendentemente simili quando si tratta di sovvertire le istituzioni democratiche.
Man mano che questi schemi diventano visibili, i passaggi che conducono al tracollo
della democrazia diventano meno ambigui e più facili da combattere. Conoscere i modi
in cui i cittadini, in altre democrazie, sono riusciti a resistere all’ascesa di autocrati
eletti, o le ragioni per cui tale resistenza è tragicamente fallita, è essenziale
per coloro che oggi cercano di difendere la democrazia americana.
Sappiamo che in tutte le società, perfino nelle democrazie sane, spuntano periodicamente
demagoghi estremisti. Anche gli Stati Uniti hanno avuto la loro parte di personaggi
del genere, come Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy e George Wallace. Un test
essenziale per le democrazie non è la frequenza con cui emergono i demagoghi, ma la
capacità dei dirigenti politici, e in particolare dei partiti politici, di fare in
modo che non conquistino il potere, tenendoli fuori dalle candidature dei partiti
principali, rifiutando di appoggiarli o schierarsi con loro e quando necessario facendo
causa comune con i rivali per sostenere quei candidati che danno garanzie di affidabilità
democratica. Per isolare un estremista che ha un grande seguito fra la popolazione
ci vuole coraggio politico. Ma quando paura, opportunismo o errori di calcolo spingono
partiti consolidati a coinvolgere gli estremisti nel gioco politico, la democrazia
è in pericolo.
Quando un aspirante autocrate riesce ad arrivare al potere, le democrazie devono affrontare
un secondo test fondamentale: il leader autocratico sovvertirà le istituzioni democratiche
oppure queste ultime riusciranno a tenerlo a bada? Da sole le istituzioni non bastano
a imbrigliare gli autocrati eletti. Le costituzioni vanno difese, e a difenderle devono
essere i partiti politici e i cittadini organizzati, ma anche le norme democratiche.
Senza norme solide, i controlli e i contrappesi previsti dalle costituzioni non possono
svolgere la funzione di baluardi della democrazia, come ci immaginiamo. Le istituzioni
diventano armi politiche, brandite con forza da quelli che le controllano a discapito
degli altri. È così che gli autocrati eletti sovvertono la democrazia: manipolando
la composizione dei tribunali e di altri organismi neutrali e usandoli come arma,
comprando i media e le aziende (o costringendoli al silenzio) e riscrivendo le regole
della politica per sbilanciare il confronto a proprio favore. Il tragico paradosso
della via elettorale all’autoritarismo è che gli assassini della democrazia usano
le sue stesse istituzioni – in modo graduale, sottile e perfino legale – per ucciderla.
L’America ha fallito il primo test nel novembre del 2016, quando ha eletto un presidente
la cui fedeltà alle norme democratiche è alquanto dubbia. La vittoria a sorpresa di
Donald Trump è stata possibile non solo grazie alla disaffezione dei cittadini, ma
anche grazie all’incapacità del Partito repubblicano di impedire che un demagogo estremista
al suo interno conquistasse la nomination.
Quant’è grave ora la minaccia? Molti osservatori trovano conforto nella nostra Costituzione,
che è stata pensata proprio per sventare e contenere il pericolo di demagoghi come
Donald Trump. Il sistema madisoniano di controlli e contrappesi ha resistito per più
di due secoli. È sopravvissuto alla Guerra di Secessione, alla Grande Depressione,
alla Guerra Fredda e al Watergate. Di sicuro, quindi, riuscirà a sopravvivere a Trump.
Noi non ne siamo così sicuri. Storicamente, è vero che il nostro sistema di controlli
e contrappesi ha funzionato piuttosto bene, ma non, o non del tutto, per merito del
sistema costituzionale disegnato dai padri fondatori. Le democrazie funzionano al
meglio – e sopravvivono più a lungo – quando le costituzioni sono rafforzate da norme
democratiche non scritte. Due sono le norme fondamentali che più di tutte hanno contribuito
a preservare il sistema di controlli e contrappesi dell’America, con modalità che
ci siamo abituati a considerare come qualcosa di scontato: la tolleranza reciproca,
ossia il tacito accordo che le parti in competizione si accettano a vicenda come avversari
legittimi, e la temperanza, ossia l’idea che i politici debbano esercitare moderazione
nell’utilizzo delle loro prerogative istituzionali. Queste due norme hanno rappresentato,
per gran parte del XX secolo, la corda d’ancoraggio della democrazia americana. I
leader dei due maggiori partiti si accettavano reciprocamente come legittimi e resistevano
alla tentazione di sfruttare il controllo temporaneo delle istituzioni per ricavarne
il massimo vantaggio per la propria fazione. La tolleranza e la temperanza sono state
le barriere di sicurezza della democrazia americana, le protezioni che l’hanno aiutata
a evitare quegli scontri all’ultimo sangue tra schieramenti politici che in altre
parti del mondo (per esempio in Europa negli anni Trenta e in Sudamerica negli anni
Sessanta e Settanta) hanno distrutto la democrazia.
Oggi, però, le barriere di sicurezza della democrazia americana si stanno indebolendo.
L’erosione delle nostre norme democratiche è cominciata negli anni Ottanta e Novanta
e ha avuto un’accelerazione negli anni Duemila. Nel momento in cui Barack Obama divenne
presidente, molti repubblicani contestavano la legittimità dei loro rivali democratici
e avevano abbandonato la temperanza abbracciando una strategia che puntava a conseguire
la vittoria con ogni mezzo necessario. Donald Trump può aver accelerato questo processo,
ma non ne è stato la causa. I problemi della democrazia americana sono più profondi.
L’indebolimento delle nostre norme democratiche affonda le sue radici in una polarizzazione
estrema, che va oltre le divergenze sulle politiche da adottare e si trasforma in
un conflitto esistenziale legato a razza e cultura. Gli sforzi dell’America per realizzare
l’uguaglianza razziale di fronte alla diversità crescente della nostra società hanno
alimentato una reazione insidiosa e accresciuto la polarizzazione6. E se c’è una cosa che emerge chiaramente dallo studio di altri casi di tracollo
della democrazia nella storia è che la polarizzazione estrema può uccidere una democrazia.
Insomma, ragioni per allarmarsi ci sono. Non solo noi americani nel 2016 abbiamo eletto
un demagogo, ma l’abbiamo fatto in un’epoca in cui le norme che un tempo proteggevano
la nostra democrazia cominciavano già ad andare alla deriva. Ma se le esperienze di
altri paesi ci insegnano che la polarizzazione può uccidere la democrazia, ci insegnano
anche che il tracollo della democrazia non è né inevitabile né irreversibile. Traendo
insegnamento da altre crisi democratiche, questo libro suggerisce strategie che i
cittadini dovrebbero, e non dovrebbero, seguire per difendere la nostra democrazia.
Molti americani sono spaventati per quello che sta succedendo al nostro paese, e hanno
ragione di esserlo. Ma per proteggere la nostra democrazia non bastano la paura o
lo sdegno. Dobbiamo essere umili e audaci al tempo stesso. Dobbiamo imparare da altri
paesi per scorgere i segnali di allerta e riconoscere i falsi allarmi. Dobbiamo stare
in guardia dai passi falsi fatali che hanno condotto alla rovina altre democrazie.
E dobbiamo capire come si sono mobilitati i cittadini per affrontare le grandi crisi
democratiche del passato, superando le loro profonde divisioni per evitare il tracollo
della democrazia. La storia non si ripete parola per parola. Però le parole della
storia di oggi fanno rima con quelle del passato. La promessa della storia, e la speranza
di questo libro, è riuscire a scovare queste rime prima che sia troppo tardi.
1.
Alleanze fatali
«Un cinghiale e un cavallo andavano a pascolare nello stesso posto. Ma il cinghiale
tutti i momenti calpestava l’erba e intorbidava l’acqua al cavallo, il quale, per
vendicarsi, ricorse all’aiuto di un cacciatore. Questo gli rispose che non poteva
far nulla per lui, se non si rassegnava a lasciarsi mettere il freno e a prenderlo
in groppa; e il cavallo acconsentì a tutte le sue richieste. Allora il cacciatore
gli salì in groppa, mise fuori combattimento il cinghiale e poi, condotto seco il
cavallo, lo legò alla greppia».
Esopo, «Il cinghiale, il cavallo e il cacciatore»,
in Favole
Il 30 ottobre 1922 Benito Mussolini arrivò a Roma alle 10,55, nel vagone letto di
un treno notturno proveniente da Milano1. Era stato invitato nella capitale dal re per ricevere l’incarico di formare un nuovo
esecutivo. Accompagnato da un ristretto gruppo di guardie del corpo, Mussolini dapprima
si fermò all’Hotel Savoia, poi, vestito con giacca nera, camicia nera e fez nero,
marciò trionfante fino al palazzo del Quirinale, la residenza del re. Roma brulicava
di voci di agitazioni. Bande di fascisti, molti con divise raccogliticce, scorrazzavano
per le strade della città. Mussolini, consapevole del potere dello spettacolo, entrò
a passo deciso nel palazzo del re, con i suoi pavimenti di marmo, e lo salutò così:
«Maestà, perdoni la mia tenuta [...] ma vengo dai campi di battaglia»2.
Questo fu l’inizio della leggendaria «Marcia su Roma» di Mussolini. Le immagini delle
masse di camicie nere che varcavano il Rubicone per strappare il potere allo Stato
liberale italiano divennero il canone fascista, ripetuto nelle festività nazionali
e nei libri di testo per bambini per tutti gli anni Venti e Trenta. Mussolini fece
la sua parte per custodire gelosamente il mito. All’ultima fermata di treno prima
di entrare a Roma, quel giorno, aveva preso in considerazione l’idea di entrare in
città a cavallo, circondato dalle sue guardie3. Anche se alla fine quell’idea venne abbandonata, fece tutto il possibile per ingigantire
la leggenda della sua ascesa al potere, conferendole l’aura, per usare le sue stesse
parole, di una «rivoluzione» e di un «atto insurrezionale» destinato a dare il via
a una nuova epoca fascista4.
La verità era più prosaica. Il grosso delle camicie nere, spesso con scarse vettovaglie
e senza armi, arrivò solo dopo che Mussolini era stato invitato a diventare presidente
del Consiglio. Le squadracce fasciste in tutto il paese rappresentavano una minaccia,
ma le macchinazioni di Mussolini per impadronirsi del potere furono tutto fuorché
una rivoluzione. Il futuro duce sfruttò i suoi 35 seggi in Parlamento (su 535), le
divisioni tra i partiti tradizionali, la paura del socialismo e la minaccia di violenza
delle sue 30.000 camicie nere per catturare l’attenzione dell’imbelle re Vittorio
Emanuele III, che vedeva in Mussolini un astro politico nascente e un mezzo per neutralizzare
l’agitazione sociale.
Con l’ordine politico ripristinato grazie alla nomina di Mussolini e il socialismo
costretto sulla difensiva, il mercato azionario italiano schizzò alle stelle. Anziani
statisti dell’establishment liberale, come Giovanni Giolitti e Antonio Salandra, si ritrovarono ad applaudire
la piega presa dagli eventi. Consideravano Mussolini un utile alleato. Ma non diversamente
dal cavallo della favola di Esopo, l’Italia si ritrovò presto «legata alla greppia».
Versioni più o meno simili di questa storia si sono ripetute in tutto il mondo nel
corso dell’ultimo secolo. Un intero cast di outsider politici, come Adolf Hitler in
Germania, Getúlio Vargas in Brasile, Alberto Fujimori in Perù e Hugo Chávez in Venezuela,
è arrivato al potere seguendo la stessa strada: dall’interno e passando per successi
elettorali o alleanze con personaggi politici potenti. In ognuno di questi casi, le
élites erano convinte che invitando l’outsider a prendere in mano le redini del governo
sarebbero riuscite a contenerlo, finché non fosse stato possibile ripristinare il controllo dei politici tradizionali.
Ma questi piani si ritorsero contro di loro. Un mix letale di ambizione, paura ed
errori di calcolo li ha condotti allo stesso, fatale errore: consegnare di propria
volontà le chiavi del potere a un autocrate in fieri.
Perché statisti anziani e navigati commettono questo errore? Pochi esempi sono più
significativi, a tale proposito, dell’ascesa al potere di Adolf Hitler, nel gennaio
del 1933. La sua capacità di organizzare un’insurrezione violenta era già stata dimostrata
con il «Putsch della Birreria» a Monaco di Baviera nel 1923, quando con un attacco
a sorpresa nelle ore serali un gruppo armato di suoi fiancheggiatori prese il controllo
di diversi edifici governativi e di una birreria di Monaco dove si riunivano funzionari
bavaresi. L’attacco, mal congegnato, fu sgominato dalle autorità e Hitler trascorse
nove mesi in cella, dove scrisse il suo famigerato testamento personale, Mein Kampf. Da quel momento, il futuro Führer si impegnò pubblicamente a conquistare il potere tramite elezioni. All’inizio il
suo movimento nazionalsocialista conquistò scarsi consensi. Il sistema politico weimariano
era stato fondato nel 1919 da una coalizione filodemocratica di cattolici, liberali
e socialdemocratici. Ma dal 1930 in poi, con l’economia tedesca che annaspava, il
centrodestra divenne preda di guerre intestine e comunisti e nazisti videro aumentare
la loro popolarità.
Il governo eletto crollò nel marzo del 1930, nel pieno delle traversie causate dalla
Grande Depressione. Con lo stallo politico che bloccava l’azione dell’esecutivo, una
figura di rappresentanza come quella del presidente, l’eroe della Prima guerra mondiale
Paul von Hindenburg, approfittò di un articolo della Costituzione che conferiva al
capo dello Stato l’autorità di nominare il cancelliere nella circostanza eccezionale
in cui il Parlamento non fosse stato in grado di produrre una maggioranza. Lo scopo
di questi cancellieri non eletti – e del presidente – non era solo governare, ma tagliare
fuori i radicali di destra e di sinistra. Da principio, l’economista del Partito di
centro Heinrich Brüning (che in seguito sarebbe fuggito dalla Germania diventando
professore a Harvard) tentò, senza successo, di rilanciare la crescita economica;
il suo mandato ebbe vita breve. Von Hindenburg si rivolse quindi all’aristocratico
Franz von Papen, e poi, sempre più scoraggiato, al caro amico e rivale di von Papen,
il generale Kurt von Schleicher, ex ministro della Difesa. Ma senza maggioranze nel
Reichstag, lo stallo persisteva. I leader politici vedevano con timore, e a ragione,
l’eventualità di nuove elezioni.
Convinta che «qualcosa alla fine deve cedere», una cricca di conservatori litigiosi
alla fine del gennaio 1933 si riunì e si accordò su una soluzione: bisognava mettere
a capo del governo un outsider che godesse di un forte consenso tra la popolazione.
Lo disprezzavano, ma sapevano che almeno aveva un seguito di massa. E soprattutto
pensavano di poterlo controllare.
Il 30 gennaio 1933 von Papen, uno dei principali architetti del piano, liquidava i
timori di chi considerava un azzardo consegnare il cancellierato di una Germania lacerata
dalla crisi nelle mani di Adolf Hitler con le seguenti, rassicuranti parole: «Siamo
noi che l’abbiamo preso a servizio. Nel giro di due mesi [...] terremo Hitler in pugno,
in un pugno così stretto che strillerà»5. Difficile immaginare un errore di calcolo più clamoroso.
Le esperienze di Italia e Germania evidenziano quell’«alleanza fatale» che spesso
spiana la via del potere agli autocrati6. In qualsiasi democrazia può capitare che i politici debbano misurarsi con problemi
gravi: crisi economiche, malcontento crescente dei cittadini e declino elettorale
dei partiti più importanti possono mettere alla prova il giudizio dei politici più
navigati. Se un outsider carismatico emerge sulla scena, conquistandosi consensi con
la sua sfida al vecchio ordine, i politici dell’establishment possono sentire di non avere più il controllo della situazione e cercare di cooptarlo.
Se uno di loro rompe la conventio ad excludendum e tende la mano all’«insorto» prima che lo facciano i suoi rivali, può usare l’energia
e la base di consenso dell’outsider per mettere fuori gioco i suoi colleghi, per poi,
è la speranza, riuscire a condizionarlo e a indirizzarlo verso il suo programma.
Questa sorta di patto con il diavolo spesso finisce per avvantaggiare l’outsider,
perché i nuovi alleati gli porgono su un piatto d’argento la rispettabilità sufficiente
a diventare un contendente legittimo per il potere. Nell’Italia dei primi anni Venti,
il vecchio ordine liberale si stava sgretolando di fronte al dilagare di scioperi
e agitazioni. L’incapacità dei partiti tradizionali di dare vita a maggioranze parlamentari
solide lasciava sconfortato l’anziano Giovanni Giolitti, per la quinta volta presidente
del Consiglio, e questi, contro il parere dei suoi consiglieri, nel maggio del 1921
convocò elezioni anticipate. Puntando ad attingere al consenso di massa dei fascisti,
Giolitti decise di offrire all’emergente movimento di Mussolini un posto nel suo «blocco
borghese», un cartello elettorale composto da nazionalisti, fascisti e liberali7. La strategia fallì: il blocco borghese conquistò meno del 20 per cento dei voti
e Giolitti fu costretto a dimettersi. Ma la presenza di Mussolini nel cartello elettorale
diede alla sua sgangherata formazione quella legittimità che le serviva per dare la
scalata al potere.
Queste alleanze fatali non sono certo confinate all’Europa fra le due guerre. Per
esempio, sono uno dei fattori che hanno facilitato l’ascesa di Hugo Chávez. Il Venezuela
andava orgoglioso del fatto di essere la democrazia più vecchia del Sudamerica, in
piedi dal 1958. Chávez, ufficiale di grado inferiore dell’esercito e capofila di un
golpe fallito, che non aveva mai ricoperto nessun incarico pubblico, politicamente
era un outsider. Ma la sua ascesa al potere ricevette una spinta decisiva da una vecchia
volpe della politica: l’ex presidente Rafael Caldera, uno dei fondatori della democrazia
venezuelana.
La politica venezuelana per molti anni era stata dominata da due partiti, l’Azione
democratica, di centrosinistra, e il centrodestra del Partito socialcristiano (o Copei)
di Caldera. Le due formazioni si erano alternate pacificamente al potere per più di
trent’anni, e negli anni Settanta il Venezuela veniva considerato un modello di democrazia,
in una regione dove colpi di Stato e dittature rappresentavano un male cronico. Durante
gli anni Ottanta, tuttavia, l’economia del paese, dipendente dal petrolio, sprofondò
in una recessione prolungata, una crisi che andò avanti per oltre un decennio, facendo
quasi raddoppiare il tasso di povertà. Come prevedibile, lo scontento cresceva sempre
di più tra i venezuelani. Nel febbraio del 1989 una serie di rivolte su larga scala
fu il segnale che la situazione si stava mettendo male per i partiti tradizionali.
Tre anni più tardi, un gruppo di ufficiali di grado inferiore insorse contro il presidente
Carlos Andrés Pérez. I ribelli, guidati da Hugo Chávez, si autodefinivano «bolivariani»,
in riferimento al venerato eroe dell’indipendenza Simón Bolívar. Il golpe fallì, ma
quando Chávez, arrestato, comparve in diretta televisiva per dire ai suoi sostenitori
di deporre le armi (dichiarando, con parole destinate a diventare leggendarie, che
la loro missione era fallita «per ora»), divenne un eroe agli occhi di molti venezuelani,
specialmente i più poveri. Dopo un secondo colpo di Stato fallito, nel novembre del
1992, dal carcere Chávez decise di cambiare rotta, puntando ad arrivare al potere
per via elettorale. Gli sarebbe servito aiuto.
L’ex presidente Caldera era un politico anziano molto stimato, ma nel 1992 la sua
carriera politica sembrava sulla via del tramonto. Quattro anni prima, non era riuscito
a strappare l’investitura del suo partito per la campagna presidenziale e ormai veniva
considerato un relitto politico. Ma il settantaseienne senatore sognava di tornare
alla presidenza, e l’arrivo di Chávez gli offrì un’ancora di salvataggio. La notte
del golpe iniziale di Chávez, l’ex presidente si alzò in piedi durante una seduta
di emergenza delle camere riunite e sposò la causa dei ribelli, dichiarando:
È difficile chiedere alle persone di sacrificarsi per la libertà e la democrazia quando
queste pensano che la libertà e la democrazia non siano in grado di dar loro da mangiare,
o impedire l’ascesa astronomica del costo della vita, o farla finita una volta per
tutte con la terribile piaga della corruzione, che sta corrodendo giorno dopo giorno,
agli occhi del mondo, le istituzioni del Venezuela8.
Questo sorprendente discorso rilanciò la carriera politica di Caldera. Attingendo
all’elettorato antisistema di Chávez, il consenso per l’ex presidente esplose, consentendogli
di candidarsi vittoriosamente alla presidenza nel 1993.
Gli ammiccamenti pubblici tra Caldera e Chávez non si limitarono a rafforzare nelle
urne il vecchio statista, ma diedero anche a Chávez una nuova credibilità. Lui e i
suoi compagni avevano cercato di distruggere la democrazia venezuelana e i suoi trentaquattro
anni di storia: ma invece di denunciare la minaccia estremista rappresentata dai leader
del tentato colpo di Stato, l’ex presidente manifestò pubblicamente simpatia nei loro
confronti (e aprì loro, in questo modo, le porte dell’establishment politico).
Caldera contribuì ad aprire a Chávez anche le porte del palazzo presidenziale, infliggendo
un colpo mortale ai partiti tradizionali. Con un clamoroso voltafaccia, abbandonò
il Copei, il partito che aveva fondato quasi cinquant’anni prima, e lanciò una candidatura
presidenziale indipendente. Certo, i partiti erano già in crisi, ma l’uscita di Caldera
e la sua successiva campagna anti-establishment contribuirono a seppellirli. Il sistema dei partiti si sgretolò dopo la vittoria
di Caldera come candidato indipendente, nel 1993, aprendo la strada a futuri outsider.
Cinque anni dopo, sarebbe stato il turno di Chávez9.
Ma allora, nel 1993, Chávez aveva ancora un ostacolo serio da superare: si trovava
in prigione, in attesa di essere processato per alto tradimento. Nel 1994, però, il
presidente Caldera fece cadere tutte le accuse contro di lui. L’ultima cosa che fece
il vecchio leader per spianare la strada a Chávez fu aprirgli le porte (stavolta letteralmente)
del carcere. Subito dopo il suo rilascio, un giornalista chiese a Chávez dove stava
andando. «Al potere», rispose lui10. Liberare Chávez era una misura popolare, e Caldera, durante la campagna elettorale,
aveva promesso di farlo. Come gran parte delle élites venezuelane, vedeva il golpista
mancato come una moda passeggera, un personaggio che di lì alle prossime elezioni
probabilmente avrebbe perso i favori dell’opinione pubblica11. Ma lasciando cadere le accuse contro di lui, invece di consentire che Chávez venisse
processato e dopo graziarlo, Caldera lo elevò, trasformando dal giorno alla notte
l’ex capofila di un tentato golpe in un candidato credibile alla presidenza12. Il 6 dicembre 1998 Chávez vinse le elezioni presidenziali, sconfiggendo largamente
un candidato sostenuto dall’establishment. Il giorno dell’insediamento, Caldera, il presidente uscente, non se la sentì di
ricevere il giuramento dalle mani di Chávez, come prescriveva la tradizione, e se
ne rimase in disparte con aria cupa13.
Al di là delle enormi differenze, Hitler, Mussolini e Chávez hanno seguito strade
sorprendentemente simili per arrivare al potere. Non solo erano tutti e tre outsider
con un’abilità speciale per catturare l’attenzione della gente, ma tutti e tre entrarono
nella stanza dei bottoni perché i politici dell’establishment trascurarono i segnali di avvertimento e consegnarono loro il potere (Hitler e Mussolini)
o crearono le condizioni per farceli arrivare (Chávez).
L’abdicazione dei leader esistenti alle loro responsabilità politiche spesso è il
primo passo di una nazione verso l’autoritarismo. Anni dopo la vittoria elettorale
di Chávez, Rafael Caldera spiegò i suoi errori semplicemente così: «Nessuno pensava
che Chávez avesse la più remota possibilità di diventare presidente»14. E appena un giorno dopo la nomina di Hitler a cancelliere, un importante politico
conservatore che lo aveva aiutato a salire al potere ammise: «Ho appena commesso la
più grande stupidaggine della mia vita: mi sono alleato con il più grande demagogo
della storia mondiale»15.
Non tutte le democrazie sono cadute in questa trappola. Alcune – per esempio il Belgio,
il Costa Rica, la Finlandia e la Gran Bretagna – hanno dovuto misurarsi con la sfida
rappresentata da politici demagoghi, ma sono riuscite a tenerli lontani dal potere.
Come hanno fatto? Sarebbe bello pensare che questa capacità di sopravvivenza derivi
dalla saggezza collettiva degli elettori: forse i belgi e i costaricani erano semplicemente
più democratici dei tedeschi e degli italiani. D’altronde amiamo pensare che il destino
di un governo risieda nelle mani dei suoi cittadini: se la gente custodisce valori
democratici, la democrazia è al sicuro; se i cittadini sono sensibili alle sirene
autoritarie, allora, presto o tardi, per la democrazia saranno guai.
È una visione sbagliata. Presuppone un eccesso di democrazia, che «il popolo» sia
in grado di decidere a suo piacimento che tipo di governo avere. È difficile trovare
dati di qualsiasi genere che segnalino l’esistenza di un supporto maggioritario per
l’autoritarismo nella Germania e nell’Italia degli anni Venti: prima che i nazisti
e i fascisti conquistassero il potere, gli iscritti dei rispettivi partiti rappresentavano
meno del 2 per cento della popolazione, e né i nazisti né i fascisti si erano avvicinati
anche lontanamente alla maggioranza assoluta dei voti in elezioni libere e corrette.
Al contrario, esistevano solide maggioranze elettorali contrarie a Hitler e Mussolini,
prima che i due uomini conquistassero il potere grazie al supporto di politici dell’establishment ciechi ai pericoli delle loro stesse ambizioni.
Hugo Chávez fu eletto da una maggioranza degli elettori, ma non ci sono molti segnali
che indichino che i venezuelani erano alla ricerca di un uomo forte. All’epoca il
consenso dei cittadini per la democrazia era più alto che in Cile (un paese che era,
e rimane, stabilmente democratico). Secondo l’indagine del Latinobarómetro del 1998,
il 60 per cento dei venezuelani sottoscriveva l’affermazione «la democrazia è sempre
la forma di governo migliore», mentre solo il 25 per cento concordava con la tesi
che «in alcune circostanze, un governo autoritario può essere preferibile a un governo
democratico». Per fare un confronto, solo il 53 per cento degli intervistati in Cile
era d’accordo che «la democrazia è sempre la forma di governo migliore»16.
Potenziali demagoghi esistono in tutte le democrazie, e capita, di tanto in tanto,
che uno di essi, o più di uno, riesca a toccare una corda sensibile nell’opinione
pubblica. Tuttavia, in alcune democrazie, i leader politici vedono i segnali d’allarme
per tempo e prendono misure per fare in modo che gli autoritari rimangano ai margini,
lontano dai centri del potere. Quando si trovano a doversi confrontare con l’ascesa
di estremisti o demagoghi, fanno uno sforzo concertato per isolarli e sconfiggerli.
Le reazioni di massa agli appelli degli estremisti contano, ma conta di più se le
classi dirigenti politiche, e in particolare i partiti, fungono da filtri. Per dirla
in parole semplici, i partiti politici sono le sentinelle della democrazia.
Per poter tenere alla larga gli autoritari, la prima cosa da fare è individuarli.
Purtroppo non esiste un sistema di preallerta infallibile. Molti autocrati possono
essere riconosciuti già prima di salire al potere, perché hanno un curriculum inequivocabile:
Hitler aveva guidato un tentativo di colpo di Stato, Chávez aveva organizzato un’insurrezione
militare fallita, le camicie nere di Mussolini praticavano violenze squadristiche
e Juan Perón, nell’Argentina di metà Novecento, aveva contribuito a guidare un tentato
golpe, due anni e mezzo prima di candidarsi alla presidenza.
Ma non sempre i politici rivelano la piena portata delle loro inclinazioni autocratiche
prima di arrivare al potere. Alcuni rispettano le norme democratiche all’inizio della
loro carriera, per poi abbandonarle. Si pensi al caso del primo ministro ungherese
Viktor Orbán. Orbán e il suo partito, il Fidesz, debuttarono alla fine degli anni
Ottanta sotto le insegne della liberaldemocrazia, e nel suo primo mandato da premier,
tra il 1998 e il 2003, Orbán governò in modo democratico. Il suo voltafaccia autoritario
dopo il ritorno al potere, nel 2010, è stato una vera sorpresa.
Ma allora come si fa a individuare i germi dell’autoritarismo in politici che non
hanno chiari precedenti antidemocratici? Qui bisogna rivolgersi all’eminente politologo
Juan J. Linz. Nato nella Germania di Weimar e cresciuto nella Spagna della guerra
civile, Linz conosceva fin troppo bene le insidie di una sconfitta della democrazia.
Nella veste di professore di Yale, dedicò gran parte della sua carriera a cercare
di capire come e perché le democrazie muoiono. Molte delle sue conclusioni sono contenute
in un libro, breve ma di grande influenza, intitolato La caduta dei regimi democratici. Pubblicato nel 1978, il saggio di Linz enfatizza il ruolo dei dirigenti politici,
mostrando come i loro comportamenti possano rafforzare la democrazia o metterla a
repentaglio. Propose anche, ma senza svilupparla mai fino in fondo, una prova della
«cartina al tornasole» per individuare i politici antidemocratici17.
Partendo dal lavoro di Linz, abbiamo elaborato quattro segnali d’allarme comportamentali
che possono aiutarci a riconoscere un autoritario quando ne vediamo uno18. Dobbiamo preoccuparci quando un politico 1) rigetta, con le parole o con i fatti,
le regole del gioco democratico, 2) nega legittimità agli avversari, 3) tollera o
incoraggia la violenza o 4) si dimostra pronto a limitare le libertà civili degli
avversari, mezzi di informazione inclusi. La tabella 1 mostra come valutare i politici
sulla base di questi quattro fattori.
Un politico che soddisfi anche soltanto uno di questi criteri è da guardare con preoccupazione.
Quale tipologia di candidati risulta solitamente positiva a questa prova della cartina
al tornasole dell’autoritarismo? Spesso e volentieri, si tratta di outsider con un
orientamento populista. I populisti sono politici anti-establishment, personaggi che, sostenendo di rappresentare la voce del «popolo», muovono guerra
a un’élite presentata come corrotta e cospiratoria. I populisti tendono a negare la
legittimità dei partiti tradizionali, accusandoli di essere antidemocratici e perfino
antipatriottici. Raccontano agli elettori che il sistema esistente non è realmente
una democrazia, ma un sistema che è stato sviato, corrotto o manipolato dalle élites.
E promettono di spazzare via queste élites e restituire il potere al «popolo». È una
retorica che va presa sul serio, perché quando i populisti vincono le elezioni spesso
prendono d’assalto le istituzioni democratiche. In America Latina, per esempio, su
quindici presidenti eletti in Bolivia, Ecuador, Perù e Venezuela tra il 1990 e il
2012, cinque erano outsider populisti: Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales,
Lucio Gutiérrez e Rafael Correa. Tutti e cinque hanno finito per indebolire le istituzioni
democratiche19.
Tenere lontani dal potere i politici autoritari è più facile a dirsi che a farsi.
Una democrazia, dopo tutto, non dovrebbe mettere al bando un partito o vietare a un
candidato di presentarsi alle elezioni, e noi non raccomandiamo misure del genere.
La responsabilità di sbarrare la strada ai politici autoritari spetta ai partiti e
ai loro leader: le sentinelle della democrazia.
Per proteggere adeguatamente la democrazia, è necessario che i partiti principali
isolino e sconfiggano le forze estremiste, un comportamento che la politologa Nancy
Bermeo definisce «distanziamento»20. I partiti democratici possono praticare questo distanziamento in vari modi. Per
prima cosa, possono tenere fuori gli aspiranti autocrati dalle loro primarie in periodo
di elezioni: per farlo, è necessario che resistano alla tentazione di candidare questi
estremisti a cariche importanti, anche quando possono portare consensi.
In secondo luogo, i partiti possono impegnarsi per estirpare gli estremisti presenti
fra i loro stessi militanti. Prendiamo l’esempio dell’Avf (Unione elettorale generale,
il nome del partito conservatore svedese nel periodo fra le due guerre). Il gruppo
giovanile dell’Avf (un’organizzazione di giovani militanti maggiorenni), chiamato
Organizzazione della gioventù nazionalista svedese, all’inizio degli anni Trenta si
radicalizzò sempre di più, criticando la democrazia parlamentare, sostenendo apertamente
Hitler e creando addirittura un gruppo di miliziani in divisa21. L’Avf nel 1933 reagì espellendo l’organizzazione. La perdita di quei 25.000 iscritti
probabilmente costò voti all’Avf nelle elezioni municipali del 1934, ma la strategia
di distanziamento messa in atto dal partito ridusse l’influenza delle forze antidemocratiche
all’interno del più grande partito di centrodestra della Svezia22.
In terzo luogo, i partiti democratici possono evitare ogni alleanza con partiti e
candidati antidemocratici. Come abbiamo visto in Italia e in Germania, i partiti democratici
in certi casi sono tentati di allearsi con gli estremisti del loro versante ideologico
per conquistare voti o (nei sistemi parlamentari) per formare governi. Ma alleanze
del genere hanno conseguenze devastanti nel lungo periodo. Come ha scritto Linz, la
morte di molte democrazie può essere ricondotta alla «maggiore affinità che un partito,
fondamentalmente prosistema, mostra nei confronti degli estremisti, i quali si collocano
dalla propria parte dello spettro politico, che non nei confronti dei partiti prosistema
che appartengono al versante opposto»23.
In quarto luogo, i partiti democratici possono agire per isolare sistematicamente
gli estremisti, invece di legittimarli. Significa che i dirigenti politici devono
evitare iniziative, come i comizi congiunti dei conservatori tedeschi con Hitler nei
primi anni Trenta o il benevolo discorso di Caldera verso Chávez, che contribuiscano
a «normalizzare» personaggi autoritari o conferiscano loro una rispettabilità pubblica.
Infine, ogni volta che gli estremisti diventano concorrenti elettorali seri, i partiti
moderati devono forgiare un fronte unito per sconfiggerli. Per citare Linz, devono
essere disposti ad «allearsi con oppositori anche ideologicamente distanti ma votati
al mantenimento dell’ordine politico democratico»24. In circostanze normali, una cosa del genere è quasi inimmaginabile: figuratevi il
senatore Edward Kennedy e altri democratici di sinistra che fanno campagna per Ronald
Reagan, o il Partito laburista britannico e i sindacati suoi alleati che appoggiano
Margaret Thatcher. I seguaci di ognuno dei partiti interessati sarebbero infuriati
di fronte a questo apparente tradimento dei loro principi di fondo. Ma in tempi straordinari,
avere coraggio per un leader di partito significa anteporre l’interesse della democrazia
e del paese all’interesse del partito, e dire chiaramente agli elettori qual è la
posta in gioco. Quando un partito o un politico che risultano positivi alla nostra
prova della cartina al tornasole diventano una minaccia elettorale seria, ci sono
poche alternative. Un fronte democratico unito può impedire agli estremisti di conquistare
il potere, e questo può significare salvare una democrazia.
Anche se i fallimenti rimangono più impressi nella memoria, ci sono anche esempi di
democrazie che sono riuscite a sbarrare la strada agli estremisti fra le due guerre.
Inaspettatamente, sono delle piccole nazioni a offrirci grandi insegnamenti. Prendiamo
il Belgio e la Finlandia. Nel periodo di crisi politica ed economica dell’Europa,
negli anni Venti e Trenta, entrambi i paesi sperimentarono un primo segnale d’allarme
del degrado della democrazia – l’avanzata di estremisti antisistema –, ma a differenza
dell’Italia e della Germania furono salvati da élites politiche che difesero le istituzioni
democratiche (almeno fino all’invasione nazista, avvenuta alcuni anni dopo).
Durante le elezioni generali del 1936 in Belgio, mentre il contagio fascista si stava
diffondendo dall’Italia e dalla Germania a tutta l’Europa, dalle urne uscì un segnale
preoccupante: due partiti autoritari di estrema destra, il Rex e il Partito nazionalista
fiammingo (Vlaamsch Nationaal Verbond, Vnv), videro esplodere i loro consensi, conquistando quasi il 20 per cento del voto
popolare e sfidando il predominio storico di tre partiti moderati: il Partito cattolico,
di centrodestra, il Partito operaio belga (socialisti) e il Partito liberale. La sfida
che veniva dal leader del Rex, Léon Degrelle, un giornalista cattolico che in seguito
sarebbe diventato collaboratore dei nazisti, era particolarmente minacciosa: virulento
contestatore della democrazia parlamentare, Degrelle si era allontanato dalla destra
del Partito cattolico e ora ne attaccava i dirigenti, accusandoli di essere corrotti.
Riceveva incoraggiamento e sostegno finanziario sia da Hitler che da Mussolini.
Le elezioni del 1936 rappresentarono un pesante colpo per i partiti moderati, che
arretrarono ovunque. Consapevoli dei movimenti antidemocratici in paesi vicini come
l’Italia e la Germania, e timorosi per la propria sopravvivenza, affrontarono il difficilissimo
compito di decidere quale risposta dare. Il Partito cattolico, in particolare, doveva
confrontarsi con un dilemma tutt’altro che semplice: collaborare con i suoi storici
rivali, socialisti e liberali, oppure dare vita a un’alleanza di destra che includesse
i rexisti, un partito con cui avevano alcune affinità ideologiche ma che non attribuiva
alcun valore alla democrazia.
A differenza degli esponenti dei partiti moderati sconfitti nelle urne in Italia e
in Germania, i leader del Partito cattolico in Belgio dichiararono che qualsiasi collaborazione
con i rexisti era incompatibile con l’appartenenza al partito, quindi portarono avanti
una duplice strategia per contrastare il movimento. Sul piano interno, imposero una
disciplina più rigida, vagliando e scremando i candidati con simpatie rexiste ed espellendo
quelli che sostenevano posizioni estremiste; inoltre, presero una posizione forte
contro qualsiasi collaborazione con l’estrema destra25. Sul piano esterno, combatterono il Rex sul suo stesso terreno, adottando nuove tattiche
propagandistiche ed elettorali rivolte ai giovani cattolici che facevano parte della
base rexista: crearono il Fronte della gioventù cattolica nel dicembre del 1935 e
iniziarono a candidare contro Degrelle esponenti che prima erano suoi alleati26.
Lo scontro finale fra il Rex e il Partito cattolico, in cui la formazione di Degrelle
si ritrovò di fatto emarginata (fino all’occupazione nazista), ruotò intorno alla
formazione di un nuovo governo dopo le elezioni del 1936. Il Partito cattolico sosteneva
il suo primo ministro uscente, Paul van Zeeland27. Quando van Zeeland riottenne l’incarico, aveva di fronte a sé due opzioni principali
per riuscire a dar vita a un esecutivo: la prima era un’alleanza con i rivali socialisti,
sul modello del «Fronte popolare» francese, che van Zeeland e altri leader cattolici
inizialmente speravano di evitare; la seconda era un’alleanza della destra antisocialista,
che avrebbe incluso il Rex e il Vnv. La scelta non era facile: la seconda opzione
era supportata da una fazione tradizionalista che cercava di rovesciare il fragile
esecutivo di van Zeeland facendo appello alla base cattolica, con l’organizzazione
di una «Marcia su Bruxelles» e la convocazione di elezioni anticipate, dove il leader
del Rex, Degrelle, si sarebbe presentato contro van Zeeland28. Questi piani furono sventati nel 1937, quando Degrelle fallì nel suo tentativo di
ottenere il voto anticipato, grazie soprattutto alla posizione ferma assunta dai parlamentari
cattolici, che rifiutarono di assecondare i piani dei tradizionalisti e scelsero di
unire le forze con liberali e socialisti per sostenere van Zeeland. Questo fu il momento
in cui il Partito cattolico dimostrò più che mai di essere disposto a svolgere la
funzione di sentinella della democrazia.
La tenuta del Partito cattolico, a destra, fu resa possibile anche da re Leopoldo
III e dal Partito operaio belga. Nelle elezioni del 1936 i socialisti erano quelli
che avevano conquistato il maggior numero di seggi, e questo dava loro il diritto
di formare il governo. Tuttavia, quando divenne evidente che il Partito operaio belga
non sarebbe riuscito a ottenere consensi sufficienti in Parlamento, invece di convocare
nuove elezioni (da cui i partiti estremisti sarebbero potuti uscire ulteriormente
rafforzati), il re si riunì con i leader dei maggiori partiti per convincerli a dar
vita a un governo di grande coalizione, guidato dal primo ministro uscente van Zeeland,
e che includesse la destra (il Partito cattolico) e la sinistra (i socialisti), ma
escludesse i partiti antisistema di entrambi gli schieramenti29. I socialisti diffidavano di van Zeeland, un uomo del Partito cattolico, ma anteposero
il bene della democrazia ai loro interessi di parte e sostennero la grande coalizione.
Una dinamica simile andò in scena in Finlandia, dove il Movimento lappista (da Lapua,
la cittadina dove venne creato) irruppe sulla scena politica nel 1929, minacciando
la fragile democrazia del paese30. Il movimento perseguiva la distruzione del comunismo con ogni mezzo necessario31. Minacciava di ricorrere alla violenza se le sue richieste non venivano accolte e
attaccava i politici moderati, che accusava di collaborazionismo con i socialisti.
All’inizio, i politici del partito di governo, l’Unione agraria, di centrodestra,
strizzavano l’occhio ai lappisti, perché trovavano politicamente utile il loro anticomunismo:
accolsero le richieste del movimento, negando ai comunisti i diritti politici e tollerando
al contempo le violenze dell’estrema destra32. Nel 1930 Pehr Evind Svinhufvud, un conservatore che i lappisti consideravano «uno
dei loro», divenne primo ministro e offrì loro due ministeri33. Un anno più tardi, Svinhufvud divenne presidente. Il Movimento lappista, tuttavia,
continuava a esibire comportamenti estremisti: con i comunisti messi al bando, cominciò
a prendersela con il più moderato Partito socialdemocratico34. Più di mille esponenti socialdemocratici, fra cui leader sindacali e parlamentari,
furono sequestrati dai lappisti35. Il movimento organizzò addirittura una marcia di 12.000 persone su Helsinki, sulla
falsariga della mitologica «Marcia su Roma», e nel 1932 appoggiò un fallito colpo
di Stato che puntava a sostituire il governo in carica con un altro «apolitico» e
«patriottico»36.
Con la progressiva radicalizzazione del Movimento lappista, tuttavia, i tradizionali
partiti conservatori finlandesi cominciarono a prendere marcatamente le distanze dalla
formazione. Alla fine degli anni Trenta, il grosso dell’Unione agraria37, i liberali del Partito progressista nazionale e gran parte del Partito popolare
svedese unirono le forze con il loro maggiore rivale ideologico, i socialdemocratici,
nel cosiddetto Fronte della legalità, per difendere la democrazia contro gli estremisti
violenti. Perfino il presidente conservatore, Svinhufvud, rigettò con decisione (e
alla fine mise fuorilegge) i suoi ex alleati38. Il Movimento lappista rimase isolato e la breve fiammata fascista in Finlandia morì
sul nascere39.
Esempi di partiti moderati che hanno svolto efficacemente il ruolo di sentinelle della
democrazia si possono trovare anche in contesti storici più recenti. In Austria, nel
2016, il principale partito di centrodestra, il Partito popolare austriaco (Övp),
è riuscito a tenere fuori dalla presidenza della Repubblica la destra radicale del
Partito della libertà (Fpö). L’Austria ha una lunga storia di protagonismo politico
dell’estrema destra, e l’Fpö è uno dei partiti di estrema destra più forti d’Europa.
Il sistema politico austriaco era diventato vulnerabile, perché i due maggiori partiti,
i socialdemocratici dell’Spö e i cristianodemocratici dell’Övp, che si erano alternati
alla presidenza nel periodo del dopoguerra, si stavano indebolendo. Nel 2016 il loro
predominio era minacciato da due outsider, l’ex presidente dei Verdi, Alexander Van
der Bellen, e il leader dell’estremista Fpö, Norbert Hofer.
Con sorpresa della maggior parte degli analisti, il primo turno vide qualificarsi
per il ballottaggio proprio Van der Bellen e Hofer. Dopo l’annullamento del voto per
un errore procedurale, nell’ottobre del 2016, il secondo turno, decisivo, si tenne
a dicembre. A questo punto, diversi politici di primo piano, inclusi alcuni esponenti
dei conservatori dell’Övp, sostenevano che Hofer e il suo Partito della libertà andavano
sconfitti. Hofer sembrava incoraggiare la violenza contro gli immigrati e molti si
chiedevano se una volta eletto avrebbe privilegiato la sua formazione, violando norme
consolidate che prescrivono che il presidente rimanga al di sopra delle parti. Di
fronte a questa minaccia, alcuni importanti esponenti dell’Övp lavorarono per sconfiggere
Hofer sostenendo il loro rivale ideologico, il candidato dei Verdi Van der Bellen.
Il candidato presidenziale dell’Övp, Andreas Khol, diede il suo appoggio a Van der
Bellen, così come il presidente del partito Reinhold Mitterlehner, la ministra Sophie
Karmasin e decine di sindaci dell’Övp nelle aree rurali. In una lettera, l’ex presidente
della Repubblica Erhard Busek scrisse che appoggiava Van der Bellen «non con passione,
ma dopo attenta riflessione», e aggiunse che la decisione era motivata dal fatto che
«non abbiamo voglia di ricevere le congratulazioni di Le Pen, dello Jobbik, di Wilders
e dell’AfD [e di altri estremisti] dopo le nostre elezioni presidenziali»40. Van der Bellen vinse per appena 300.000 voti.
Era una posizione che richiedeva coraggio politico. Secondo il sindaco dell’Övp di
una cittadina vicino a Vienna, Stefan Schmuckenschlager, che aveva deciso di appoggiare
il candidato verde, era una decisione che aveva diviso le famiglie: il suo fratello
gemello, anche lui un quadro del partito, aveva scelto di sostenere Hofer. Come ha
spiegato Schmuckenschlager, a volte bisogna accantonare gli interessi politici di
parte per fare quello che è giusto41.
Le dichiarazioni di voto degli esponenti dell’Övp sono servite? I dati indicano di
sì. Secondo gli exit poll, il 55 per cento degli intervistati che si dichiaravano
elettori dell’Övp ha detto di aver votato per Van der Bellen, e il 48 per cento degli
elettori di Van der Bellen ha detto di aver votato per lui per impedire a Hofer di
vincere. Inoltre, la marcata divisione tra centri urbani e aree rurali, che ha sempre
caratterizzato la politica austriaca (con i centri urbani che votavano a sinistra
e le aree rurali che votavano a destra), si è ridotta notevolmente nel secondo turno
del dicembre 2016, con Van der Bellen che ha vinto in un numero sorprendente di Länder rurali tradizionalmente conservatori.
Insomma, nel 2016 una serie di dirigenti responsabili dell’Övp ha resistito alla tentazione
di allearsi con un partito estremista all’interno del loro schieramento ideologico,
e il risultato è stato la sconfitta di quel partito. L’ottimo risultato dell’Fpö nelle
elezioni del 2017, che lo ha messo nelle condizioni di partecipare a un nuovo governo
di destra come socio di minoranza, mostra chiaramente che il dilemma che si trova
a fronteggiare la destra conservatrice austriaca persiste. Tuttavia, lo sforzo messo
in campo per impedire a un estremista di accedere alla presidenza fornisce un utile
esempio contemporaneo di forze moderate che svolgono la funzione di sentinelle della
democrazia.
Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno una storia impressionante di episodi di questo
tipo. Sia i democratici che i repubblicani hanno contrastato l’ascesa al loro interno
di politici estremisti, che in alcuni casi godevano di un consenso notevole tra gli
elettori. Per decenni, i due grandi partiti sono riusciti a tenere questi personaggi
fuori dal gioco politico più importante. Fino, naturalmente, al 2016.
2.
Sentinelle in America
Il romanziere americano Philip Roth, nel suo libro Il complotto contro l’America, partiva da eventi storici reali per immaginare quali caratteristiche avrebbe potuto
avere il fascismo nell’America dell’anteguerra.
Il personaggio centrale del romanzo è Charles Lindbergh, uno dei primi eroi mediatici
americani: assurse alla fama nel 1927 con il suo sorvolo in solitario dell’Oceano
Atlantico, e in seguito diventò un isolazionista dichiarato e un simpatizzante nazista.
Ma è qui che la storia prende una piega fantasiosa, nelle mani di Roth: invece di
svanire pian piano nell’oblio, Lindbergh arriva in aereo alla convention del Partito repubblicano del 1940 a Filadelfia, alle 3,14 del mattino, mentre la
sala gremita, al ventesimo ballottaggio, non è ancora riuscita a rompere lo stallo
e a scegliere un candidato per la Casa Bianca. Grida di «Lindy! Lindy! Lindy!» esplodono
per trenta, sfrenati minuti tra la folla della convention, e in un momento di intenso fervore collettivo il suo nome viene proposto, sostenuto
e approvato per acclamazione. Lindbergh, un uomo senza alcuna esperienza politica
ma con un fiuto mediatico senza eguali, ignora le raccomandazioni dei suoi consiglieri
e porta avanti la campagna elettorale per la presidenza pilotando il leggendario aereo
con cui aveva traversato l’Atlantico, lo Spirit of St. Louis, da uno Stato all’altro,
indossando i suoi occhialetti da aviatore, gli stivaloni e la tuta.
In questo mondo a rovescio, Lindbergh (i cui consiglieri elettorali, si scopre poi,
erano legati a Hitler) sconfigge Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica,
ed entra alla Casa Bianca, procedendo subito a firmare trattati di pace con i nemici
dell’America. In tutto il paese si scatena un’ondata di antisemitismo e violenze.
Molti americani hanno trovato dei parallelismi tra le elezioni presidenziali del 2016
e il libro di Roth. La premessa – un outsider con dubbie credenziali democratiche
sale al potere con l’aiuto di una nazione straniera – presenta indubbiamente delle
forti similitudini. Ma la comparazione solleva un’altra domanda eclatante: considerando
la gravità della crisi economica vissuta dall’America negli anni Trenta, perché qui
da noi non successe?
La ragione per cui nessun demagogo estremista aveva mai conquistato la presidenza
prima del 2016 non sta nell’assenza di contendenti per quel ruolo. E nemmeno nella
mancanza di consenso tra la cittadinanza. Al contrario, il panorama della politica
americana è storicamente costellato di politici estremisti. Solo negli anni Trenta
esistevano ottocento organizzazioni di estrema destra, negli Stati Uniti1. Fra le figure di maggior rilievo che emersero in quel periodo c’era padre Charles
Coughlin, un prete cattolico antisemita che con i suoi programmi radiofonici ferocemente
nazionalistici raggiungeva quaranta milioni di ascoltatori ogni settimana. Padre Coughlin
era apertamente antidemocratico: invocava l’abolizione dei partiti politici e contestava
l’importanza delle elezioni. Il suo giornale, «Social Justice», negli anni Trenta
adottò posizioni filofasciste, proclamando Mussolini «Uomo della Settimana» e difendendo
a più riprese il regime nazista2. Nonostante il suo estremismo, padre Coughlin era immensamente popolare. La rivista
«Fortune» lo definì «probabilmente la cosa più grande mai successa alla radio»3. Teneva discorsi in stadi e auditorium gremiti in tutto il paese; viaggiava di città
in città, con i suoi fan che si affollavano ai bordi della strada per vederlo passare4. Alcuni osservatori contemporanei lo definirono la figura più influente degli Stati
Uniti dopo Roosevelt5.
La Depressione favorì l’ascesa anche del governatore e senatore della Louisiana Huey
Long, che si faceva chiamare «The Kingfish». Long fu definito dallo storico Arthur
M. Schlesinger Jr. il grande demagogo del momento, «che assomigliava [...] a un dittatore
dell’America Latina, un Vargas o un Perón»6. Il «Kingfish» era molto dotato per i discorsi a braccio, e aveva l’abitudine di
sfidare apertamente lo Stato di diritto7. Come governatore, costruì quello che Schlesinger ha definito «quanto di più vicino
a uno Stato totalitario sia mai esistito nella repubblica americana», usando un miscuglio
di mazzette e minacce per mettere in riga il Parlamento statale, la magistratura e
la stampa8. Quando un parlamentare dell’opposizione gli chiese se avesse mai sentito parlare
della Costituzione dello Stato, Long rispose: «Ora sono io la Costituzione»9. Il direttore di giornale Hodding Carter definì Long «il primo vero dittatore comparso
sul suolo americano»10. Quando il direttore della campagna elettorale di Franklin Delano Roosevelt, James
A. Farley, incontrò Mussolini a Roma nel 1933, scrisse che il dittatore italiano «mi
ha fatto pensare a Huey Long»11.
Long si costruì un seguito di massa grazie alla sua battaglia per la ridistribuzione
della ricchezza. Nel 1934 si diceva che ricevesse «più lettere di tutti gli altri
senatori messi insieme, perfino più del presidente»12. A quel punto, il suo movimento Share Our Wealth (Condividiamo la nostra ricchezza)
aveva più di 27.000 cellule in tutto il paese, e un indirizzario di quasi otto milioni
di nominativi13. Long aveva in mente di correre per la Casa Bianca14 e disse a un giornalista del «New York Times»: «Posso prendere questo Roosevelt [...]
posso fare promesse molto più grandi delle sue. E lui lo sa»15. Roosevelt vedeva Long come una seria minaccia, ma il problema si risolse quando
il senatore della Louisiana fu assassinato, nel settembre del 193516.
Questa vena autoritaria della politica americana non scomparve neppure durante l’età
dell’oro seguita alla Seconda guerra mondiale. Il senatore Joseph McCarthy, che usò
la paura della sovversione comunista nel periodo della Guerra Fredda per promuovere
liste nere, censura e messa al bando di libri, godeva di un ampio sostegno nell’opinione
pubblica americana17. Nel suo momento di massima popolarità, i sondaggi indicavano che quasi metà di tutti
gli americani approvava il suo operato. Perfino dopo la mozione di censura del Senato
nei suoi confronti, nel 1954, nei sondaggi Gallup continuava a godere di un tasso
di approvazione del 40 per cento18.
Un decennio più tardi, le provocatorie posizioni in difesa del segregazionismo regalarono
al governatore dell’Alabama George Wallace una notorietà nazionale, che si tradusse
in due candidature alla Casa Bianca nel 1968 e nel 1972, con risultati sorprendentemente
positivi. Wallace praticava, secondo il giornalista Arthur Hadley, «l’antica e onorata
tradizione americana di odio verso i potenti»19. Era maestro, scriveva Hadley, nello sfruttare «l’antica, pura e semplice rabbia
americana». Wallace spesso incoraggiava la violenza e mostrava una disinvolta indifferenza
verso le norme costituzionali, dichiarando:
C’è una cosa più potente della Costituzione [...]. È il volere del popolo. Che cos’è
in fondo una costituzione? È il prodotto del popolo, il popolo è la prima fonte di
potere e il popolo può abolire una costituzione, se lo vuole20.
Il messaggio di Wallace, che mescolava il razzismo agli ammiccamenti populisti al
senso di ingiustizia e alla rabbia economica dei proletari bianchi, lo aiutò a fare
proseliti fra la tradizionale base operaia del Partito democratico21. I sondaggi mostravano che circa il 40 per cento degli americani aveva una visione
positiva di Wallace nella sua candidatura come indipendente, nel 1968, e nel 1972
lasciò di stucco l’establishment emergendo come un serio contendente nelle primarie democratiche22. Prima che la sua campagna elettorale venisse scombussolata da un tentativo di assassinarlo,
nel maggio del 1972, aveva oltre un milione di voti di vantaggio su George McGovern,
nelle primarie23.
Insomma, in America esiste un filone autoritario ben radicato. Non era insolito che
personaggi come Coughlin, Long, McCarthy e Wallace riuscissero a conquistarsi il sostegno
di una cospicua minoranza (il 30 o addirittura il 40 per cento dell’elettorato). Ci
piace spesso credere alla storia che la nostra cultura politica nazionale ci immunizza,
non si sa bene come, da queste sirene, ma dire una cosa del genere significa leggere
la storia con lenti colorate di rosa. La vera protezione contro gli aspiranti autocrati
non è venuta dall’incrollabile fede degli americani nella democrazia, ma dalle sentinelle
delle istituzioni democratiche, i partiti politici.
L’8 giugno 1920, mentre la presidenza di Woodrow Wilson si avviava al termine, i delegati
repubblicani si riunivano per scegliere il loro candidato, in un Chicago Coliseum
rivestito di bandiere ma scarsamente ventilato, dove la temperatura, asfissiante,
superava i trentotto gradi. Dopo nove votazioni in quattro giorni, la convention non aveva ancora prodotto un risultato. Il venerdì sera, nella suite 404, al tredicesimo
piano del vicino Blackstone Hotel, il presidente del Comitato nazionale repubblicano
(il principale organo di governo del partito), Will Hays, e George Harvey, il potente
editore dell’«Harvey’s Weekly», ricevevano a rotazione senatori e leader del partito
nell’antesignana di tutte le smoke-filled rooms, le «fumose stanze» dove vengono prese, a porte chiuse, tutte le decisioni politiche
importanti. Gli esponenti della Vecchia Guardia, come li chiamavano i giornalisti,
si versavano da bere, fumavano sigari e discutevano fino a tarda notte come mettere
fine allo stallo e trovare un candidato che ottenesse i 493 voti dei delegati necessari
per strappare la nomination24.
Il principale contendente alla convention era il generale di divisione Leonard Wood, un vecchio alleato di Theodore Roosevelt
che aveva generato un certo entusiasmo popolare nelle primarie ed era in testa alle
votazioni all’inizio della settimana, con 287 delegati. Era seguito dal governatore
dell’Illinois Frank Lowden, dal senatore della California Hiram Johnson e molto più
indietro, al quarto posto, con solo 65 delegati e mezzo, dal senatore dell’Ohio Warren
G. Harding. Dalla sede della convention, scrivevano i giornalisti, «Nessuno parla di Harding [...]. Non è nemmeno inserito
fra gli outsider più promettenti»25. Ma quando ai giornalisti arrivarono indiscrezioni sulle discussioni in corso al
Blackstone Hotel, i più determinati fra loro riuscirono a intrufolarsi fino al tredicesimo
piano e si radunarono, zitti zitti, nei corridoi fuori dalla suite 404, per vedere
di sfuggita l’andirivieni di senatori di primo piano (fra gli altri, Henry Cabot Lodge
del Massachusetts, McCormick dell’Illinois, Phipps del Colorado, Calder dello Stato
di New York e l’ex senatore del Massachusetts Crane).
Dentro alla suite 404, i pregi e i difetti di ciascun candidato venivano attentamente
vagliati e discussi (Knox era troppo vecchio, a Lodge non piaceva Coolidge). All’una
del mattino, sette esponenti della Vecchia Guardia rimasero nella stanza e procedettero
a una votazione per alzata di mano. Convocato alle due e undici minuti del mattino
da George Harvey, Harding venne informato, con suo sommo stupore, che era lui il prescelto. La voce si sparse. La sera seguente, alla decima votazione e con grande
sollievo dei sudatissimi delegati, Warren G. Harding ottenne una schiacciante maggioranza
con il voto di 692 delegati e mezzo, accolto da una travolgente ovazione. Anche se
aveva raccolto poco più del 4 per cento dei voti nelle primarie, ora era il candidato
alla Casa Bianca del Partito repubblicano per le elezioni presidenziali del 1920.
Oggigiorno, le «fumose stanze» non piacciono a nessuno, e giustamente. Non sono molto
democratiche: i candidati venivano scelti da un gruppo ristretto di pezzi grossi che
non rispondevano alla base del partito, e tantomeno al cittadino medio. Inoltre, le
fumose stanze non sempre hanno sfornato presidenti brillanti (la presidenza di Harding
fu caratterizzata da scandali). Tuttavia, la selezione di un candidato a porte chiuse
aveva un pregio che oggi viene spesso dimenticato: svolgeva la funzione di sentinella,
tenendo fuori dalle investiture e dalla possibilità di arrivare al potere personaggi
palesemente inadatti. Certo, non è che questo succedesse per la nobiltà d’animo dei
dirigenti di partito: i «boss», come li chiamavano i loro avversari,
...