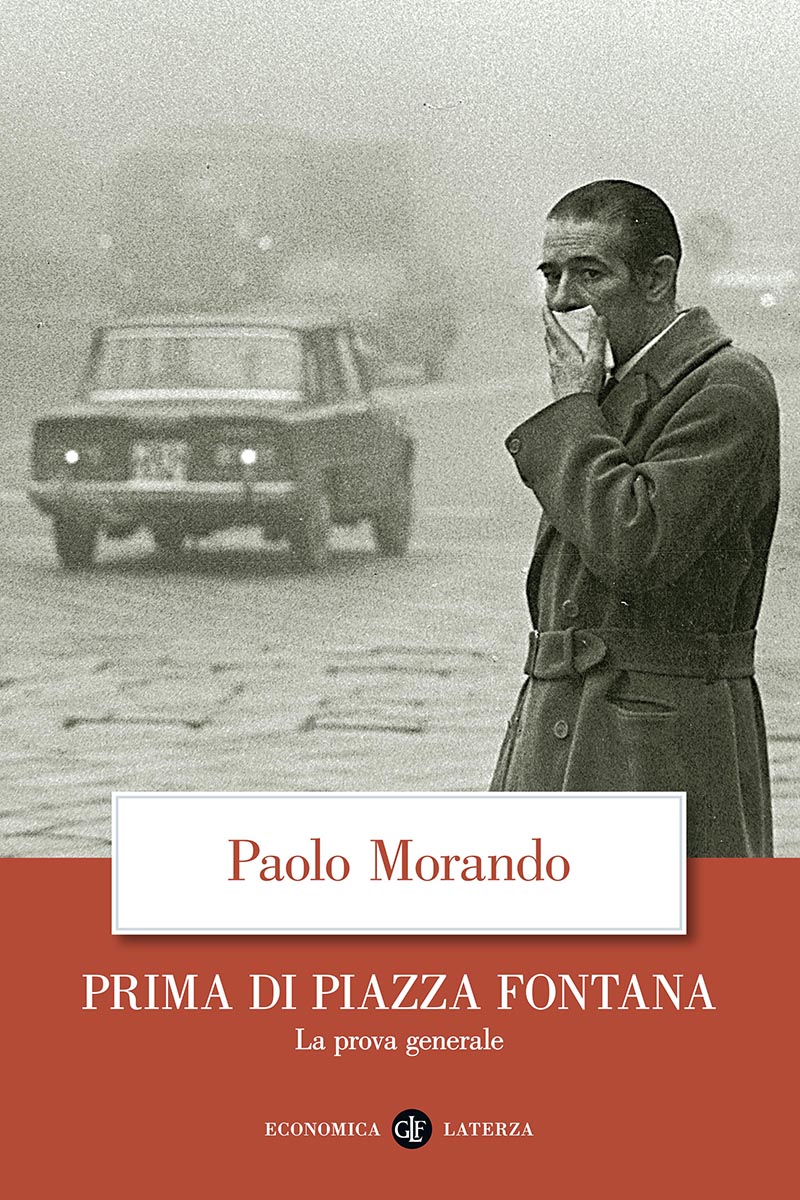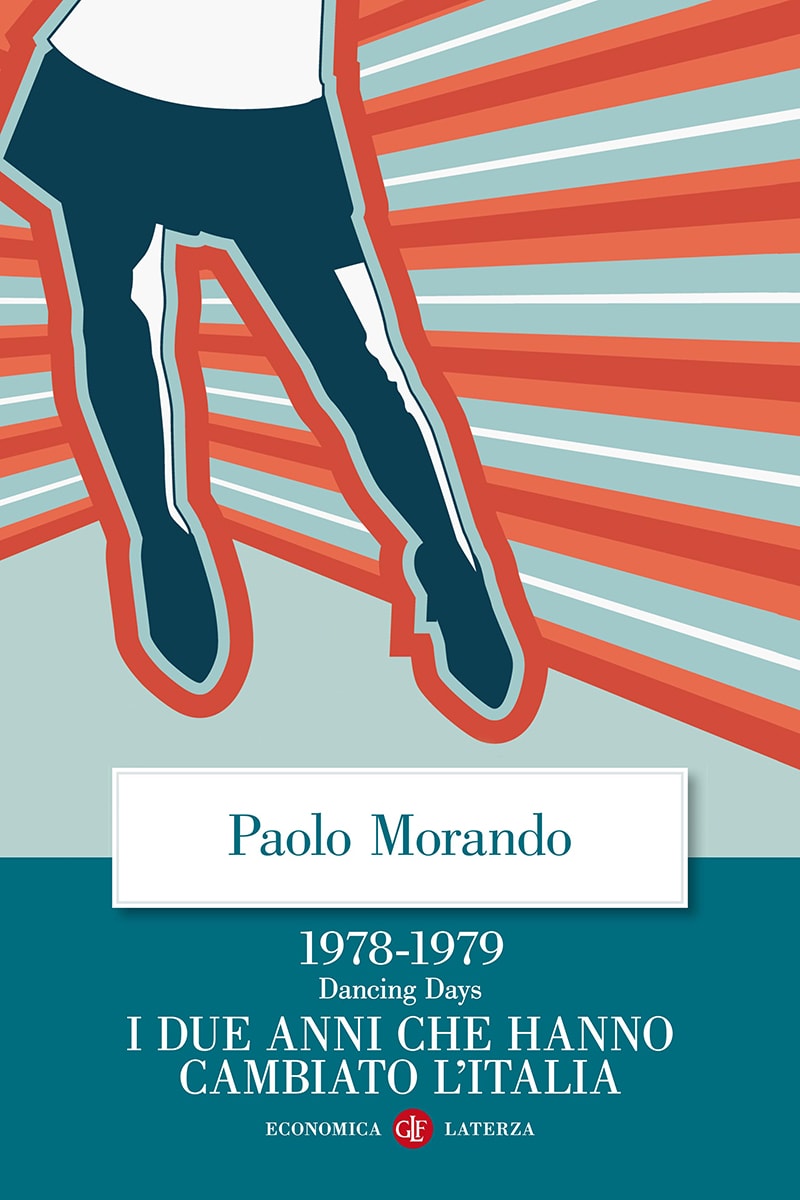Ricordati:
Se hai cinque lire, compera 5 lire di fiducia in te stesso.
Diffida dei facili entusiasmi.
Persevera nelle decisioni prese.
Credi solo ai fatti provati.
È il testo della targa che Eugenio Cefis
ricevette in regalo dallo studio legale
in cui aveva svolto la pratica di avvocato.
La conservò per oltre mezzo secolo.
Prima di morire la donò al nipote Lorenzo.
La magnifica ossessione
Scorro la chat di WhatsApp per cercare di capire quando tutto questo è iniziato e
la data è quella del 30 maggio 2019, un giovedì. «Con me, tu lo sai, scherzi col fuoco»,
scrivevo al mio amico Luca Dal Bosco nel pomeriggio. La mattina di quel giorno, al
bar per un caffè, Luca mi aveva travolto come mai aveva fatto prima, ma la ragione
la conoscevo bene: la sua ossessione per Eugenio Cefis, il braccio destro di Enrico
Mattei all’Eni, poi suo successore e da lì passato alla guida di Montedison.
Di Cefis e del mistero che circondava la sua figura parlavamo spesso, ma fino a quel
momento ero riuscito a non farmi trascinare: ossessioni ne avevo già abbastanza e
le vicende dei vari Pinelli, Valpreda, Calabresi, Freda, Ventura, Russomanno e della
sciagurata Zublena le infliggevo da tempo a chiunque, figli compresi. Dopo averne
scritto, finalmente libero dalle storie di quei fantasmi, non intendevo proprio imbarcarmi
subito in un altro viaggio del genere. Provai quindi a resistere a quella raffica
di nuovi link che mi arrivavano sul telefono. Ma non potevo ignorarli così: la polpa
c’era. O almeno l’odore della polpa.
«Non posso mettermi a pensare a un altro libro prima ancora che esca quello che ho
appena scritto...» era stato l’ultimo mio tentativo di sottrarmi. Ma un’ossessione,
se ben motivata come in questo caso, può essere contagiosa. E alle 17.20 avevo già
alzato bandiera bianca. Vedo infatti che in risposta all’arrembare di Luca digitai
queste precise parole:
Allora. Cefis è tema potenzialmente immenso. Immagino archivi da compulsare. E lo
escludo. Non ne avrei il tempo. Ma tutte le cose che dicevamo stamane sono già moltissimo.
Quello che immagino è un volo d’uccello su queste “emersioni” del lato nero di Cefis,
scendendo a fondo su ognuna, con solida documentazione. Per il libro sulle bombe del
25 aprile ho avuto la fortuna di incocciare negli atti processuali digitalizzati,
sennò non ne sarei mai uscito. E le interviste alla fine sono state poche. In effetti
ho scritto tutto in tre mesi. Forse si può fare.
«Daje» fu la sua risposta.
Quei link che Luca mi inviava in chat rimandavano a un surreale seguito del video
che mi aveva fatto vedere la mattina al bar, sul telefonino. Pensandoci bene, mi aveva
fregato già in quel momento. Anzi, Luca aveva iniziato a instillarmi il tarlo anni
prima. Vedo infatti che è del gennaio 2015 la mia prima mail al giudice Vincenzo Calia.
Mi aveva risposto, cortesissimo, spiegandomi che spesso per ragioni familiari saliva
a Trento, la mia città, da Genova, dove allora lavorava, e che quindi avremmo potuto
incontrarci facilmente. Bingo, ricordo d’aver pensato, questo è un segnale. Mi procurai
il filedella sua richiesta d’archiviazione del caso Mattei, che girai subito a Luca. Ma allora
l’ossessione del momento era un’altra, gli anni ’80, e sotto la cenere covava da sempre
quella di Piazza Fontana. Proprio per via delle continue iniziative legate al 50°
della strage, dopo il caffè e la chat di quel maggio del 2019, di Cefis io e Luca
non avemmo più il tempo neppure di parlare.
Fu solo a marzo 2020, nelle settimane del Covid, riprendendo letture interrotte, che
la partita iniziò a riaprirsi davvero. Alla fine di maggio i tempi erano maturi e
ricontattai Calia. Mi scrisse che frequentava ancora Trento: anzi, visto che il primo
lockdown era finito da pochi giorni, sarebbe salito di lì a breve. E così, la mattina
del 10 giugno, eccoci lì: Calia, Luca ed io seduti a un bar del centro storico, mascherine
in tasca o poggiate sul tavolino, a parlare di Cefis. Con la prima battuta del giudice,
all’appuntamento in piazza Duomo, che non ci aveva affatto sorpreso: «Quindi anche
voi state lavorando su Cefis? Ma il vostro è un libro oppure un film?».
Sapevamo che altri coltivavano la medesima ossessione. A febbraio del 2019 avevamo
infatti conosciuto Giuseppe Oddo, tre anni prima coautore di un libro sull’Eni. Eravamo
andati a Firenze, per seguire un seminario di due giorni organizzato dall’associazione
Libertà e Giustizia e dall’editore Chiarelettere intitolato Il potere occulto. Storia dell’anti-Stato in Italia. I temi c’erano tutti: da Mattei a Berlusconi, passando per lo stragismo di destra,
la P2, la mafia. Impressionante l’elenco dei relatori, coordinati da Sandra Bonsanti
e Stefania Limiti: Paul Ginsborg, lo stesso Oddo, Guido Salvini, Giovanni Tamburino,
Manlio Milani, Antonella Beccaria, Giuliano Turone, Davide Vecchi, Elisabetta Rubini,
Fabio Repici, Claudio Fava, Isaia Sales, Giorgio Galli, Leo Sisti, Davide Conti, Ilaria
Moroni, Antonio Padellaro, Nadia Urbinati e Corrado Stajano. Luca ne approfittò per
portarsi Oddo al bar e imbastire con lui un dialogo vertiginoso, chiedendogli poi
di presentarlo a Galli. Qualche settimana dopo eccoli entrambi, Luca e Oddo, nella
casa milanese del politologo, per una video-intervista che io avrei visto solo molti
mesi più tardi: ero ancora alle prese con Piazza Fontana e dintorni, Cefis doveva
attendere. Oddo avrebbe poi chiesto a Luca una copia di quel filmato, spiegandogli
che assieme a Riccardo Antoniani stava pensando a un lavoro su Cefis: un libro, un
documentario, forse entrambi. E appunto a loro aveva fatto riferimento Calia incontrandoci
a Trento.
L’editoria vive di ricorrenze. E nel 2021 sarebbe caduto il centenario della nascita
di Eugenio Cefis: buono spunto per tornare a parlarne, no? In fondo bastava tirare
i fili, riordinare quanto negli ultimi anni era stato pubblicato in più libri di cui
Cefis non era il focus. E da lì eravamo partiti, poco prima dell’incontro con Calia. Non troppi mesi dopo,
nell’autunno del 2020, mi è ricapitata per caso in mano la cartelletta in cui nella
primavera avevo iniziato a raccogliere il materiale fondamentale, nel frattempo finita
sotto caterve di altra carta. L’ho aperta, ho sfogliato i pochi documenti che conteneva
e ho pensato due cose: primo, sembrava passato un secolo; secondo, quanta strada avevamo
fatto. Il Cefis che usciva da quella cartelletta era davvero poca cosa, trita e ritrita:
quanto altro c’era da raccontare, quante interpretazioni andavano sfatate. Ma senza
fargli sconti.
I.
Lo stato delle cose
Sembrava logico partire dalla nascita, per poi seguirne la vita: allievo all’Accademia
militare di Modena, partigiano in Val d’Ossola, all’Eni prima braccio destro di Mattei
e poi suo successore. Nel 1971, dopo aver organizzato la “scalata” a Montedison con
i soldi dell’Eni, ne divenne presidente. Per anni era stato forse l’uomo più potente
d’Italia. Maniaco della riservatezza: le sue interviste si contano sulle dita di una
mano. C’è chi lo indica come mandante delle morti di Mattei, De Mauro e Pasolini.
Secondo un documento del Sismi, sarebbe il fondatore della P2. E sulle sue “tentazioni”
eversive si favoleggia da anni. La sua stella cadde nel 1977 quando a 56 anni, per
motivi mai del tutto chiariti, si dimise da presidente di Montedison e sparì dalla
scena, riparando prima in Canada e poi in Svizzera, c’è chi dice con 100 miliardi
di lire e per evitare un imminente arresto. E invece no, partire dalla nascita non
andava bene. L’inizio di tutto, per Luca e per me, era infatti la leggenda nera di
Cefis. Era quella ad ammaliarci e a spingerci ad analizzare ogni aspetto della sua
vita, scandagliare la rete a caccia di connessioni le più suggestive, accumulare (e
leggere) libri e libri su di lui e su quegli anni. Si doveva quindi mettere subito
le cose in chiaro: cari lettori, era l’idea, questo è il Cefis che per anni ci/vi
hanno raccontato. Andava fatto per chi non lo aveva mai sentito neppure nominare,
naturalmente. Ma anche – strada facendo iniziavamo a capirlo – per distanziarcene
il più possibile. Perché molte cose non quadravano.
Prima di tutto però il video, quello che Luca mi aveva fatto vedere sul telefonino:
sta lì su YouTube dal 30 aprile 2014 e in tutti questi anni, ad oggi (febbraio 2021),
ha collezionato circa 470 visualizzazioni, nessun commento e la miseria di due “like”.
Di quelle visualizzazioni molte sono tra l’altro di chi scrive: play, pause, stop,
e riplay, ripause, ristop. E poi ancora dall’inizio. Ma più spesso ripartendo da circa
metà, precisamente da 1’26” di 2’58” (tanto dura il filmato), quando compare una donna,
intervistata. Dopo aver letto la prossima pagina fatelo anche voi, cercate quel video
e guardatelo. Scoprirete una clamorosa violazione della prima regola dell’informazione
televisiva, che vuole l’intervistato in favore di camera. Ma in fondo c’era da aspettarselo.
Per grazia ricevuta
La ripresa è frontale sulla giornalista, sorridente, seduta a un tavolo con alle spalle
una finestra. Porge il microfono a una signora dai capelli bianchi seduta allo stesso
tavolo di spalle, non del tutto ma per tre quarti abbondanti: e infatti il primo piano
è tutto sull’orecchio sinistro della donna. È un servizio di VCO Azzurra Tv, dove
VCO sta per provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che documenta una collezione artistica
singolare come poche. La donna intervistata spunta nella seconda parte del filmato:
nella sua fresca (allora) nomina in un consiglio di amministrazione risiedeva l’interesse
giornalistico del servizio. Parlare di intervista, per la donna del cui viso si vedono
in pratica solo la punta del naso, un fior di labbra giusto un attimo e, ma solo a
tratti, mezzo occhio sinistro, è abbastanza improprio: il suo è infatti poco più di
un cameo, meno di trenta secondi. Nel corso dei quali, con una musica carezzevole
di sottofondo, pronuncia queste poche parole: «So che a Pallanza il Museo del Paesaggio
per mio padre era molto importante. Il fatto di poter collaborare attivamente, cosa
che non era stata possibile negli ultimi due-tre anni, sicuramente arricchirà sia
loro che noi». La giornalista la imbecca: «Intanto lei è entrata nel cda del Museo
del Paesaggio immagino proprio con questo obiettivo...». Risposta: «L’obiettivo è
sicuramente di cercare di valorizzare loro, di aiutarli a far vedere il loro patrimonio».
Punto.
1. Di padre in figlia
Gli intervistati di spalle, di solito, lo sono per motivi che hanno a che fare con
la necessità di tutelare le loro identità: collaboratori di giustizia, tipicamente,
magari con voce contraffatta, oppure testimoni di fatti oggetto d’inchiesta. E vittime
di violenza, minori e soprattutto donne. Non è questo il caso. Perché non c’è alcun
mistero da tenere nascosto, nessuna generalità da occultare per ragioni indicibili.
Più semplicemente, siamo forse di fronte all’abitudine alla riservatezza passata di
padre in figlio (anzi, in figlia). Il servizio di VCO Azzurra Tv, correttamente, svela
comunque fin dall’inizio di chi si sta parlando. Inizia così: «C’è un filo rosso che
lega Pallanza a Milano: Palazzo Biumi Innocenti a Pallanza e Casa Manzoni. Sono gli
ex voto, migliaia, della famiglia Cefis: più di 5 mila quelli donati al Museo del
Paesaggio nel 1996 da Eugenio Cefis ed esposti a Palazzo Biumi Innocenti. Una collezione
unica e straordinaria, purtroppo poco conosciuta, che oggi si vuole valorizzare anche
grazie all’impegno e al sostegno della figlia di Cefis, Cristina». Che appunto entrava
a far parte del cda del museo. Il tutto mentre le immagini scorrono dagli esterni
del museo ai suoi interni, con la telecamera che indugia sulle pareti che accolgono
generose decine e decine di quei quadretti che tutti almeno una volta abbiamo visto,
in chiesette o santuari, magari in vallette sperdute: quadretti curiosi, spesso coloratissimi,
di valore artistico in senso stretto magari risibile, ma certo toccanti nel raccontare
incredibili tragedie (incendi, frane, devastazioni le più varie) e ancor più incredibili
salvataggi per grazia ricevuta.
Il servizio prosegue spiegando che per anni il lago Maggiore è stato la seconda casa
della famiglia Cefis: «Eugenio Cefis poi è stato capo partigiano in val d’Ossola e
proprio il contatto con don Girolamo Giacomini, suo partigiano, lo ha portato a Verbania
e alla donazione al Museo del Paesaggio». Già, la Repubblica della Val d’Ossola: un’esperienza
seminale per il futuro capitano d’industria. Dopo l’8 settembre 1943 ci salì anche
questo don Giacomini, arruolato nel Corpo Volontari per la Libertà, raggruppamento
“Alfredo Di Dio”, divisione “Remo Rabellotti”: quest’ultimo era un giovane della divisione
“Valtoce”, fucilato dai nazifascisti a Ornavasso il 14 giugno del 1944. Sulle montagne
del Novarese don Giacomini, scomparso nel 1998 a 85 anni, fungeva da collegamento
tra i gruppi partigiani. E lì conobbe Eugenio Cefis: uomo che resterà per l’intera
propria vita legato ai compagni di battaglia. E che quando non saprà più dove accatastare
gli ex voto accumulati nei decenni, passionaccia tanto originale quanto non priva
di sottotesti, eccolo rivolgersi al sacerdote partigiano, dal 1958 al ’90 parroco
appunto a Pallanza.
Dal servizio di Azzurra Tv si apprendeva poi che gli ex voto finiti a Pallanza erano
solo una parte dell’immensa collezione di Cefis. Che alla figlia ne aveva infatti
donati numerosi altri. Ma pure questi sono a disposizione del pubblico (meglio: lo
erano), grazie alla Fondazione “Per Grazie Ricevute” animata proprio da Cristina Cefis.
Le riprese si spostavano infatti a Milano, nel palazzo dove visse e morì addirittura
Alessandro Manzoni. Qui, informava la giornalista, «fino al 20 dicembre [del 2014,
ndA] sarà visitabile a ingresso libero “Navigando tra gli ex voto”»: e si trattava di
una mostra di ex voto di stile “marittimo”, che riportano cioè ringraziamenti per
tragedie scampate in acqua. E intanto la telecamera si soffermava sulla rappresentazione
di una grazia ricevuta proprio sul lago Maggiore, il naufragio di una tipica imbarcazione
lacustre preda di onde enormi, con le vele flagellate dal vento e i remi ormai abbandonati
dalla moltitudine di navigatori. E davvero, a contarli tutti, sembra un barcone di
profughi disperati dei giorni nostri. Ma tutto era finito bene, grazie all’intercessione
della Madonna pure immortalata dal pittore, formidabile apparizione appollaiata lì
a sinistra su un albero. È una Madonna speciale: la Madonna del Boden nota anche come
“Madonna dei Miracoli”, il cui santuario si trova a Ornavasso. Il paese del martirio
del partigiano Rabellotti.
2. Il collezionista
Che Eugenio Cefis avesse il pallino degli ex voto si sapeva, nonostante la coltre
di segreto di cui amava circondarsi. Solo alla fine di marzo del 1999, però, la collezione
era stata svelata. Avvenne all’inaugurazione di una nuova sezione del Museo del Paesaggio:
un’ala opportunamente battezzata “della Religiosità”, dedicata proprio all’esposizione
permanente della collezione Cefis, con quasi 800 opere scelte. Le cronache della vernice
raccontano dell’apparizione del “donatore” in prima persona. Così Natalia Aspesi su
«la Repubblica»:
Un uomo di 78 anni, elegante nell’impermeabile chiaro stretto in vita nello stile
Humphrey Bogart, prestante, che allontana con grazia i fotografi intimoriti e gli
estimatori tuttora genuflessi. Gira per le sale compiaciuto, perché “tenevo i dipinti
accatastati e per la prima volta riesco a vederli bene, appesi alle pareti”.
E la scena va immaginata: quest’omone alto un metro e 88 che per decenni tutta la
stampa italiana ha inseguito, raramente fotografato, che di quella stessa stampa è
stato padrone temuto. Eccolo lì spiegare sorridendo che «subito dopo la fine della
guerra mi ero innamorato della pittura contemporanea italiana, avevo cominciato a
comprare dei Morandi, dei De Pisis. Poi divennero troppo cari per le mie tasche e
mi ricordai di una passione giovanile». Dove la credibilità di quel «troppo cari»
(e non per le cifre in loro stesse, ma per le disponibilità economiche del Cefis appassionato
d’arte) andrebbe presa non con le molle, ma proprio respinta al mittente.
Aspesi gli concedeva che sì, era possibile che la sua passione risalisse agli inizi
della sua carriera «di grande e invincibile manager di Stato, quando dovette sembrargli
indispensabile dare un segno di gratitudine al cielo dei potenti, per la valanga di
grazie ricevute, mentre i potenti terreni soccombevano travolti dalla sua inarrestabile
ascesa». Una gratitudine perfettamente rappresentata da «queste preziose testimonianze
di antichi e un tempo terrorizzanti incidenti da cui chi usciva vivo ringraziava le
madonne più clementi e i santi più salvifici». Ottime insomma per un Cefis «ritiratosi
dalla scena al momento giusto, nel 1977, quando l’intreccio talvolta criminale tra
finanza e politica e il grande saccheggio perpetrato dalla Montedison potevano diventare
ormai pericolosi per i suoi protagonisti». Già, la Montedison. Che non esiste più
da anni: precisamente dal 2002, quando ancora era il secondo gruppo privato italiano,
scalato dalla Fiat e dalla francese Edf che poi ne smembrarono le attività fino a
lasciare nella scatola svuotata giusto l’energia. Ora si chiama solo Edison S.p.A.,
come quella che tanti anni fa ne fu la madre (o il padre, a seconda di come si voglia
considerare la Montecatini), controllata però ancora dai francesi e dall’Aem, la municipalizzata
di Milano: fine ingloriosa per un marchio che ha segnato l’immaginario collettivo
della nazione, perché – con lievi modifiche – anche simbolo della catena di supermercati
Standa, appunto nel periodo di controllo Montedison (1973-1988), logo di distributori
di benzina, addirittura grido dell’italianità vincente nello sport quando compariva
sulle fiancate del Moro di Venezia di Raul Gardini nelle regate di America’s Cup.
Ma simbolo anche costantemente associato a scandali e mazzette.
Raccontò comunque Cefis, a quella inaugurazione, che la passione per gli ex voto gli
era nata durante la lotta partigiana in Val d’Ossola, tra uno scontro a fuoco e l’altro,
ammirando questi dipinti ingenui nelle chiesette di montagna. Una passione evidentemente
agevolata dalle ristrettezze di chi quei dipinti li custodiva: e infatti i preti «non
sapevano dove metterli, facevamo dei cambi. Io gli davo un’enciclopedia, una tonaca
nuova, quel che nella loro povertà gli mancava, e loro mi davano gli ex voto antichi,
per far posto a quelli nuovi, del dopoguerra. Poi hanno cominciato anche a regalarmeli,
un paio mi arrivarono da Giulio Andreotti». E per quei lettori all’insaputa di chi
fosse stato Cefis e che cosa avesse rappresentato, era la chiusa dell’articolo a dettagliarne
la potenza devastante. Mettendo in fila i suoi avversari in quella che fu la sua stagione
più gloriosa e controversa («sgominati Agnelli e Pirelli, accantonato Visentini, tacitato
Cuccia, conquistato Fanfani, allettato Rumor, Piccoli e anche De Martino, contattati
i comunisti») e restituendo per intero la vertigine della sua magnifica ossessione.
E si capisce che chi [quella collezione, ndA] l’ha messa insieme in anni e anni di ricerca l’ha fatto con passione, competenza
e virtù cristiane, mentre per collezionare prima l’Eni e poi la Montedison si era
servito soprattutto di virtù democristiane. Come era indispensabile in quegli anni
’60 e ’70, quando la guerra tra la borghesia di Stato e il capitalismo privato era
rovente. Erano tempi in cui probabilmente Cefis si rasserenava scovando in santuari
sperduti (in Italia ce ne sono più di 400) la tavoletta secentesca in cui il contadino
ringraziava per essere ancora vivo dopo essere stato travolto da un carro trainato
dai buoi, o quella della fine ’800 che testimoniava il miracolo del morente resuscitato
dopo l’estrema unzione. Per poi, confortato dalla benevolenza divina verso le disgrazie
della vita semplice, sbaragliare con la massima determinazione ogni ostacolo al suo
potere.
3. Refurtiva
Nell’ossessione per gli ex voto, Cristina Cefis era stata solida alleata del padre.
«Ricordo che da piccola m’accompagnava nei suoi giri, faceva dei cambi con i parroci,
i soldi per una tonaca, un aiuto per la parrocchia... – raccontò nel 2000 al «Corriere
della Sera» –. Il mio interesse è nato così, anche se la passione vera e propria è
iniziata quando ho cominciato a catalogarli sul computer: incidenti con carri e carrozze
sul lavoro, malattie, aggressioni, episodi marinari...». Un lavoro immenso, perché
la collezione era di quasi 7 mila pezzi. Che Cefis, come si è visto, donò in gran
parte al Museo del Paesaggio di Pallanza, mentre il resto rimase nella disponibilità
della figlia. Che tra il 6 marzo e il 1° aprile del 2001 ne espose parte a Milano,
nella sagrestia del Bramante al Convento di Santa Maria delle Grazie: a due passi
dall’Ultima cena di Leonardo da Vinci. Anni dopo, nel 2013, creò anche una Fondazione, la “P. G. R.”
(Per Grazie Ricevute) da lei stessa presieduta, per curare le numerose mostre che
si susseguirono puntuali. Fino al 15 giugno del 2016, quando i carabinieri entrarono
al civico 1 del palazzo di via Morone, al primo piano di Casa Manzoni, con in mano
un decreto di sequestro probatorio degli ex voto esposti nelle quattro sale. E con
essi, dell’intera collezione della Fondazione. Erano i carabinieri del Nucleo tutela
patrimonio artistico di Monza, coordinati dal pm Luigi Luzi. L’inchiesta era partita
da due denunce: una del 1994, l’altra addirittura di vent’anni prima, per un furto
in un santuario di Tolentino. Gli avvocati della Fondazione si videro poi respingere
per due volte la richiesta di dissequestro. La Cassazione sentenziò infatti che «almeno
195 delle tavolette votive sono risultate provento di furto» e che «nessuna delle
altre opere è accompagnata da documenti di riconoscimento». Neppure, pare, le tre
donate a Cefis da papa Paolo VI, che pure facevano parte della collezione sequestrata.
Tutti gli ex voto rimasero comunque a disposizione della Fondazione, individuata nel
decreto della Procura come custode, potendo quindi continuare ad allestire mostre.
Ma nel frattempo l’inchiesta procedeva. E pensare che era nata per caso, quando nel
2015 un carabiniere, passeggiando mentre non era in servizio, notò una locandina di
una mostra d’arte religiosa allestita a Casa Manzoni: stando al calendario delle esposizioni
riportato nel sito di “P. G. R.”, potrebbe trattarsi di quella intitolata “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”, che tra il 10 novembre 2015 e il 28 maggio 2016, nell’ambito
delle iniziative collaterali dell’Expo, contò ben 11.200 visitatori. Ma un carabiniere,
si sa, è tale anche quando è in borghese. Di lì l’intuizione. E quel carabiniere faceva
parte appunto del Nucleo tutela patrimonio artistico di Monza. Quattro anni dopo quell’intuizione,
il 9 aprile 2019, si capì quanto l’inchiesta era andata avanti. In sostanza, tutti
gli ex voto della collezione Cefis risultavano rubati o comunque di dubbia provenienza.
E andavano quindi tutti restituiti ai precedenti proprietari. Ma visto che nella stragrande
maggioranza dei casi risalire a chi fossero era pressoché impossibile, la decisione
fu quella di affidarli alle diocesi. Ecco perché la cornice della conferenza stampa
in cui venne illustrato l’esito finale dell’operazione fu l’Arcidiocesi di Milano,
in piazza Fontana, con consegna simbolica di una tavoletta a monsignor Corrado Sanguineti,
presidente della Consulta regionale lombarda dei beni culturali. Erano invece ben
594 quelle di provenienza messicana già tornate ai legittimi proprietari: scomparse
chissà quando, il 6 marzo erano state restituite dall’allora ministro per i Beni e
le attività culturali, Alberto Bonisoli, alla segretaria dell’omologo dicastero messicano,
Alejandra Frausto Guerrero, con una cerimonia ufficiale nella Sala della Crociera
del Ministero. Le “sottrazioni” in Italia erano avvenute negli anni ’60 un po’ ovunque,
da Nord a Sud: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sardegna e Toscana. Per imponenza del saccheggio spiccava quella al santuario
della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (Napoli), il cui priore, il domenicano padre
Alessio Romano, era pure presente alla conferenza stampa all’Arcivescovado. Ma anche
il santuario della Madonna della Civita di Itri (Latina) risultava particolarmente
colpito.
Era stato Eugenio Cefis? Oppure, più semplicemente, nel coltivare la propria passione
non si era curato di verificare la provenienza delle tavolette, affidandosi magari
a frequentazioni, come dire, disinvolte? L’inchiesta giudiziaria in effetti si chiuse
senza individuare alcun reato, con il collezionista passato a miglior vita nel 2004
e dunque non più perseguibile e i responsabili del Museo di Pallanza e di Casa Manzoni
estranei ad ogni responsabilità penale. Di tutto questo, a eterna memoria dell’ineffabilità
del nostro, resta il filmato della conferenza stampa all’Arcidiocesi tenuta dal colonnello
Alberto Deregibus, vicecomandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale. Pure questo è lì su YouTube, da allora: 12 minuti e 48 secondi in cui il
nome di Cefis, naturalmente, non viene mai pronunciato.
L’uomo nero
«È il ramsinga, il ramsinga dei thugs presso il baniano sacro», dice Belbo a Casaubon
in uno dei passaggi più esilaranti de Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, quando nascosti ai margini della radura osservano il rito propiziatorio
del contatto con le onde telluriche sotterranee che tutto determinano, officiato da
tre misteriose druidesse. «Sono le tre hallouines di Lisieux, di Clonmacnois e di Pino Torinese», li avverte ieratico Aglié, che li
ha condotti fin lì: e quel Pino Torinese dava la misura di quanto fosse grottesca
la situazione. Nel romanzo di Eco siamo alle prime mosse della costruzione del complotto
universale che perderà sia Casaubon sia Belbo, ma la scaltrezza ancora consente a
quest’ultimo di prendersi gioco delle altrui ossessioni occultiste: quel «ramsinga
dei thugs» infatti altro non è che una supercazzola alla conte Mascetti di Amici miei. E ci vorrebbe uno come Casaubon, quando leggi certe cose.
Più seriamente, parlare oggi di Eugenio Cefis ai millennials significa riavvolgere una matassa complicatissima. E infinita, perché dentro c’è
tutto: l’8 settembre, la guerra partigiana, la Liberazione dal nazifascismo, la ricostruzione
di un Paese devastato materialmente dalla guerra e spiritualmente da un regime ventennale,
l’invenzione di una politica energetica autonoma, la sfida alle “sette sorelle”, il
grande miracolo italiano, gli americani e i sovietici, la Dc e il Pci (e i fondi neri
per pagare un po’ tutti, eversori compresi), intelligence di tutti i colori, l’industria pubblica e privata, la stagione delle partecipazioni
statali, la scalata a Montedison, lo scontro con le grandi famiglie del capitalismo
italiano (Agnelli in testa), la “razza padrona”, i boiardi di Stato, l’assalto ai
giornali, la P2... E Cefis sempre lì, “grande vecchio” di tutto, snodo obbligato di
ogni groviglio, dall’alto del suo quasi metro e novanta: ben lontano dalle buche in
cui puntualmente finivano per inciampare tutti i suoi avversari. Fino alla sorprendente
decisione, nel 1977, di ritirarsi a vita privata lasciando l’Italia per il Canada
prima e la Svizzera poi.
Da allora la leggenda nera su Cefis è rimasta a lungo in naftalina, e si capisce:
lontano dagli occhi lontano dal cuore, si dice. E dagli occhi dell’opinione pubblica
il nostro non si è più fatto vedere. Letteralmente. Già di foto ne giravano pochine,
ma con l’avvento del digitale le già scarsissime immagini di Cefis si sono inabissate,
sostituite da quelle di nuovi protagonisti dell’economia e della finanza, ben più
disponibili di lui a farsi filmare, fotografare, intervistare. Per vedere confermata
la circostanza, basta fare una rapida ricerca su Google: dove digitando “Eugenio Cefis”,
tra l’altro, una delle prime immagini a spuntare è quella di un giovane Eugenio Scalfari,
suo acerrimo avversario. E arriva per giunta da un sito ufficiale del Comune di Domodossola,
dedicato alla Repubblica dell’Ossola, erroneamente associata alla scheda del partigiano
Cefis. Di video, poi, proprio non se ne parla. Ed è incredibile se si pensa al rilievo
pubblico dell’uomo per così tanti anni della nostra storia. Anche questa sua inafferrabilità
è parte della leggenda nera: se si nasconde certo ha qualcosa da nascondere, è il
ferreo ragionamento. E sarà anche così. Ma si dovrebbe pure fare i conti con un paio
di cose.
Primo: è assolutamente vero, comprovato dalle cronache di allora e dai racconti di
molti testimoni autorevoli che all’Eni con lui lavorarono, che Cefis non sopportava
la ribalta pubblica. Gli aneddoti sarebbero infiniti: basti quello relativo a «Il
Giorno», il quotidiano che era proprietà appunto dell’Eni, a cui Cefis praticamente
ordinò di citarlo sempre e solo come “il presidente dell’Eni” e mai con nome e cognome,
come se si trattasse di un’entità ultraterrena. Una spiegazione, raccontata dallo
stesso Cefis, risale tra l’altro all’Ossola e allo shock che ebbe quando vide il proprio
nome su un manifesto dell’esercito tedesco, ricercato e condannato a morte. Secondo:
se si vanno a sfogliare invece i giornali del periodo Montedison, quindi dal 1971
al ’77, soprattutto settimanali come «L’Espresso», «Panorama» o «L’Europeo», le foto
del nostro si sprecano, anche in copertina. Ma pure sui rotocalchi: come la «Domenica
del Corriere», che nel giugno del ’72 dedicò al nostro un ritrattone dove lo si definiva
«schivo per natura, vestito secondo uno stile inglese che lo porta a sgusciare tra
la folla in modo che la sua immagine sparisca un minuto dopo aver fatto la sua comparsa».
E con sommari («Perché viaggia su auto dal molleggio speciale», «Telefona anche di
notte per sapere notizie») pensati apposta per un pubblico popolare. D’altra parte
gli anni erano trascorsi e i giornali, arricchiti graficamente, si erano fatti più
spregiudicati. Senza dimenticare che quelli sono gli anni in cui Cefis è pure vicepresidente
di Confindustria.
Del fatto che quelle immagini oggi in rete scarseggino non si può certo imputare a
Cefis la responsabilità, se non nella misura in cui dal 1977 in poi i giornali hanno
smesso di occuparsi di lui. Provate oggi, su Twitter o Facebook, a buttar lì una sua
foto: tolti i cultori della materia, quanti ne saprebbero subito fare il nome? Quanti,
sulla base della propria anagrafe, riconoscerebbero un uomo scomparso dalle cronache
italiane quasi mezzo secolo fa e morto all’estero da tre lustri abbondanti? C’è però
un’altra questione, forse la più importante. Cioè l’attitudine, molto italiana, al
voler ricondurre a un unico burattinaio i fili di mille storie che si vorrebbero concatenate.
E quindi Andreotti, Gelli, Berlusconi... Riduzione della complessità, la chiamano
i sociologi, e in questo senso si tratta di uno strumento di sopravvivenza: immaginare
che dietro a infinite terribili vicende ci sia appunto un “grande vecchio”, o gli
inevitabili “poteri forti”, o una qualsiasi Spectre (la Trilateral, Soros e i suoi,
Big Pharma...), certo aiuta a farsi una ragione, una qualsiasi ragione, dell’inaudito.
1. Complotterie
Nel caso di Cefis l’uomo ci ha messo del suo, visto che architrave del sospetto sono
proprio i suoi rarissimi discorsi pubblici, tre in tutto (ma in questo libro ne scoprirete
un quarto). In particolare il primo: quello pronunciato nel 1972 all’Accademia militare
di Modena in cui, questa la lettura in sintesi più che estrema, prefigurava una visione
tecnocratica del potere e delle sue dinamiche, per giunta sposandola. Quindi, per
i tempi di allora in cui tutto veniva tagliato con l’accetta, una visione antidemocratica.
E dunque golpista, via. Lo stesso titolo di quella conferenza sembrava allora, e così
pure adesso, confermare la giustezza del sospetto: “La mia Patria si chiama Multinazionale”.
A leggerle oggi invece, quelle pagine – che vedremo nel dettaglio più avanti – più
che sinistre appaiono semplicemente preveggenti. Ma qui si aprirebbe subito una questione
enorme: visione profetica, e naturalmente criticabile, di uno che aveva un gran fiuto
oppure, attenzione, l’esposizione cinica di un piano che lui stesso stava portando
avanti sotterraneamente, assieme a chissà quali altre forze occulte? Peraltro, contrariamente
alla vulgata, il titolo della conferenza non era affatto quello. Il che almeno un
po’ dovrebbe cambiare le cose. Ma hai voglia, adesso, a rimettere a posto i cocci
dopo decenni in cui la costruzione del Cefis nero è proseguita mattone su mattone.
Tutto questo nulla toglie alla centralità del nostro nell’Italia della Prima repubblica,
anzi. Ma lo si è visto per tante vicende nere, una per tutte la strage di Piazza Fontana:
spesso serve il tempo della storia prima che i tasselli vengano messi almeno parzialmente
al loro posto, consentendo di mettere a fuoco connessioni fin lì solo intraviste.
A conferma della scia che nel 1977 Cefis si lasciò comunque alle spalle, di un sulfureo
mai dissoltosi compiutamente, vale la pena di citare questa parte della lunga intervista
che tra il 1994 e il 1995 Fabio Tamburini, allora inviato di «Repubblica» e oggi direttore
del «Sole 24 Ore», fece ad Aldo Ravelli, il “re Mida” della Borsa italiana, mito e
leggenda di Piazza Affari per generazioni di operatori. E in quanto tale custode di
segreti giocoforza inconfessabili. Non a caso il titolo del libro è Misteri d’Italia, prima edizione gennaio 1996: sei mesi dopo la morte dello stesso “Aldone”. Che fu
sempre uomo di sinistra. E non solo in quanto ex deportato a Mauthausen.
Tra i tanti misteri dell’era Cefis, uno risulta particolarmente indecifrabile. Perché
uscì di scena all’improvviso, lasciando l’Italia e quasi dissolvendosi? Ne sai qualcosa?
È una storia lunga, che potrebbe diventare la trama di un film, a metà tra il giallo
e l’avventura. Te lo dirò, un giorno. Conosco con precisione quello che è avvenuto.
Stavano per arrestarlo. E non per storie di tangenti ante litteram. I motivi erano
molto più gravi, importanti. Deve ritenersi fortunato che non l’abbiano fatto.
Quali erano i suoi rapporti con Fanfani?
Stretti, molto stretti. Secondo me, in quella primavera del 1977 stavano per arrestare
anche lui. Proprio nei mesi precedenti a quando Cefis annunciò l’uscita da Montedison.
Coltivavano sogni autoritari?
Non ti rispondo.
Chi era al loro fianco?
Ufficiali e generali dell’esercito. E poi una parte dei carabinieri.
Come fai a saperlo?
Uno di loro era mio amico. E me ne parlò.
Perché il piano fallì?
Fu merito di una sola persona: Agnelli Gianni, nemico di Cefis. Di questo, all’Avvocato,
bisognerà rendere merito.
Più avanti scoprirete di che razza di abbaglio si trattasse. Da allora comunque, ed
è passato un quarto di secolo, del presunto colpo di Stato Fanfani-Cefis non una parola
in più si è detta o è stata scritta: silenzio anche da Tamburini, benché sollecitato
via mail. L’unica replica, indiretta, è venuta dallo stesso Cefis, in una torrenziale
intervista rilasciata nell’autunno del 2002 a Dario Di Vico del «Corriere della Sera»
che la pubblicò il 6 e il 7 dicembre, ma per quanto riguarda questa parte si dovettero
attendere le due successive puntate sul «Corriere Economia» uscite nel maggio e giugno
2006. Cioè esattamente due anni dopo la morte dell’intervistato (ed era una delle
“regole d’ingaggio” del colloquio): articoli a tutta pagina in cui, lo stesso Di Vico
lo ammise, non vi erano rivelazioni clamorose. Però tanti aneddoti, tanti spunti.
E appunto la replica alle rivelazioni di Ravelli.
Nelle sue memorie l’agente di cambio Aldo Ravelli sostiene che lei lasciò la ribalta
perché temeva di essere arrestato.
Le rispondo che durante il periodo partigiano ho temuto molte volte di essere arrestato...
Non solo, ma anche di essere fucilato. Allora, almeno per quelli della mia età, esisteva
il solo partito fascista prima e fascista repubblicano poi. Ero in Jugoslavia a combattere
Tito, come ufficiale del secondo Granatieri di Sardegna ed avevo un attendente di
oltre 40 anni. Da lui per la prima volta sentii dire «sono comunista». Per noi la
politica non esisteva. Oggi non è più così. Comunque mi ritengo una persona aperta
alle idee degli altri, non sono una persona sempre sicura di essere il depositario
della verità rivelata. Una personalità assai diversa da come mi pare sia stata raccontata.
Finita la guerra feci praticantato dall’avvocato Rolle che usava raccomandarmi: «Cefis,
se hai cinque lire compra cinque lire di fiducia in te stesso».
Continua poi a perpetuarsi nella narrazione quella frase di Enrico Cuccia riportata
da Piero Ottone in un suo libro ancora del 1985, e da allora perennemente utilizzata
a riprova della pericolosità del nostro. Rivolto a Cefis, che gli comunicava la decisione
di ritirarsi e lasciare l’Italia, il banchiere di Mediobanca avrebbe detto così: «Questo
da lei non me lo aspettavo. Credevo che lei avrebbe fatto il colpo di Stato». Frase
che apre addirittura la pagina di Wikipedia dedicata al nostro ma di cui nessuno è
testimone, visto che il colloquio avvenne a quattrocchi, e che Ottone riporta de relato, attribuendola a un amico (anonimo) a cui lo stesso Cefis l’avrebbe successivamente
riferita. Amico che era probabilmente Francesco Micheli, già suo pupillo in Montedison:
«Più passa il tempo e più quell’esperienza mi sembra positiva – disse infatti nel
2009 a Paolo Madron in un’intervista pubblicata dal «Sole 24 Ore» –. Mi pesava di
più all’epoca, quando i miei amici della sinistra credevano che stessi aiutando Eugenio
Cefis a fare il colpo di Stato». Madron, stupefatto: «Come, scusi?». E Micheli: «Subito
dopo le sue clamorose dimissioni da Montedison, un Cefis sbalordito mi raccontò a
caldo la reazione di Cuccia che gli disse: “Ma dottore, io ero convinto che lei avrebbe
fatto il colpo di Stato...”». Di tutto questo, è stato sempre lo stesso Cefis a dare
l’“interpretazione autentica” (certo, a patto di credergli) sempre nell’intervista
con Di Vico di cui sopra.
Si racconta che Cuccia avesse detto «pensavo che Cefis facesse il golpe e invece se
n’è andato».
Venne a dirlo anche a me e io gli risposi «ma lei è matto. Quando e come le ha dato
la sensazione che stessi preparando un colpo di Stato?» A quanti andavano facendo
in Italia discorsi vagamente autoritari io replicavo di togliersi dalla testa che
da noi ci potesse essere un golpe appoggiato dall’esercito. È un paese lungo dalle
Alpi alla Sicilia e le poche divisioni efficienti che avevamo erano tutte su, ai confini
con la Jugoslavia. Ci sarebbero volute quattro-cinque settimane per concentrarle tutte
al Nord, se ne sarebbero accorti tutti. Sono cose da operetta.
Ma lei si è dato una risposta: come mai Cuccia la pensava così?
Forse pensava a un golpe non militare. Nemmeno Mussolini era riuscito a neutralizzare
l’establishment laico-massonico italiano, che per un lungo periodo aveva retto le
fila della finanza. Forse Cuccia pensava che potessi fare qualcosa di equivalente
in campo imprenditoriale. Tenga presente che lui era stato fuorviato dall’aver visto
in Africa muoversi l’Eni, con autorità e successo. Risultato: Cuccia mi ha detto che
l’avevo tradito. Mattei mi aveva detto lo stesso quando ero andato via dall’Eni, «è
come se mi avessero tagliato il braccio destro», affermò.
Avete letto bene? Tornate all’inizio della prima risposta di Cefis: «Venne a dirlo
anche a me». No, Cuccia lo disse solo a lui. Poi la cosa girò: grazie a Micheli, grazie a Ottone, oggi grazie a Wikipedia.
Finendo su decine di libri. Per poi tornare a Cefis, grazie a Di Vico. Capite il cortocircuito?
Per dire come una battuta in un colloquio privatissimo (avete mai letto un’intervista
di Cuccia? Avete mai assistito a una sua conferenza stampa?) sia potuta diventare
pietra angolare di una vulgata su cui gli elementi si sono poi stratificati. E la
morte di Cefis, eliminando il pericolo di querele da parte dell’interessato, ha ovviamente
facilitato la crescita del mito. Anche se c’è da scommettere che il nostro avrebbe
tranquillamente ignorato ogni cosa, figuriamoci: come aveva fatto per anni.
2. Derive
Gira anche la voce secondo cui furono Cefis e Italo Pietra, suo compagno partigiano
e poi direttore del «Giorno», cioè il giornale dell’Eni, a giustiziare niente di meno
che Benito Mussolini. È riemersa un paio d’anni fa, rilanciata in un quadro a tinte
foschissime a base di misteriosi simboli esoterici, ma che poggia essenzialmente su
quanto pubblicò quasi mezzo secolo fa una rivista di cui si è persa la memoria: secondo
«La Rivolta del Popolo», così si chiamava la testata, Cefis e Pietra obbedirono a
un ordine della massoneria inglese, che mise loro a disposizione 50 mila sterline
per rientrare dalla Svizzera e portare a termine la missione. A raccontare tutto questo
è Enrico Montermini, autore di Mussolini e gli Illuminati, che si giova in appendice di un sorprendente contributo del politologo Giorgio Galli,
con gli anni sempre più appassionatosi all’esoterismo. Non solo: l’autore ipotizza
un ruolo di papa Montini, allora segretario di Stato vaticano, come spia degli angloamericani.
Per poi affermare:
A riscontro di queste supposizioni vi è l’intera simbologia dell’esecuzione di Mussolini
e di Piazzale Loreto, che, come abbiamo visto, sono incentrate su un messaggio di
riconciliazione e di unificazione della Chiesa cattolica col mondo ebraico sotto l’egida
della massoneria. Non a caso uno dei significati del 12° Arcano è il sacrificio: ritorna
dunque il concetto di Mussolini scelto come vittima sacrificale di patti indicibili.
Ce lo conferma un testimone d’eccezione come Ezra Pound, che così descrisse, in termini
esoterici, quella misteriosa e macabra liturgia: «L’enorme tragedia del sogno sulle
spalle curve del contadino / Manes! Manes fu conciato e impagliato / Così Ben e la
Clara a Milano / per i calcagni a Milano / Che i vermi mangiassero il torello morto»
(Cantos, LXXIV, sez. Canti pisani). Secondo una tradizione gnostica diffusa a partire dalla seconda metà del XIX secolo
Manes sarebbe contemporaneamente Mosè (fondatore dell’Ebraismo), Gesù (Messia del
Cristianesimo) e Mani (fondatore del manicheismo): ecco quindi ritornare il simbolismo
del sacrificio e dell’iniziato, come pure l’idea di mixare tutti i culti in un’unica
religione universale.
Nella brama connettivista sfugge a Montermini quello che sarebbe stato un logico (si
fa per dire) proseguimento: l’uno e trino Manes come anche l’omonimo generale dei
carabinieri Giorgio, quello morto d’infarto poco prima di essere ascoltato da una
commissione parlamentare d’inchiesta e che nell’ottobre del 1966, nei propri diari,
scrisse del Sifar che effettuava intercettazioni telefoniche per conto dell’Eni (e
dunque di Cefis). Ma forse è meglio così. Perché il terreno come si vede è scivolosissimo:
già si è arrivati a Pound e da lì basta un niente per finire su un piano inclinato,
di quelli che portano dritti nel campo minato dell’antisemitismo. Lo dimostra il nome
del blog, che si tace per decenza, secondo cui Cefis sarebbe ebreo. Anzi, è: il condizionale,
quando le presunte connessioni sono più d’una, non serve più... E così capita di leggere,
a mo’ d’introduzione a uno sterminato dossier sul nostro, le seguenti parole:
Fin dall’inizio, quando abbiamo visionato a grandi linee la biografia di Cefis ci
siamo resi conto che era un ebreo, ce ne siamo accorti anche per la completa impunità
e il completo anonimato di cui per anni ha goduto. Sapevamo che quando avremmo letto
la sua biografia non autorizzata Questo è Cefis, scritta da un certo Giorgio Steimetz, avremmo trovato dei marcatori di ebraicità.
E infatti ne abbiamo trovati in abbondanza.
A Questo è Cefis arriveremo presto. Intanto, «marcatori di ebraicità» a parte, senza neppure scavare
troppo ci si può infilare in buchi neri ancora più vertiginosi, fino a ritrovarsi
addirittura dalle parti di Dallas, Texas, alle 12.30 ora locale di venerdì 22 novembre
1963: il giorno dell’assassinio del presidente Kennedy. Ricordate Clay Shaw, il Centro
Mondiale Commerciale, la Permindex? Anche il film di Oliver Stone JFK – Un caso ancora aperto vi si sofferma: erano tra gli elementi cardine dell’inchiesta shock del procuratore
di New Orleans Jim Garrison, finita peraltro nel nulla. Ora: a patto di calarsi nel
particolarissimo mood del genere, quindi ben al di là dei condizionali, saltando di nome in nome e di data
in data si può abbastanza facilmente collegare Cefis appunto alla faccenda Permindex,
come infatti in rete già è stato fatto. Il che, esattamente come la questione della
sua ebraicità, per molti è sufficiente a confermare senza necessità di ulteriori riscontri
quanto l’uomo avesse davvero un piede ovunque si tramasse nell’ombra. Lo scacco matto
complottista si perfezionerebbe poi aggiungendo il tenebroso particolare della partecipazione
di Cefis alle riunioni Bilderberg, addirittura alla prima che si tenne in Italia:
chi volesse farlo la troverebbe comunque ampiamente documentata sui quotidiani dei
primi giorni dell’aprile 1965, scoprendo inoltre che a Cernobbio tra i vari Agnelli,
Pirelli, il governatore della Banca d’Italia Carli, il presidente dell’Iri Petrilli,
i segretari di Dc, Pri e Pli Rumor, La Malfa, Malagodi e altri, di chi contava non
mancava nessuno.
La centralità luciferina del nostro sembrerebbe comunque ancor più dimostrata da un
testo sterminato a firma “Helter Skelter” (la canzone dei Beatles, o più probabilmente
nelle intenzioni di chi lo ha scelto citazione di Charles Manson e del massacro di
Bel Air) che ormai gira da un decennio in rete, citato da più parti. Sono decine di
pagine intitolate Ritratto di uomo in... “grigio”, e già qui si capisce che l’autore ne sa. Il riferimento è infatti a Pier Paolo Pasolini
e al suo Petrolio, di cui si riparlerà a breve: precisamente all’Appunto 22A quando a proposito di
Troya (appunto Cefis) il poeta scrive che «non ci teneva a primeggiare per primeggiare.
Era qualcosa di più che ambizioso. Non aveva dunque le debolezze degli ambiziosi:
la sua vita, il suo aspetto, il suo comportamento erano grigi o, per meglio dire,
ascetici». L’attacco del saggio promette bene:
Bisogna ammetterlo in assoluta tranquillità: il complottismo portato all’eccesso e
all’estremo non ha mai pagato e non pagherà mai, perché tenta nella quasi totalità
dei casi a far “entrare tutto” in una grande congiura ideata e portata avanti, magari
nei secoli dei secoli, da una tenebrosa e monolitica congrega che soggioga le masse
naturalmente ignare ed imbelli cercando di conferire a quel “tutto” i crismi della
plausibilità e della verosimiglianza.
Peccato che poi, passando in una cinquantina di pagine abbondanti per tutti i topoi della complotteria, tra cui la “pasolineide” oggetto del prossimo capitolo, si finisca
per approdare nei paraggi di Autonomia Operaia e al processo Metropoli, e da lì ovviamente
al caso Moro. Un triplo salto mortale grazie al trampolino del Cerpet, istituto di
ricerca economica e sociologica di area socialista fondato nel 1975, a cui a suo tempo
anche la Montedison di Cefis commissionò studi e analisi. Leggiamo.
Tanto per aggiungere illazione a illazione sulla base, però, di ragionevoli supposizioni
dedotte da elementi fattuali è veramente così peregrino pensare che i maggiori leader
del gruppo dell’“Autonomia” raccolto intorno alla rivista Metropoli conoscessero la
provenienza di determinati fondi (Montedison) che pervenivano al Cerpet, la perfetta
copertura dei rapporti fra il movimento e importanti esponenti del Psi? E che fossero
stati messi al corrente, magari proprio dagli stessi esponenti socialisti, che Cefis
costituiva la punta di diamante di una cordata di potere politica finanziaria massonica
– magari sostenuta generosamente da taluni ambienti americani (Gelli – Andreotti –
Sindona – Calvi)? E che, dopo aver appreso queste primizie, si sono adattati ad un
ruolo cucito su di loro per poi lanciare messaggi minacciosi in corrispondenza con
gli sviluppi della situazione politica italiana seguiti alla morte dell’onorevole
Moro? Restano le domande e rimangono le illazioni...
Appunto: illazioni. Sulla base, però, di «ragionevoli supposizioni dedotte da elementi
fattuali». E vabbè. A tutto questo aggiungete l’incessante attività via Facebook di
Rosy Mattei, nipote di Enrico, la cui pagina “Il caso Mattei” ogni giorno inonda il
web da un lato di foto e memorabilia dello zio, dall’altro di link ad articoli e commenti
a senso unico contro il nostro. Ecco perché per comprendere davvero la portata del
Cefis “uomo nero” è meglio riavvolgere la matassa con ordine, procedendo a ritroso:
partendo come nella fiaba dalle ultime briciole di pane.
Pasolineide
Cefis nel 1962 regista della morte di Enrico Mattei, per prenderne il posto e avviare
l’Eni lungo un percorso meno sgradito agli amici americani. Poi della scomparsa nel
settembre 1970 del giornalista Mauro De Mauro, che di quel misterioso incidente aereo
aveva scoperto i retroscena. Infine nel 1975 dell’uccisione di Pier Paolo Pasolini,
che in Petrolio, pubblicato postumo addirittura diciassette anni dopo la sua morte, stava per collegare
definitivamente Troya (Cefis) all’eliminazione di Bonocore (Mattei). Questo è il disegno
tracciato negli ultimi quindici anni e che ormai si è fatto vulgata. Lo svelamento
del disegno, avvincente, si è sviluppato articolandosi in una pubblicistica ormai
sterminata, ma che in sostanza poggia su un’unica gamba: le richieste del pubblico
ministero Vincenzo Calia in ordine al procedimento penale n. 181/84 mod. 44 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. La data sul frontespizio è
20 febbraio 2003, e va appuntata: perché è da quel momento che la leggenda nera di
Cefis inizia a farsi nerissima. Si tratta di 427 pagine corredate da altre 11 di Indice
dei nomi, come in un saggio fatto come si deve, e ben 42 (tra l’altro in chiusura,
dunque al momento di tirare le fila) sono incentrate proprio su Cefis.
Rifare qui un riassunto esaustivo del poderoso lavoro di Calia è impossibile. Basterà
dire che la presenza a bordo dell’aereo di un congegno esplosivo (e appunto esploso
durante il volo, poco prima dell’inizio della manovra di atterraggio a Linate) pare
inequivocabilmente provata. Così come la falsità di alcune testimonianze chiave di
chi, il contadino Mario Ronchi, la sera del 27 ottobre ’62 vide precipitare il Morane-Saulnier
pilotato da Irnerio Bertuzzi su cui viaggiavano Mattei e il giornalista americano
William McHale. Per non parlare naturalmente della palmare approssimazione con cui
vennero svolte in prima battuta perizie, indagine ministeriale e istruttoria giudiziaria.
Di tante circostanze successive che sembrano costituire elementi di un vasto depistaggio.
E del disinteresse in cui cadde questo appunto del Sisde, ritrovato proprio da Calia.
Datato 25 luglio 1979, ancora non fa il nome di Pasolini ma quello di un altro morto
ancora: il capo della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, ucciso appena quattro
giorni prima con sette colpi di pistola sparati alle spalle.
Si vocifera che il defunto V. Questore, Giuliano, si occupava, quasi a titolo personale,
cercando di evitare ogni indiscrezione, della scomparsa del noto giornalista Mauro
De Mauro, eliminato, si afferma, per aver trovato il bandolo della matassa sull’incidente
aereo che costò la vita all’On. Enrico Mattei. In proposito un Magistrato della Procura
di Roma, collegando l’intera vicenda, avrebbe confidato a persona amica che, secondo
il suo giudizio, l’eliminazione di De Mauro, dell’On. Mattei e del V. Questore Giuliano,
gli richiamerebbe il nome dell’ex Presidente della MONTEDISON, Eugenio Cefis.
Lasciamo da parte il caso Giuliano: che ad ammazzarlo fosse stato il mafioso Leoluca
Bagarella, allora ancora non si sapeva. Ma per il resto ce ne sarebbe abbastanza per
indicare Cefis come orchestratore di alcuni dei casi più controversi della storia
repubblicana. E qui è arrivato il momento di parlare del libro firmato Steimetz di
cui si è detto.
1. “Questo è Cefis”
L’inchiesta di Calia fu lunga e solitaria: il magistrato la aprì nel 1994 e la chiuse
nel 2003. E la stampa lo degnò di scarsissima attenzione, impegnata com’era ad attaccare
o difendere Silvio Berlusconi. In quei nove anni, a un certo punto, un’incredibile
coincidenza portò Calia a fermarsi a una bancarella in piazza della Vittoria a Pavia,
imbattendosi in un libro singolare e raro. Del “grande vecchio” quel libro riportava
bello grande in copertina il cognome e, rosso fuoco, addirittura il disegno del capo
glabro: Questo è Cefis, il titolo in grande evidenza, sottotitolo L’altra faccia dell’onorato presidente. L’autore, mai sentito prima, tale Giorgio Steimetz. Che nulla ha a che fare con
George Steinmetz, il fotografo americano quasi omonimo che, con i suoi scatti soprattutto
di Africa e di deserti dai quattro angoli del mondo, da anni appassiona i lettori
di testate come «New Yorker», «Time», «New York Times Magazine» e «National Geographic».
Peraltro Steinmetz, all’uscita del libro, era un qualsiasi quattordicenne di Los Angeles.
Ma la scelta di uno pseudonimo, per giunta così particolare, può portare alle supposizioni
più estreme. Giorgio Steimetz infatti in carne e ossa non esiste: è il nome-schermo
dietro il quale nel 1972 si è trincerato l’autore del pamphlet (perché tale è, e durissimo) contro l’allora presidente di Montedison, fresco di
passaggio dall’Eni. L’editore del libro invece esiste, ma per modo di dire: è Ami,
che sta per Agenzia Milano Informazioni, finanziata dall’Ente minerario siciliano
di Graziano Verzotto, in quel momento senatore della Dc dopo esserne stato segretario
regionale in Sicilia. E qui servirebbe un’ampia parentesi sul Verzotto in questione,
ma visti i mille link che andrebbero dettagliati si soffoca la tentazione per non
complicare la vita al lettore.
Due o tre cose però vanno dette. Ad esempio, che fu lui l’organizzatore dell’ultimo
fatale viaggio di Mattei in Sicilia. Poi, che prima di diventare rappresentante dell’Eni
nell’isola, ebbe anche lui un passato di partigiano “bianco”, nel Veneto dove nacque,
seppure con molte ombre di cui si parla in numerosi libri. L’ultima notazione ha invece
a che fare con il tentato sequestro di cui fu vittima il 1° febbraio 1975. E fu un
sequestro che non convinse nessuno. Se ne parla lungamente nelle motivazioni della
sentenza della terza sezione della Corte d’assise di Palermo sul caso De Mauro, che
nel giugno 2011 assolse Totò Riina dall’accusa di omicidio premeditato pluriaggravato
del giornalista, «per non aver commesso il fatto». Vi si legge infatti che già a suo
tempo l’istruttoria e il processo non avevano «affatto fugato il sospetto addensatosi
già all’indomani dell’aggressione all’ex senatore che quel maldestro tentativo fosse
in realtà una messinscena ordita dallo stesso Verzotto o con il suo assenso». Uno
dei presunti responsabili, condannato in primo grado ma assolto in appello, altro
non era poi che il suo segretario particolare: nella sentenza viene definito «sorta
di investigatore privato con compiti sia di intelligence – a uso privato – che di tutela della sicurezza personale». Verzotto dunque prima
partigiano bianco, poi uomo Eni, al pari di Mattei e Cefis. E chissà se il Troya pasoliniano
di Petrolio non gli debba qualcosa, visto che il segretario particolare di Verzotto, il suo uomo
per le “operazioni sporche”, quello coinvolto nel finto sequestro, si chiamava Alessandro
Troja.
Si diceva però dell’Ami: il libro firmato Steimetz altro non è che una carrellata
di servizi speciali diffusi dall’agenzia nel corso del 1971 (il primo è del 22 aprile,
titolo “Le due potenze occulte del pozzo d’oro nero”, quello finale del 18 dicembre,
“Ultimo round per il Ko”). Sono tutti incentrati su Cefis ed escono proprio nel periodo
in cui maggiori sono le polemiche attorno alla sua figura. Quelli sono infatti esattamente
i mesi del suo passaggio (che avviene a maggio) dalla guida dell’Eni a quella di Montedison,
cioè il colosso dell’industria e della finanza privata, bastione dei “poteri forti”
del capitalismo italiano, conquistato però grazie al capitale pubblico: appunto i
soldi dell’Eni. Sono 279 pagine che grondano pesante sarcasmo, fin dall’introduzione:
«Eugenio Cefis: un personaggio inquietante, integrazione perfetta del sistema. Sfrenato
nelle sue mire, freddo nella connessione scoperta dei suoi intrighi privati con gli
impegni della sua gestione pubblica». L’autore di quelle pagine è il giornalista Corrado
Ragozzino, titolare appunto dell’Ami, o così almeno si è sempre detto. Uno di coloro
che negli ultimi anni è andato a fondo nella “pasolineide” cefisiana, Riccardo Antoniani,
ricercatore al Dipartimento di Italianistica della Sorbona di Parigi, sostiene invece
che si tratti di Luigi Castaldi, pure lui dentro all’Ami ma soprattutto – pare – compagno
partigiano ai comandi di Cefis ai tempi dell’Ossola.
Lo si desume da una nota nella prima pagina della riedizione integrale di Questo è Cefis curata dalla critica letteraria Carla Benedetti, dell’Università di Pisa, e dall’editore
pavese Giovanni Giovannetti, la cui Effigie ancora nel 2010 ha finalmente rimesso
in circolazione il libro “maledetto” (ovviamente commentato sviluppi alla mano). E
con successo: è il long seller della casa editrice, più volte ristampato negli anni. Vi si cita appunto un testo
di Antoniani: Contro tutto questo, «in corso di pubblicazione in Francia». Ma ad oggi, e sono trascorsi dieci anni,
quella pubblicazione ancora non si è vista. «Quel libro è il mio Vietnam», spiegava
il suo autore nel novembre 2020, annunciandone però l’ormai imminente pubblicazione,
nel 2021: prima in Francia, tradotto dall’italiano, e poi anche da noi, probabilmente
nella seconda metà dell’anno, comunque prima del 2022 per non finire inghiottito nella
più che probabile congerie di pubblicazioni per il centenario della nascita di Pasolini.
Lì si conosceranno i dettagli su Castaldi, e molto altro. Le ricerche cefisiane di
Antoniani sono di lunga data e traggono origine dalla sua tesi di laurea su Petrolio. Oggi, dopo tanti incontri e letture, ecco l’immagine che si è fatto di Cefis che
consegna a chi scrive.
È stato uno dei protagonisti della nostra Prima repubblica. Per temperamento personale
teneva enormemente alla propria privacy, per ragioni che possono essere declinate
in tanti motivi, ma anche molto banalmente: perché in quegli anni, come ha ricordato
una volta lo stesso Cefis, anche della Ford o di una qualsiasi multinazionale non
si diceva quasi mai chi fosse il presidente. Cefis fu sicuramente un uomo di grandissima
statura in termini imprenditoriali: non si può pensare di riuscire a portare avanti
un ente come l’Eni tutti quegli anni senza avere della stoffa. Poi tutti i grandi
Belzebù d’Italia, da Andreotti in giù, hanno difeso la propria idea del Paese. E che
su questa idea si sia d’accordo o meno è un altro paio di maniche. Questo però non
giustifica assolutamente gli abusi del potere che sono stati commessi. Cefis era un
uomo estremamente ambizioso e, soprattutto, come ogni militare degno di questo nome,
ha capito quando la sconfitta era arrivata. Non a caso negli ambienti a lui vicini
si dice che il suo autentico capolavoro non fu la gestione degli enti che gli vennero
affidati, o di cui fu presidente, ma la sua uscita di scena.
2. “Petrolio”
Un passo indietro, torniamo a Petrolio. Quando nel 1992 venne pubblicato incompiuto e postumo da Einaudi, un po’ tutti si
chiesero se ne valesse la pena: «Un immenso repertorio di sconcezze d’autore, di un’enciclopedia
di episodi ero-porno-sado-maso, di una galleria di situazioni omo ed eterosessuali,
come soltanto dall’autore di Salò e le centoventi giornate di Sodoma ci si può aspettare», scrisse ad esempio un giornalista autorevole come Nello Ajello
su «la Repubblica», ma anche quei critici che preferirono volare più alto non nascosero
il proprio imbarazzo. E a rileggerle oggi, le articolesse dei vari Alberto Arbasino,
Lorenzo Mondo e addirittura Enzo Siciliano sorprendono per presbiopia: altro che la
struttura sconclusionata, altro che la gang bang sul pratone della Casilina, la polpa del libro era ben visibile a occhio nudo. L’Appunto
22A per dire si apre così:
Troya emigrato a Milano nel 1943, fu colto non inaspettatamente preparato alle proprie
scelte, a quanto pare, dalla fine del fascismo e dall’inizio della Resistenza. Partecipò
infatti alla Resistenza (questo, come vedremo, costituisce lo scandalo). C’era una formazione mista degasperiana e repubblicana (il misto cominciò subito, come si vede), che lottava sui monti della Brianza. Il capo di quella
formazione partigiana era l’attuale presidente dell’Eni, Ernesto Bonocore. (Sia Troya
che Bonocore, come il lettore avrà notato, non sono due cognomi settentrionali: si
trattava effettivamente di immigrati. Quelle che erano settentrionali erano le madri:
una certa Pinetta Springolo di Sacile, per Troya, e una certa Rosa Bonali, di Bascapè
(xxx), per Bonocore.) [...] La cosa che vorrei sottolineare è la seguente: Troya nella
formazione partigiana era secondo. E la cosa pareva gli si addicesse magnificamente fin da allora. [...] Dunque, Troya
è attualmente vicepresidente dell’Eni. Ma questa non è che una posizione ufficiale,
premessa per un ulteriore balzo in avanti dovuto non tanto a una volontà ambiziosa
quanto all’accumularsi oggettivo e massiccio delle forze guidate da tale volontà.
La vera potenza di Troya è per ora nel suo impero privato, se queste distinzioni sono
possibili.
Si proseguirebbe anche a lungo, ma è già abbastanza così. Perché questo solo passo
ci dice che non era poi così difficile identificare i due. E invece fino al 2003 nessun
lettore (e nessun recensore all’uscita nel ’92, a meno di ipotizzare una ben orchestrata
manovra editoriale e giornalistica) capì quello che i familiari e gli amici più stretti
di Pasolini avevano sempre saputo: e cioè che dietro i nomi dei protagonisti del libro,
Aldo Troya ed Ernesto Bonocore, si nascondevano Cefis e Mattei. E che quello era il
cuore nero di Petrolio. Il primo a intuirlo fu appunto il giudice Calia, incrociando il libro di Steimetz,
e verificando che suoi interi passi erano finiti dritti nel manoscritto pasoliniano.
Anche all’atto del deposito delle sue conclusioni, e siamo a settembre del 2003, la
cosa passò del tutto inosservata, così come era avvenuto per un articolo del sempre
puntuale Filippo Ceccarelli su «La Stampa» del 20 gennaio 2001, in cui il link Petrolio-Mattei-Cefis veniva per la prima volta segnalato. Fu però solo nell’agosto 2005,
in L’eresia di Pasolini, che il poeta e critico letterario Gianni D’Elia sganciò la bomba. Così:
Secondo il giudice Vincenzo Calia, che ha indagato sul caso Mattei, depositando una
sentenza di archiviazione nel 2003, le carte di Petrolio appaiono come fonti credibili di una storia vera del potere economico-politico e dei
suoi legami con le varie fasi dello stragismo italiano fascista e di stato. In particolare,
acquisiti agli atti, tutti i vari frammenti sull’«Impero dei Troya» (da pagina 94
a pagina 118), compreso il capitolo mancante Lampi sull’Eni, che dall’omicidio ipotizzato di Mattei guida al regime di Eugenio Cefis, ai “fondi
neri”, alle stragi dal 1969 al 1980, e ora sappiamo fino a Tangentopoli, all’Enimont,
alla madre di tutte le tangenti. Troya è Cefis, nel romanzo dal passato antifascista
macchiato, e dunque ricattabile, morto nel maggio 2004. Calia ha scoperto un libro,
che è la fonte di Pasolini, un libro nato dai veleni interni all’ente petrolifero
nazionale pubblicato nel 1972 da una strana agenzia giornalistica (Ami), a cura di
un fittizio Giorgio Steimetz: Questo è Cefis (L’altra faccia dell’onorato presidente). Pasolini ne riporta interi brani, ne rifà la parafrasi. Forse, aveva capito troppe
cose. Il lavoro di Calia è agli atti: il mandante possibile è in Petrolio.
Non era una boutade, perché Petrolio parla spesso fin troppo chiaro: in un passo si legge infatti che Troya «sta per essere
fatto presidente dell’Eni: e ciò implica la soppressione del suo predecessore (caso
Mattei cronologicamente spostato in avanti)». E poco dopo si legge che quello stesso
Troya «sta per essere fatto presidente della Montedison». Benché con trent’anni di
ritardo rispetto a quando Pasolini lavorava alla sua opera più ambiziosa, la falla
nella diga si era dunque aperta. Il primo a infilarvisi fu Paolo Di Stefano, che sul
«Corriere della Sera» diede conto del lavoro di D’Elia partendo appunto dalla sua
rivelazione. Poche settimane dopo, ecco su «Micromega» un lunghissimo articolo-saggio
di Gianni Borgna e Carlo Lucarelli (Così morì Pasolini) che, riallineando tutti i misteri del delitto all’idroscalo di Ostia Lido, dettagliava
ancor più la connessione tra Pasolini e Steimetz. Quattro mesi dopo il libro di D’Elia,
la riedizione di Petrolio negli Oscar Mondadori restituiva a Steimetz ciò che era di Steimetz. In uno scrupoloso
apparato di note, in cui Silvia De Laude aggiornava e ampliava quello curato nel 1998
assieme a Walter Siti per la monografia dei “Meridiani” su Pasolini, si risolvevano
finalmente i nodi filologici della questione, svelando tra l’altro che il poeta voleva
utilizzare nella propria opera, esattamente a metà racconto, tre rarissimi discorsi
pubblici di Cefis: a partire naturalmente da “La mia Patria si chiama Multinazionale”,
perché quello era il titolo con cui già era stato “fissato” da «L’erba voglio», la
rivista bimestrale dello psicanalista Elvio Fachinelli che lo pubblicò come “supplemento
pedagogico” al proprio numero di luglio/agosto 1972.
Non è il caso di riproporre qui l’analisi passo passo dei due libri in parallelo:
c’è da tempo un corpus imponente di opere che ne hanno sviscerato tutti i passaggi
più oscuri (e sono molti), a partire appunto dalla riedizione integrale di Questo è Cefis. Per non parlare del già citato D’Elia, che alle “profezie” di Pasolini suggerite
da Steimetz da anni si è applicato con rigore. Va detto invece che Questo è Cefis è un libro di culto non solo per i suoi contenuti scottanti nei confronti dell’allora
fresco presidente di Montedison o per via di come, oggi, è stato messo correttamente
in relazione con Pasolini e Petrolio. Lo è soprattutto per la sua rarità, visto che dell’originale girano pochissime copie,
poiché scomparve improvvisamente appena uscito. E il motivo, si dice da anni, è che
quasi certamente fu proprio Cefis a far rastrellare tutte quelle in circolazione,
forse per distruggerle in un fuoco purificatore. Al punto che non ne sopravvivono
esemplari neppure nelle due sedi di Roma e Firenze della Biblioteca Nazionale Centrale,
che istituzionalmente conservano copia di qualsiasi pubblicazione venga stampata in
Italia. Chi ne ha una, oggi se la tiene stretta. Ed è disponibile a cederla (tipicamente
su eBay) solo per svariate centinaia di euro.
La morbosità nel frattempo è però scemata, visto che solo pochi anni fa il valore
non scendeva sotto al migliaio di euro. E da tempo non si vedono spuntare esemplari
caratterizzati da una ulteriore rarità: è quella segnalata da Simone Berni, punto
di riferimento di tutti i bibliofili italiani, che nel suo “Manuale del cacciatore
di libri introvabili” intitolato Questo è Berni, con copertina mutuata ovviamente da Questo è Cefis, rivela che il libro (o almeno parte delle copie, probabilmente quelle di una seconda
edizione) conteneva anche una “cartolina editoriale” con questa scritta:
Gentile Signore,
se Lei conviene con noi che la verifica formulata dal nostro libro sui casi di malcostume
e sui sistemi del sottobosco corrente meriti adesione non soltanto formale, e possa
anzi investire più alte e determinanti censure, spedisca questa cartolina in busta
chiusa. Sarà una testimonianza e un gesto di coraggio: presenza consapevole e coerente.
Le siamo assai grati per la comprensione.
Edizioni Ami
E a fianco l’indirizzo a cui spedire la cartolina: «Chiarissimo Signor Procuratore
Generale della Repubblica – Palazzo di Giustizia – Piazzale Clodio – Roma». Sul retro,
accanto allo strillo «Anche lei – con noi – per una protesta: civile e doverosa, concreta
e responsabile» (in originale tutto in maiuscolo), la lettera già pronta per l’invio,
da sottoscrivere con firma e indicando le proprie generalità precise, così come l’indirizzo
per esteso.
Signor Procuratore, ho letto il libro «Questo è Cefis». Delle due, o il signor Cefis
è stato oggetto di meschine e artificiose calunnie, o le notizie (e le denunce) ivi
contenute presentano validi motivi di inquietante attualità. Il silenzio su questo
caso avvalora piuttosto la seconda supposizione. Mi unisco allora a quanti Le chiedono
di occuparsi di così sconcertante situazione, nell’interesse della verità.
Il che, mettetevi nei panni dell’allora presidente di Montedison, era un eccellente
motivo per decidere di rastrellarne il maggior numero di copie possibile: più che
il libro, di per sé un centone di faticosa lettura e ben distante dagli standard di
qualità e profondità degli autentici pamphlet, forse il vero pericolo erano proprio quelle cartoline. Comunque un po’ sorprende
che Pasolini sia rimasto abbagliato dal cumulo di allusioni spazzatura contenute in
Questo è Cefis, frutto velenoso di una stagione italiana ancor più velenosa: la guerra della chimica
in cui a chi scriveva certi libri (o li commissionava) premeva più che altro minacciarne
l’uscita, per mettere sotto scacco il protagonista di turno. Cefis in questo caso,
ma anche il suo avversario Nino Rovelli un paio di anni dopo, pure lui irriso e sepolto
di illazioni in Il malaffare di un Diego Monteplana inesistente come le Edizioni Everest responsabili della pubblicazione
(pure questa scomparsa nel nulla, benché le copie d’obbligo risultino depositate nelle
Biblioteche nazionali). Libri come armi di ricatto, agenzie come l’Ami di Verzotto
(e pure Roma Informazioni, altra emanazione verzottiana, con l’opuscolo L’Eni da Mattei a Cefis) che informavano solo i loro abbonati e da cui i giornalisti “veri” si tenevano ben
lontani. Non a caso Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, che in Razza padrona a Cefis non risparmiarono nulla, ignorarono bellamente Steimetz. Che invece folgorò
Pasolini. E con lui oggi schiere di pasoliniani: una quindicina d’anni fa, infatti,
Questo è Cefis fu perfetto per rilanciare la tesi del poeta ucciso perché sul punto di svelare l’indicibile.
Tesi solida, viste le manchevolezze della sentenza che condannò il solo Pino Pelosi.
Che quell’indicibile riguardi però Cefis, non è dimostrabile. Così come altri scenari:
l’ultimo sviluppo, per dire, colloca senza dubbio alcuno il movente del delitto tra
strategia della tensione e dossieraggio ai danni di un potente Dc come Mariano Rumor.
Ma da qui al 2022, centenario della nascita di Pasolini, c’è da scommettere che altri
ne spunteranno.
3. “L’uragano Cefis”
Un libro come Questo è Cefis non poteva sfuggire all’ossessione di un bibliofilo particolare: Marcello Dell’Utri,
altra figura che da sola meriterebbe un libro intero. Ma sulla sua parabola dai campetti
palermitani della Bacigalupo ad Arcore, con al seguito lo “stalliere” Vincenzo Mangano,
fino alla gloria di Publitalia, alla fondazione di Forza Italia, al Senato (dove in
dieci anni mai ha presentato un disegno di legge come primo firmatario) e alla condanna
definitiva per cose di mafia e al carcere, schiere di giornalisti si sono già esercitati.
Qui l’ex senatore interessa solo per quanto avvenne nel marzo del 2010, quando annunciò
che alla Mostra del libro antico di Milano avrebbe esposto il “Sacro Graal” della
“pasolineide”: cioè “Lampi sull’Eni”, che di Petrolio è il famigerato “Appunto 21” mancante. Mai scritto, sembrerebbe, poiché l’originale
rinvenuto tra le carte del poeta dopo la sua morte consiste in un foglio bianco riportante
solo il titolo, ma la cui esistenza sarebbe invece dimostrata da rimandi a quella
stessa parte contenuti altrove nella bozza. Un giallo mai chiarito e che appassiona
da anni storici e filologi, per non parlare della diatriba che sul punto da sempre
divide gli stessi eredi del poeta. E forse se ne saprà di più con la prossima riedizione
Garzanti di Petrolio sempre a cura di Walter Siti: era attesa per la primavera 2021, ma uscirà invece
nel 2022, centenario della nascita del poeta. E già si sa che dovrebbe includere i
tre discorsi di Cefis.
Già dieci anni fa dunque Dell’Utri affermava di avere l’Appunto 21, però dicendo e
non dicendo come ne era venuto in possesso. E di lì al reato di ricettazione il passo
sarebbe stato breve. Sta di fatto che alla Mostra del libro non se ne vide mai traccia,
con spiegazioni poco plausibili circa l’apparizione/sparizione: ad esempio, per sostenere
di averlo realmente visto e sfogliato, l’affermazione che il titolo effettivo era
“Lampi su Eni”. In esposizione nelle vetrinette dellutriane era invece spuntata una
copia di Questo è Cefis. E un altro libro mai visto né sentito prima: L’uragano Cefis, edito da tale Egr, firmato Fabrizio De Masi con presentazione di Pier Crescenzi,
tutti nomi paravento. Una sorta di “gemello” successivo di Questo è Cefis di cui Antoniani, sul «Sole 24 Ore» del 1° giugno 2014, ha scritto così:
Dissacrante e denigratorio come il libro del ’72, Uragano illustra «la storia mediocre di un uomo mediocre, un’indagine spietata del Sistema-Cefis
che non lascia adito a interrogativi inevasi, per un giudizio quasi definitivo in
un processo a porte spalancate». Parimenti a Questo è Cefis, di Uragano sparirono – se mai arrivarono – le copie d’obbligo presso biblioteche nazionali;
ma diversamente dal testo di Steimetz, non n’è rimasta traccia negli archivi dei nostri
Servizi. Ignoto perfino alle stanze montedisiane, verosimilmente del libro di De Masi
fu stampato solo qualche esemplare. Uragano non reca data, ma fu scritto plausibilmente agli inizi del 1975. Nel capitolo dedicato
alle incursioni cefisiane nell’editoria, si denuncia l’assalto al Corsera in cui furono
trascinati, dal luglio 1974, i Rizzoli.
Il virgolettato di L’uragano Cefis riportato da Antoniani è parte del breve testo della quarta di copertina. Per chi
volesse consultarle, le 318 pagine del libro firmato De Masi sono comunque ancora
tutte lì a Milano, alla Biblioteca di via Senato: il sequestro giudiziario cui erano
sottoposte, nell’ambito di un’inchiesta apertasi proprio in seguito all’annuncio di
Dell’Utri sull’Appunto 21, non le riguarda più. E infatti c’è chi le ha fotografate
una per una. Lo ha fatto un paio d’anni fa Salvatore Diodato, videomaker abruzzese pure lui folgorato dall’ossessione pasoliniana: da tempo infatti progetta
un documentario con al centro “Lampi sull’Eni”. Nell’autunno 2020 le ha poi messe
a disposizione di Giovanni Giovannetti, conosciuto leggendone il recente e monumentale
Malastoria. L’Italia ai tempi di Cefis e Pasolini, oltre 700 pagine di scavo sul rapporto a distanza tra il Dottore e il Poeta, in
relazione all’incompiuto Petrolio ma con sullo sfondo l’intera storia del Paese nel secondo dopoguerra. E da Giovannetti,
che già sta pensando di pubblicarle come fece per Questo è Cefis, quelle pagine sono arrivate a chi scrive.
Dopo una lettura faticosissima, l’impressione è netta: anche quel libro era un’arma
di ricatto, anzi molto più di quello firmato Steimetz. Lo stile, allusivo e pesante,
è il medesimo. La mole di dettagli sulle attività private di Cefis (nomi, sigle, date,
cifre) è però impressionante, frutto di un certosino lavoro di documentazione su atti,
come ha scritto Antoniani, di archivi tributari e tribunali. Ma anche uffici dell’Anagrafe,
del Catasto, tutta insomma roba solida. Più che nelle venti pagine del sesto capitolo
intitolato “Le evasioni del gran metanista”, comunque, il ricatto sembra stare altrove.
Si deve infatti tornare al terzo, “La costellazione familiare”, in particolare al
paragrafo “Rosei mediocri risvolti d’un inatteso femminino”. Qui De Masi, in due paginette
francamente rivoltanti, racconta infatti di una amante di Cefis: senza farne il nome,
è vero, ma i dettagli sciorinati senza freni l’avrebbero resa allora perfettamente
riconoscibile, benché non si trattasse di un personaggio pubblico. E pure oggi, senza
troppi sforzi, anche chi scrive potrebbe risalirne al nome. Il tutto poi scritto con
finto fare paternalistico, per giunta ironizzando sulla figura della moglie di Cefis,
Marcella Righi. Figuratevi il nostro, con la sua ossessione per la riservatezza. E
ovviamente a prescindere dalla fondatezza del racconto.
Visto che il libro come fonte di per sé non esiste, nel senso che mai è stato pubblicato
e distribuito, si può supporre come fa Antoniani che le copie effettivamente realizzate
furono pochissime: giusto quelle che servivano per sottoporle all’interessato, ricavandone
quanto desiderato in cambio della mancata stampa. Oppure, sub ipotesi, che prima della pubblicazione Cefis sia venuto a sapere di quanto stava
per finire nelle librerie, muovendosi come sapeva per bloccare il tutto. E in entrambi
i casi, chi al suo posto non l’avrebbe fatto? A suo modo però L’uragano Cefis è utilissimo per mettere finalmente a fuoco un punto fondamentale e mai spiegato
delle vicende cefisiane, su cui si specula da decenni: da questo punto di vista è
quasi un peccato che solo ora lo si sia potuto leggere. Il libro mai diventato tale
chiarisce infatti che la fortuna personale del nostro, le sue ricchezze, i suoi interessi
privati su cui tanto si è favoleggiato, avevano un’origine davvero banale: tutto proveniva
dalla moglie. In tre fitte pagine, De Masi elenca infatti l’intero patrimonio di Antonio
Diana, industriale di Lesa (Novara), nonno di Marcella Righi, a partire dai terreni
del “Prato Buono” di Milano, acquistati nel 1907 e di lì a pochi anni formidabile
area orientale di espansione immobiliare (siamo tra viale Corsica e viale Argonne).
Fra il 1936 e il 1937 muoiono uno dopo l’altro Marcello Righi, cioè il padre di Marcella
(aveva sposato Jole Diana, terzogenita di Antonio), lo stesso capostipite Antonio
e sua moglie Edvige Riva. Conseguenza: patrimonio ereditato dai tre figli. A Jole
vedova Righi, che già di suo possedeva case, negozi e pure un’industria di garze,
vanno in particolare un appartamento a Milano, una villa a Lesa, un bel pacchetto
di azioni Saffa (la storica azienda che produceva fiammiferi) e numerosi altri titoli.
In più la quota parte di interi palazzi già costruiti in “Prato Buono”.
De Masi annota poi l’esistenza di una procura, stesa davanti a un notaio, tale Quadri:
a Cefis, a quel punto già marito di Marcella Righi, tale documento consentiva «di
amministrare incondizionatamente i beni presenti e futuri, mobili e immobili della
suocera, tanto suoi che in compartecipazione, con autorizzazione alla procura generale,
a farne nome e vece in ogni atto o pratica». Per avere un’idea del valore dei terreni
di “Prato Buono”, e dunque dell’arricchimento di Cefis e della moglie, basta leggere
alle pagine 69 e 70, partendo da una cessione di 10.227 metri quadri avvenuta il 22
marzo 1951:
Antonio Diana, per stabilire un raffronto possibile, nel 1907, esattamente il 31 gennaio,
aveva pagato quel terreno L. 1,29: ora ne viene alienato poco più di un ettaro a 6.400
lire circa il metro. Una lettera, nel 1907, si spediva con 20 centesimi; nel ’51,
con 20 lire: se il parallelo tiene, il prezzo per mq. pagato dal vecchio Diana corrisponde
a lire 130 del ’51. La rivalutazione rende nettissima l’impronta dell’affare colossale.
Nel ’56, 7.500 metri passano al Comune di Milano per 215 milioni; una terza nel ’57
alla “Immobiliare Sassiba” (955 mq.) per 50 milioni (oltre cinquantamila al metro
quadro!). E abbiamo scrupolosamente ricordato tre sole cessioni fra decine di altre.
Le ex marcite, gli irrigui da Porta Vittoria, verso Viale Corsica e il ponte della
ferrovia da cui prende inizio Viale Forlanini, non smentiscono l’eccezionale bontà del prato toccato in sorte agli eredi Diana. Da via Zanella a via Negroli, da via Battistotti
a via Sismondi, da via Ostiglia a via Lomellina, cioè nel contesto urbanistico del
“Prato Buono”, tra il 1950 e il 1960 è tutta una cessione, un ricorrere a notai, un
reimpiego frenetico dei capitali così rimediati. Quanto agli stabili insistenti, venuti
in eredità alla suocera nella misura d’un terzo, saranno inglobati dal genero d’oro
in talune immobiliari costituite ad hoc.
4. Da Dell’Utri a Berlusconi
L’ultimo coup de théâtre di Dell’Utri, entrando a piedi uniti nel cuore della questione, fu la sua straniante
comparsa nel film documentario di Franco Maresco Belluscone – Una storia siciliana, del 2014. Il colpo d’occhio è abbastanza pazzesco: lui in abito grigio a righine
alla boss di Chicago, sopra a gilettino nero e cravatta viola, assiso su un trono
cardinalizio in campo nero, a rispondere a domande una più imbarazzante dell’altra
(per lui) che Maresco gli pone. A un certo punto arriva questa: «Ma se Berlusconi
svelasse i suoi segreti, che cosa verrebbe fuori?». Ed ecco la risposta: «Mah, secondo
me delle cose tremende. Per esempio? La morte di Mattei. Delle verità sulla morte
di Mattei, che non è ancora così chiara...». E qui accade l’incredibile, resocontato
pari pari nel film: si sente uno stridìo che copre il parlato, da quel momento in
poi incomprensibile. E infatti Belluscone prosegue con questo racconto del fonico Rino Cammarata: «Né io né il microfonista
ci accorgemmo che l’audio non era venuto. Non c’era nessuna registrazione. In trent’anni
di questo mestiere non era mai successo». Direte voi: va bene che Berlusconi ne ha
fatte di cotte e di crude, ma della morte di Mattei che cosa diavolo dovrebbe sapere?
E soprattutto, Cefis che cosa c’entra in questo caso?
Se in questi anni vi siete accostati anche solo per un attimo al pozzo nero della
“pasolineide”, magari senza leggere alcuno dei tanti libri sul tema ma solo tuffandovi
nel mare magnum della rete, la risposta la sapete già. Chi invece ancora non ne ha avuto l’occasione,
sappia che nella sua indagine il pubblico ministero Vincenzo Calia (che ora è sostituto
procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano) si è imbattuto in materiale
ancora più appetitoso del libro di Steimetz. In particolare un documento acquisito
a Forte Braschi, cioè la sede del Servizio segreto militare, che recita così:
La Loggia P2 è stata fondata da Eugenio Cefis che l’ha gestita sino a quando è rimasto
Presidente della Montedison. Da tale periodo ha abbandonato il timone, a cui è subentrato
il duo Ortolani-Gelli, per paura. Sono di tale periodo gli attacchi violenti (Rovelli
della Sir) contro uomini legati ad Andreotti con il quale si giunse a un armistizio
per interessi comuni: lo scandalo dei petroli.
Spiega Calia, nel proprio libro Il caso Mattei (coautrice Sabrina Pisu), che si tratta di un allegato a un “appunto”: consiste in
tre pagine scritte a mano in corsivo e la fonte si firma “Turi”, «identificabile in
un alto funzionario del ministero della Difesa». Le tre pagine si articolano in sei
blocchi informativi, introdotti dalla frase «Notizie acquisite, il 20 settembre 1983,
da qualificato professionista molto vicino ad elementi iscritti alla Loggia P2, dei
quali non condivide le idee». E il link Cefis-P2 è il quarto dei sei punti. Non solo:
agli atti dell’inchiesta di Calia c’è un altro appunto riservato, questa volta del
Sisde, cioè la struttura che nel 1977 prese il posto del tristemente noto Ufficio
Affari riservati del Ministero dell’Interno. Datato 17 settembre 1982, fa sapere che
«intensi contatti sarebbero intercorsi in Svizzera, fino al mese di agosto u.s., tra
Licio Gelli ed Eugenio Cefis, presidente della Montedison International». Agosto 1982:
dunque mentre Gelli era uccel di bosco, il suo arresto a Ginevra avverrà appena un
mese dopo. Mettete assieme tutto questo al numero 1816, cioè la tessera P2 di Silvio
Berlusconi, fate due più due e valutate da voi la plausibilità dell’allineamento Mattei-Cefis-Berlusconi.
E poi ci sarebbe un’altra questione, esile ma suggestiva.
Milano, novembre 1979. Il nome di Silvio Berlusconi è ancora associato solo a palazzine
e gru, ma l’imprenditore è in ascesa: la nascita di Canale 5 è alle porte. Anche la
Guardia di Finanza è però interessata alle mosse del Cavaliere: non si capiva bene
quale fosse il suo ruolo nell’ambito della Edilnord Centri Residenziali sas, che stava
tirando su Milano 2 e dietro la quale si scorgevano come finanziatori due oscure società
svizzere. Ed era lo stesso meccanismo utilizzato nel 1963 per creare una delle prime
società di Berlusconi, la Edilnord sas. Senza scendere nei dettagli, perché la questione
è intricata, in sostanza il sospetto dei finanzieri che lo interrogarono era che in
questo modo fossero state aggirate le norme valutarie. Ma Berlusconi se la cavò sostenendo
di essere semplicemente un consulente della Edilnord, addirittura un progettista.
Strano che al tempo stesso dichiarasse di essere pure fideiussore a favore della Edilnord
di fronte alle banche creditrici, ma pazienza. Il verbale di chiusura dell’indagine,
a cui interrogando Berlusconi collaborò il capitano Massimo Maria Berruti, anni dopo
deputato di Forza Italia, dà atto che il Cavaliere venne creduto: «Non è emerso alcun
elemento comprovante che nella persona del dottor Berlusconi si possa identificare
l’effettivo soggetto economico delle società estere Aktiengesellschaft für Immobilienanlagen
in Residenzzentren di Lugano e Cefinvest di Lugano». Cefinvest. Lugano: ultimo domicilio
di Cefis. Che però nel ’79, per quel che vale, stava a Zurigo.
A valere di più è invece il decreto con cui il gip Fabio Lambertucci, il 17 marzo
2004, dispose l’archiviazione dell’inchiesta di Calia. I titoli dei giornali lo interpretarono
più o meno così: l’attentato a Mattei ci fu, ma dopo tanti anni è impossibile risalire
ai colpevoli. Sintesi imprecisa, visto che il decreto si concludeva con questa frase,
forse un po’ severa: «Quel che è certo, oggi, è come in sede giudiziaria non sia stata
raggiunta una prova sufficiente che Enrico Mattei, Irnerio Bertuzzi e William McHale
furono uccisi». Peraltro già dopo poche righe il gip, altrettanto severamente, era
netto:
I risultati tecnici non sono tali da fornire la prova che l’aereo che cadde in località
Bascapè fu sabotato ed esplose in volo per effetto di una carica di esplosivo attivatasi
al momento dell’apertura del carrello di atterraggio: detti accertamenti, non isolatamente
considerati, e valutati nelle loro interrelazioni, conducono, appunto, a un giudizio
di mera compatibilità con l’ipotesi delittuosa.
Ma come? E la mole di elementi raccolti da Calia su Cefis? Anche qui Lambertucci era
tranchant. E il suo giudizio traspariva tra le righe in cui definiva «suggestivo e inquietante»
il quadro emerso a carico di Cefis, frutto però di un’inchiesta che ha attinto «a
materiali quali informative e note dei servizi segreti basate per lo più su fonti
imprecisate e comunque confidenziali, nonché su pareri e sensazioni di giornalisti,
studiosi e testimoni di quegli anni». Risultato: una «minuziosa rassegna» di fonti
a senso unico contro Cefis, cioè chi lo sospettava «di aver avuto diretto interesse
alla morte di Mattei allo scopo di coltivare rivincite personali, interessi economici
egoistici, cambi di politica dell’Eni in favore di inconfessabili superiori interessi
nazionali e/o sopranazionali». Lo sospettava o accusava per propri fini altrettanto
inconfessabili: e qui va nuovamente soffocata la tentazione di riparlare di Verzotto.
A scorrere i verbali, pure citati da Calia, della prima inchiesta sulla scomparsa
di De Mauro (che in effetti lambì Cefis: i relativi atti giudiziari furono inviati
a suo tempo anche a Pavia perché connessi alla morte di Mattei, ma misteriosamente
mai arrivarono), spunta ad esempio quello del giornalista di «Epoca» Paolo Pietroni.
Tutto ruota attorno a un appunto di Elda De Mauro, consegnato ai magistrati, in cui
la moglie del giornalista riferiva di un racconto fattole appunto da Pietroni: una
sua fonte gli aveva parlato di una telefonata
intercettata da una donna impiegata presso l’Eni, fatta dal presidente dell’Eni stesso,
Cefis, a un ignoto interlocutore di Palermo, ivi abitante, del seguente tenore: «A
proposito di’ all’avvocato Guarrasi questa volta di essere più prudente di quanto
non sia stato nella faccenda del giornalista di Palermo: stava per lasciarci le penne
e non so chi l’avrebbe tirato fuori, nemmeno il Presidente della Repubblica». Tale
donna, a dire del Pietroni, sarebbe disposta a confermare dinanzi alla magistratura
quanto confidato, solo nel caso che le indagini si estendessero nell’ambito dell’Eni
e del Cefis.
Anche sull’avvocato Vito Guarrasi va tenuta a bada la tentazione di aprire una parentesi
a lui dedicata, perché davvero non si finirebbe più. Ma a prescindere dalla plausibilità
della vicenda, si tratta comunque di un de relato addirittura di terzo grado. Pietroni in effetti non lo smentì mai (pur tenendo coperta
la propria fonte) ma nel 1974, sempre davanti a un magistrato, disse anche – così
negli atti di Calia – che «alla luce della situazione politica all’interno dell’Eni,
rivelatasi in epoca successiva, penso che non sia da escludersi che io sia stato strumentalizzato
nel quadro delle manovre tese a screditare la riconferma di Cefis alla presidenza
dell’Eni».
Tornando a Lambertucci, nella parte finale del decreto d’archiviazione rendeva comunque
l’onore delle armi al collega, parlando di «merito indiscusso in chiave di ricerca
storiografica dell’inchiesta condotta dalla Procura di Pavia». Concludeva poi citando
Carlo Ginzburg: «Uno storico ha il diritto di scorgere un problema là dove un giudice
deciderebbe il non luogo a procedere». Ma lo faceva, il gip, dopo aver rievocato le
diverse piste prese in considerazione da Calia: la mafia per conto delle “sette sorelle”,
l’Oas (la sigla dell’organizzazione paramilitare francese stava in calce a una lettera
con minacce di morte giunta a Mattei il 28 maggio del ’61) e, «pur senza formulare
espressamente una ipotesi», la pista Cefis. Commentando infine così: «Significativo
appare il fatto che lo stesso pm abbia ritenuto così labile l’ultima delle piste prospettate
da evitare, congruamente, di iscrivere Cefis nel registro degli indagati».
Massonerie
L’appunto di “Turi” su Cefis fondatore occulto della P2, portato alla luce dall’inchiesta
del giudice Calia, ha avuto una fortuna che era facile pronosticare. Lo si cita ovunque:
libri, articoli, nel web poi è un trionfo. E così è diventato pietra angolare della
“cefisologia”. Ma qui bisogna intendersi: che cosa significa “un appunto”? Tecnicamente
è meno di un’informativa ufficiale, nella quale non è detto che poi finiscano i singoli
appunti relativi ai “prodotti” di una fonte. Dipende, a seconda del giudizio da parte
del “controllore” della stessa fonte circa la fondatezza dell’elemento informativo.
Se quell’appunto sia poi stato trasfuso in un vero e proprio rapporto destinato ai
vertici del Servizio (e da lì, magari, fino al potere politico), non lo sappiamo.
Così come non sappiamo se le “carte” dei Servizi riguardanti Cefis giunte in mano
a Calia costituiscano la totalità delle informazioni effettivamente esistenti negli
archivi. Anzi, Calia è abbastanza certo del contrario: «Quando chiesi al Sismi, tra
l’altro, di inviarmi il loro materiale d’archivio relativo a Cefis, sapevo bene che
mi sarebbe arrivato solo quello che avrebbero voluto darmi», spiega. Peraltro, il
documento in questione non è neppure un “appunto” bensì un “allegato” allo stesso.
Quel documento il giudice se lo trovò infatti in mano solo dopo essersi recato di
persona a Forte Braschi, su invito “collaborativo” dell’allora direttore del Sismi,
il generale Sergio Siracusa (siamo a metà degli anni ’90), che mise a disposizione
di Calia un paio di funzionari per le ricerche, aiutati da un altro paio di carabinieri
fidatissimi che il giudice si portò appresso. E fu così che spuntò la carta con la
pista Cefis-P2, che seguendo la trafila burocratica della richiesta da parte della
Procura difficilmente sarebbe venuta alla luce: un funzionario del Servizio, di norma,
avrebbe analizzato infatti i riassunti informativi propedeutici ai rapporti, non i
singoli appunti (e men che meno i loro eventuali allegati). A quella suggestione rivelatrice,
nel corso dell’inchiesta di Calia seguirono poi numerose testimonianze, tutte nel
senso di un Cefis luciferino: che è poi quello di cui oggi si discute. Perché allora
il tutto si chiuse con una richiesta di archiviazione? Non ce n’era abbastanza per
fare il passo successivo, chiedere cioè al gip di rinviarlo a giudizio? La risposta
di Calia è netta: no, per un processo non era abbastanza. Il che spiega anche perché,
tra i molti testimoni sentiti in fase di indagine, Cefis non figurò mai. Spiega il
magistrato:
Certo, gli elementi di prova si raccolgono per poterli utilizzare in un dibattimento,
ma a patto che siano stringenti e non equivoci. In un tribunale, per capirci, Cefis
non sarebbe mai stato condannato: tutti gli elementi portati dai testimoni potevano
tranquillamente essere letti in un altro modo.
Perché allora quegli elementi sono comunque finiti nella richiesta di archiviazione?
Semplice, spiega ancora Calia: «Per sottoporre al giudice che avrebbe dovuto decidere
sulla mia richiesta ogni elemento di giudizio e perché non s’inabissassero nel nulla
e anzi “girassero”, affinché venissero letti e, nel caso, valutati e approfonditi
da ricercatori, storici, giornalisti». Il che è senz’altro avvenuto. E da allora l’ossessione,
non poteva andare altrimenti, ha contagiato anche Calia: «Sì, della morte di Mattei
continuo a occuparmi, ma come “cultore della materia”, non più come magistrato. E
in alcuni libri degli anni ’60 ho trovato altri elementi che sarebbero stati meritevoli
di approfondimento».
1. Giustizia e Libertà
Parafrasando Calia: quell’allegato all’appunto è uscito perché qualcuno voleva che
uscisse. E come sa bene ogni ricercatore che ha a che fare con gli archivi, oltre
a ciò che essi contengono conta ciò che non svelano. Il che, nel caso della pista
Cefis-P2, può significare almeno due cose: primo, chissà quante altre carte potrebbero
avvalorare la nota di “Turi” e chissà quando le vedremo (sempre che esistano ancora);
oppure, in alternativa, null’altro c’è mai stato, quindi quell’indicazione va valutata
per quello che è: un elemento senza ulteriori riscontri, anche a prescindere dal fatto
che siano stati cercati o meno. Comunque sia, che Cefis fosse massone pare sufficientemente
documentato. Anche in questo caso, peraltro, la fonte originaria è una sola. Ma più
che il fatto che mai sia stata smentita dall’interessato, a renderla solida è l’impianto
complessivo che la sorregge. Si tratta di un libro pubblicato alla fine del 1978 da
«L’Espresso», in una propria collana: siamo quindi in un momento in cui il caso P2
è ben lontano dall’esplodere, avverrà oltre due anni dopo. Ma in quel libro, I massoni in Italia, firmato dall’inviato dello stesso settimanale Roberto Fabiani, della loggia gelliana
si raccontava fin nei minimi dettagli. Partendo da una dettagliata storia della massoneria
in Italia, fin dai tempi (precedenti a Napoleone Bonaparte) delle prime logge fondate
a Firenze nel 1732 da alcuni nobili inglesi, passando poi per la prima Costituente
massonica italiana del 1862, la nomina di Giuseppe Garibaldi a “Gran Maestro”, le
innumerevoli scissioni e controscissioni del periodo risorgimentale, l’avvento di
Ernesto Nathan e tanto altro. E a un certo punto, a proposito dell’“obbedienza” di
piazza del Gesù (dove stava pure la Dc), a pagina 130 Fabiani scrive così:
Anche a piazza del Gesù, come in tutte le massonerie del mondo, esisteva una loggia
coperta, destinata a riunire i fratelli più in vista. Si chiamava Giustizia e Libertà
e in passato aveva visto una comparsa (rapida) dell’ex presidente del Senato e senatore
a vita Cesare Merzagora, dei generali Giuseppe Aloja e Giovanni De Lorenzo; perfino
il caporione fascista Giulio Caradonna era entrato e uscito diverse volte. Da qualche
anno la Giustizia e Libertà era stata affidata a Giorgio Ciarrocca, direttore centrale
della Rai, libero docente dell’Università di Roma. In quel forziere Ciarrocca aveva
concentrato un materiale di primissima scelta, tra cui Franziskus König, arcivescovo
di Vienna e cardinale tra i prelati. Tra i politici: Giacinto Bosco, Marcello Simonacci,
Eugenio Gatto, democristiani; Luigi Preti, socialdemocratico e perfino il dirigente
comunista, speranza del partito Gianni Cervetti. Formidabile la presenza dei grandi
e inamovibili condottieri delle industrie e delle banche pubbliche, dei boiardi di
Stato, di personaggi usi a trattare col potere da pari a pari. Eugenio Cefis, primo
tra i primi, iscritto dal 15 settembre 1961, Leopoldo Modugno, dirigente delle Partecipazioni
Statali, in loggia dal 9 giugno 1965, Giuseppe Arcaini, iniziato il 15 luglio 1963,
Guido Carli, tra i liberi massoni dal 19 settembre 1967. E un altro grande e riservatissimo
personaggio del mondo bancario non solo italiano ma internazionale, Enrico Cuccia,
amministratore delegato di Mediobanca, seduto tra le colonne del tempio fin dal 27
marzo 1955. Il più importante di tutti costoro, da un punto di vista massonico, era
Raffaele Ursini, che aveva la carica di luogotenente del Sovrano Gran Commendatore
del Rito.
E poi militari (una presenza «contenuta ma di altissimo livello»), costruttori, professionisti
e alti burocrati, naturalmente magistrati e finanzieri, a partire da Michele Sindona.
Tutti indicati con nome, cognome e addirittura codice di iscrizione: quello di Cefis,
per dire, era OHN – 05371 / S. 15. Un libro dunque formidabile perché superdettagliato.
Le fonti di Fabiani, che pure era massone iscritto alla “Giustizia e Libertà”, erano
infatti di primissima mano: pare infatti che raccogliesse le confidenze dello stesso
Gelli e di Francesco Siniscalchi, grande avversario del “Venerabile” in nome di una
massoneria che si voleva “democratica”. Il libro di Fabiani andò rapidamente a ruba,
salvo poi cadere altrettanto rapidamente nel dimenticatoio allo scoppio dello scandalo
e alle sue ripercussioni politiche. Per poi nuovamente rispuntare, citatissimo da
saggisti e ricercatori, diventando così negli anni a venire architrave di quella linea
diretta che da Cefis, via Gelli, porta fino al Berlusconi dei giorni nostri. In verità
una smentita era arrivata, tardiva, dal comunista Cervetti, che nel 1992 (dunque quattordici
anni dopo la pubblicazione del libro di Fabiani) querelò addirittura «Famiglia Cristiana»,
“rea” di aver riportato come oro colato il passaggio di I massoni in Italia che lo riguardava e che lo voleva “fratello massone” di Cefis nella “Giustizia e Libertà”.
Da un lancio d’agenzia dell’AdnKronos dell’11 dicembre 1992:
Il deputato del Pds, Gianni Cervetti, ha querelato per diffamazione il settimanale
«Famiglia Cristiana» per un articolo comparso sull’ultimo numero, intitolato “Loggia
e tangente”. In una dichiarazione Cervetti spiega che nell’articolo gli si attribuisce
l’adesione a «una loggia coperta (Giustizia e Libertà) retta dal maestro venerabile
Giorgio Ciarrocca». Questa e «altre simili notizie – dice ancora Cervetti – sarebbero
tratte da un libro a firma di Roberto Fabiani pubblicato dalle edizioni dell’Espresso
nel 1978». Il parlamentare del Pds ricorda di aver sporto querela contro Fabiani (citato
nell’articolo di «Famiglia Cristiana») e che di fronte al tribunale competente Fabiani
dichiarò che «non rispondeva al vero la asserita appartenenza di Gianni Cervetti alla
loggia coperta “Giustizia e Libertà”» e che ne aveva riferito, prosegue Cervetti,
in quanto «tratto in inganno da notizie che erano risultate prive di fondamento».
Anche di Cervetti il libro riportava il codice d’iscrizione: OKL – 0321 – L/3. E di
quello di Cefis, a comprovare la sua “massonità”, si è già detto. Per dire insomma
come sia sempre meglio procedere con cautela: basta un niente per mettere in crisi
dalle fondamenta splendide costruzioni intellettuali dove agganci, rimandi e riferimenti
appaiono ferrei.
2. Il “sistema Cefis”
È il caso del lavoro di Massimo Teodori nell’ambito della Commissione d’inchiesta
sulla P2. L’allora deputato radicale fu tra i più agguerriti nel contrastare, con
successo, chi il caso Gelli lo voleva minimizzare. Memorabile ad esempio il suo “interrogatorio”
di Ugo Niutta, più che un amico per Cefis. In un’audizione che da sola meriterebbe
un film, svelò moltissimo: non tanto del presunto sistema di potere gelliano, visto
che nelle liste della P2 non compariva, bensì della disinvoltura che caratterizzava
l’agire dello stesso Niutta. Il lavoro di Teodori confluì in una dura relazione di
minoranza, che ancor più di quella “ufficiale” timbrata dalla Commissione Anselmi
è ancora oggi punto di riferimento della pubblicistica in materia. Così come ovviamente
della “cefisologia”. È quindi il caso di soffermarcisi nel dettaglio, anche perché
contiene un capitolo dal più che invitante titolo “Da Cefis a Gelli”, in cui si legge
quanto segue:
Il sistema di potere che prima della P2 è comparabile con il centro gelliano è quello
organizzato e promosso da Eugenio Cefis, presidente dell’Eni nella seconda metà degli
anni ’60 e quindi alla testa della Montedison dal maggio 1971. A differenza di Gelli,
Cefis usa la preminente posizione in campo economico e finanziario, delegatagli dai
politici, per organizzare un centro di potere che si avvale in maniera sempre più
aggressiva delle risorse del gruppo da lui gestito per annettere a sé uomini, gruppi
e risorse nei diversi settori della vita nazionale. Il sistema Cefis diviene progressivamente
un vero e proprio potentato che, sfruttando le risorse imprenditoriali pubbliche,
condiziona pesantemente la stampa, usa illecitamente i servizi segreti dello Stato
a scopo di informazione, pratica l’intimidazione e il ricatto, compie manovre finanziarie
spregiudicate oltre i limiti della legalità, corrompe politici, stabilisce alleanze
con ministri, partiti e correnti. La capacità dell’uomo e del suo sistema di coinvolgere
elementi nei più disparati settori è esemplare. Come c’è stato un “partito” di Mattei
che aveva spostato equilibri politici e condotto un’autonoma politica estera, così
all’inizio degli anni ’70 si era formato un “partito” di Cefis che in Parlamento poteva
contare sostenitori in tutti i settori dello schieramento politico. L’Eni prima e
la Montedison poi, con la presidenza Cefis, non sono semplici anche se potenti lobbies economico-finanziarie, ma vengono usate come strumenti di intervento per influenzare
il corso degli avvenimenti del paese.
Lo scenario è preciso, come si vede. E Teodori sottolinea che il sistema P2 si sviluppa
in contemporanea con l’inizio del declino del sistema Cefis, quindi alla metà degli
anni ’70 e fino all’uscita di scena dello stesso Cefis nel 1977. Sarebbe però «superficiale
affermare che il nuovo sistema di potere prende piede perché il precedente tramonta
oppure che la P2 eredita, in quanto tale, il sistema cefisiano», si legge nella relazione
Teodori, che può al massimo rilevare «degli elementi di continuità tra il sistema
cefisiano e quello gelliano». Ah, se anche Teodori avesse avuto in mano l’allegato
all’“appunto Turi”... sarebbe stata la quadratura del cerchio, già nel 1986 quando
la sua relazione diventò un libro: da Cefis a Gelli e da Gelli dritti a Berlusconi.
Tanto che è forte la tentazione di chiedersi quanto quell’appunto debba a Teodori:
se cioè la “fonte Turi” non possa in realtà essersi limitata a svolgere semplicemente
una sintesi estrema di quanto stava emergendo dai lavori dalla Commissione P2, così
come la stava apprendendo il «qualificato professionista molto vicino a elementi iscritti
alla loggia P2». Sintesi più che estrema, in realtà, perché a fronte dell’imponente
mole di elementi raccolti in commissione (ma già prima pubblicati da Fabiani) circa
la P2 creatura di Gelli in tutto e per tutto, nulla è mai emerso a favore di un coinvolgimento
di Cefis, né come “padrone” della loggia né come semplice iscritto.
I tempi quadrano: la Commissione inizia infatti i propri lavori a dicembre del 1981
e li porta avanti a tamburo battente fino al luglio del 1984, quando vengono depositate
le relazioni conclusive: sono lavori seguiti dalla stampa con attenzione spasmodica,
con i risultati delle audizioni e delle acquisizioni di nuovi documenti puntualmente
raccontati sui giornali. Nella propria nota, “Turi” scrive di aver acquisito la notizia
di Cefis fondatore della P2 il 20 settembre 1983: quando cioè il quadro in commissione
era già stato sufficientemente delineato e si iniziava a ragionare sulle relazioni
(a quella di maggioranza Dc-Psi-Psdi-Pri se ne aggiungeranno addirittura quattro di
minoranza, espressione di Pci, Pli, Msi e appunto i radicali). Tra l’altro, una delle
ultime audizioni fu proprio quella di Niutta già citata: audizione show (ma più per
merito di Teodori che di Niutta) in cui il consigliere di Stato raccontò che tra il
1975 e il 1976 Gelli gli chiese di poter essere presentato a Cefis, richiesta respinta
dallo stesso Niutta. Ma commenta il deputato radicale: «Non si sa se quell’incontro
sia mai avvenuto ed eventualmente cosa esso possa aver rappresentato. Si potrebbe
a lungo speculare sul passaggio delle consegne del regno del potere occulto e illegittimo
da Cefis a Gelli o sull’investitura che il presidente può aver dato al nuovo grand commis. Non è questo però che interessa».
Saggio e preveggente, Teodori: certo che si sarebbe potuto a lungo speculare, da allora
sono passati oltre trentacinque anni e siamo fermi esattamente lì. Lo dimostra una
tesi di laurea discussa alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna,
anno accademico 2012-13: La vicenda Cefis. L’industria italiana fra pubblico e privato il titolo, autore Domenico Tumolo, un cui saggio spin off della stessa tesi, pubblicato nel marzo 2015 dalla rivista «I Sentieri della Ricerca»,
compare anche nella bibliografia della voce “Eugenio Cefis” di Wikipedia. Il terzo
capitolo della tesi è tutto dedicato al nostro: vi si ripercorrono brillantemente
la parabola di manager e le tante vicende ad essa correlate. E nelle ultime dieci
pagine, puntuali, ecco “pasolineide” e massonerie, in ogni loro dettaglio. Con Tumolo
che si spinge ad avanzare due proprie ipotesi (anzi «congetture», come lui stesso
le definisce) sull’abbandono del 1977, legandole naturalmente a scenari golpisti e
piduisti.
La prima è che Cefis sia stato sconfitto nel confronto con Gelli. Se i rapporti sono
stati sempre conflittuali e le tattiche politiche basate sulle alleanze e i dossieraggi,
la situazione di crisi nella quale Cefis visse il biennio ’76-’77 potrebbe essere
il frutto anche di un attacco sotterraneo che lo costrinse alla fuga. L’altra congettura
è invece quella di un passaggio di consegne. In questo caso le coincidenze sono numerose,
a partire dai programmi politici. Sempre la crisi in cui era implicato potrebbe averlo
spinto a lasciare la leadership del gruppo parastatale in favore di Gelli. Se il suo
entourage lo si ritrova successivamente attirato da Gelli è singolare come dal 1976
(anno in cui si documentano i contatti fra i due) le iscrizioni alla loggia massonica
subiscano un’impennata, sinonimo forse di “qualcosa di nuovo”.
L’unica documentazione dei contatti tra Cefis e Gelli è però relativa a Niutta, che
alla Commissione P2 negò comunque di averli fatti incontrare. E infatti lo stesso
Tumolo chiude il capitolo (e con esso l’intera tesi) con queste parole: «È necessario
ricordare però che queste righe sono state scritte esclusivamente sulla base di congetture
e intriganti coincidenze; non ci sono prove consolidate, è solo dietrologia». Appunto.
Mentre su Niutta, volendo, c’è molto altro da dire.
3. Antelope Cobbler
Dell’Ugo Niutta eroe dell’aviazione della Prima guerra mondiale, a cui a Napoli è
intitolato l’aeroporto di Capodichino, era più che omonimo. Stando all’albero genealogico
della nobile famiglia partenopea il cui capostipite era Ilariantonio, erano infatti
anche parenti: cugini di terzo grado, benché divisi per generazione. L’Ugo Niutta
che qui interessa, nato a Tripoli nel 1921 e morto suicida a Londra nel 1984, è figura
incredibilmente poco nota all’opinione pubblica tanto oggi quanto allora, benché negli
anni ’70 si fosse seduto su una poltrona pubblica dietro l’altra, dopo aver già accumulato
nel proprio curriculum importanti incarichi nell’Eni di Mattei prima e di Cefis poi.
Curiosamente, l’Enciclopedia Treccani (che liquida Cefis in appena sei righe) su Niutta
è sorprendentemente fitta di dettagli. La voce che lo riguarda è interminabile e parte
dagli anni ’40:
Prese parte alla seconda guerra mondiale, prima sul fronte russo poi su quello africano.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schierò con i Savoia, entrando a far parte
dell’organo di controspionaggio del Regno del Sud, il Servizio informazione militare
(SIM), nella sezione Calderini, e collaborò attivamente con il servizio di sicurezza
britannico, lo Special Operations Executive. In tale veste partecipò a una rischiosa operazione in Valdossola, dove fu paracadutato
dietro le linee tedesche per attivare contatti con le brigate partigiane. Per le sue
azioni fu poi insignito della medaglia di bronzo al valor militare e della croce di
guerra, e ottenne dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia la qualifica di
«partigiano combattente». In quel periodo fece due incontri destinati a rivelarsi
cruciali per il suo futuro: Enrico Mattei ed Eugenio Cefis, alla guida di gruppi partigiani
bianchi.
Dunque Niutta era agente del Sim, il controspionaggio dei Savoia dopo l’8 settembre
del ’43, nella sezione Calderini che ne era la “branca offensiva”. E anche Cefis ne
faceva parte, come ha documentato Aldo Giannuli, che ha consultato l’archivio della
Calderini (allora depositato al Sismi, ora si trova all’ufficio storico dello Stato
maggiore dell’Esercito) nell’ambito di una consulenza prestata nel 1999 alla Procura
della Repubblica di Brescia nel corso delle indagini preliminari per la strage di
Piazza della Loggia. È difficile non vedere in questo combaciare di dettagli il quadro
di un’operazione che vedeva entrambi agire congiuntamente. In più la Treccani, già
dal 2013, di Niutta certificava una circostanza quanto meno singolare, fin lì svelata
solo da un paio di ricercatori e patrimonio di pochi addetti ai lavori: il suo nome
in codice, ai tempi della guerra partigiana, era infatti “Antelope Cobbler”. Come
quello del collettore di tangenti dello scandalo Lockheed. E un filo sottile della
matassa che riguarda Cefis porta da Niutta-Cobbler addirittura a Rino Gaetano. Che
cosa c’entra il cantautore? Dipende naturalmente da quanto si è disposti a lasciarsi
ammaliare dalle coincidenze. Ma presto ci arriviamo: è il prossimo capitolo.
Per Cefis i compagni dell’Ossola restarono tali tutta la vita. E infatti, dopo alcuni
anni come magistrato, pure Niutta finì all’Eni, prima nel servizio studi legislativi
di cui fu responsabile, poi nello staff dei collaboratori più stretti di Mattei. Cioè
al fianco di Cefis. Negli ultimi giorni di vita di Mattei, tra l’altro, in Sicilia
c’era pure Niutta, che restò in Eni fino al passaggio di Cefis a Montedison. Ma a
quel punto gli si era dischiusa un’altra carriera, quella di grand commis della Repubblica, forte anche della nomina a consigliere di Stato, in particolare
al Ministero delle Partecipazioni statali. È da lì che il ministro Antonio Bisaglia
lo scelse come commissario straordinario prima dell’Ente Cinema, poi dell’Egam (Ente
gestione attività minerarie), il più disastrato degli enti pubblici. Ma il comandante
dei giorni dell’Ossola per Niutta c’era sempre: con il placet di Bisaglia, Cefis lo chiamò infatti a guidare l’azienda farmaceutica Carlo Erba,
gruppo Montedison, che portò alla fusione con Farmitalia creando così il primo grande
polo farmaceutico nazionale, diventandone presidente. Un uomo dunque di successo.
Che nel frattempo, lasciata la moglie, era pure diventato ricercato materiale per
rotocalchi avendo intrecciato una relazione con la conduttrice televisiva Aba Cercato.
Come Cefis, e forse proprio per via dello stretto rapporto che li legava, anche Niutta
è al centro da anni di leggende nere. Molto si deve al suicidio a Londra a 63 anni,
in una camera d’albergo con un mix di farmaci: una fine tragica che molti vorrebbero
ancora più tragica, cioè un delitto al posto di un atto disperato. Un delitto per
giunta connesso a un’altra misteriosa morte londinese, quella del presidente del Banco
Ambrosiano Roberto Calvi di due anni precedente. Resta il fatto, testimoniato da più
parti, che Niutta da tempo si era scoperto addosso il male di cui morì il padre, il
morbo di Parkinson. L’inchiesta del coroner britannico aveva accertato che tra i farmaci assunti in massicce dosi vi erano un
tranquillante e un antispasmodico assunto dai malati di Parkinson, che tale mistura
era perfettamente in grado di uccidere un uomo che era pure gravemente malato a un
polmone e con le coronarie in cattivo stato, che nell’ultimo incontro prima di morire
aveva detto al responsabile della Montedison per la Gran Bretagna Franco Pace di sentirsi
profondamente depresso per motivi personali, che lo stesso Pace aveva testimoniato
di averlo visto incapace di salire le scale senza aiuto («aveva perso la capacità
di coordinamento del lato sinistro del corpo»), che le lettere d’addio trovate nella
stanza del Grosvenor Hotel erano effettivamente di suo pugno, che infine sul corpo
non vi erano tracce di violenza.
4. Pecorelli e Varisco
La leggenda quando è nera è anche dura a morire. Nel caso di Niutta, poi, è una leggenda
alimentata anche da una foto del 1960 pubblicata da «Il Borghese», che lo ritrae nel
momento della firma di un delicato accordo stragiudiziale in base al quale, dopo anni
di controversie, lo Stato concedeva al Grande Oriente d’Italia l’uso di parte di Palazzo
Giustiniani, dietro pagamento di un canone annuo. Grande Oriente, massoneria, Gelli
e la P2: la connessione è immediata, no? Peraltro, nella foto compare pure l’allora
ministro delle Finanze Giuseppe Trabucchi, proprio all’atto della firma. E Niutta,
collocato fuori ruolo dalla magistratura nel 1957, è chiaramente lì in quanto collaboratore
del ministro, cui siede a fianco. Sta di fatto che l’appartenenza di Niutta alla P2
è sempre stata ipotizzata. Non solo: di Niutta scrive anche Mino Pecorelli, che in
un articolo su «OP» lo definì «duca SIFARitico». Era un messaggio trasparente, stava
per “colui che conduce i dossier del Sifar”, ma se non fosse stato chiaro lo aggettivava
anche «protetto e obbedientissimo collaboratore di L.G. P2». Non basta. Niutta era
grande amico del colonnello dei carabinieri Antonio Varisco, ucciso dalle Brigate
rosse il 13 luglio del 1979, al quale aveva offerto un posto alla Carlo Erba poche
settimane prima della sua uccisione: posto che Varisco aveva accettato. E chissà che
l’amicizia non fosse nata nel 1964, quando come vedremo più avanti fu proprio Varisco
a consegnare a Cefis e appunto a Niutta convocazioni giudiziarie relative a un’indagine
sui finanziamenti occulti dell’Agip ai partiti.
Ancora, ed è un dettaglio spettacolare, diversi anni dopo Varisco e la sua giovane
fidanzata di allora potevano godere dell’uso di una villa di Eugenio Cefis a Sperlonga,
che il Dottore gli affittava a un prezzo simbolico. E poi ci sarebbe tutto il filone
bisagliano dispiegato in Gli annegati, librino di poche ma densissime pagine di Carlo Brambilla e Daniele Vimercati del
lontano 1992, dove in quarta di copertina Niutta compare citato assieme a Pecorelli,
Varisco, Toni Bisaglia e il fratello Mario, sacerdote, sotto all’inquietante titoletto
«...e in ordine di sparizione». Anche in questo caso è impossibile rifare qui la storia
della strana morte del ministro, caduto dallo yacht della ricca moglie Romilda Bollati
di Saint Pierre e annegato al largo di Portofino nel giugno del 1984, così come di
quella di don Mario Bisaglia, misteriosamente annegato pure lui l’agosto di otto anni
dopo in un laghetto del Cadore: però va almeno detto di quella dozzina di pagine dedicate
a Niutta, di cui i due giornalisti tracciano un identikit superdettagliato facendo
poi a pezzi la versione del suicidio, suggerendo invece un link tra la sua morte e
quella del Bisaglia ministro, di poco precedente. Che ovviamente non sarebbe dovuta
a un incidente nautico.
Per chiudere il cerchio, sulla morte di Varisco (e sui molti dubbi che sembrano caratterizzarla)
è uscito recentemente un libro il quale, benché ben documentato, è però un curioso
mix tra reportage e romanzo: è infatti zeppo di dialoghi tra persone da tempo decedute
(Varisco, Niutta e Pecorelli su tutti), a cui l’autrice non ha certo assistito e che
non sono neppure de relato. Anna Maria Turi, che lo firma, ha d’altra parte nel proprio curriculum decine di
opere che hanno indagato temi come levitazione, stigmate, magnetismo, apocalisse,
profezie, Nostradamus e quant’altro (ma anche il rapporto tra Emanuela Orlandi, il
sufismo e la jihad). Il libro, intitolato L’agguato sul Lungotevere, si giova tra l’altro della prefazione del giudice Vincenzo Calia che in effetti
con la Turi, a propria insaputa, aveva avuto indirettamente a che fare durante la
propria inchiesta sulla morte di Mattei. Ricordate l’appunto del Sismi su Cefis fondatore
della P2? L’informatore si firmava Turi, figura che il magistrato di Pavia indicava
come un alto funzionario della Difesa. Bene: quel Turi era il padre della scrittrice
Anna Maria e Varisco lo conosceva e frequentava. Poi però l’autrice tira dentro un
po’ tutto: il presunto golpe cefisiano evocato da Ravelli e Cuccia (e se ne dovrà
riparlare), il discorso “eversore” di Modena (idem), la suggestiva successione in
pochi giorni delle uccisioni di Giorgio Ambrosoli, dello stesso Varisco e del capo
della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, ovviamente il caso Moro, di Pecorelli
poi non ne parliamo. Stringi stringi, però, alla fine la lettura più appassionante
è proprio quella dei dialoghi inventati. Potenza della narrazione.
Tornando all’appartenenza piduista del nostro, vale la pena di chiederne un giudizio
a un magistrato come Carlo Mastelloni, che in qualità di giudice istruttore a Venezia
nel 1995 ebbe di fronte Cefis nell’ambito della sua ciclopica inchiesta su Argo 16,
l’aereo utilizzato dai servizi segreti italiani per missioni “coperte” precipitato
il 23 novembre 1973 a Porto Marghera, provocando la morte dei quattro militari a bordo.
Una storiaccia esemplare del singolare destino dell’Italia degli anni ’70: non solo
palestra di terrorismi di ogni colore e crocevia di spioni di osservanza atlantica
o di oltre cortina, ma anche propaggine sottotraccia della delicatissima faglia che
attraversa/divide Israele e Palestina. Richiesto di un parere sull’appunto Turi, Mastelloni
risponde citando l’ammiraglio Fulvio Martini, che del Sismi fu direttore dal 1984
al ’91 e che in una conversazione eccepì che ogni magistrato, in presenza di una qualsiasi
carta dei servizi, è portato ad attribuire al contenuto del documento, in particolare
a quanto raccolto da una “fonte”, un’affidabilità totale. Per Martini questo costituisce
un errore metodologico: in questo modo, infatti, non ci si comporta correttamente
come invece fanno gli analisti dei Servizi, adusi a graduare l’affidabilità di una
fonte sulla base di parametri precisi. Mastelloni non dice di più. Ma è già abbastanza.
Vestito d’amianto
Se dietro non ci fosse anche un pizzico di genialità, si potrebbe sorridere. E invece
no, il tema va affrontato seriamente. Perché l’opera in vita di Rino Gaetano e la
sua tragica morte costituiscono il più recente e intrigante filone di studi cefisiani.
C’entrano ovviamente la notorietà e l’originalità del cantautore calabrese scomparso
il 2 giugno del 1981 a Roma, alle 6 del mattino al Policlinico Gemelli, due ore dopo
uno schianto sulla Nomentana, dove con la propria auto aveva invaso la corsia opposta
finendo frontalmente contro un camion. Già allora le circostanze della morte furono
oggetto addirittura di una interrogazione parlamentare, in relazione all’incredibile
vicenda del mancato ricovero del moribondo (dalla sua Volvo 343 Gaetano venne estratto
già in coma, per una frattura alla base cranica): più ospedali contattati ma tutti
senza posti disponibili, con il risultato di perdere tempo prezioso. Ed era inevitabile
che prima o poi qualcuno scrivesse un libro intitolato Chi ha ucciso Rino Gaetano?, dove la perentorietà dell’impostazione generale è perfettamente illustrata dal sottotitolo,
che recita “Il coraggio di raccontare: un’indagine tra massoneria, servizi segreti
e poteri economici”. Mentre lo strillo in quarta di copertina recita testuale: “La
realtà, è sempre unica, però quando serve viene manovrata da una ristrettissima elite
di superpotenti”.
Lo ha fatto nel 2016 Bruno Mautone, avvocato cassazionista ischitano con studio ad
Agropoli (Salerno), dove è stato anche sindaco. Già autore di Rino Gaetano. La tragica scomparsa di un eroe, che non era affatto piaciuto alla sorella del musicista Anna, per via delle ipotesi
sull’adesione del fratello alla massoneria oltre che per i dubbi sulla dinamica della
morte, in questo secondo lavoro Mautone getta il cuore oltre l’ostacolo infilando
un collegamento dietro l’altro con generosità di condizionali e un certo sprezzo della
geografia (e con essa della storia): ad esempio, quando nelle prime pagine definisce
la spiaggia di Capocotta dove venne trovato il corpo di Wilma Montesi «la località
ove pure trovò la morte nel novembre del 1975 il noto regista e scrittore Pier Paolo
Pasolini». Gelli e la P2, Gladio e i Rosacroce, Pecorelli, Ustica, la Cia, il gruppo
Bilderberg, il golpe Borghese e le stragi neofasciste, ovviamente il caso Mattei,
il Grande Oriente, Adalberto Titta e il “noto servizio”, Sindona, gli americani, lo
yacht Britannia e le privatizzazioni: l’autore non si fa mancare nulla, in un crescendo
in cui a un certo punto spuntano le tangenti della Lockheed, il più clamoroso malaffare
della politica italiana prima del ciclone “Mani pulite”. E qui però ci si deve fermare.
Perché finalmente i collegamenti con Rino Gaetano hanno un loro perché.
1. E Berta filava
Peccato per l’approssimazione di Mautone sul luogo in cui Pasolini venne massacrato:
gli sarebbe bastato infatti leggere Questo è Cefis per portare acqua al proprio mulino, giustificando con una solida pezza d’appoggio
il tirar dentro il poeta nella propria concatenazione. E senza neppure arrivare in
fondo alle 280 pagine di Steimetz. Già alla 34, infatti, inizia un capitolo intitolato
“L’uomo vestito d’amianto”: esattamente come il “santo / vestito d’amianto” di Berta filava, uno dei brani più celebri di Gaetano, che non è affatto la canzoncina giocosa e
scherzosa su una ragazza (Berta) e i suoi alterni accoppiamenti («E Berta filava /
e filava con Mario / e filava con Gino / e nasceva il bambino / che non era di Mario
/ che non era di Gino»). Dietro a Mario e Gino, Mautone ha efficacemente individuato
gli ex ministri della Difesa Mario Tanassi e Luigi Gui, che finirono a processo davanti
alla Corte costituzionale (ad oggi unico caso nella storia repubblicana) per lo scandalo
Lockheed, cioè le mazzette distribuite a politici e alti gradi militari dall’impresa
americana costruttrice di aerei. Berta invece nascondeva forse il soprannome di Robert
E. Gross, il fondatore della Lockheed: che era appunto Bert. Mentre il bambino erano
le tangenti, finite dunque in tasca chissà a chi: d’altra parte della reale identità
di “Antelope Cobbler”, il nome in codice del politico percettore di mazzette (e soprannome
di Niutta, non va dimenticato), a tutt’oggi l’Italia intera mai è venuta a capo. Nulla
l’avvocato Mautone ha invece scritto della «lana e l’amianto / del vestito del santo»
in relazione a Eugenio Cefis. Eppure del libro di Steimetz in rapporto a Petrolio già si sapeva. E sarebbe stato già abbastanza.
C’è però un’altra singolare circostanza, pure sfuggita a Mautone, che ha ancora a
che fare con Berta filava. E la rete consente oggi di apprezzarla compiutamente. Fatelo anche voi, andate su
YouTube e digitate il titolo di quella canzone. Tra i molti video, cercate quello
in bianco e nero dell’esibizione del cantautore al programma Rai “Adesso musica”,
puntata andata in onda nel luglio del 1976, come “lancio” del 33 giri Mio fratello è figlio unico appena uscito (il lato B è aperto appunto da Berta filava), una cui gigantografia della copertina appare sullo sfondo di scena. Il video è
abbastanza surreale, ma trattandosi di Rino Gaetano la cosa non sorprende: canta infatti
stando seduto su una pedana molto bassa, facendo rimbalzare una pallina da tennis
e con un cane come spalla (razza cocker), che lo osserva evidentemente avido di veder
lanciata lontano quella pallina per poterla rincorrere.
Il filmato dura 3’15” e dopo meno di una trentina di secondi la ripresa si sposta
dal cantautore in carne e ossa e dal cane, nel frattempo salitogli in braccio, a una
loro riproduzione in cartapesta, ripresa in primo piano con la telecamera che via
via si allontana, lasciando intravedere dell’altro attorno. Mentre la canzone continua,
ecco apparire attorno a quella riproduzione una cornicetta in legno, senza troppe
pretese, da immagine sacra da pochi soldi. E sulla destra di quella cornice c’è appesa
una targhetta bianca, con una scritta che, sembra di capire, deve spiegare al telespettatore
disattento (questo zoom al contrario dura meno di dieci secondi) di che cosa si tratta.
Indovinate la scritta su quella targhetta? Ma certo: EX VOTO, la magnifica ossessione
di Eugenio Cefis. E vista l’assoluta gratuità della presenza di quella cornicetta,
è evidente che si trattava di un messaggio, chissà a chi e chissà a quale scopo. Quella
scritta, tutta in maiuscolo, appare poi piazzata giusto sopra a un fiorellone bianco
che sembra una maxi-margherita da cui pende, riconoscibilissimo, uno di quegli amuleti
napoletani al cui rosso fuoco la tv in bianco e nero di allora non rende giustizia.
È uno dei più tipici, con la mano serrata a pugno escluse due dita, indice e mignolo:
è il gesto delle corna. Perché quando c’è di mezzo Cefis non si sa mai.
Allora in pochi associarono Tanassi e Gui ai Mario e Gino della canzone, poi nessuno
ne ha più riparlato fino all’arrivo del libro di Mautone. Che ha dato la stura a un’autentica
sarabanda di ipotesi su chi fosse il santo «che andava sul rogo / e mentre bruciava
/ urlava e piangeva / e la gente diceva / anvedi che santo / vestito d’amianto». E
giù quindi dotte disquisizioni su Rumor, Moro, Leone... quando invece, a ben vedere,
il concentrarsi sulle ragioni che permettono o meno di indicare uno o l’altro ha fatto
totalmente perdere di vista l’elemento cruciale dell’amianto. E quindi il link che
portava a Cefis. Mautone ha però buttato lì altre suggestioni:
...