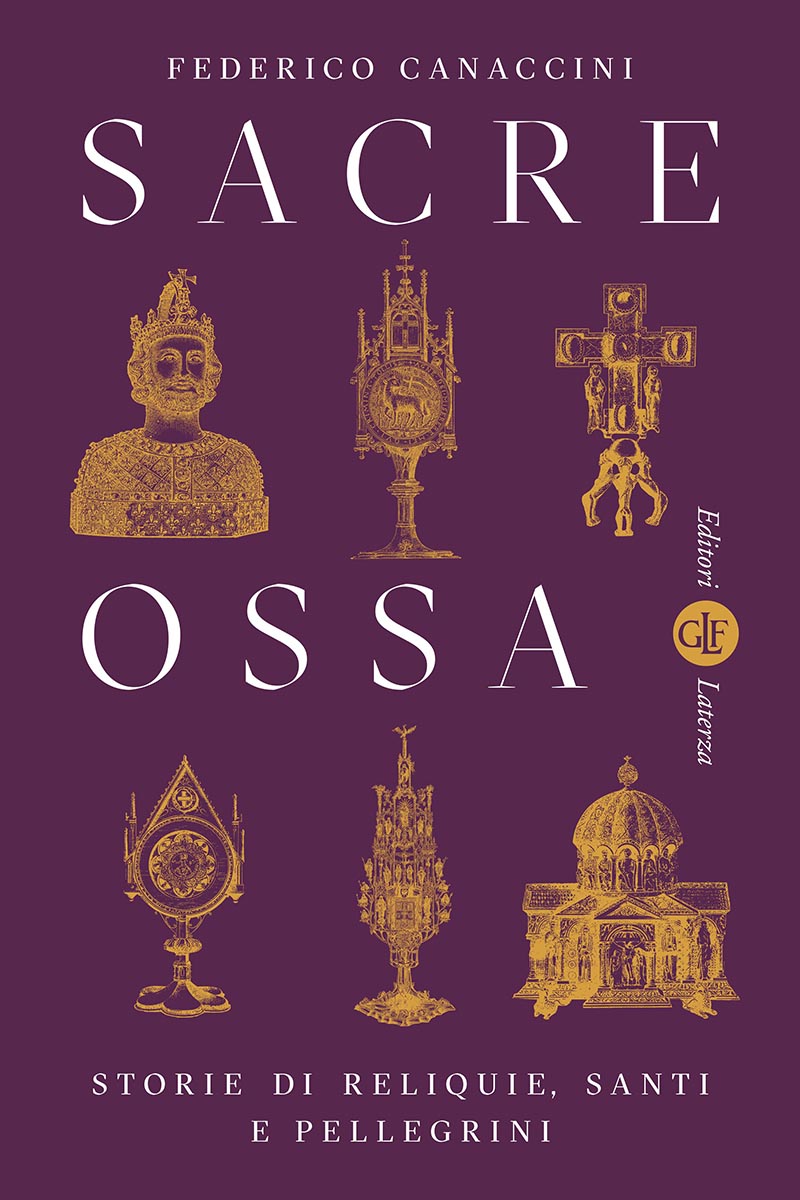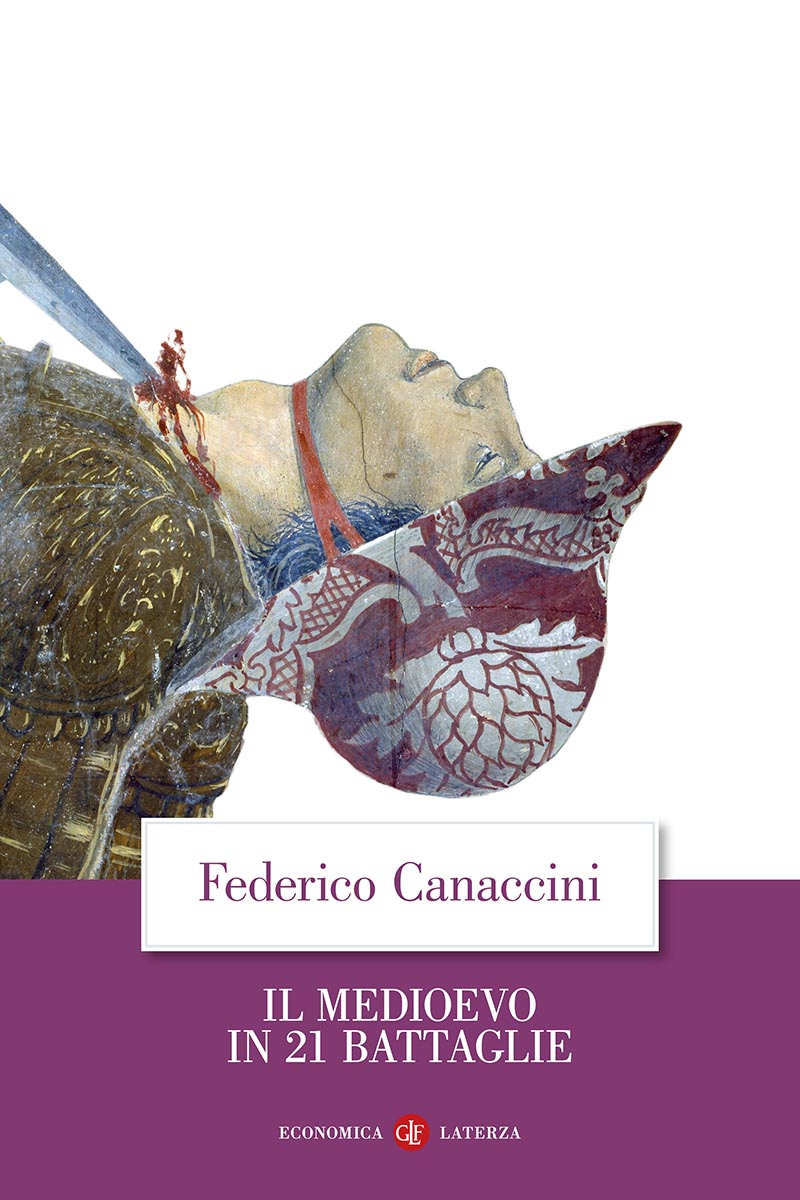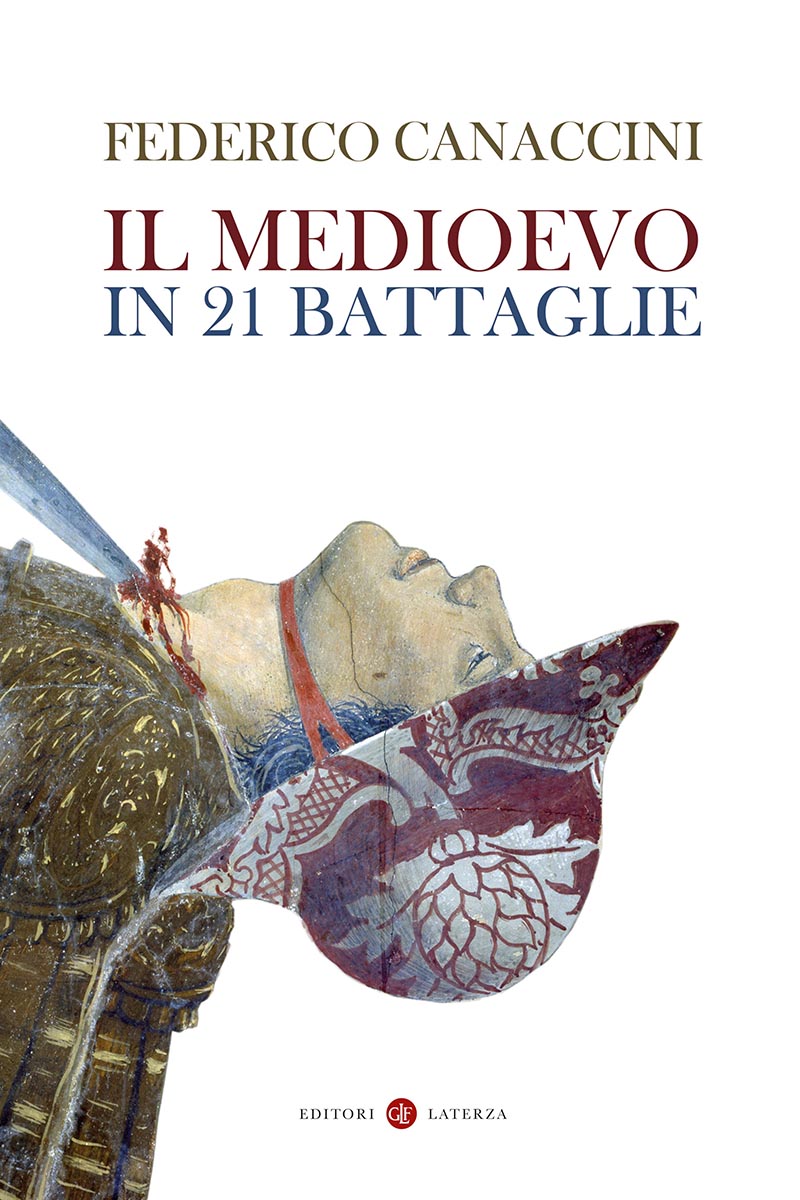Introduzione
Un afoso giorno di giugno, un sabato, in Toscana. Siamo ai piedi di Poppi, nella valle
del Casentino, un luogo ameno. I campi sono ancora parzialmente coperti dalle spighe
ma l’apparente quiete del luogo è brutalmente spezzata da centinaia di strepiti, un
orribile clangore di metallo, nitriti di cavalli e urla disperate di uomini. Un cozzo
colossale di circa 20.000 persone, animate dall’odio e dalla paura. Cos’altro infatti,
se non l’odio e la paura, può indurre un uomo a mettersi «carpone sotto i ventri de’
cavalli, colle coltella in mano» per sbudellarli? Scena agghiacciante e al tempo stesso repellente, trasmessaci da
Dino Compagni che a Campaldino fu probabilmente giovane soldato e testimone oculare.
Più che il valore, se non l’incoscienza, cosa poteva mai indurre tanti uomini a impugnare
uno spiedo, una roncola, e uccidere altri uomini? L’odio. L’odio per il nemico, per
colui che, secondo una valutazione spesso irrazionale, è l’avversario, l’antagonista,
il diverso. L’avversario diviene immediatamente oggetto di scherno, di derisione,
e così gli uni prendono a insultare gli altri, colpendoli nella virilità, «dicendo
che si lisciavano come donne, e pettinavano le zazzere, e gli aveano a schifo e per
niente», dice Giovanni Villani. E, parimenti, a smuovere gli animi è quel sentimento che si insinua in ogni uomo
quando ci si trova con la morte dinnanzi agli occhi: la paura. La paura di morire
in un modo violento e assurdo, magari travolti da un cavallo, colpiti dal fuoco amico
o schiacciati nella morsa mortale di una calca incontrollabile. Giovani e vecchi,
nobili e contadini, laici e persino ecclesiastici.
Siamo a Campaldino, nel 1289, e si risolve con le armi il dissidio che separa due
città e due mondi profondamente diversi: Guelfi contro Ghibellini. Firenze contro
Arezzo. Ma siamo anche in presenza di una guerra civile e di faide interfamiliari.
Chi, o cosa, è ispiratore dell’odio? Da dove proviene la paura? Il tema che fa da
sottofondo al conflitto tra Guelfi e Ghibellini e che sfocia nella battaglia ai piedi
di Poppi pare essere il Male e origine del Male è il Diavolo.
Proprio negli anni attorno allo scontro di Campaldino sarebbe esplosa quella che è
stata definita una «svolta demonologica»: se infatti l’ossessione per il Diavolo pare
non aver costituito «un aspetto essenziale del cristianesimo medievale», essa sarebbe
«emersa repentinamente tra il 1280 e il 1330». In realtà questa perentoria affermazione è stata parzialmente ridimensionata, ma bisogna pur tener presente che, secondo una tradizione giudaico-cristiana, da
sempre «i demoni circondano e tentano gli uomini, e pullulano sulla Terra come mosche,
e sono infiniti come gli atomi». Nonostante l’infinita potenza di Dio, si dovrà attendere l’Apocalisse e la seconda
venuta di Cristo perché il Maligno venga definitivamente sconfitto. Sino ad allora,
«il Principe di questo mondo», quello terreno, di quaggiù, resta Satana, dedito senza
posa a tentare gli uomini, arrivando a sfidare addirittura Cristo nel deserto. Il
Diavolo e i suoi scherani istillano dunque quotidianamente pensieri torbidi nell’animo
dell’uomo, seminano il male, provocano discordie, aizzano fratello contro fratello,
causano cataclismi, malattie, e poi scismi, guerre, morte.
Volendo risalire alle origini del conflitto dei Guelfi e dei Ghibellini, ci accorgeremo
che la presenza del Diavolo è evocata più volte. I nomi stessi delle fazioni deriverebbero,
per più di un intellettuale del tempo, da nomi di demoni o sarebbero, in qualche modo,
connessi con il Diavolo. La genesi dello scontro tra le fazioni si ritrova, stando
alle colorite narrazioni dei cronisti del Trecento, per le vie di Firenze agli inizi
del Duecento. La scissione tra le fazioni sarebbe nata per l’oltraggio recato agli
Amidei da Buondelmonte de’ Buondelmonti. Costui, per riparare un’offesa precedentemente
fatta, avrebbe dovuto prendere in sposa la figlia di messer Lambertuccio degli Amidei.
Tutto era stato stabilito, le nozze erano pronte. Ma a spezzare l’incantesimo ci pensò
il Diavolo: fu infatti «per subsidio Diaboli» che il Buondelmonti accettò l’offerta
di impalmare una Donati, su offerta di madonna Aldruda, e da ciò sorse il lutto, la
divisione della città e, nondimeno, «molti scandali e incendi e battaglie cittadinesche». Aldruda, nuova Eva, è certamente istigata da Satana; Buondelmonte, novello Adamo,
cede alle lusinghe femminili e, come si legge nel libro dell’Ecclesiastico, «dalla
donna ebbe principio il peccato e per sua cagione si muore tutti».
Il male si impossessa così della città del Giglio, Florentia sfiorisce, e una maledizione si diffonde come un virus su tutta la Toscana e poi,
come un miasma, sull’Italia. Conferma e presagio infausto di ciò che sarebbe accaduto
ancora nel secolo seguente, quando un’alluvione nel 1333 trascina in Arno una statua
di Marte posta da tempo immemorabile all’imbocco di Ponte Vecchio, proprio lì dove
Buondelmonte sarebbe stato atterrato da cavallo: l’ira del dio della guerra, risvegliato
ormai da un secolo, aggiunge una nota di paganesimo a un conflitto spesso combattuto,
a quanto dicevano, in difesa della Chiesa dai Guelfi contro gli eretici Ghibellini. Nel commentare l’episodio dell’assassinio di Buondelmonte, consumatosi ai piedi
della statua del dio pagano, l’Ottimo scrisse che «alcuna idolatria si parea per li
cittadini contenere in quella pietra, che credeano che ogni mutamento che ella avesse
fosse segno di futuro mutamento della cittade».
Questa sete di conoscenza del futuro, il tentativo di prevedere gli eventi, richiama
alla memoria la figura dell’astrologo, una figura che nel Medioevo pencolava ancora
tra scienza e magia. Ed ecco che ad aleggiare su Campaldino compare l’ombra di Guido
Bonatti, astrologo di Guido Novello, colui che aveva consigliato l’attacco ghibellino
di Montaperti. Divenuto «Astrologus communis Florentie» lavorò a fianco del Guidi
negli anni di governo ghibellino per poi passare a servizio di Guido da Montefeltro,
fattosi francescano ma strappato all’Ordine da «un nero cherubino» che lo condusse
sino alle profondità dell’Inferno, là dove Dante lo incontra. La figura del Bonatti
destò viva impressione nei suoi contemporanei, soprattutto per la fama di oscura stregoneria
che gli veniva attribuita. Ma la trama di magia nera e stregoneria si allarga, grazie
a Dante: Guido da Montefeltro, infatti, sarebbe stato consigliere financo di Bonifacio
VIII. Il papa, nel corso del processo postumo intentatogli per eresia nel 1310, fu
accusato di avere un proprio demone imprigionato in un anello-talismano: «Egli possiede
un demone privato, dal quale accetta consigli su tutto». Molti cardinali avevano osservato
che quel gioiello sembrava riflettere a volte un uomo, a volte un animale.
Se poi è vero che Dante combatté in prima fila a Campaldino, è anche vero che proprio
lui non fa che evocare suoi concittadini macchiatisi di colpe gravissime, sprofondati
nei gironi più profondi, laggiù dove «son l’anime più nere». Dante incontra il Diavolo
nel corso del suo fantastico viaggio della Commedia, confitto nel Cocito, ma ne fa terribile esperienza sin da bambino, tra le strade
di Firenze, là dove si aggirano, ancora vivi, quanti portano sul corpo o sul volto
i segni della violenza e dell’odio. Molti, infatti, erano sfigurati dagli scontri
urbani, dalle zuffe e dalle battaglie campali: tra tanti, Bindo Tosinghi, già privo
di un occhio, dopo Campaldino morirà a Firenze «fra pochi dì», tra atroci dolori per
le ferite. Ricoverino dei Cerchi, il primo maggio del 1300, perderà il naso in piazza
santa Trinita, «il quale colpo fu la distruzione della nostra città, perché crebbe
molto odio tra i cittadini». Ancora odio che condurrà alla divisione in Bianchi e Neri e all’esilio anche di
Dante. Poi c’è Ghignata Uberti, che deve il suo tragicomico soprannome ad una coltellata
che gli ha squarciato la bocca trasformandola in un eterno quanto orrido e involontario
sorriso, né più né meno dell’odierno Joker che si aggira per le vie di Gotham City.
E quel segno, stampato in volto, quei moncherini, erano il continuo richiamo a una
vendetta che, prima o poi, si sarebbe consumata, o in città o in un campo di battaglia.
La maledizione di Marte divenne una spirale senza fine: la caduta in Arno del simulacro,
nel 1333, non lasciava presagire nulla di buono. Quella stessa alluvione che causa
l’irrimediabile perdita del nume tutelare può essere letta come causata dal Diavolo,
che ha il potere di controllare le nuvole e le saette, oppure essere interpretata
come una sorta di biblico Diluvio, mandato per punire la protervia cittadina.
E con un temporale finisce a Campaldino la giornata dedicata a san Barnaba: l’11 giugno,
infatti, si chiude nell’oscurità, sotto un diluvio scrosciante. La tempesta scatenata
dal Diavolo, scornato per aver perduto l’anima di un peccatore pubblico, Buonconte,
si abbatte sui combattenti, non per mondarli dal sangue e dal peccato, ma solo per
ricoprire di fango il Montefeltro. A smuovere le nubi è la frustrazione del demone,
beffato dal pentimento del condottiero e dalla sua catartica ascesa verso il Purgatorio,
anticamera del Paradiso. Ciò che era nato «per subsidio Diaboli» a Firenze si conclude
dunque a Campaldino, in uno scenario da tregenda, all’imbrunire, «come ’l dì fu spento»,
in una valle coperta di nebbia, dove «quel mal voler che pur mal chiede / con lo ’ntelletto»,
il Diavolo, si trova più a suo agio, tra «il fummo e ’l vento», apparendo e scomparendo «in aere caliginoso», sprofondando migliaia di morti nelle
tenebre «nel piano a pie’ di Poppi, nella contrada detta Certomondo, che così si chiama
il luogo, e una chiesa de’ frati minori che v’è presso, e in uno piano che si chiama
Campaldino. E ciò fu un sabato mattina a dì 11 del mese di giugno, il dì di santo
Barnaba apostolo, degli anni di Cristo 1289».
Un conflitto che nasce da lontano
«In qual parte saprestimi tu dire, dove sia più dilettevole abitare che in Italia?
La quale, dico, se non avesse questo vizio delle divisioni non credo che si potesse pareggiare in niuna parte: ché Italia è troppo piacevole
parte, per le delicatezze che ci si usa». Il confronto tra le fazioni dei Guelfi e Ghibellini, associato prevalentemente all’età
di Dante, turbava le coscienze di molti abitanti d’Italia ancora a metà del Quattrocento
e induceva Bernardino da Siena (1380-1444) a tuonare in piazza a Siena contro coloro
che parteggiano per le fazioni: «Guai, guai, guai a chi abita in terra divisa! E chi
vi abita è come cieco e sordo». Bernardino poi, rivolgendosi agli astanti, domandò:
«Chi è colui che è cieco e sordo? È colui che tiene di parte e fassi di parte o Guelfo
o Ghibellino». Il francescano non aveva dubbi su che cosa fossero le parti e, tantomeno,
su dove conducessero: «Or dimmi: che cosa è parte? Sai che è? È una divisione: questi
da questi. Qui vedi già che parte l’uno dall’altro. Or dimmi: che cosa è carità? Sai
che è carità? È unire l’uno coll’altro. E però tu vedi che costoro sono contrari alla
carità; però che carità è unire, e parzialità è dividare; sì che tu fai contra alla
carità di Dio; sì che l’uno di costoro va a Dio, e l’altro va al Diavolo».
Il tenere partito aveva diviso talmente in profondità famiglie e città che era divenuto
un male endemico e tutti quanti erano dannati. I risultati di questo odio erano più
che mai visibili nelle città, come riporta Giacomo della Marca (1391-1476) quando
scrive che «una parte caccia l’altra, le case vengono distrutte, i loro beni sottratti,
le vigne vanno in malora, i campi si coprono di erbacce, arti e mestieri spariscono,
gli animali vengono divorati, i ragazzi espulsi coi genitori e, costretti dalla povertà,
si riducono all’elemosina, diventano ladri. Alcuni vengono impiccati, altri passati
a fil di spada, alcuni spariscono e concludono la loro vita in modo miserabile, con
una morte crudele». Il brano prosegue e non esclude nulla e nessuno: chiese profanate,
campi abbandonati e poi donne, vecchi e bambini ridotti in miseria. Ma dove, come e perché erano nate «le maladette parti»? E i loro nomi così singolari
da dove giungevano? I cronisti concordano quasi tutti sull’origine fiorentina della
nascita dei Guelfi e dei Ghibellini, ma divergono sull’origine dei loro nomi. In molti,
poi, ne sottolineano un’origine diabolica o associano i nomi a entità demoniache.
Sulla nascita dei due nomi possiamo prendere per buone le parole di Giovanni Villani
(1276-1348), il quale nelle sue cronache ricorda che «i maladetti nomi di parte guelfa
e ghibellina [...] si criarono prima in Alamagna, per cagione che due grandi baroni
là aveano guerra insieme, e aveano ciascuno un forte castello [...] che l’uno avea
nome Guelfo e l’altro Ghibellino, e durò tanto la Guerra che tutti gli Alamanni se
ne partiro; [...] infine in corte di Roma ne venne la questione, e tutta la corte
ne prese parte [...]: e così rimasero in Italia i detti nomi». In realtà il nome dei Guelfi non sarebbe disceso dal maniero familiare, ma dal nome
del duca Welf, cioè Lupo, mentre Weiblingen era proprio il nome di un castello degli Hohenstaufen, vicino
a Heidelberg. L’origine dei nomi fu subito oggetto di studio, ma già nel Trecento
diverse e strampalate ipotesi legavano i due epiteti a origini singolari: consapevoli
delle stragi, delle distruzioni che tali partes avevano arrecato, in molti sottolinearono quasi subito il nesso con Satana.
Saba Malaspina (1240 ca.-98) riporta che «gli uomini inclini a credere qualsiasi cosa
loro riferita» credono che tali epiteti derivassero dai nomi di demoni femminili,
apparsi sulla terra il giorno in cui nacque Manfredi, e subito azzuffatisi sopra la
Toscana. Gli spiriti demoniaci amano manifestarsi «in aere caliginoso», e infatti
queste due donne appaiono «nel cielo nuvoloso sopra la Toscana», «sospese come nebbia
sulla terra».L’evento è poi accompagnato da un sinistro rombo che non rende ben distinguibili i
nomi dei due demoni, avvolgendo l’intero episodio in un’aura di mistero, maligno e
inquietante. Anche per Pietro Azario (1312-66) si tratta di due principi infernali. L’Anonimo Romano riferisce che a Firenze «in questo tiempo fuoro fatte quelle maladette
parti [...]. Una sera [...] nella citate de Fiorenza se appicciaro doi cani. L’uno
abbe nome Guelfo, l’aitro Gebellino. Forte se stracciavano. A questo romore de doi
cani la molta iovinaglia trasse: parte favorava allo Guelfo, parte allo Gebellino». Purtroppo il testo lacunoso non consente di comprendere come da una zuffa tra cani
si giungesse alla lotta politica. È stato notato che il nome di Welf, Lupo, giustificherebbe il riferimento ai cani, ma si ricordi, piuttosto, che il cane simboleggia,
oltre che la fedeltà, anche l’invidia, la più grave colpa di Lucifero.
Si comprende come, man mano che le vicende imperiali si affacciavano in Italia, risvegliando
antiche rivalità per la supremazia politica, le origini della prima contesa venissero
aggiornate, affondando nel mito e nella fantasia. Anche Ricordano Malispini (1220-90)
lega l’origine dei nomi ai castelli familiari. Lapo da Castiglionchio (1316-81) mescola invece le versioni affermando che i nomi
appartenevano a due castelli, «che l’uno si chiamava Guelfo e l’altro Ghibellino»,
appartenenti a due nobili tedeschi in conflitto. Propone un’improbabile etimologia dei due nomi affermando che Gelfi significherebbe «portatori di fede» (ge- da gero, cioè porto,e -fi da fides), mentre Gebellini, «portatori di guerra». Bartolo da Sassoferrato (1314-57), che dedicò alle fazioni
un trattato, associa i due termini a nomi biblici, annettendo Guelfo a Zelpha, citato in Genesi, e Ghibellino a Gelboe, nome di un’altura citata nel Libro dei Re. Tornando però alla realtà storica, subito viziata da congetture fantasiose, per
chiarire la questione sono certamente utili le parole di Ottone di Frisinga (1109-45):
«Due sono state nell’Impero Romano le casate famose: una quella degli Enriciani di
Weiblingen, l’altra dei Guelfi di Altdorf».
Le più antiche attestazioni dei nomi delle fazioni sono documentate a Firenze prima
del 1250. A confermarlo c’è un passo di Salimbene de Adam (1221-88), il quale scrive
che «a Firenze quelli della parte della Chiesa son chiamati Guelfi, quelli della parte
dell’Impero Ghibellini». Il frate chiosa dicendo che proprio «da queste due, in tutta
la Toscana le parti presero i nomi, e ancora li hanno».
«Cosa fatta, capo ha!»
Sempre rispetto alle fantasiose narrazioni riguardanti i nomi delle fazioni, soffermiamoci
ora sul racconto dello Pseudo Brunetto, che circa le origini della divisione fiorentina
propone due momenti distinti ma tra loro connessi. Siamo a Campi, nel 1215, e si tiene un banchetto per l’investitura cavalleresca
di Mazzingo Mazzinghi. Attorno al novello cavaliere siedono molti milites, giovani, dediti al gioco dei dadi, intenti a parlare di una battuta di caccia, di
belle donne, alzando forse il gomito più del solito. Nel bel mezzo della festa irrompe
un giocoliere che, per scherzo, toglie il piatto di portata a messer Uberto Infangati,
giunto alla festa con il suo amico Buondelmonte. Il cavaliere però non la prende bene:
qualcuno alza la voce, vola qualche parola grossa. Oddo Fifanti «villanamente riprese
messer Uberto» il quale, a sua volta, «lo smentìo per la gola». A questo punto Oddo
prese un altro vassoio e lo «gettò nel viso» all’Infangati. La festa divenne un parapiglia
e «quando furono levate le tavole», il Buondelmonti tirò una coltellata al Fifanti
«villanamente fedendolo per lo braccio». Qualcuno avrà diviso i due, ma ormai il danno
era fatto. Il giorno di festa divenne un caso: la questione non poteva rimanere insoluta
e l’offeso chiamò parenti e amici per trovare la migliore soluzione e, alla fine,
«per loro fue consiglato che di queste cose fosse pace»: alla riunione avevano partecipato
gli Uberti, i conti da Gangalandi, i Lamberti e gli Amidei, insomma i vicini e i parenti
acquisiti tramite le politiche matrimoniali.
Per mettere fine allo spiacevolissimo episodio si pensò di combinare delle nozze:
Buondelmonte avrebbe sposato una Amidei, nipote di Oddo. La proposta era piaciuta
a tutti e si era alla vigilia delle nozze: ma a insidiare la pace ci pensò il Diavolo.
Villani scrive infatti che, per subsidio diaboli, Buondelmonte cedette all’offerta di madonna Aldruda Donati. La versione del Villani,
che non riferisce del banchetto e dell’accaduto, ebbe però maggior successo dell’altra.
Ma torniamo alla narrazione dello Pseudo Brunetto. Pur avendo fissato le nozze, proprio
il giorno prima del matrimonio, madonna Aldruda si rivolse al Buondelmonti dicendogli:
«Chavaliere vitiperato, ch’ài tolto mogle per paura dell’Uberti e di Fifanti; lascia
quella ch’hai presa e prendi questa e sarai sempre inorato chavaliere». Il Buondelmonti,
«senza alkuno consiglo», accettò l’offerta della Donati, senza informare neppure i
genitori della Amidei. L’indomani «la gente dell’una parte e d’altra fue raunata,
venne messer Bondelmonte e passò per Porte Sancte Marie e andò a giurare la donna
di Donati e quella delli Amidei lasciò stare, sotto questo vituperio che inteso avete».
Lo sciagurato rifiuta un matrimonio riparatore, senza preavviso, sfilando impudentemente
davanti agli Amidei, ridicolizzando la consorteria e sposando una donna di una famiglia
a loro poco gradita. Il Fifanti si lamentò «della vergogna che lli era stata fatta».
Si fecero varie proposte per punire la sfacciataggine di Buondelmonte: chi propose
di riempirlo di bastonate, chi di tirargli una coltellata in faccia. Alla fine prevalse
la voce di Mosca dei Lamberti che suggerì la maniera più estrema: sbarazzarsi del
Buondelmonti e metterci una pietra sopra. O si arriva in fondo o tanto vale ingollare l’offesa, mettendosi in ridicolo. «Cosa
fatta, capo ha!» avrebbe causticamente concluso il Mosca, dando vita a un modo di
dire per significare come, presa una decisione, non si torna indietro. La vendetta,
per essere soddisfacente, doveva essere consumata là dove la gente attendeva il giuramento
del matrimonio.
E così, il giorno di Pasqua, in vetta al Ponte Vecchio, dove sorgeva la statua di
Marte, Buondelmonte, vestito di bianco, in groppa a un cavallo bianco e con una ghirlanda
di fiori in testa, fu circondato. Un Uberti gli corse incontro al galoppo e lo colpì
«d’una mazza in sulla testa e miselo a terra del cavallo». La corona di fiori si spampanò.
Una volta a terra, col capo sanguinante, un altro lo colpì. Infine sopraggiunse Oddo
Arrighi, col braccio e l’orgoglio feriti dal Buondelmonti: cacciò un coltello dal
fodero e, come suggerito dal Lamberti, «li seghò le vene e lasciarlo morto». Con la
gola tagliata, l’abito di seta bianca si trasforma in un orrido cencio scarlatto. La città fu subito in subbuglio, urla, strepiti e «lo romore fue grande. E fu messo
in una bara e la mogle istava nella bara e tenea il capo in grenbo fortemente piangendo;
e per tutta Firenze in questo modo il portarono». Vendetta chiama vendetta: fu allora che «si cominciò la struzione di Firenze che
imprimamente si levò nuovo vocabile: Parte guelfa e Parte ghibellina».
Le offese al Fifanti e l’omicidio del Buondelmonti acuiscono la tensione che già preesisteva
tra i gruppi famigliari, come ci dice il Villani («con tuttoché dinanzi assai erano
le sette tra’ nobili cittadini»). Certo è che questa serie di episodi innescò una
serie di vendette tra famiglie legate al gruppo dirigente che, per molti aspetti,
era ancora legato a usi feudali, tra cui appunto la vendetta. La narrazione scarna e cruda degli eventi, scevra di riferimenti paranormali, pare
essere nella sua semplicità anche la più verosimile.
Ma per l’uomo del Trecento, costretto a giustificare i successivi decenni di guerre
ed esìli, risultava quasi impossibile non coinvolgere, quale oscuro direttore d’orchestra,
il «principe di questo mondo». Il Villani scrisse infatti che, dopo l’apostrofe di
Aldruda, Buondelmonte «per subsidio diavoli preso di lei, la promise e isposò a moglie, per la qual cosa i parenti della prima donna promessa,
raunati insieme [...] si presono il maledetto isdegno [...], si congiurarono insieme di fare vergogna al detto Buondelmonte». Uno sdegno che, per il Villani, non può che essere maledetto e illegittimo. La prima
delle donne coinvolte in questa vicenda, quella promessa al Buondelmonti, è figlia
di Lambertuccio Amidei e nipote di Oddo Fifanti. Dante, invece, ricordando il Buondelmonti,
addebita al suo rifiuto di unirsi alla Amidei la causa delle loro sventure e poi di
tutta la storia fiorentina: «la casa di che nacque il vostro fleto, / per lo giusto disdegno che v’ha morti». Questo rifiuto pare dunque il casus belli. Ma è solo il primo passo di una trama tessuta con perizia dal Maligno, motore in
negativo che causa la divisione, strumento del Demonio per provocare la scissione.
Altre due donne sono protagoniste di questo intricato disegno: madonna Aldruda e una
delle sue «due figliuole molto belle», la Donati che, quasi involontariamente, con le sue grazie attira Buondelmonte.
Comunque Dante Alighieri, a differenza del Villani che ha una visione negativa della
donna, istigatrice al peccato, evocando il modello della donna-Eva, non ritrova in
una donna il principio della fine. Il casus per Dante non sarà «lo strazio e il grande scempio» dell’Arbia e il tradimento di
Bocca degli Abati, e neppure il motto che fu «mal seme per la gente tosca» esclamato
da Mosca de’ Lamberti. La requisitoria di Dante contro Buondelmonte, per bocca di Cacciaguida, è talmente
veemente che, a ben guardare, la causa della divisione risiede per lui nella debolezza
dello sprovveduto Buondelmonte. Per questo la reazione degli Amidei è per Dante «lo giusto disdegno» e non «il maladetto disdegno» del Villani; e la casata degli Amidei, benché poi bandita, «era onorata,
essa e i suoi consorti». Oltre ad avere una visione politica più matura – Dante è un Bianco, di spessore
politico-filosofico ben più alto del Villani –, si riconosce nel suo pensiero un rispetto
per la donna che non fu sempre condiviso ai suoi tempi. La responsabilità della divisione
in factiones sta per Dante in quella debolezza dettata dalla passione di Buondelmonte, alla cui
schiatta augura una morte prematura così da evitare a monte il disastro: «Molti sarebber
lieti che son tristi / se Dio t’avesse conceduto ad Ema / la prima volta ch’a città
venisti». Se il capostipite dei Buondelmonti, la prima volta che venne in città, anziché salvarsi,
fosse affogato per volontà divina, tutto il male che ne conseguì non sarebbe mai accaduto.
Ma non fu questa la versione di maggior fortuna: serviva una genesi epica per le lotte
di fazione nella storia di Firenze. Non è casuale che alla radice della divisione
vi siano delle donne: l’Aquinate, a proposito del fatto che Eva si lasciò sedurre
scrive che la donna è meno dotata dell’uomo riguardo all’anima, e allude all’incapacità
di resistere e prevedere il pericolo. Siamo in una società ancora molto maschilista
e la tendenza ad addossare la colpa alla donna pare la soluzione più plausibile. E
così, per la memoria collettiva, viene inscenato un piccolo dramma, esemplato sul
modello della Genesi: nella mimetica rievocazione non manca nulla e nessuno.
Lo scenario, nuovo Eden, è la Firenze antica, rimpianta da Dante: Aldruda interpreta
Eva, Adamo è lo sprovveduto e quasi innocente Buondelmonte. Il frutto del peccato
è la bella figlia dei Donati. La trama è nota: Adamo passeggia per il Paradiso Terrestre,
così come se ne va «cavalcando per la città il detto Bondelmonte». Eva, «una gentile donna chiamata madonna Aldruda, [...] mostrogli una delle dette
figliole», dunque offre il frutto del peccato all’incauto Adamo: l’immagine evoca assieme i due peccati carnali, gola e lussuria, i cui organi sono
talmente vicini da eccitarsi a vicenda. Satana ha talmente preso possesso di Aldruda
che, per convincere il bel cavaliere, usa parole cariche di malizia e invidia: «Chavaliere vitiperato, ch’ài tolto mogle per paura dell’Uberti e di Fifanti; lascia
quella ch’hai presa e prendi questa e sarai sempre inorato chavaliere». Il Demonio insinua nell’animo di Buondelmonte il disonore, l’orgoglio, facendo leva
sulla paura e sulla sua superbia. Adamo in un istante cedette e «prese il frutto e ne mangiò»: Buondelmonte tentenna un istante poi, rassicurato, esclama: «E io la voglio». La risposta è analoga a quella del matrimonio, giuramento
fatto davanti a Dio e a testimoni, ma in questo caso è stipulato dinnanzi a Satana
e ai suoi testes.
Il progetto mortifero termina il giorno fissato per le nozze: la vendetta infatti
si consuma proprio il giorno di Pasqua, il giorno in cui Cristo sconfigge la morte.
Il Diavolo non lascia nulla al caso: la vittoria di Satana, nel piccolo Eden fiorentino,
è totale. Alla scoperta del peccato originale Dio disse: «La terra sarà maledetta
per colpa tua [...] essa ti produrrà spine e dolori e mangerai l’erba dei campi».
E analogamente a Firenze la terra fu maledetta, «i cittadini se ne divisono e trassersi
insieme i parentadi e l’amistà di amendue le parti, per modo che la detta divisione
mai non finì». Il Paradiso era perduto. Per sempre.
Toscana: terra di città e di fazioni
Piangano adunque i suoi cittadini sopra loro e sopra i loro figliuoli, i quali, per
loro superbia e per loro malizia e per gara d’ufici, ànno così nobile città disfatta,
e vituperate le leggi, e barattati gli onori in picciol tempo, i quali i loro antichi
con molta fatica e con lunghissimo tempo ànno acquistato, e aspettino la giustizia
di Dio, la quale per molti segni promette loro male siccome a colpevoli, i quali erano
liberi da non poter esser soggiogati.
Dino Compagni (1255-1324) apre così la sua Cronica. Il suo scoramento era certamente motivato dai fatti che, verso il 1300, avrebbero
condotto Firenze alla nuova frattura tra Bianchi e Neri e alle espulsioni che videro,
fra gli sbanditi, lo stesso Compagni nonché Dante. Dino invece, a differenza del poeta,
evitò l’esilio, ma finì tra coloro costretti a stare in città «quatti come topi in
farina». A salvare il Compagni venne in soccorso il suo carattere, teso più alla conciliazione
che all’intemperanza, ma soprattutto una norma statutaria che proibiva processi, fuorché
per gravi fatti di sangue, contro i priori e altre figure istituzionali. Anche se
la sua Cronica coprirà gli anni a cavallo del 1300, Compagni avverte l’esigenza di iniziare, dopo
la triste constatazione dei suoi tempi, proprio dall’omicidio di Buondelmonte. Pur
non volendosi dilungare su «cose antiche, perché alcuna volta il vero non si ritruova»,
il cronista sente come necessario scrivere «questo principio per aprire la via a intendere
donde procedette in Firenze le maledette parti de’ Guelfi e Ghibellini». L’episodio del 1216 divenne dunque il simbolo di un conflitto dapprima strisciante
e poi eclatante: in quell’episodio fu trovato da molti cronisti il casus belli ma,
in realtà, le sue conseguenze sulla lunga distanza vanno certamente ridimensionate
perché l’assassinio consumatosi ai piedi del Ponte Vecchio, pur essendo stato fatto
certamente clamoroso, non fu né l’unico né il più grave. Non riuscendo a distinguere
il falso dal vero, e dovendo trovare una radice a tale maledizione che, come dice
l’Anonimo, «300.000 d’uomini e più ne sono morti, kè l’uno pilgla l’una parte e l’altro
l’altra», i cronisti preferirono attribuirne la responsabilità al gioco di Satana, che scatena
l’odio tra gli uomini e li conduce rapidamente dentro a una spirale di violenza senza
fine.
Se potessimo osservare per un istante i Comuni toscani alla fine del XII secolo, noteremmo
che all’interno delle mura urbane iniziano a distinguersi due gruppi facenti capo
per lo più a due famiglie principali, entrambe animate dall’obiettivo di accaparramento
delle maggiori cariche politiche comunali. Più che di factiones parlerei di fractiones. Nel Lexicon des Mittelalters si definisce factio come un «partito politico», un patto giurato assieme, mentre fractio, «rottura», è una spaccatura in seno alle famiglie urbane, ciò che accade in molti
Comuni italiani.
Immaginiamo di tracciare un cerchio sulla Toscana, del raggio di circa una settantina
di chilometri, ponendone il centro a Firenze. Ci accorgeremmo di come in quest’area,
non poi così vasta, vi sia una densità massiccia di poli urbani: Firenze, Siena, Prato,
Lucca, Pistoia, Pisa sulla costa, Arezzo nell’interno, per non parlare di centri demici
minori. Sia chiaro che tale urbanizzazione è largamente debitrice dell’età romana:
sono infatti rare le fondazioni di città nel Medioevo. La Toscana era una delle aree
più urbanizzate d’Italia e tali centri avrebbero finito per scontrarsi: infatti i
territori su cui si proiettavano queste città non avevano sempre confini ben delimitati
trattandosi, il più delle volte, di valli aperte.
Nello scacchiere della Toscana interna la partita era giocata a tre: Firenze, sempre
più esuberante, Siena e Arezzo. Nel confronto con il Comune dominante alcune città
assunsero una posizione politica segnata più dall’essere «antifiorentine» che schierate
per una fazione. Certamente episodi decisivi, come Montaperti o Campaldino, hanno
marchiato le posizioni delle città coinvolte nel conflitto, e perciò oggi si sente
dichiarare che Siena è ghibellina e Firenze è guelfa. Ma non scordiamoci che a Montaperti, assieme ai senesi, i vincitori sono quei fiorentini
esuli che, di lì a pochi giorni, faranno il loro ingresso in città da signori. E,
per par condicio, ricordiamo che dopo la disfatta di Colle furono stavolta i ghibellini senesi a essere
banditi dalla città e a Siena prevalse un’oligarchia mercantile e bancaria di chiara
ispirazione guelfa.
La città di Siena, per la sua posizione centrale nella regione, si trovò a combattere
più volte contro Firenze per la Valdelsa e il Chianti, e contro Arezzo per il Valdarno
e la Val di Chiana. Nella prima metà del Duecento il governo era affidato al «Consiglio
dei Ventiquattro di Parte ghibellina del Popolo della città e del contado di Siena»:
la posizione politica era inequivocabile e altrettanto era chiaro che si trattava
di un governo di Popolo, non solo di magnati ghibellini. Ma dopo il 1250 anche Firenze
ha un governo popolare, e dunque come è possibile che vi sia una guerra tra due governi
apparentemente di posizioni comuni? Alla base dello scontro, naturalmente, al di là
dell’appoggio senese a Manfredi, vi sono interessi economici. E il successo di Montaperti
trasformò Siena, anche se per una manciata di anni, nella potenza finanziaria più
rinomata d’Europa, capeggiata da stuoli di mercanti e banchieri, con filiali in ogni
dove, nonché dagli esattori delle decime pontificie, scelti proprio tra i senesi.
Proprio il legame con la Curia sarebbe stato il grimaldello del papa per scardinare
il connubio tra Siena e Manfredi: colpiti da scomunica e impossibilitati nei loro
traffici, i senesi perdono presto il primato, sostituiti dagli antagonisti fiorentini.
La battaglia contro Firenze è persa prima sul campo finanziario e poi su quello militare:
nel giugno 1269 l’esercito guelfo di Firenze sconfigge a Colle le truppe ghibelline
di Siena, guidate da Provenzano Salvani, la cui testa finisce su una picca a battaglia
conclusa. «Messere Provenzano Salvani, signore e guidatore dell’oste dei Sanesi, fu
preso, e tagliatogli il capo, e per tutto il campo portato fitto in su una lancia»,
riprendendo la leggenda secondo cui gli sarebbe stato pronosticato che la sua testa
sarebbe stata «la più alta del campo», intesa invece come una brillante vittoria.
Se la pacificazione condotta in Firenze non ebbe successo, a Siena si giunse a un
compromesso nel 1280, a cui seguirono alcuni governi traballanti che sfociarono nel
Governo dei Nove, espressione della oligarchia bancaria e mercantile che avrebbe retto
la città in chiave guelfa sino a metà del Trecento: ma il guelfismo di Siena, a livello
ideologico, non ha attraversato i secoli. Da un punto di vista squisitamente campanilistico
i senesi si percepiscono ancora oggi come «ghibellini»: ma questa identità ghibellina,
tanto per Siena quanto per Arezzo, significava, e ancora oggi in parte significa,
una carica identitaria proprio in quanto in opposizione a Firenze.
Spostandoci a est, incontriamo un’altra grande rivale di Firenze, anch’essa di fama
«ghibellina»: Arezzo, con cui Firenze lottò per il controllo sul Valdarno e la Val
di Chiana, importanti vie di traffico viario e commerciale, sia per terra che per
fiume.
Ad Arezzo si distinguevano, già dal XII secolo, alcune grandi casate come i Bostoli,
guelfi, opposti agli Ubertini e ai Tarlati, di fede opposta. Nel 1241 il vicario imperiale
pacifica le fazioni, e così anche Arezzo accetta podestà di nomina imperiale. Ma dal
1237 sedeva sulla cattedra aretina il vescovo Marcellino, che aveva svolto, con successo,
una missione diplomatica tra i Comuni della Lega e Federico II. Dopo aver mostrato
piena adesione ai dettami imperiali, giurando quale vassallo per il controllo su Cortona,
il vescovo si schierò con Gregorio IX e dovette abbandonare la città, inseguito dai
soldati di Federico. Caduto in mani nemiche nel corso di uno scontro a Osimo (dicembre
1247), fu gettato in carcere. Il 21 febbraio del 1248 Marcellino fu legato mani e
piedi con ancora i paramenti sacri addosso, steso sopra un asino, con il volto sul
posteriore della bestia e condotto al castello di San Flaviano dove, coperto di sterco,
fu impiccato quale traditore. Pare addirittura che successivamente gli scherani dello
Svevo riesumassero il suo cadavere, trascinandolo nel fango, per impiccarlo nuovamente. Il cardinale Raniero Capocci rese l’episodio un simbolo della propaganda antifedericiana,
trasformando Marcellino in una sorta di martire, icona del guelfismo, e abbellendo
il racconto di eventi miracolistici e soprannaturali.
Nello stesso anno veniva eletto vescovo il trentenne Guglielmino Ubertini, che avrebbe
retto Arezzo sino al 1289. In questo quarantennio la città si sarebbe barcamenata
tra le vicende politiche del tempo: Guglielmino, pur di famiglia ghibellina, nel 1255
condusse una schiera di balestrieri in Puglia per combattere contro Manfredi. Nonostante la vittoria ghibellina di Montaperti, si deve attendere il 1262 per giungere
a una pace interna: solo a questo punto i ghibellini, sino ad allora fuorusciti, poterono
rientrare in città. All’arrivo di Carlo d’Angiò, Guglielmino nel 1265 diviene capitano
della Parte Guelfa di Siena, pronto a prestare aiuto ai senesi schieratisi con Carlo.
L’Ubertini si mostra un abile politico, capace di passare da una fazione all’altra,
in base al momento: se Arezzo accoglie molti fuorusciti da Siena, è lo stesso Guglielmino
che promette al papa di cacciarli dalla città in cui egli stesso gli ha offerto riparo.
Nella fase finale della sua carriera episcopale, il prelato riabbraccerà la Parte
Ghibellina: dopo una fase popolare e un fallito tentativo di cooperazione tra le fazioni,
Arezzo conosce infatti un triennio ghibellino (1287-89). I Guelfi fuorusciti chiederanno
aiuto a Firenze che travolgerà Arezzo e i suoi alleati a Campaldino, dove l’anziano
vescovo troverà la morte.
Firenze e Arezzo: mondi diversi destinati a scontrarsi
Dopo le vicende legate all’omicidio del Buondelmonti, Firenze visse in realtà un paio
di decenni di quiete, al punto che il Comune poté impegnarsi nella guerra contro Pisa
e Siena, sue concorrenti nell’espansione politico-economica. Agli inizi del Duecento
non esisteva ancora in Toscana una città in grado di esercitare una funzione dominante.
Firenze perseguiva questo obiettivo, ma Siena la seguiva da presso. Infine, con una
vicenda tutta proiettata sul mare, vi era Pisa, che nei secoli XI e XII aveva trascurato
di espandersi sulla terraferma per puntare sui traffici con l’Oriente e mirare alla
«colonizzazione» della Sardegna. Arezzo, infine, si trovava in una posizione particolarmente
felice, essendo «allo snodo di assi viari fondamentali per tutto il centro Italia,
collocata in posizione geografica dominante rispetto ai percorsi [sia] nord-sud che
est-ovest». La resistenza sarebbe stata a oltranza, ma l’ormai inarrestabile crescita del «Leone»
fiorentino avrebbe travolto il «Cavallo sfrenato» aretino.
Attorno al 1236 a Firenze riprendono le «battaglie cittadinesche», fomentate dall’azione
di Federico II che accentua l’odio interfamiliare: le torri urbane vengono armate
e si collocano in questo periodo le sistematiche distruzioni di palazzi, al punto
che si creano modifiche nel tessuto urbano delle città italiane. Le famiglie dell’antica
aristocrazia consolare si affrettano a stringere legami con i rappresentanti del papa
o dell’imperatore, che sono impegnati in Italia in una nuova contesa e non si astengono
dal promettere o elargire favori. Per far questo le fazioni si organizzano, dando
vita a nuove istituzioni politiche, distinte da quelle consiliari: nascono così le
parti, con un capitano, consiglieri e tutta una serie di apparati, anche militari,
esemplati sui più antichi modelli comunali. Contemporaneamente a questo processo,
però, a complicare il quadro, si pone la nascita delle cosiddette «Società di Popolo»,
rappresentate da membri della ricca borghesia inurbata, e che reclamano una partecipazione
al governo, scontrandosi con i magnati, detentori, sino ad allora, del potere politico.
Questi dissidi, fra l’altro, rendono impossibile una qualsiasi politica, che spesso
viene congelata dagli scontri interni, e Firenze rischia di sprofondare in una crisi
economica e di divenire facile bersaglio per attacchi dall’esterno. Ma il conflitto
oramai si è esteso oltre le mura fiorentine grazie all’azione del papa e dell’imperatore,
i quali intervengono sostenendo o avversando le parti che si richiamano ai due poteri
universali. Ciò che era nato come un fenomeno locale è ormai divenuto un conflitto
intercittadino: la guerra di fazione diviene una guerra totale, che scavalca gli interessi
cittadini, e si inserisce all’interno di un più vasto scontro politico che riguarda
l’intera cristianità.
Nel 1249 giunge in Firenze Federico di Antiochia, figlio dell’imperatore, con un contingente
di milizie tedesche. Federico II avrebbe sempre evitato di entrare a Firenze per un
presagio che aveva decretato che egli sarebbe morto «sub flore»: per questo fece edificare l’unico grande castello del Centro Italia nella vicina
Prato, con l’obiettivo mal celato di controllare Firenze. All’arrivo delle milizie
tedesche, i Guelfi furono costretti a lasciare la città, disperdendosi tra borghi
e fortilizi amici. Tutt’altro che domi, ingaggiarono una guerra di logoramento coi
Ghibellini, i quali si videro costretti a inasprire le tasse. Dopo una sollevazione
popolare, i mercanti estromisero i Ghibellini dal governo: a ciò si aggiunga che,
il 13 dicembre 1250, l’imperatore moriva. Nel volgere di un triennio le sorti mutarono
rapidamente: prima furono i Guelfi a prendere la via dell’esilio (1249); l’anno seguente
i Ghibellini furono privati dal Popolo della possibilità di attività politica; dopo
la morte di Federico IIi Guelfi rientrarono in città, con l’appoggio del Popolo, e bandirono i Ghibellini
(1251). La città cresceva e si trasformava anche a livello urbanistico: rispetto alla
civitas vetus, caratterizzata da blocchi di case-torri dotate di curtis e ricalcata sull’impianto romano, la nova si caratterizzava per una maggiore ariosità, con borghi sorti lungo le nuove strade
vicine agli insediamenti conventuali che, per tutto il Duecento, animavano la città:
Santa Maria Novella, Santa Croce, Santissima Annunziata. Dopo la morte di Federico
II i lavori ripresero con maggior vigore: furono inaugurate le chiese di Santo Spirito,
quella di Ognissanti e quella del Carmine, e fu inaugurato un gran numero di conventi
e strutture ospedaliere aperte per accogliere vecchi, malati e pellegrini. Proprio
negli anni del conflitto con Arezzo fu aperto quello che sarebbe divenuto uno dei
più grandi nosocomi europei, l’ospedale di Santa Maria Nuova, in grado di ospitare
all’epoca 17 degenti: il fondatore fu tal Folco Portinari, il padre della Beatrice di Dante. Venne riedificato
il ponte di Santa Trinita che andava ad aggiungersi ai tre precedenti che attraversavano
l’Arno: Ponte Vecchio, ponte alla Carraia e ponte alle Grazie. Se Firenze era divenuta
celebre in Europa, a questo punto doveva mostrare la propria potenza e la propria
bellezza ai mercanti e banchieri forestieri che quotidianamente vi giungevano: la
forza di una città si vede anche nelle dimensioni, nelle sue mura, nei suoi monumenti,
nella sua estetica fatta di pietra. La città fu dunque abbellita con il rinnovamento
di spazi pubblici, come la piazza del Duomo e alcuni tratti del Lungarno e fu iniziata
la pavimentazione di alcune strade.
L’indirizzo popolare del nuovo governo si manifestò anche nell’urbanistica: fu infatti
stabilito che venissero scapitozzate e abbassate tutte le torri private, edificate
prevalentemente nella civitas vetus, quella di epoca romana e matildina. Le torri non avrebbero potuto superare le 50
braccia di altezza: cambiava la fisionomia della città, adeguandosi alla fisionomia
politica. È infatti proprio di quegli stessi anni la decisione di costruire il Palazzo
del Popolo, il Bargello, che inglobò l’antica torre detta «la Volognona», utilizzata
come torre campanaria per convocare la popolazione. Firenze era in rapida espansione
demografica ed economica: gli abitanti, tra il 1125 e il 1280, erano più che triplicati,
sfiorando le 80.000 persone, e la coniazione del Fiorino, nel 1252, fu il segno che
questa città era avviata a divenire la potenza bancaria più importante dell’Occidente.
Il governo di «Primo Popolo» avrebbe probabilmente voluto porsi come ago della bilancia
fra le due partes e ben presto riammise in città le famiglie ghibelline espulse. Ma se all’inizio si
presentò equidistante, ben presto iniziò a propendere per la fazione guelfa. Ciò si
manifestò palesemente nel 1258, quando Manfredi, re di Sicilia, riprese l’attività
politica in Toscana, incontrando resistenza proprio a Firenze. A quel punto le famiglie
ghibelline, con in testa gli Uberti di Farinata, furono nuovamente espulse e trovarono
ricetto principalmente a Siena, dove, con le milizie inviate da Manfredi, prepararono
il proprio ritorno. Il 4 settembre del 1260 a Montaperti si consumò una sanguinosa
battaglia il cui esito avrebbe portato i Ghibellini al governo di Firenze: un esercito
composto da senesi e fuorusciti ghibellini fiorentini sconfisse quello popolare e
guelfo di Firenze. Farinata e i suoi facevano ingresso trionfalmente in città, ridotta
parzialmente in macerie per le distruzioni operate dai Guelfi, mentre gli avversari
abbandonavano Firenze trovando riparo chi a Lucca, chi addirittura a Bologna. A completare
l’opera di distruzione furono ora i Ghibellini, che presero ad abbattere le torri
degli avversari, trasformando Firenze in un cantiere a cielo aperto.
La Toscana issa bandiere sveve su quasi tutti i castelli e le città: Arezzo e Lucca
resistono contro le milizie di Manfredi e della Lega ghibellina. Ma anche esse cederanno,
la prima nel 1262, la seconda nel 1263. A questo punto della vicenda storica interviene,
chiamato dal papa e pagato dalla Curia e dai banchieri fiorentini, colui che risolleverà
le sorti del guelfismo e della Chiesa, ponendo fine alla casata sveva: Carlo I re
di Sicilia, conte d’Anjou e del Maine (Carlo d’Angiò). Con una duplice vittoria militare,
prima a Benevento (1266), poi a Tagliacozzo (1268), Carlo riesce a estirpare «la razza
di vipere» sveva, costringendo i Ghibellini ad abbandonare le loro città e piazzeforti.
Nel 1267, dopo alcuni tentativi di governo misto, molte famiglie ghibelline sono costrette
a lasciare la città, caduta in mano a un contingente angioino, che appoggia un governo
di simpatia guelfa interessato a espropriare e vendere immediatamente i beni immobili
degli avversari. La lotta oramai è giunta al culmine: Carlo ottiene la carica di podestà
per la durata, assolutamente inedita, di sette anni e viene nominato «paciarius generalis».
Un tentativo di pacificazione delle partes giunse nel giugno 1273 per volere di papa Gregorio X, il quale però, pressato dalle
lamentele dei Ghibellini e dalle lungaggini dei Guelfi, lanciò l’interdetto sulla
città e la scomunica sui Guelfi. Tentando una pacificazione, Gregorio si era circondato
di quattro prelati, destinati a succedergli sul soglio pontificio: i francesi Pierre
de Tarantaise, domenicano, e Simon, cardinal-prete di Santa Cecilia; gli italiani
Ottobuono Fieschi e Giangaetano Orsini. Oltre a questi, vi erano anche due parenti
del cardinale Ottobuono, il domenicano Bonifacio, arcivescovo di Ravenna, e un giovane
Percivalle Fieschi da Lavagna, che tanta parte avrebbe occupato nelle vicende di Campaldino
in qualità di vicario imperiale. Il papa si recò poi in Francia, dove si trattenne
due anni. Rientrato in Toscana, la trovò così come l’aveva lasciata e pochi mesi dopo,
minato dalla malattia, morì ad Arezzo il 10 gennaio del 1276. La fama di santità di
Gregorio si diffuse rapidamente a Piacenza, sua città natale, ma anche ad Arezzo e
per la Toscana: la sua immagine fu dipinta o scolpita sulle chiese e per le strade
della città in cui si svolse la cerimonia funebre. Dalle campagne iniziarono a giungere
persone inferme o possedute, convinte che la potenza esorcistica dell’anima di papa
Gregorio li avrebbe liberati dai demoni.
Morto il papa che tanto si era dato da fare per una tregua, la situazione tornò ad
essere incandescente: a Volterra si tentò una pace che non giunse a nulla; a San Gimignano
il ghibellino Nanza Paltoni uccise suo fratello a picconate, per poi riparare a Pisa;
a Colle scoppiò addirittura una guerra civile. Prima dell’elezione di Niccolò III,
nel 1277, morirono ben tre papi nel giro di due anni: il nuovo eletto, intimorito
dallo strapotere di Carlo d’Angiò, tentò di mitigare la lotta in Toscana, facendo
suggellare matrimoni pacificatori. Ma l’azione del cardinal Latino, suo inviato, pur
essendo ben strutturata, non poteva durare: la riforma infatti prevedeva la creazione
di 14 magistrati, otto guelfi (di cui sei Popolari) e sei ghibellini (di cui due Popolari).
Così congegnato il lodo non lasciava ben sperare e infatti, dopo pochi mesi, sorsero
nuove violenze. A ciò si aggiunga anche una serie di congiunture che risvegliò antichi
rancori e vecchie ideologie. Dopo una lunghissima vacanza imperiale, era stato eletto
re dei Romani Rodolfo d’Asburgo. Sul soglio di San Pietro, invece, sedeva ora un papa
francese, Martino IV, apertamente favorevole agli Angioini, i quali però assistevano
ai Vespri Siciliani, che il cronista Paolino Pieri non sapeva dire se fossero stati
opera di Dio o del Diavolo. A Firenze, poi, i Popolari riprendevano il potere, istituendo il Priorato delle
Arti (15 giugno 1282) ed emarginando i magnati, dando vita a una nuova costituzione,
basata sulle corporazioni mercantili e artigiane. I Guelfi, pur estromessi, avevano
l’opportunità di risiedere in città; per i Ghibellini, invece, ogni possibilità di
partecipazione alla vita politica era decisamente preclusa.
Firenze sta diventando anno dopo anno una superpotenza regionale, rinomata a livello
internazionale per i suoi prodotti e per il fiorino d’oro, apprezzato e utilizzato
ovunque. Negli anni che precedono lo scontro con Arezzo, Firenze si lancia in un’ulteriore
e colossale impresa, consapevole di ciò che il futuro potrebbe riservarle. La costruzione
della nuova cerchia di mura, finalizzata a proteggere i nuovi quartieri della città,
ha infatti inizio il 2 febbraio del 1285, ma viene bruscamente interrotta tre anni
più tardi: la guerra con Arezzo era iniziata.
«E’ Fiorentini che sempre me fenno / ingiuria per recarmi al lor contado», scriveva
nel Trecento ser Bartolomeo nella sua Cronica, quando oramai Arezzo era caduta sotto il dominio gigliato. Firenze tentò, sin dagli
albori della civiltà comunale, di farsi largo verso nuovi mercati e il Valdarno divenne
teatro di plurimi scontri con Arezzo che, nel Duecento, si rese protagonista di una
rapida espansione. Sino al 1289. La sconfitta di Campaldino non coincise però con
l’immediata sottomissione a Firenze, con cui Arezzo continuerà a scontrarsi, con alterne
vicende. Si trattò certamente di una brusca battuta d’arresto, a cui tuttavia seguì
ancora una pagina di espansione, ad opera dell’intraprendenza del vescovo Guido Tarlati,
ai primi del Trecento.
Arezzo – proprio perché la sua posizione era vantaggiosa per i traffici – dovette
misurarsi con molti Comuni dell’Italia centrale: con Firenze a nord, ma anche con
Siena a ovest, e con Perugia a est. Se con queste ultime il confronto fu frequente
ma altalenante, con la città del Giglio lo scontro fu continuo e feroce: la posta
in palio erano le valli, Casentino, Valdarno e, in parte, Val di Chiana. Il fatto
che Arezzo si trovasse al centro dell’Appennino in un primo momento la favorì, ma
poi fu di fatto uno svantaggio perché rimase tagliata fuori da quelle rotte commerciali
e culturali che invece attraversavano città come Firenze, dalla quale fu infine sconfitta.
Arezzo aveva avuto uno sviluppo politico simile a quello di altri Comuni dell’Italia
centrale: dopo la fase consolare vi compaiono i primi podestà, che si affermeranno
nel Duecento. E, come a Firenze, anche ad Arezzo iniziano a emergere gruppi familiari
interessati alla gestione della res publica. Gli anni coincidono con le vicende di Buondelmonte e anche qui, artefice o complice
delle divisioni è, ancora una volta, il Diavolo: a testimoniarlo è un passo della
Legenda Maior, la biografia di Francesco d’Assisi composta da Bonaventura da Bagnoregio tra il
1260 e il 1263. È singolare che l’episodio non sia stato inserito nella prima biografia
del santo, ma che, a cavallo degli anni ’40 e ’60, quando il confronto tra Papato
e Impero si fa più serrato, si senta l’esigenza di ricordare l’intervento pacificatore
di Francesco.
Nel 1217 Francesco, diretto in Francia, è a Firenze, dove incontra il cardinale Ugolino
che lo convince a restare in Italia. Francesco ha quindi avuto esperienza del clima
di odio che serpeggiava a Firenze e, quando giunge ad Arezzo, in data imprecisata
ma prossima, incontra analoghe divisioni tra le famiglie aretine.
Bonaventura narra che «quando il beato Francesco vide sopra la città di Arezzo i demoni
esultanti, al suo compagno disse: “Va’, e in nome di Dio scaccia i diavoli, così come
dal Signore stesso ti è stato ordinato, gridando da fuori la porta”. E come quello
obbedendo gridò, i demoni fuggirono e subito pace fu fatta». Nella decima scena del ciclo giottesco della Basilica Superiore di Assisi, si vedono
i due frati, presso il Duomo vecchio, che cacciano i diavoli da Arezzo. Dobbiamo supporre
che il miracolo dell’Assisiate risieda nella potenza delle parole da lui utilizzate
in una predicazione indirizzata – più che contro i demoni – contro i litigiosi aretini.
Sono anni di fermento politico ad Arezzo: nel 1196 si menziona una concio, l’assemblea dei cittadini, mentre due anni più tardi si cita un parlamentum. Sono termini che, nella loro indefinitezza, mostrano «una struttura comunale ancora
fortemente in embrione» e quindi anche soggetta a frizioni: nel 1209 compare il Consiglio della Campana,
forse un consiglio allargato. Nel 1215 fu poi eletto podestà Guelfo dei Bostoli, il
cui nome ne chiarisce l’indirizzo politico: approfittando di questa nomina, la famiglia
sottrasse al Comune i castelli di Capolona e Rondine, restituendo il primo all’abbazia
con cui essa aveva stretti legami. L’episodio scatenò una guerra civile che potrebbe
essere quella di cui stiamo parlando e che fu placata con un’amnistia forse proprio
nel 1216: non sapremo mai se Francesco ebbe un ruolo in questa pacificazione. Certo è che
la coincidenza temporale sarebbe impressionante, anche in relazione agli analoghi
fatti fiorentini. Solo nel 1222 si giunge a una definizione più compiuta del massimo
organo consultivo aretino: il «Consiglio generale della Campana dei Duecento». La
nascita di questa istituzione non dovette essere lineare e pacifica: del resto, se
dopo il miracolo di Francesco «i demoni fuggirono e subito pace fu fatta», ciò può
significare che la città aveva attraversato un periodo di guerra civile, forse tra
il vescovo e il Comune, simbolicamente raffigurato nell’opposizione tra il Duomo vecchio
e la città. Il Diavolo, dopo aver sconvolto Firenze, era volato fino ad Arezzo e aveva
seminato rancore se i demoni, a detta di Bonaventura, esultavano in cielo per il loro
successo.
Il Duecento aretino può essere definito «l’epoca di Guglielmino», sia cronologicamente,
sia anche perché il suo mandato quarantennale coincide con «una fase particolarmente
saliente dello sviluppo urbano e architettonico di Arezzo», che rilancia «un globale
riordinamento e riassetto della città che si riqualifica come rinnovato capoluogo
di una vasta diocesi».
I primi secoli del Basso Medioevo aretino furono contraddistinti dal confronto tra
un consolidato potere episcopale e un nascente Comune: il nucleo altomedioevale urbano
ebbe infatti un primo ampliamento con la rinascita della città attorno al fatidico
anno Mille. Questa dialettica politica avrebbe contribuito non poco alla definizione
di città: Arezzo si espanse sul Poggio San Pietro dove sorgeva la chiesa di San Pier
Maggiore e successivamente verso valle, assumendo una tipica «forma a ventaglio» il cui interno era ed è intersecato a raggiera da strade ampie e regolari. Dalla
Porta Burgi si delineò un nuovo asse, il Borgo Maestro, destinato a divenire il principale;
da Porta del Foro, in coincidenza con il decumanus, si affermò la direttrice della Piaggia di Murello. L’ultima via principale infine,
l’attuale via Pellicceria, corrispondeva all’antico cardo romano.
Tra XII e XIII secolo, dunque, la città crebbe: nel 1194 fu iniziata la costruzione
di una nuova cinta muraria che inglobò la Pieve di Santa Maria e la Platea Communis, cui fu data sistemazione già nel 1200. Questa nuova cinta inglobava i borghi che
si erano formati nel corso del XII secolo, racchiudendo un’area di circa 55 ettari.
Nel 1196 la porzione di mura a sud, l’area più vulnerabile, era stata ultimata: era
rinforzata dal torrente Castro, ulteriore difesa della città su cui sorgevano diversi
mulini. La crescita di Arezzo proseguì fervente per tutta la prima metà del Duecento,
come testimonia l’istituzione di uno Studium presso cui, nel 1215, insegnò, in qualità di lettore di diritto, il famoso magister Roffredo Epifanio da Benevento, e poi Martino da Fano e ancora Bonfiglio d’Arezzo
e Mino da Colle. Nel 1200 erano state completate le mura e la piazza principale, centro
economico della città, detta Platea porcorum. Da allora in poi la piazza avrebbe assolto anche funzioni politiche, divenendo uno
spazio aggregante, emblema dell’affermazione comunale. Nel 1203, «il vescovado, chiesa
e Duomo vecchio, fu levato e fu posto drento a la città»; trenta anni dopo fu costruito il Palazzo comunale e nel 1241 lo Studium – per il quale Roffredo lamentava la mancanza di alloggi adeguati – fu trasferito
negli annessi di San Pier Piccolo.
Dicevamo che l’espansione urbana creò tensioni tra Guglielmino e il Comune: la preminenza
dei vescovi aretini aveva radici lontane ed era parzialmente il risultato dell’iniziativa
degli imperatori, già in età carolingia. Al progetto imperiale, teso a favorire il
vescovo in città, faceva eco nel contado il dinamismo del presule che tentava di svincolarsi
dalle ingerenze regie. Questo meccanismo si tradusse, sul piano urbanistico, nella
scelta di riorganizzare la città e la diocesi: perciò Arezzo ebbe due poli cattedrali,
uno urbano e uno extraurbano. Il primo presso la Pieve, che divenne sede episcopale;
il secondo presso il colle del Pionta, fuori dalla città, simbolo dell’autonomia dell’episcopio,
là dove il vescovo Donato avrebbe subito il martirio. Si dovrà attendere Guglielmino per sanare questa dicotomia e avere finalmente un
Duomo intramurario.
Nei decenni successivi, però, non fu solamente il vescovo ad accrescere il proprio
potere, giacché anche il neonato Comune prese coscienza della propria forza. La volontà
di popolare la città si scontrava con gli interessi episcopali, al punto che nel 1234
Gregorio IX scrisse al vescovo di Sarsina chiedendogli di invitare il podestà aretino
a espungere dallo Statuto un capitolo che incoraggiava i coloni a immigrare in città,
concedendo loro alcuni diritti ritenuti dannosi per il vescovo. Questi uomini, che
troviamo citati nel 1284, quando «venerunt comitatini ad habitandum Arretium», dovettero
popolare l’area oltre il torrente Castro, dando vita a nuovi piccoli borghi extramurari:
perciò, per proteggere la città, fu aggiunto un sistema di fossati e palizzate che
sembra essere ancora attivo nel 1289, quando, dopo Campaldino, la città sotto l’assedio
era ancora «senza mura, con stechata et fossa».
Nel corso del Duecento si osservano le maggiori trasformazioni legate al confronto
tra vescovo e Comune: dopo la vittoria guelfo-angioina degli anni ’60, anche Arezzo
visse anni convulsi, che videro il Popolo ottenere un significativo riconoscimento
politico. Tale affermazione trovò una corrispondenza nell’erezione del Palazzo del
Popolo, conclusosi nel 1278. D’altra parte non era certo un caso che anche Guglielmino
e il Capitolo avessero deciso di intraprendere l’inizio dei lavori della nuova cattedrale,
posta sul poggio San Pietro, nel 1277, come «mirabile espressione visiva del potere
spirituale e civile esercitato dal Vescovo» e dunque inequivocabile risposta alla Pieve, chiesa dell’autorità civica. Guglielmino
aveva già dato un segnale nel 1256, con la costruzione di un nuovo Palazzo vescovile.
Il Palazzo del Popolo sorgeva nella parte alta della città, dove svettavano le torri
delle famiglie signorili: la concentrazione in questa zona dei palazzi del potere
conferiva a questi edifici un’aura di alta auctoritas e li identificava come il centro direttivo. Il confronto tra i poteri che animavano
il ceto dirigente trovava conferma nella volontà di prevalere anche in una sorta di
«tenzone architettonica».
L’estetica urbana cominciò a funzionare anche ad Arezzo come mezzo di comunicazione
politica: infatti il decoro urbano non fu solo inteso come atto a migliorare le condizioni
di vita, ma anche come un vero programma politico. Con Guglielmino la città e il suo
contado furono interessati da un «piano regolatore»: oltre ai cantieri dei grandi
palazzi pubblici, nel 1269, «fu fatta la Fonte Vinitiana fora de la cità» per l’approvvigionamento
idrico (si dovrà attendere invece il 1354 perché Jacopo del Casentino, modificando
un acquedotto romano, porti l’acqua in città, rifornendo la fontana di Piazza Grande).
Nel 1277 fu poi realizzato il Ponte a Buriano, che «costò un gran denaio» e grazie
al quale il contado aretino fu connesso al territorio al di là dell’Arno. Nel 1278
fu creato un bacino idrico artificiale a Broglio e furono completate le Vie recte, forse grandi arterie di comunicazione che uscivano dalla città e che attraversavano,
in modo rettilineo, il planum Aretii. Dalla città, dunque, si dipartivano strade che erano il simbolo di un centro urbano
proiettato sul contado, a sottolineare un’ideale prosecuzione del controllo politico
della città sul territorio.
L’ambizione di Arezzo, però, entrava in collisione con quella di Firenze, che da anni
meditava la conquista del Valdarno e non disdegnava certo di puntare gli occhi sui
boschi, gli alpeggi, i pascoli e i castelli del Casentino. La popolazione urbana cresceva
e con essa le necessità: in caso di carestia, la ricaduta poteva essere devastante.
Nel 1286 «spezialmente del mese d’aprile e di maggio, fu grande caro di vittuaglia
in tutta Italia, e valse in Firenze lo staio di grano alla misura cara soldi XVIII,
di soldi XXXV il fiorino d’oro». Si dovevano trovare con tutti i mezzi, nuovi campi da cui trarre grano, uva, frutta:
anche a costo di combattere.
Ai margini delle città: Valdarno e Casentino
Tra i protagonisti di Campaldino si erge per spessore Corso Donati. «Il Barone», come
era soprannominato, affermava con veemenza nelle sedute dei Consigli che tutti i territori
confinanti col contado fiorentino dovessero ricadere a «iurisdictionem Communis Florentiae», grazie ad accordi o con la guerra: fra i territori interessati c’erano anche la
fertile vallata del Valdarno e quella boscosa del Casentino. Già nel 1256, ad Arezzo,
si era svolta una solenne cerimonia finalizzata a riportare la pace interna fra le
partes, sotto egida fiorentina. I patti stipulati comprendevano legami con Firenze; il regime
instaurato ad Arezzo, benché definito equanime, era chiaramente guelfo, perciò destinato
a provocare malcontenti. Di questi disordini avrebbe approfittato la città rivale
e oramai dominante.
L’economia aretina del Duecento si basava sull’agricoltura, favorita da un territorio
ampio e vario, e su una ricca attività mercantile. Dalle valli aretine partivano per i mercati fiorentini grandi quantità di cereali,
vino, lana, cuoio, pelli, e prodotti caseari. Arezzo non superò mai i 15.000 abitanti
e questo le permise un’intensa attività di esportazione, sfruttando il proprio contado
che andava dalle montagne casentinesi alle ampie valli del Tevere e dell’Arno, sino
alla lacustre Val di Chiana, dove cresceva il guado, una pianta tintoria da cui era
ricavato il blu pastello, ricercato nella pittura e nell’industria tessile che fioriva
a Firenze, verso cui ne venivano esportati grandi quantitativi. Tutti quanti noi facciamo
ancora esperienza quotidiana – benché in modo indiretto – di questo prodotto, giacché
dal guado veniva ricavato l’indaco dei pantaloni in tela indossati dagli operai americani
del secolo scorso: sto parlando, naturalmente, dei blue-jeans.
La valle che si estende dal Ponte a Buriano sino a Firenze prende il nome di Valdarno
di Sopra, fiancheggiata dal massiccio del Pratomagno a est e dalle colline del Chianti
a Ovest. Si tratta di una valle ampia, i cui confini non sono sempre facilmente definibili
ma che, stando al Repetti, potrebbero essere rinvenibili a nord nella strettoia dell’Incisa
e a sud nell’area attorno al borgo di Levane.
Prima di giungere agli anni culminati nello scontro di Campaldino, il Valdarno aveva
vissuto una particolare condizione politica, poiché il suo centro era abbastanza lontano
sia da Firenze che da Arezzo. A lungo i due Comuni non si interessarono de
...