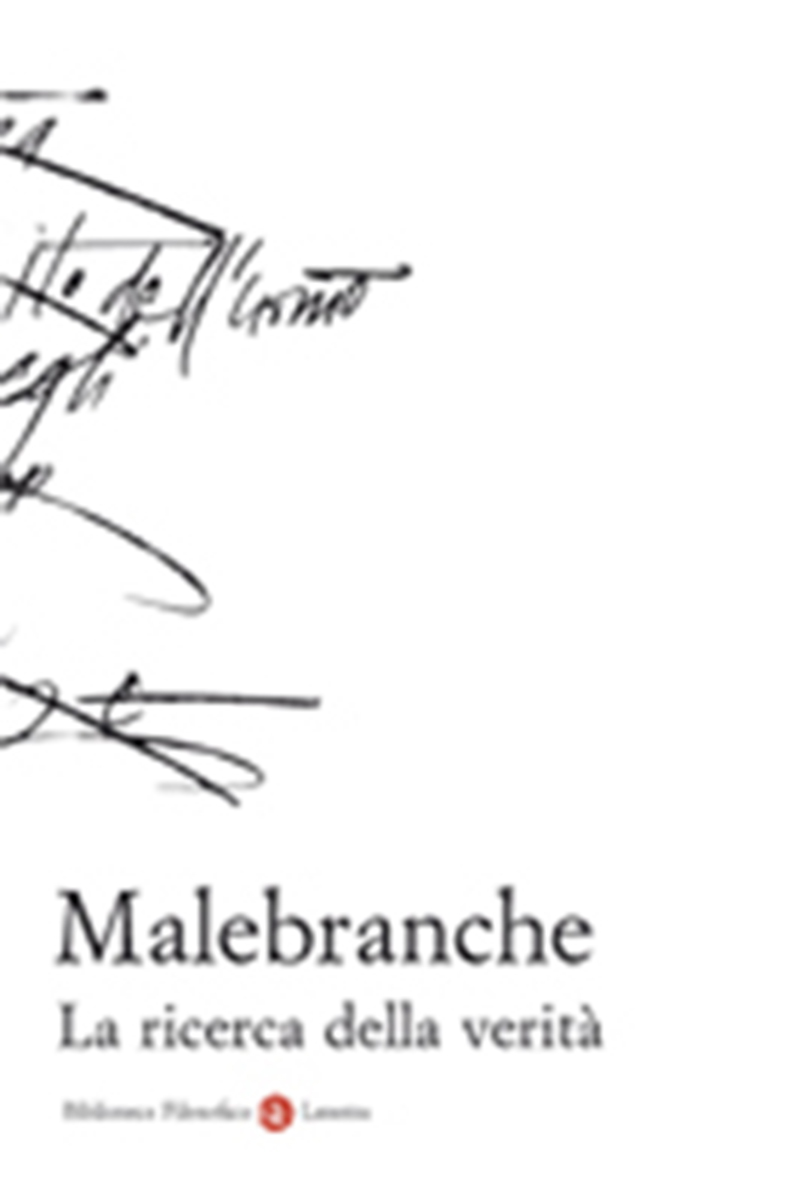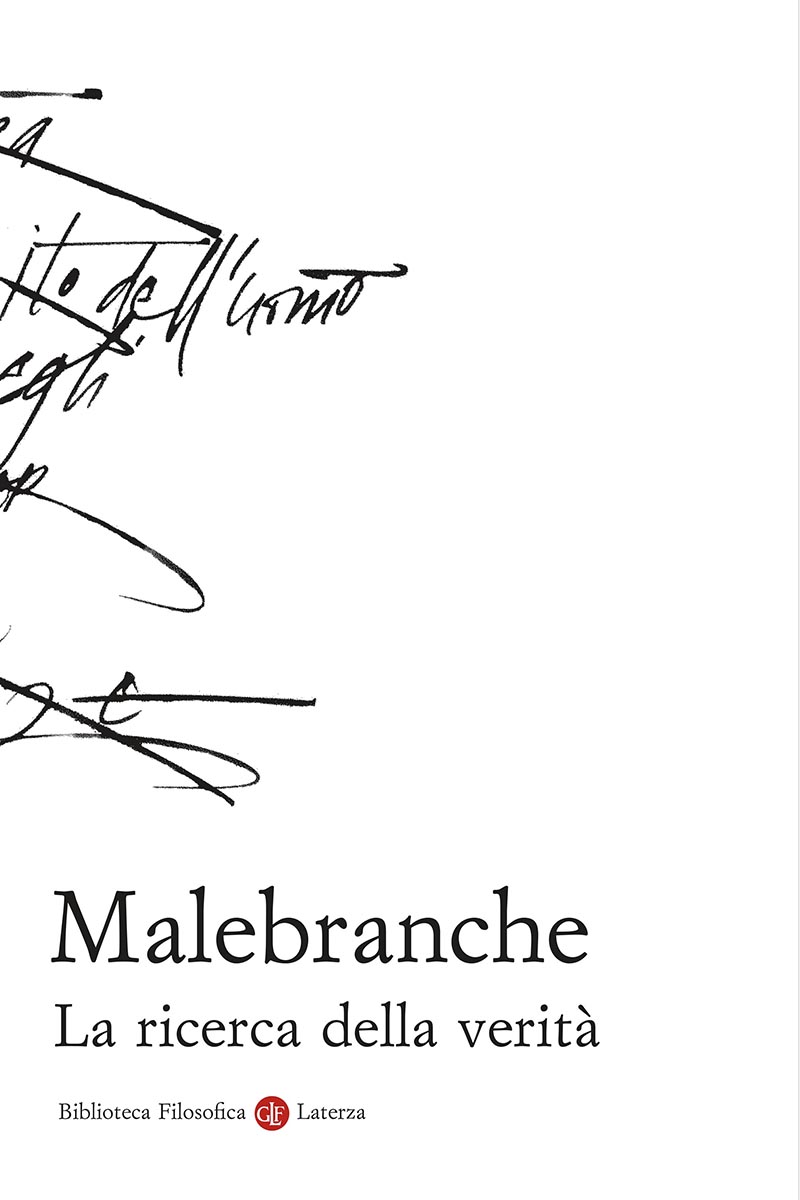
La ricerca della verità
Dio, nostro solo maestro di Emanuela Scribano
1. Lalleanza di Cartesio e Agostino - 2. Agostino contro Cartesio - 3. Oltre Cartesio. Loccasionalismo - 4. Oltre Cartesio. Limmaginazione
Introduzione alledizione 1983 di Eugenio Garin
Prefazione
Avvertenza relativa a questultima edizione
LA RICERCA DELLA VERITÀ
LIBRO PRIMO
I SENSI
Capitolo primo
I. Natura e proprietà dellintelletto - II. Natura e proprietà della volontà. Che cosè la libertàI. Natura e proprietà dellintelletto - II. Natura e proprietà della volontà; la libertà
Capitolo secondo
I. Giudizi e ragionamenti - II. Loro dipendenza dalla volontà - III. Quale uso si deve fare della propria libertà in rapporto ad essi - IV. Due regole generali per evitare lerrore e il peccato - V. Riflessioni necessarie su queste regoleI. Giudizi e ragionamenti - II. Giudizi e ragionamenti dipendono dalla volontà - III. Quale uso dobbiamo fare della nostra libertà per non ingannarci mai - IV. Regole generali per evitare lerrore - V. Riflessioni necessarie su queste due regole
Capitolo terzo
I. Risposte ad alcune obbiezioni - II. Rilievi su ciò che si è detto della necessità dellevidenza[I.] - II. Rilievi su ciò che si è detto della necessità dellevidenza
Capitolo quarto
I. Le cause occasionali dellerrore: le più importanti sono cinque - II. Disegno generale di tutta lopera e disegno particolare del primo libro I. Le cause occasionali dei nostri errori: le più importanti sono cinque - II. Disegno generale di tutta questopera - III. Disegno particolare del primo libro
Capitolo quinto. I sensi
I. Due maniere di spiegare come i nostri sensi sono corrotti dal peccato- II. La vera causa dei nostri errori non sono i nostri sensi ma la nostra libertà - III. Regola per non ingannarsi nelluso dei propri sensi I. Due maniere di spiegare la corruzione dei sensi per effetto del peccato - II. A farci precipitare nellerrore non sono i nostri sensi, ma il cattivo uso della nostra libertà - III. Regola per evitare lerrore nelluso dei propri sensi
Capitolo sesto
I. Gli errori della vista in rapporto allestensione in sé - II. Conseguenze di questi errori in rapporto a oggetti che non sono visibili - III. Gli errori dei nostri occhi a proposito dellestensione considerata dal punto di vista relativo I. Gli errori della vista a proposito dellestensione in sé - [II. Conseguenze degli errori dei nostri occhi a proposito di cose che esorbitano dalla sfera visiva] - III. Gli errori dei nostri occhi a proposito dellestensione dei corpi considerati nel loro rapporto reciproco
Capitolo settimo
I. Gli errori dei nostri occhi a proposito delle figure - II. Non abbiamo cognizione alcuna delle più piccole - III. La nostra conoscenza delle più grandi non è esatta - IV. Spiegazione di certi giudizi naturali che ci impediscono di sbagliare - V. Questi medesimi giudizi cingannano in casi particolari I. Gli errori della nostra vista a proposito delle figure - II. Non abbiamo cognizione alcuna delle più piccole - III. La nostra conoscenza delle più grandi non è esatta - IV. Spiegazione di certi giudizi naturali che ci impediscono di sbagliare. Li chiamo naturali perché a darceli è lArtefice della natura - V. Questi medesimi giudizi cingannano in alcuni casi particolari
Capitolo ottavo
I. I nostri occhi non ci rivelano la grandezza o la velocità del movimento considerato in sé - II. Ignoriamo la durata necessaria perché si conosca il movimento - III. Esempio degli errori dei nostri occhi circa il movimento e il riposoI. I nostri occhi non ci rivelano la grandezza o la velocità del movimento considerato in sé - II. Ignoriamo la durata necessaria per conoscere la grandezza del movimento - III. Esempio dellerrore dei nostri occhi circa il movimento o il riposo dei corpi
Capitolo nono
Ancora sullo stesso argomento: I. Prova generale degli errori della nostra vista a proposito del movimento - II. È necessario conoscere la distanza degli oggetti per giudicare lampiezza del loro movimento - III. Esame dei mezzi per riconoscere le distanze [I.] Ecco una prova generale di tutti gli errori in cui ci fa cadere la nostra vista a proposito del movimento - II. È necessario conoscere la distanza degli oggetti per conoscere la grandezza del loro movimento - III. Esame dei mezzi per riconoscere la distanza degli oggetti
Capitolo decimo
Errori relativi alle qualità sensibili: I. Distinzione tra anima e corpo - II. Spiegazione degli organi di senso - III. A quale parte del corpo si trova unita immediatamente lanima - IV. Azione degli oggetti sui corpi - V. Che cosa determinano nellanima e per quali ragioni lanima non avverte i movimenti delle fibre del corpo - VI. Quattro cose che vengono confuse in ciascuna sensazioneI. Distinzione tra anima e corpo - II. Spiegazione degli organi di senso - III. Lanima è immediatamente unita alla parte del cervello dove vanno a terminare i filamenti degli organi di senso - IV. Esempio delleffetto che gli oggetti fanno sul corpo - V. Che cosa determinano gli oggetti nellanima e per quali ragioni lanima non avverte i movimenti delle fibre del corpo - VI. Quattro cose che vengono confuse in ciascuna sensazione
Capitolo undicesimo
I. In che errore si cade a proposito dellazione degli oggetti contro le fibre esterne dei nostri sensi - II. Causa di tale errore - III. Obbiezione e rispostaI. In che errore si cade a proposito dellazione degli oggetti contro le fibre dei nostri sensi - II. Causa di tale errore - III. Obbiezione
Capitolo dodicesimo
I. Errori che riguardano i movimenti delle fibre dei nostri sensi - II. Non ci accorgiamo di tali movimenti o li confondiamo con le nostre sensazioni - III. Esperienza che lo prova - IV. Tre tipi di sensazioni- V. Gli errori che le accompagnanoI. Errori che riguardano i movimenti o vibrazioni delle fibre dei nostri sensi - II. Li confondiamo con le sensazioni della nostra anima e a volte non li percepiamo - III. Esperienza che lo prova - IV. Spiegazione di tre tipi di sensazioni dellanima - V. Errori che accompagnano le sensazioni
Capitolo tredicesimo
I. Natura delle sensazioni - II. Le conosciamo meglio di quanto non si creda - III. Obbiezione e risposta - IV. Perché simmagina di non saper nulla delle proprie sensazioni - V. Ci si sbaglia quando si crede che tutti gli uomini abbiano le medesime sensazioni a proposito degli stessi oggetti - VI. Obbiezione e risposta I. Definizione delle sensazioni - II. Si conoscono le proprie sensazioni meglio di quanto non si creda - III. Obbiezione e risposta - IV. Donde deriva che simmagina di non saper nulla delle proprie sensazioni - V. Ci si sbaglia quando si crede che tutti gli uomini abbiano le medesime sensazioni a proposito degli stessi oggetti - [VI.]
Capitolo quattordicesimo
I. Giudizi errati che accompagnano le nostre sensazioni e che noi confondiamo con esse - II. Ragioni di tali giudizi errati - III. Lerrore non sta nelle nostre sensazioni, ma solo in questi giudizi I. Giudizi errati che accompagnano le nostre sensazioni e che noi confondiamo con esse - II. Ragioni di tali giudizi errati - III. Lerrore non sta nelle nostre sensazioni, ma solo nei nostri giudizi
Capitolo quindicesimo
Spiegazione degli errori particolari della vista addotta come esempio degli errori generali dei nostri sensi
Capitolo sedicesimo
I. Gli errori dei nostri sensi ci servono come princìpi generali, e anche molto fertili, per ricavarne conclusioni errate che, a loro volta, servono da princìpi - II. Origine delle differenze essenziali - III. Le forme sostanziali - IV. Alcuni altri errori della filosofia della scuola I. Gli errori dei nostri sensi ci servono come princìpi generali per ricavarne conclusioni errate che, a loro volta, servono da princìpi - II. Lorigine delle differenze che si attribuiscono agli oggetti; queste differenze sono nellanima - III. Lorigine delle forme sostanziali - IV. Lorigine di tutti gli altri errori più generali della fisica della scuola
Capitolo diciassettesimo
I. Altro esempio ricavato dalla morale: ci fa vedere che i nostri sensi ci offrono soltanto dei falsi beni - II. Il nostro solo bene è Dio - III. Origine degli errori degli epicurei e degli stoici I. Esempio ricavato dalla morale: i nostri sensi ci offrono soltanto dei falsi beni - II. Il nostro solo bene è Dio; tutti gli oggetti sensibili sono incapaci di farci provare piacere - III. Lorigine degli errori degli epicurei e degli stoici
Capitolo diciottesimo
I. I nostri sensi ci traggono in errore anche a proposito di cose non sensibili- II. Esempio ricavato dalla conversazione degli uomini - III. Non ci si deve fermare agli aspetti che colpiscono i nostri sensi I. I nostri sensi ci traggono in errore anche a proposito di cose che non sono sensibili - II. Esempio ricavato dalla conversazione degli uomini - III. Non ci si deve fermare agli aspetti sensibili e gradevoli
Capitolo diciannovesimo
Altri due esempi. I. Primo esempio: gli errori che riguardano la natura dei corpi - II. Secondo esempio: gli errori che riguardano le qualità dei medesimi corpi I. Errori che riguardano la natura dei corpi - II. Errori che riguardano le loro qualità e le loro perfezioni
Capitolo ventesimo
Conclusioni di questo primo libro. I. I nostri sensi ci sono dati solo in funzione del nostro corpo - II. Bisogna dubitare di quel che ci riferiscono- III. Dubitare correttamente non è cosa di poco conto I. I nostri sensi ci sono dati solo per la conservazione del nostro corpo - II. Bisogna dubitare di come ci presentano le cose - III. Saper dubitare correttamente non è cosa di poco conto
LIBRO SECONDO
LIMMAGINAZIONE
Parte prima
Capitolo primo
I. Idea generale dellimmaginazione - II. Due facoltà dellimmaginazione, attiva luna, passiva laltra - III. Causa generale dei mutamenti che avvengono nellimmaginazione e fondamento di questo secondo libro
Capitolo secondo
I. Gli spiriti animali e i mutamenti a cui vanno generalmente soggetti- II. Il chilo va al cuore determinandovi dei mutamenti negli spiriti- III. Altrettanto fa il vino[I.] - II. Il chilo va al cuore determinandovi dei mutamenti negli spiriti - III. Altrettanto fa il vino
Capitolo terzo
Anche laria che si respira determina qualche mutamento negli spiriti
Capitolo quarto
I. Mutamento degli spiriti dovuto ai nervi che vanno al cuore e ai polmoni- II. Mutamento dovuto ai nervi che vanno al fegato, alla milza e ai visceri - III. Si tratta di fatti indipendenti dalla nostra volontà, ma che non possono verificarsi senza una provvidenza I. Mutamento degli spiriti dovuto ai nervi che vanno al cuore e ai polmoni - II. Mutamento degli spiriti dovuto ai nervi che vanno al fegato, alla milza e agli altri visceri - III. Questi mutamenti avvengono indipendentemente dalla nostra volontà in base allordine di una provvidenza
Capitolo quinto
I. Il legame delle idee dello spirito con le tracce del cervello - II. Legame reciproco che sussiste fra queste tracce - III. La memoria - IV. Le abitudini I. Lunione dellanima col corpo - II. Il legame reciproco fra le tracce - III. La memoria - IV. Le abitudini
Capitolo sesto
I. Le fibre del cervello non sono soggette a mutamenti così rapidi come quelli degli spiriti - II. Tre diversi mutamenti nelle tre diverse età I. Le fibre del cervello non sono soggette a mutamenti così rapidi come quelli degli spiriti - II. Tre considerevoli mutamenti che si verificano nelle tre età diverse
Capitolo settimo
I. Comunicazione che sussiste fra il cervello di una madre e quello del suo bambino - II. Comunicazione fra il nostro cervello e le altre parti del nostro corpo: essa ci porta allimitazione e alla compassione - III. Spiegazione della generazione dei parti mostruosi e della propagazione delle specie - IV. Spiegazione di alcuni disordini mentali e di talune inclinazioni della volontà - V. La concupiscenza e il peccato originale- VI. Obbiezioni e risposte I. Comunicazione che sussiste fra il cervello della madre e quello del suo bambino - II. Comunicazione fra il nostro cervello e le parti del nostro corpo: essa ci porta allimitazione e alla compassione - III. Spiegazione della generazione dei parti mostruosi e della propagazione della specie - IV. Spiegazione di alcuni disordini mentali e di talune inclinazioni distorte della volontà - V. Spiegazione della concupiscenza e del peccato originale - VI. Obbiezioni e risposte
Capitolo ottavo
I. Mutamenti che si verificano nellimmaginazione di un bambino uscito dal seno materno per effetto del suo conversare con la nutrice, con la madre e con gli altri - II. Consigli per una buona educazione[I.] - II. Consigli per una buona educazione dei bambini
Parte seconda
LIMMAGINAZIONE
Capitolo primo
I. Limmaginazione delle donne - II. Quella degli uomini - III. Quella dei vecchi I. Limmaginazione delle donne - II. Limmaginazione degli uomini nella loro età migliore - III. Limmaginazione dei vecchi
Capitolo secondo
Gli spiriti animali seguono in genere le tracce delle idee che ci sono più familiari; perciò non diamo un retto giudizio delle cose
Capitolo terzo
I. Gli uomini di studio sono i più soggetti allerrore - II. Ragioni per cui si preferisce seguire lautorità anziché far uso della propria mente I. Gli uomini di studio sono i più soggetti allerrore - II. Ragioni per cui si preferisce seguire lautorità piuttosto che fare uso della propria mente
Capitolo quarto
Due effetti negativi della lettura sullimmaginazione
Capitolo quinto
Gli uomini di studio sinnamorano di solito di qualche autore, sicché il loro principale scopo è di sapere ciò che egli ha creduto senza curarsi di ciò che si deve credere
Capitolo sesto
La preoccupazione dei commentatori
Capitolo settimo
I. Glinventori di nuovi sistemi - II. Un ultimo errore degli uomini di studio[I.] - II. Un considerevole errore degli studiosi
Capitolo ottavo
I. Degli spiriti effeminati - II. Degli spiriti superficiali - III. Delle autorità- IV. Degli sperimentatori I. Degli spiriti effeminati - II. Degli spiriti superficiali - III. Delle persone autorevoli - IV. Degli sperimentatori
Parte terza
LINFLUENZA CONTAGIOSA DELLE FORTI IMMAGINAZIONI
Capitolo primo
I. La nostra disposizione a imitare gli altri in tutte le cose è alla radice del comunicarsi degli errori dovuti alla potenza dellimmaginazione- II. Due cause principali che aumentano una tale disposizione - III. Cosa sintende per immaginazione forte - IV. Ce ne sono di più tipi. I pazzi e coloro che hanno unimmaginazione forte nel senso che intendiamo qui - V. Due considerevoli difetti di quanti posseggono una forte immaginazione - VI. Loro capacità di persuadere e di imporsi[I.] - II. Le due cause principali che aumentano la nostra disposizione a imitare gli altri - III. Cosa sintende per immaginazione forte - IV. Ce ne sono di due tipi - V. Due difetti considerevoli di quanti posseggono una forte immaginazione - VI. Chi è provvisto di forte immaginazione ha facili poteri persuasivi
Capitolo secondo
Esempi generali della forza dellimmaginazione
Capitolo terzo
I. La forza dellimmaginazione di certi autori - II. Tertulliano[I.] - [II.]
Capitolo quarto
Limmaginazione di Seneca
Capitolo quinto
Il libro di Montaigne
Capitolo ultimo
I. Stregoni per forza dimmaginazione e lupi mannari - II. Conclusione dei due primi libriI. Stregoni per forza dimmaginazione e lupi mannari - II. Conclusione dei primi due libri
LIBRO TERZO
LINTELLETTO O SPIRITO PURO
[Parte prima]
Capitolo primo
I. Solo il pensiero è essenziale allo spirito. Sentire e immaginare sono soltanto sue modificazioni - II. Non conosciamo tutte le modificazioni di cui la nostra anima è capace - III. Le nostre sensazioni, e anche le nostre passioni, sono diverse dalla nostra conoscenza e dal nostro amore e non sempre ne sono conseguenze I. Solo il pensiero è essenziale allo spirito. Sentire e immaginare non sono che sue modificazioni - II. Noi non conosciamo tutte le modificazioni di cui la nostra anima è capace - III. Le nostre sensazioni sono diverse dalla nostra conoscenza e dal nostro amore e non ne sono conseguenze
Capitolo secondo
I. Lo spirito, essendo limitato, non può intendere ciò che partecipa dellinfinito- II. La sua limitazione è la fonte di parecchi errori - III. E principalmente delle eresie - IV. Bisogna sottomettere lo spirito alla fede I. Lo spirito, essendo limitato, non può intendere ciò che partecipa dellinfinito - II. La limitazione dello spirito è la fonte di parecchi errori - [III.] - [IV.]
Capitolo terzo
I. I filosofi si disperdono applicandosi a temi che implicano troppi rapporti e che dipendono da troppe cose senza osservare nei loro studi ordine alcuno - II. Esempio tratto da Aristotele - III. I geometri, al contrario, nella ricerca della verità, seguono una buona strada, specialmente quelli che si servono dellalgebra e dellanalisi - IV. Il loro metodo aumenta la forza dello spirito, mentre la logica di Aristotele la diminuisce - V. Altro difetto degli uomini di studio I. I filosofi mancano dordine nei loro studi - II. Esempio della mancanza di un ordine in Aristotele - III. I geometri nella ricerca della verità seguono una buona strada - IV. Il loro metodo aumenta la capacità dellintelletto, quello dAristotele la diminuisce - V. Altro difetto degli studiosi
Capitolo quarto
I. Lintelletto non può applicarsi a lungo a oggetti con cui non ha rapporto o che non partecipano in qualche modo dellinfinito - II. Lincostanza della volontà è causa di un tale difetto dapplicazione e quindi dellerrore - III. Le nostre sensazioni ci assorbono più delle pure idee dello spirito - IV. Questa è la fonte della corruzione dei costumi- V. E dellignoranza della comune degli uomini[I.] - II. Lincostanza della volontà è causa del difetto di applicazione e quindi dellerrore - III. Le nostre sensazioni ci assorbono più delle pure idee dellintelletto - IV. Questa è la fonte della corruzione dei costumi - V. E dellignoranza degli uomini
Seconda parte dellintelletto puro
LA NATURA DELLE IDEE
Capitolo primo
I. Cosa sintende per idee. Esse esistono veramente e sono necessarie per la percezione di tutti gli oggetti materiali - II. Classificazione di tutte le maniere in cui si possono vedere gli oggetti esterni[I.] - II. Classificazione di tutte le maniere in cui si possono vedere gli oggetti esterni
Capitolo secondo
Gli oggetti materiali non emettono specie ad essi somiglianti
Capitolo terzo
Lanima non ha il potere di produrre le idee. Causa dellerrore in cui si cade a questo proposito
Capitolo quarto
Non vediamo gli oggetti per mezzo di idee create con noi. Dio non le crea in noi via via che ne abbiamo bisogno
Capitolo quinto
Lo spirito non vede né lessenza né lesistenza degli oggetti considerando le sue proprie perfezioni. Solo Dio le vede così
Capitolo sesto
Noi vediamo tutte le cose in Dio
Capitolo settimo
I. Quattro diverse maniere di vedere le cose - II. Come si conosce Dio- III. Come si conoscono i corpi - IV. Come si conosce la propria anima- V. Come si conoscono le anime degli altri uomini ed i puri spiriti I. Quattro maniere di vedere le cose II. Come si conosce Dio - III. Come si conoscono i corpi - IV. Come si conosce la propria anima - V. Come si conosce lanima degli altri uomini
Capitolo ottavo
I. Lintima presenza dellidea vaga dellessere in generale è la causa di tutte le astrazioni abnormi dello spirito e della maggior parte delle chimere della filosofia corrente che impediscono a molti filosofi di riconoscere la fondatezza dei veri princìpi della fisica - II. Esempio relativo allessenza della materia [I.] - II. Dellessenza della materia
Capitolo nono
I. Ultima causa generale dei nostri errori - II. Le idee delle cose non sempre si presentano allo spirito appena lo si desidera - III. Ogni spirito finito è soggetto allerrore; per quale ragione - IV. Non si deve giudicare che vi siano solo corpi o spiriti, né che Dio sia spirito nel senso in cui noi concepiamo gli spiriti I. Ultima causa generale dei nostri errori - II. Le idee delle cose non si presentano allo spirito appena lo desidera - III. Ogni spirito finito è soggetto allerrore - IV. Non si deve concepire che non vi sia altro di creato oltre ai corpi o agli spiriti, né che Dio sia spirito nel senso in cui concepiamo gli spiriti
Capitolo decimo
Esempi di alcuni errori di fisica in cui si cade perché si suppone che esseri diversi per natura, qualità, estensione, durata, proporzione, siano simili sotto tutti questi rispetti
Capitolo undicesimo
Esempi di errori dordine morale che dipendono dallo stesso principio
Conclusione dei primi tre libri
LIBRO QUARTO
INCLINAZIONI O MOVIMENTI NATURALI DELLO SPIRITO
Capitolo primo
I. Gli spiriti devono avere delle inclinazioni come i corpi hanno dei movimenti - II. Dio conferisce movimento agli spiriti solo nella sua direzione - III. Gli spiriti si volgono ai beni particolari solo per il loro moto verso il bene in generale - IV. Origine delle principali inclinazioni naturali su cui si fonderà la partizione di questo quarto libro I. Gli spiriti devono avere delle inclinazioni come i corpi hanno dei movimenti - II. Dio non ha che se stesso come fine principale delle sue azioni e conferisce movimento agli spiriti solo nella sua direzione - III. Gli spiriti si volgono ai beni particolari solo per il loro moto verso il bene in generale - IV. Origine delle principali inclinazioni naturali su cui si fonderà la partizione di questo quarto libro
Capitolo secondo
I. Linclinazione per il bene in generale è il principio dellinquietudine della nostra volontà - II. Quindi della nostra scarsa applicazione e della nostra ignoranza - III. Primo esempio: la morale poco conosciuta dalla comune degli uomini - IV. Secondo esempio: limmortalità dellanima contestata da taluni - V. Estrema è la nostra ignoranza nei confronti delle cose astratte o prive di rapporto con noi I. Linclinazione per il bene in generale è il principio dellinquietudine della nostra volontà - II. Quindi della nostra scarsa applicazione e della nostra ignoranza - III. Primo esempio: la morale poco conosciuta dalla comune degli uomini - IV. Secondo esempio: limmortalità dellanima contestata da taluni - V. Estrema è la nostra ignoranza nei confronti delle cose astratte o che non hanno molto rapporto con noi
Capitolo terzo
I. La curiosità è naturale e necessaria - II. Tre regole per tenerla a freno - III. Spiegazione della prima regola I. La curiosità è naturale e necessaria - II. Tre regole per tenere a freno la curiosità - III. Spiegazione particolare della prima di queste regole
Capitolo quarto
Continuazione del medesimo tema. I. Spiegazione della seconda regola della curiosità - II. Spiegazione della terza I. Seconda regola della curiosità - II. Terza regola della curiosità
Capitolo quinto
I. La seconda inclinazione naturale o amor proprio - II. Si suddivide in amore dellessere e del benessere, ossia della grandezza e del piacere I. La seconda inclinazione naturale o amor proprio - II. Lamor proprio si suddivide in amore dellessere e del benessere, ossia della grandezza e del piacere
Capitolo sesto
I. La nostra inclinazione per tutto ciò che ci eleva al disopra degli altri - II. Falsi giudizi di persone dedite alla pietà - III. Falsi giudizi dei superstiziosi e degli ipocriti - IV. Voët nemico di Descartes I. La nostra inclinazione per tutto ciò che ci eleva al disopra degli altri - II. Falsi giudizi di persone dedite alla pietà - III. Falsi giudizi dei superstiziosi e degli ipocriti - IV. Voët
Capitolo settimo
Il desiderio della scienza e i giudizi dei falsi dotti
Capitolo ottavo
I. Il desiderio di apparire dotto - II. Le conversazioni dei falsi dotti - III. Le loro opere I. Il desiderio di apparire dotto - II. Le conversazioni dei falsi dotti - III. I libri dei falsi dotti
Capitolo nono
Come la nostra inclinazione per le dignità e le ricchezze ci porta allerrore
Capitolo decimo
Lamore del piacere in rapporto alla morale. I. Bisogna fuggire il piacere anche se rende felici - II. Esso non deve portarci allamore dei beni sensibiliI. Bisogna fuggire il piacere anche se rende felici - II. Esso non deve portarci allamore dei beni sensibili
Capitolo undicesimo
Lamore del piacere in rapporto alle scienze speculative. I. Come cimpedisce di scoprire la verità - II. Qualche esempio - III. Chiarimento sulla prova cartesiana dellesistenza di Dio I. Come lamore del piacere cimpedisce di scoprire la verità - II. Qualche esempio - III. Chiarimento sulla prova cartesiana dellesistenza di Dio
Capitolo dodicesimo
Quali effetti è capace di produrre nello spirito il pensiero dei beni e dei mali futuri
Capitolo tredicesimo
I. La terza inclinazione naturale, cioè lamicizia che proviamo per gli altri uomini - II. Essa ci porta a sostenere i punti di vista dei nostri amici e ad ingannarli con lodi fittizie I. La terza inclinazione naturale, cioè lamicizia che proviamo per gli altri uomini - II. Essa ci porta a sostenere i punti di vista dei nostri amici e ad ingannarli con lodi fittizie
LIBRO QUINTO
LE PASSIONI
Capitolo primo
Natura e origine delle passioni in generale
Capitolo secondo
Lunione dello spirito con gli oggetti sensibili, ossia la forza e lestensione delle passioni in generale
Capitolo terzo
Spiegazione dettagliata di tutti i mutamenti che nelle passioni hanno luogo nel corpo e nellanima
Capitolo quarto
I piaceri e i moti delle passioni cinvischiano nellerrore nei confronti del bene. Bisogna opporre continua resistenza. Come combattere il libertinaggio
Capitolo quinto
La perfezione dello spirito consiste nella sua unione con Dio attraverso la conoscenza della verità e lamore della virtù; mentre, al contrario, la sua imperfezione viene solo dalla dipendenza dal corpo, per via del disordine dei suoi sensi e delle sue passioni
Capitolo sesto
Gli errori più generali delle passioni; esempi particolari
Capitolo settimo
Le passioni in particolare e in primo luogo la meraviglia e i suoi effetti negativi
Capitolo ottavo
Continuazione del medesimo tema. Possibilità di fare buon uso della meraviglia e delle altre passioni
Capitolo nono
Amore, avversione e loro principali specie
Capitolo decimo
Le passioni in particolare e, in generale, il modo di spiegarle e di individuare gli errori di cui sono causa
Capitolo undicesimo
Tutte le passioni si giustificano; giudizi che ci fanno formulare per giustificarle
Capitolo dodicesimo
Le passioni che hanno per oggetto il male sono le più pericolose ed ingiuste; quelle che meno si accompagnano alla conoscenza sono le più vive e sensibili
LIBRO SESTO
DEL METODO
Parte prima
Capitolo primo
Disegno di questo libro. I due mezzi generali per mantenere levidenza nella ricerca della verità che saranno il soggetto del libro
Capitolo secondo
Lattenzione è necessaria per mantenere levidenza nelle nostre conoscenze. Le modificazioni sensibili rendono lanima attenta ma frazionano troppo la sua capacità di percepire
Capitolo terzo
Che uso si può fare delle passioni e dei sensi per tener viva lattenzione della mente
Capitolo quarto
Impiego dellimmaginazione per mantenere lattenzione della mente e utilità della geometria
Capitolo quinto
Mezzi per aumentare lestensione e la capacità della mente. Laritmetica e lalgebra sono assolutamente necessarie
Parte seconda
DEL METODO
Capitolo primo
Regole che vanno osservate nella ricerca della verità
Capitolo secondo
Regola generale che riguarda loggetto dei nostri studi. I filosofi della scuola non la osservano; ne derivano parecchi errori in fisica
Capitolo terzo
Lerrore più pericoloso della filosofia degli antichi
Capitolo quarto
Spiegazione della seconda parte della regola generale. I filosofi non la osservano quasi mai. Descartes ha cercato di osservarla scrupolosamente nella sua fisica; a riprova ne offriamo un riassunto
Capitolo quinto
Spiegazione dei princìpi della filosofia di Aristotele; si fa vedere che non ha mai osservato la seconda parte della regola generale e si esaminano i suoi quattro elementi e le sue qualità elementari
Capitolo sesto
Direttive generali necessarie per procedere con ordine nella ricerca della verità e nella scelta delle scienze
Capitolo settimo
Limpiego della prima regola che riguarda le questioni particolari
Capitolo ottavo
Applicazione delle altre regole a questioni particolari
Capitolo nono
Ultimo esempio volto a far conoscere lutilità di questa opera. In tale esempio si ricerca la causa fisica della durezza ossia dellunione reciproca delle parti dei corpi
Conclusione dei tre ultimi libri
Indice dei nomi
Pagine: Array
Collana: Biblioteca Filosofica Laterza
ISBN carta: 9788858146057
ISBN digitale: 9788842083986
Argomenti: Classici della filosofia moderna
La ricerca della verità
a cura di M. Garin, introd. di E. Garin, con un saggio di E. Scribano
Di quest'ultima, Maria Garin ha realizzato nel 1983 per i tipi della Laterza una traduzione in italiano, basata sul testo critico fornito da Geneviève Rodis-Lewis nel quadro delle Oeuvres complètes di Malebranche. L'edizione era introdotta da un saggio di Eugenio Garin. Oggi viene riproposta con una nota di Emanuela Scribano che riattraversa la filosofia di Malebranche mettendone in luce originalità e ricchezza.
Pagine: Array
Collana: Biblioteca Filosofica Laterza
ISBN: 9788858146057
L'autore
Nicolas Malebranche
Altre opere
La Newsletter di Laterza
Iscriviti alla Newsletter Laterza per essere sempre informato sulle novità in uscita e sugli appuntamenti in agenda!