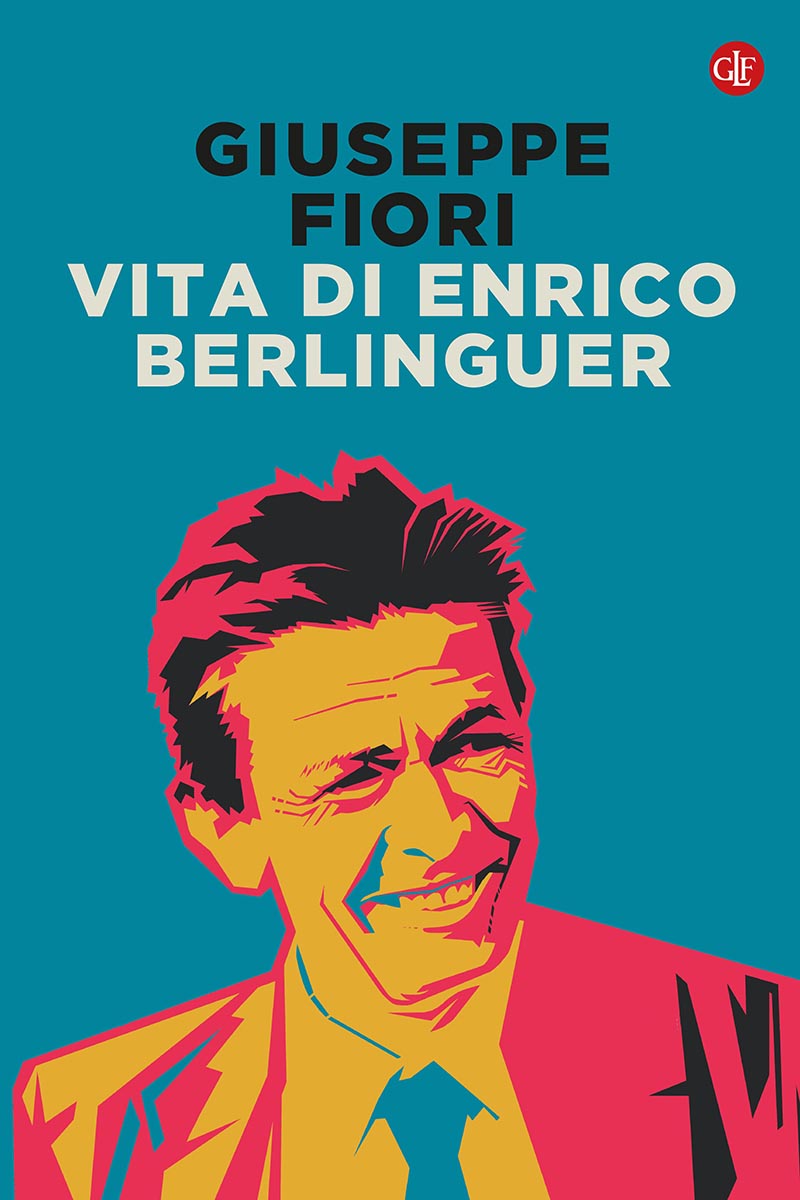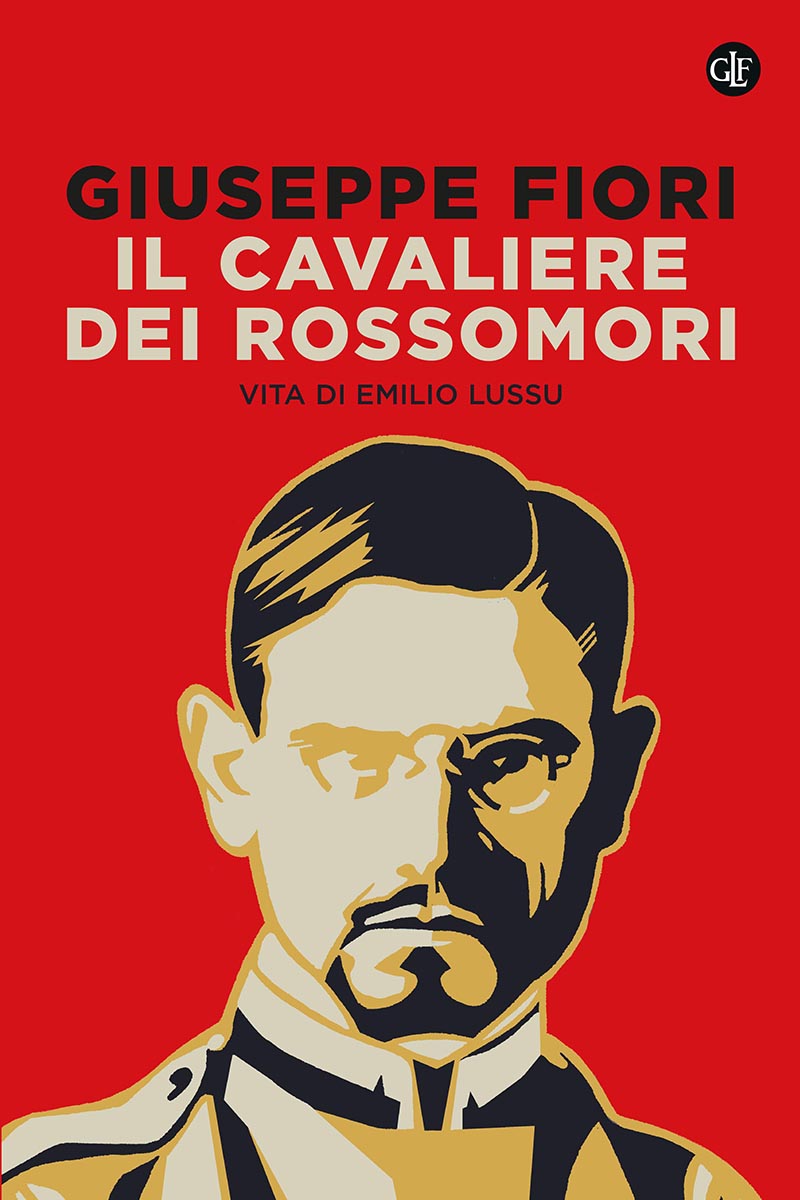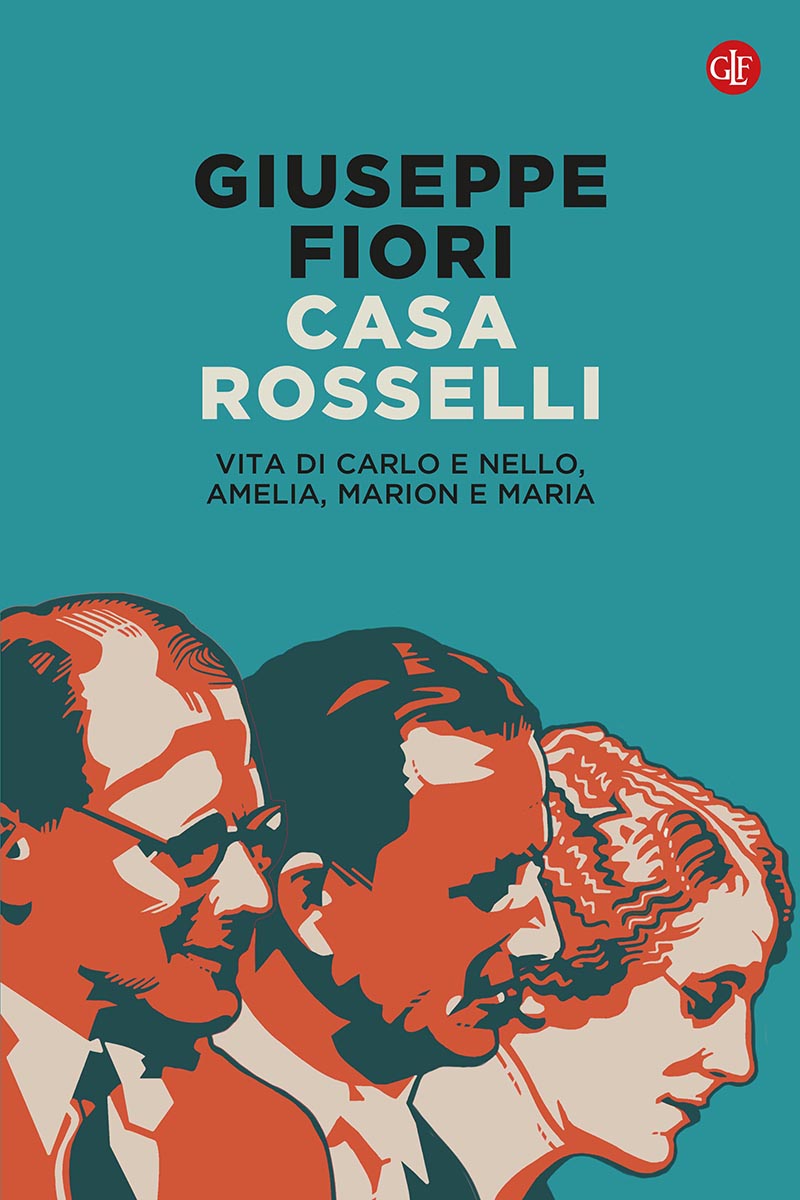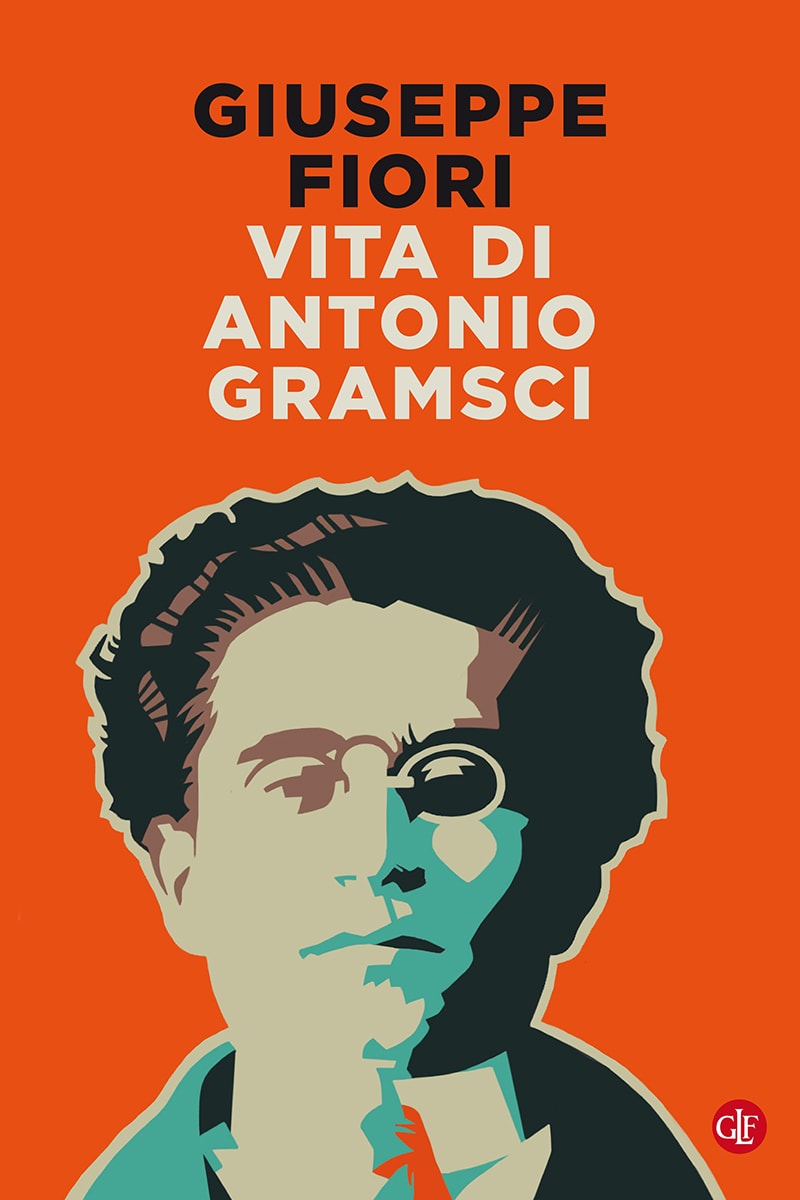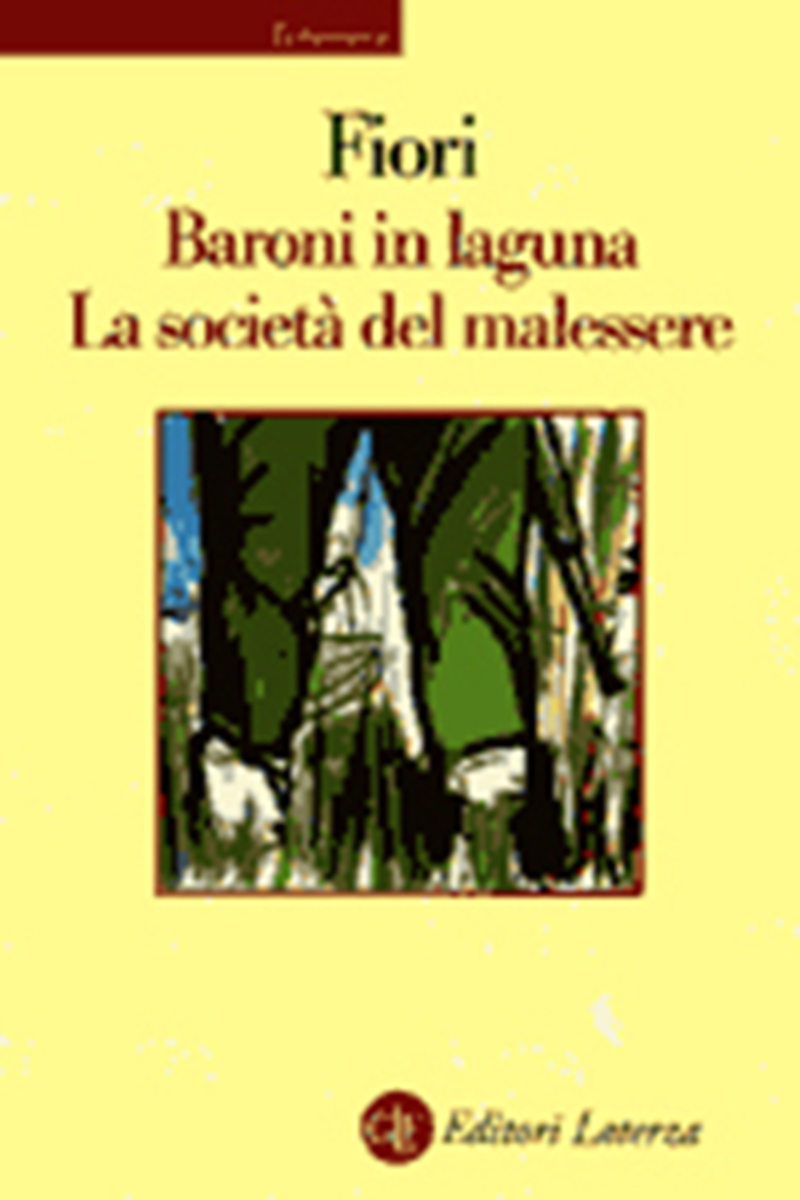Vita di Enrico Berlinguer
Questo libro è soprattutto un’analisi dell’attività di Berlinguer come massimo dirigente del più grande partito comunista occidentale, e di come il Pci abbia svolto un ruolo centrale nelle vicende politiche del nostro paese. Proprio per questo si può anche dire che in fondo questa di Fiori è una storia del Pci di quegli anni, e se si vuole una storia anche dell’Italia di quegli anni.
Walter Veltroni
Si continuerà a discutere a lungo della politica di Berlinguer, con passione e disparità di opinioni; ma un fatto è certo: di uomini del suo stampo il paese avrebbe oggi più che mai bisogno.
Eugenio Scalfari
Enrico Berlinguer è stato un protagonista assoluto della vita politica italiana in un quindicennio denso di avvenimenti, dal 1969 al 1984. Un’età aperta dall’autunno caldo, proseguita con l’esplosione del terrorismo rosso e nero, i grandi successi elettorali del Pci, la solidarietà nazionale e il rapimento di Aldo Moro, chiusa alla fine con la rottura dell’unità sindacale e con lo scontro con il Psi di Craxi. In questa biografia,Giuseppe Fiori ci racconta quegli anni difficili dell’Italia repubblicana, la complessa separazione dall’Urss del Partito comunista, l’affacciarsi della questione morale. Ma anche l’intera vicenda di un uomo che ha lasciato il segno per il valore riconosciuto della sua qualità umana: uomo schivo, severo, coerente, geloso della sua privacy, attaccato alla sua Sardegna, a Sassari, a Stintino. A cento anni dalla sua nascita, il ritratto appassionato di un protagonista indimenticabile e indimenticato della vita politica italiana.