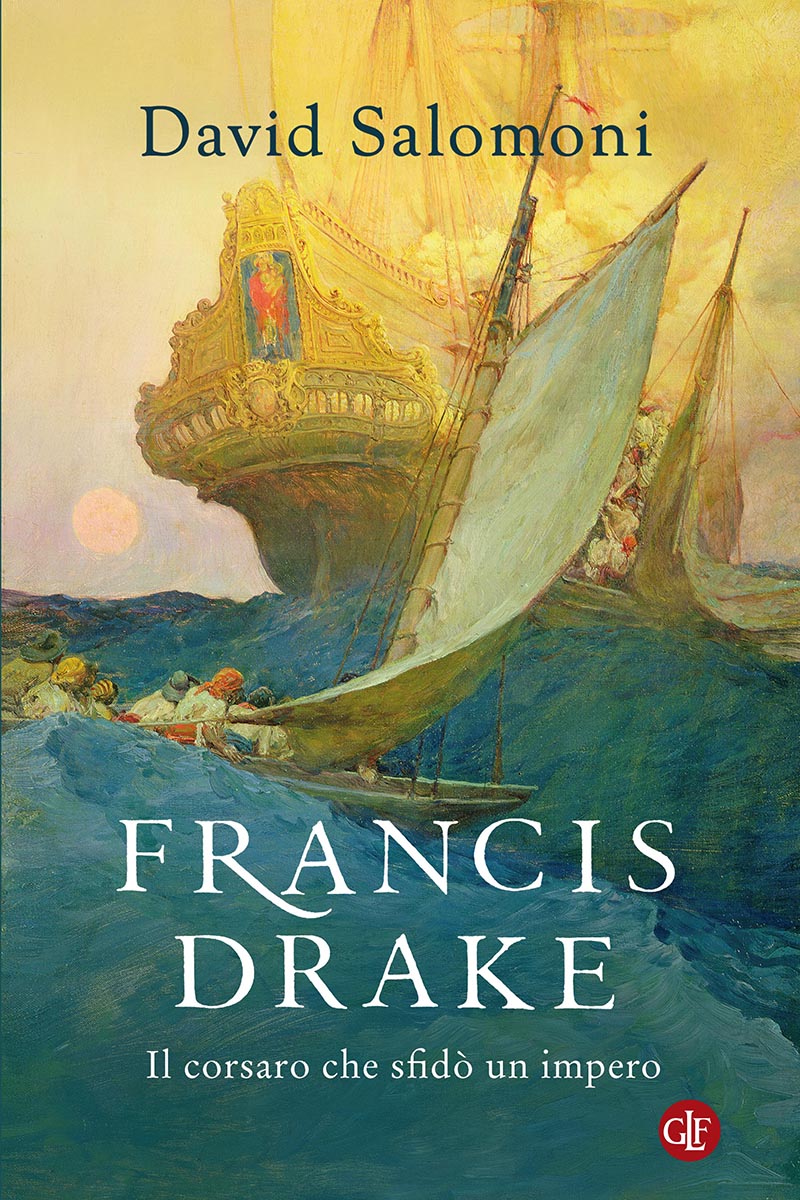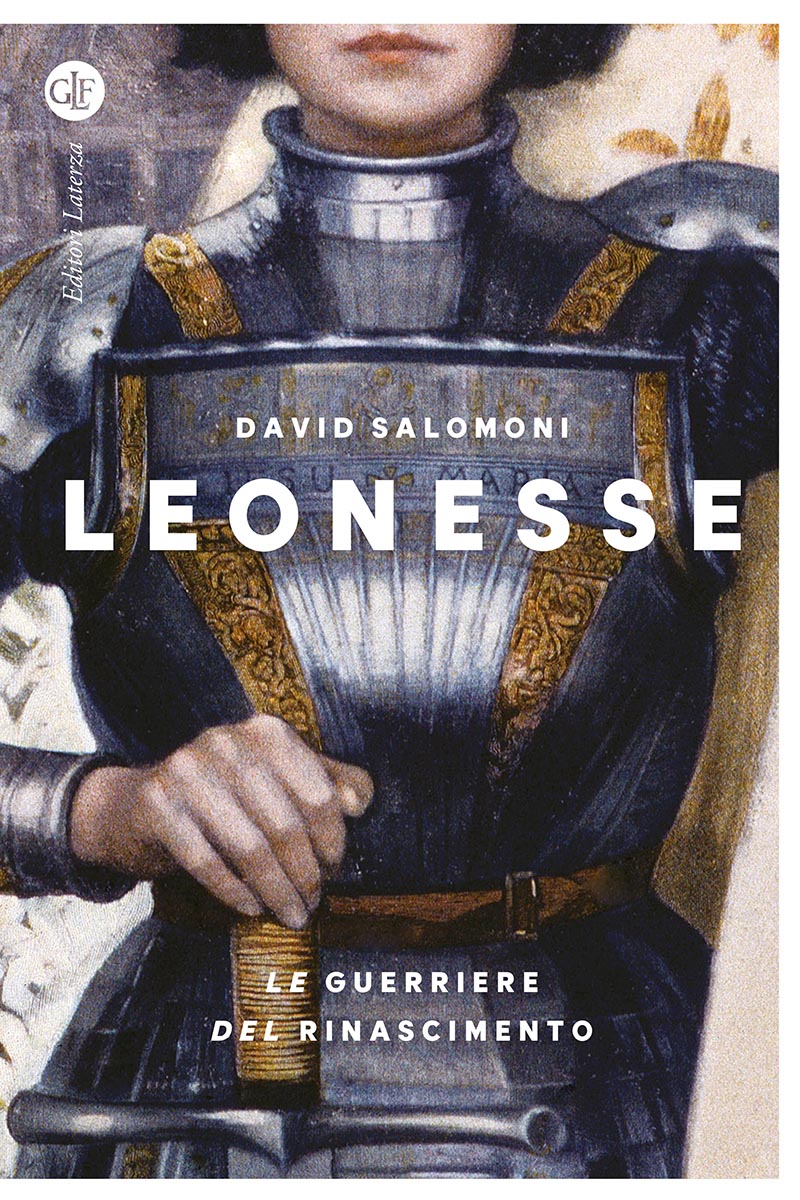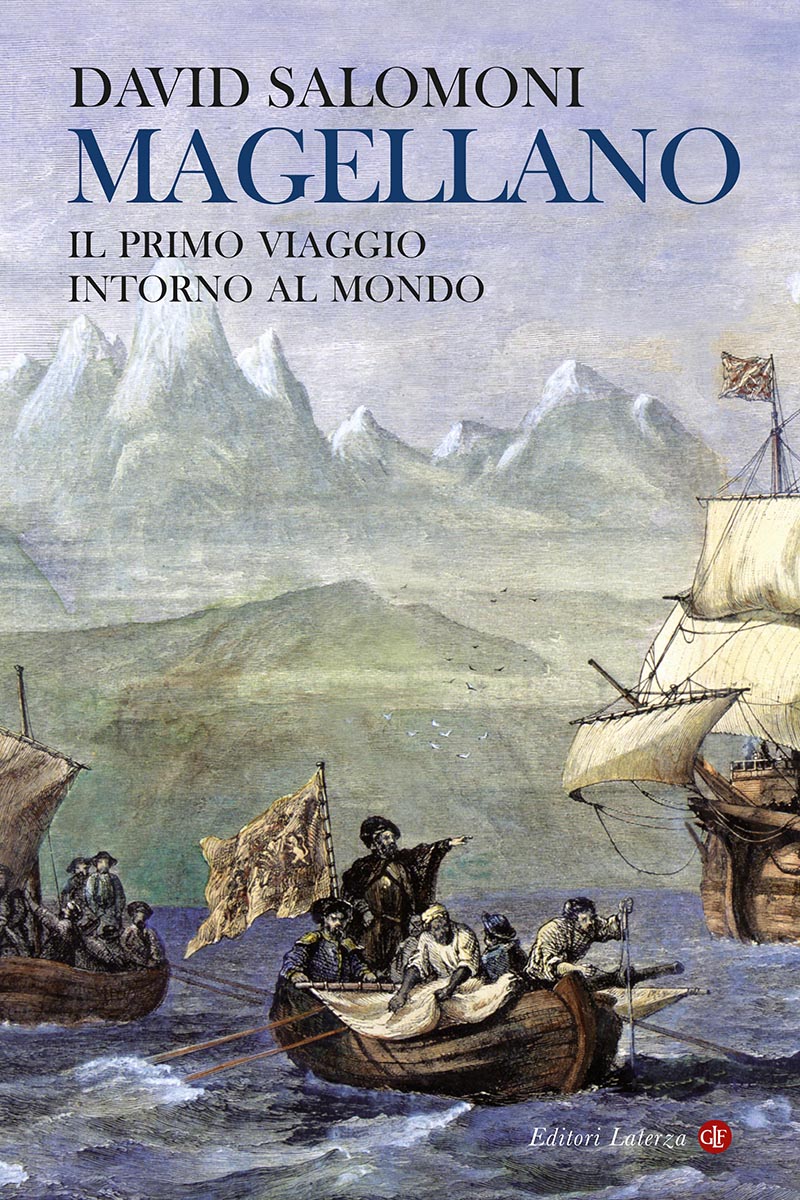Dedicato ai miei nonni,
Angelo e Franco,
che mi hanno tenuto per mano
Un documento perduto e ritrovato
Il palazzo reale di Ajuda sorge su un promontorio a ovest di Lisbona, non lontano
dalle rive del fiume Tago. La reggia fu edificata dalla dinastia di Braganza nella
seconda metà del Settecento, all’indomani del terremoto che nel 1755 distrusse la
capitale portoghese. Dalle sue finestre si scorge l’estuario del più lungo corso d’acqua
della penisola iberica, appena prima di gettarsi nell’Atlantico. Quelle acque furono
un tempo solcate dai navigatori e dagli esploratori che da Lisbona partivano e tornavano
dai più remoti confini del mondo: Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, Ferdinando Magellano.
Nelle giornate estive una calda luce inonda i grandi saloni del palazzo, foderati
di sete color porpora, blu cobalto e verde smeraldo. In quelle sale, tra i fasti di
una gloria estinta, è ospitata una delle più ricche e affascinanti biblioteche d’Europa.
È stato in una tiepida mattina di maggio del 2021, durante una ricerca condotta alla
biblioteca di Ajuda, che mi accadde ciò che nella vita di uno storico avviene poche
volte. Sfogliavo le pagine di un grande volume manoscritto alla ricerca di documenti
sulla storia marittima portoghese nel Cinquecento. Improvvisamente, come da un libro
di antiche leggende, iniziarono a emergere nomi che catturavano la mia attenzione:
Francisco Drac, Nuño de Silva. Mi resi conto di aver trovato qualcosa sul famoso corsaro inglese Francis Drake.
Con l’aiuto del collega José María Moreno Madrid, realizzai di non trovarmi davanti
a materiale qualunque; avevo in mano il primo, nuovo documento su Drake a 60 anni
di distanza dall’ultimo ritrovamento.
La fonte contiene la testimonianza di Nuno da Silva rilasciata a Madrid nel 1583 davanti
al Consiglio delle Indie, il più importante organo amministrativo dell’impero coloniale
spagnolo. Da Silva era il pilota portoghese rapito da Drake nel gennaio del 1578 nell’arcipelago
di Capo Verde per farsi guidare nell’Oceano Pacifico, passando per lo Stretto di Magellano,
e sferrare un terribile attacco all’America spagnola. Il portoghese fu liberato dal
corsaro nell’aprile del 1579, nella città portuale di Huatulco, in Messico, dove iniziò
una lunga odissea giudiziaria, passando anche per le mani dell’Inquisizione. La relazione
trovata ad Ajuda sul viaggio di Nuno da Silva con Francis Drake non fu l’unica prodotta
dal pilota, che nel corso degli anni subì vari interrogatori, ma è senz’altro la più
ricca di particolari. Narra di battaglie all’ultimo sangue, arrembaggi, e violente
tempeste ai confini del mondo allora conosciuto.
Dal documento emerge il ritratto del mondo e della tormentata Europa nel secondo Cinquecento,
un’epoca di drammi e contraddizioni. La vicenda che sto per narrare è essenzialmente
il racconto di una guerra. Ritengo giusto avvertire il lettore che, forse, nelle pagine
che seguono, faticherà talvolta a trovare una logica, una consequenzialità, nell’agire
dei protagonisti. Com’è stato ripetuto spesso in questi mesi, i conflitti tra potenze
sono sempre sottesi da logiche complesse, benché perlopiù congruenti; addirittura,
si è detto, ricorrenti. La storia e la vita, però, insegnano che la coerenza non è
una categoria dell’agire umano, salvo forse rari casi (con esiti ancor più raramente
felici). Le persone sono spesso divise tra fedeltà familiari, politiche, religiose,
di fazione; tra brame personali e istinti ancestrali. Troveremo, di volta in volta,
donne e uomini dalle ambizioni sconfinate, di dominio globale, popoli in lotta per
la sopravvivenza, profeti che invocano la guerra santa, affaristi senza scrupoli,
maghi, alchimisti, sbandati, fuorilegge.
Ho pensato che valesse la pena scrivere un libro per far conoscere questa avventura
al grande pubblico. Alcuni protagonisti saranno già noti al lettore, come le regine
Elisabetta Tudor e Maria Stuart, Filippo II d’Asburgo, lo stesso Francis Drake. Altri
meno: il mago John Dee, l’ammutinato Thomas Doughty, l’inquisitore Pedro de Moya,
o il nostro testimone, Nuno da Silva. Tutti, comunque, saranno attori nel grande dramma
che andiamo a raccontare.
Chiudo questa nota con alcuni doverosi e più che sentiti ringraziamenti. In primo
luogo il mio team di ricerca all’Università di Lisbona, nel quadro del progetto ERC
Rutter: Making the Earth Global. La mia gratitudine va in particolare a Henrique Leitão per la guida professionale
e umana, e a José María Moreno Madrid per l’instancabile dialogo e il confronto storiografico.
Quest’opera non avrebbe visto la luce senza Giovanni Carletti, che da subito ha creduto
nelle mie idee. Grazie ad Alessandro Vanoli, per i consigli e per l’amicizia, e a
Paolo Cerruti, per le stimolanti conversazioni. La mia riconoscenza è per tutti gli
amici, i colleghi, i maestri vicini e lontani: Juan Acevedo, Andrew Bellisari, Bradley
Blankemeyer, Andrea Canova, Cristiano Casalini, Nuno Castel-Branco, Guido Castelnuovo,
Marco Gentile, Paul F. Grendler, Laura Madella, Francesco Mattei, Davide Mombelli,
Franco Palmieri, Luana Salvarani. Un ultimo pensiero è per la comunità di Villa I
Tatti, fellows e staff, per la compagnia e il dialogo nell’ultima stesura di questo libro.
Il Drago
Tutti insieme sono andati all’inferno, dove non c’era mancanza di ospiti.
Lope de Vega, La Dragontea (Cant. IV, oct. 42)
Il pilota portoghese Nuno da Silva giunse in catene a Madrid nel settembre dell’anno
del Signore 1583. Il terzo giorno di quel mese Juan de Ledesma, segretario del reale
e supremo Consiglio delle Indie, il più alto tribunale dell’impero, prese in custodia
il prigioniero secondo le regole previste dalla legge. Lo scopo era ascoltare di persona
quanto ebbe visto e vissuto durante il viaggio compiuto con il corsaro inglese noto
in Spagna come il Drago. Nei palazzi del potere castigliano quel nome veniva pronunciato
a denti stretti, con un misto di timore e disprezzo. In quegli anni, il pirata eretico,
altrimenti conosciuto come Francis Drake, aveva sferrato un colpo durissimo al cuore
dell’impero ispanico, in quell’Oceano Pacifico da poco soggiogato dove le navi asburgiche,
rigurgitanti d’oro e d’argento, si ritenevano più al sicuro. Il poeta Lope de Vega,
anni dopo, avrebbe definito Drake «Satana in persona, l’incarnazione del genio del
male, l’arcinemico della Chiesa di Dio». Da Silva era accusato di aver navigato con lui fino agli estremi confini del mondo,
rivelandogli alcuni dei segreti più importanti custoditi dalla monarchia cattolica.
L’ossessivo martellare delle campane invadeva il cielo di quella solenne mattina di
San Gregorio. Il suono bronzeo, quasi ipnotico, forse riportò la mente del portoghese
ai tanti allarmi dati a bordo della Golden Hind, la nave di Drake, per prepararsi a un arrembaggio o a una tempesta in arrivo nelle
spietate correnti dei mari australi. In quel finale d’estate, la canicola era ancora
opprimente a Madrid, ma il clima, nella capitale, era molto diverso da quello respirato
nelle calde acque tropicali. Nel Real Alcázar, il palazzo reale dove si riuniva il
Consejo de Indias, i saloni erano adornati da immensi globi terrestri sorretti da lignee sculture erculee.
Gli austeri funzionari del Consiglio, di nero vestiti, gorgiere inamidate intorno
ai colli, dai loro scranni foderati di velluto trattavano da Silva alternando superiorità
e diffidenza. Per il pilota lusitano, infatti, fino a pochi anni prima la capitale
spagnola era stata una città nemica.
Nuno aveva lasciato la penisola iberica nel 1577 da Oporto, diretto verso le coste
del Brasile a bordo di navi mercantili. In quel momento il Portogallo era ancora un
regno indipendente. Nel volgere di pochi mesi, però, nell’agosto del 1578, il re lusitano
Sebastiano d’Aviz perse la vita nella disfatta di Alcazarquivir durante l’ennesima
crociata in Marocco, senza lasciare eredi. Il trono passò al vecchio zio di Sebastiano,
il settantenne cardinale Enrico, morto anch’egli due anni dopo, dando inizio a una
violenta guerra di successione. Tra i pretendenti prevalse il re di Spagna Filippo
II d’Asburgo, annientando il rivale Antonio, priore di Crato, nella sanguinosa battaglia
di Alcântara alle porte di Lisbona, il 25 agosto 1580. L’anno successivo, col nome
di Filippo I, il figlio del defunto imperatore Carlo V riunì sotto la sua sovranità
il regno e le colonie portoghesi alla Spagna, diventando così il più potente monarca
del mondo.
Nel momento del suo arrivo a Madrid, quindi, malgrado l’autonomia istituzionale mantenuta
da Lisbona, Nuno da Silva era un suddito del re Filippo. Un altro fatto, però, insospettiva
i magistrati incaricati di giudicare il caso. L’unione delle due corone non aveva
del tutto cancellato l’antica alleanza tra il regno lusitano e l’acerrimo nemico della
Spagna: l’Inghilterra. Un trattato stipulato nel 1373 sanciva ancora perenne amicizia
tra i due paesi. Probabilmente non fu questo il motivo che indusse il corsaro Drake
a rapire da Silva nel gennaio del 1578, durante una sosta nell’arcipelago di Capo
Verde, lungo la rotta per il Brasile. Più del diritto, infatti, negli oceani di quel
tempo vigeva la legge del più forte. Chi aveva bisogno di qualcosa, o di qualcuno,
di solito lo prendeva con la forza, cannoni e armi alla mano. Ciò che destava sospetto,
a Madrid, era che tra il Drago, El Drac, come lo troviamo spesso nominato nelle fonti, e l’esperto pilota portoghese potesse
essere sorta un’amicizia, o anche di più.
L’antica alleanza anglo-lusitana, unita al comune antagonismo antispagnolo, poteva
aver indotto il nuovo suddito ad agire in aperta ostilità contro re Filippo, macchiandosi
del grave crimine di lesa maestà. A ciò, tuttavia, si univa un altro terribile sospetto.
Quando il 13 aprile 1579 Drake rilasciò da Silva nella località portuale di Huatulco,
sulle coste occidentali del Messico, all’epoca noto come viceregno della Nuova Spagna,
il tribunale dell’Inquisizione locale aprì contro di lui un processo per eresia. Le
accuse erano di aver assistito a riti e sermoni luterani a bordo della nave inglese,
di aver compiuto di sua spontanea volontà atti di riverenza e sottomissione verso
la falsa dottrina cristiana. La colpa attribuitagli era grave. Dopo varie torture
e interrogatori, gli inquisitori giudicarono da Silva colpevole, condannandolo a fare
abiura de vehementi suspicione in un autodafé sulla pubblica piazza e all’esilio perpetuo dalle colonie.
In realtà, dietro alle formali accuse di eresia, di per sé già molto serie, si insinuava
un dubbio ancor più indicibile. Circolava una voce a Huatulco. Alcuni testimoni oculari
del rilascio di da Silva affermavano che il Drago – appellativo dalle suggestioni
sataniche, chiaro rimando a un’indole subdola e corruttrice – avesse indotto il portoghese
a indulgere in atti contro Dio e natura. Scriveva in proposito Simón de Miranda, vicario
del porto di Huatulco, che al momento del suo arrivo «Nuno da Silva aveva con Francis
Drake, da cui era stato rapito, un rapporto molto intimo. Il corsaro inglese lo accarezzava
e lo trattava molto bene, facendolo sedere regolarmente alla sua tavola». Anche il responsabile del porto della cittadina messicana, Francisco Gómez Rengifo,
affermava che «Drake e Nuno da Silva condividevano un’amicizia totale», senza però essere in grado di capire cosa i due si dicessero poiché parlavano entrambi
in inglese, lingua che egli non comprendeva.
Al momento del suo arrivo a Madrid nel 1583, quindi, Nuno da Silva non era solo un
prigioniero politico, ma era anche un eretico condannato. La sua posizione era compromessa
su vari piani. Da portoghese, fino a pochi anni prima, aveva operato in aperta rivalità
con il regno di Spagna. Dopo essere stato rapito da Drake egli avrebbe potuto mettere
le sue competenze di esperto marinaio al servizio dei più temibili nemici di Filippo
d’Asburgo: gli inglesi. La condanna per eresia completava la situazione peggiore che
egli potesse immaginare.
Questa storia aveva attirato anche l’attenzione del re, che volle convocare a Madrid
il pilota lusitano in quella fine d’estate per giudicare personalmente la sorte di
quel suo suddito così peculiare. Nella penombra delle austere sale del Consiglio delle
Indie, tra carte nautiche, mappamondi e sfere armillari, sotto il severo sguardo dei
suoi inquisitori, da Silva rilasciò una delle più strabilianti testimonianze mai ascoltate
da quegli uomini.
La vicenda narrata nelle prossime pagine è la storia dell’incredibile avventura vissuta
da Nuno da Silva insieme a Francis Drake, personaggio complesso, affascinante, contraddittorio:
esploratore, avventuriero, pirata, politico, intellettuale, scienziato. Seguiremo
le peripezie dei due navigatori nell’Oceano Atlantico e nell’Oceano Pacifico. Sullo
sfondo troveremo l’Inghilterra di Shakespeare e della regina Elisabetta I, la Spagna
di Miguel de Cervantes e dell’Inquisizione, l’Africa dei trafficanti di schiavi, l’America
dei conquistadores e delle ultime vestigia degli imperi azteco, maya e inca. Per finire, accompagneremo
da Silva nel suo viaggio di ritorno dal Messico alla Spagna e Francis Drake nel suo
giro del mondo, il primo compiuto da un inglese, monito e presagio della futura talassocrazia
britannica.
Come affermarono alcuni sopravvissuti di questo viaggio, grande fu il debito inglese
al pilota portoghese Nuno da Silva. Francis Fletcher, cappellano della nave di Drake,
scrisse nel suo diario che «se Dio non lo avesse mandato da noi, probabilmente nel
corso del viaggio saremmo tutti morti».
Prima di lanciarci all’inseguimento dei corsari inglesi e dei galeoni spagnoli nel
Mar dei Caraibi e nelle acque del Pacifico, però, facciamo un passo indietro per capire
meglio il terribile conflitto e le titaniche personalità che animarono e fecero da
sfondo a queste gesta.
1.
Lotta per la supremazia
1. Anatomia di un conflitto
Nella seconda metà del Cinquecento, il cuore d’Europa fu lacerato da guerre crudeli
e sanguinose. La riforma protestante, iniziata nel 1517 da un oscuro presbitero sassone,
l’agostiniano Martin Lutero, aveva distrutto irrimediabilmente le fondamenta comuni
della cristianità occidentale. Secondo alcuni costui era l’Anticristo, il segno diabolico
e inequivocabile della prossima fine dei tempi. Secondo altri, Lutero era il rinnovatore
che avrebbe messo fine alla depravazione che imperversava nella Chiesa di Roma.
Alcune dinastie europee videro in questa rottura una ghiotta opportunità. Il papato,
in quei decenni, si mostrava agli occhi di molti sempre più corrotto e decadente.
Il lusso in cui vivevano i pontefici mal si sposava con il crescente bisogno di rinascita
spirituale avvertito in Europa in quei decenni turbolenti. Le enormi somme di denaro
destinate alla faraonica costruzione della nuova basilica di San Pietro, sottratte
ai semplici cristiani (e alle casse degli erari) con la vendita delle indulgenze,
lucrando sul terrore dell’inferno e sulla superstizione degli ingenui, erano sempre
meno tollerate. Molti sovrani, soprattutto nel nord (tedeschi e scandinavi), erano
stanchi di sottostare al giogo apostolico romano e aderirono alle nuove dottrine.
Un misto di senso religioso e ragion di Stato determinava queste decisioni. La separazione
dalla Chiesa cattolica, infatti, avrebbe permesso a principi e re di incamerare gli
enormi patrimoni di monasteri e conventi, a beneficio di sé stessi e delle finanze
pubbliche.
Non tutti i regnanti, tuttavia, scorsero un vantaggio nell’adesione alla Riforma.
Ad alcuni la fedeltà al papato garantiva forza e stabilità. La monarchia francese,
fille ainée de l’Église, figlia primogenita della Chiesa, traeva una mistica legittimità dalla secolare alleanza
con il papa. Malgrado le ambiguità e le contraddizioni del recente passato, il re
di Francia restava sempre le Roi très chrétien, il Re cristianissimo. Altri regni, come Spagna e Portogallo, fondavano in quei decenni
le proprie ambizioni di egemonia globale sull’autorità di dominus orbi incarnata dai papi. Nella città spagnola di Tordesillas, nel 1494 era stato firmato
un trattato che aveva spartito il mondo in due, concedendolo alle monarchie lusitana
e castigliana. L’accordo fu voluto da Alessandro VI Borgia, uno dei pontefici più
mondani e assetati di potere di quest’epoca irrequieta. Fu ancora il Borgia a conferire
ai monarchi di Castiglia e Aragona, sul modello dei re di Francia, l’appellativo di
Re Cattolici, trasmissibile in perpetuo ai propri eredi.
Come vedremo nelle pagine seguenti, comprendere la tragica profondità di questi conflitti
sarà essenziale per seguire le gesta del corsaro Francis Drake. Le grandi potenze
cattoliche, infatti, quando non erano occupate a combattersi tra loro, soffocavano
nel sangue il diffondersi delle dottrine protestanti che si facevano ormai strada
con prepotenza all’interno dei loro confini. Una dinastia, in particolare, si ergeva
sulle altre in difesa dell’intransigenza cattolica. Filippo II d’Asburgo, sul trono
dal 1556 al 1598, aveva ricevuto dal padre, Carlo V, i regni di Castiglia, Aragona,
Napoli, Sicilia, Sardegna, i ducati di Milano e Borgogna, le Fiandre, oltre allo sconfinato
impero americano ottenuto dai conquistadores spagnoli al costo di innumerevoli lutti, inferti e subiti. Come se ciò non bastasse,
nel 1580 l’acquisizione della corona di Portogallo e Algarve aveva conferito alla
Casa d’Asburgo il dominio sull’altra metà del mondo: Africa e Asia. Il potere del
re di Spagna si estendeva così dai deserti delle Ande alle foreste pluviali dell’Angola
e del Mozambico, dalle foci del Rio delle Amazzoni agli arcipelaghi indonesiani. Filippo
d’Asburgo era stato investito dalla Provvidenza divina del dovere di portare la Santa
religione, cattolica, apostolica e romana, fino agli antipodi del mondo, soffocando
nel sangue, una volta per tutte, l’eresia luterana iniziata nel 1517.
Filippo non era bello, ma era circondato da un’aura carismatica; basso di statura,
i suoi occhi azzurri emanavano una gelida luce in grado di incutere soggezione a chi
gli stava innanzi. Egli era anche l’erede di un secolare impegno crociato. I suoi antenati terminarono
con successo la Reconquista della penisola iberica, strappandola al dominio delle dinastie musulmane. Davanti
a lui, in un mondo ormai globale, si profilavano nuove, titaniche sfide. A est e a
sud, nel Mediterraneo, premevano i turchi ottomani e avanzava potente la minaccia
islamica. Nel cuore d’Europa si diffondeva il veleno della nuova eresia. Agli occhi
di Filippo la perniciosità di quelle dottrine era pari al loro moltiplicarsi in nuove
confessioni: luterani, calvinisti, anglicani, anabattisti. Nel resto del mondo, tra
immensi oceani e continenti da poco soggiogati, vi erano masse sterminate di persone
da conquistare alla vera fede. Filippo sapeva di essere il solo a poter prevalere
in queste prove.
Nessun altro.
Non i re di Francia, invischiati in quegli anni in un’estenuante serie di guerre civili.
Troppo deboli anche i suoi cugini, gli Asburgo d’Austria. I sacri romani imperatori,
contestati dai principi dei tanti, troppi Stati tedeschi, sempre in bilico tra cattolicesimo
ed eresia, contenevano a stento l’espansione ottomana, che sotto la guida del sultano
Solimano il Magnifico, nel 1529, era giunta fino alle porte di Vienna.
Solo un regno si ergeva ancora tra Filippo e il dominio del mondo. Un periferico Stato
insulare, retto da una donna, che in pochi avrebbero creduto capace di guidare un
popolo nel furore della battaglia. Si trattava dell’Inghilterra e della sua regina,
Elisabetta I Tudor. Suo padre, Enrico VIII, dopo un’iniziale difesa del papato, nel
1534 aveva sottratto il regno di San Giorgio alla comunione con Roma, emanando l’Atto
di Supremazia. Tuttavia, a metà del Cinquecento il reame inglese era ancora in preda
a trasformazioni dolorose che ne laceravano il tessuto sociale. Lo Stato ereditato
da Elisabetta nel 1558 era afflitto da contraddizioni e ferite profonde.
Il grande numero di fedeli cattolici ancora presenti nel regno poneva un serio problema
di ordine pubblico e di fedeltà alla corona. Le enormi ricchezze incamerate grazie
alla soppressione degli ordini religiosi avevano arricchito enormemente lo Stato,
ma l’economia inglese, basata su pastorizia e agricoltura, era ancora marginale e
relativamente arretrata rispetto ad altre regioni d’Europa. Niente di paragonabile
alle manifatture tessili fiamminghe e italiane. Nulla di simile alle navi ricolme
d’oro, d’argento e spezie che ogni anno giungevano in Spagna e in Portogallo dalle
colonie americane e asiatiche.
Anche l’ascesa al trono di Elisabetta non era stata senza problemi. Sua madre, Anna
Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, fu decapitata nel 1536 con l’accusa di stregoneria,
incesto e alto tradimento. La principessa, di soli tre anni, fu così estromessa dalla
linea di successione e mandata in esilio. Venne riammessa a corte qualche anno dopo,
grazie a una serie di fortunate amicizie con le successive mogli del padre. Le matrigne,
diversamente da quanto avviene nelle fiabe, l’aiutarono a rientrare nella linea ereditaria.
Enrico, infatti, era riuscito nel frattempo ad avere un figlio maschio succedutogli
nel 1547, all’età di dieci anni, col nome di Edoardo VI. Il giovane re, tuttavia,
non era destinato a regnare a lungo. Morì di una dolorosa malattia, forse tubercolosi,
quando era appena adolescente, nel 1553. Il momento di Elisabetta, comunque, non era
ancora arrivato. Davanti a lei, in ordine di successione, vi era la sorellastra Maria,
figlia di Caterina d’Aragona, prima moglie di Enrico. Era stato proprio il divorzio
tra i due illustri coniugi a provocare la separazione da Roma dell’Inghilterra e il
suo ingresso nel partito protestante.
I piani di Maria, però, non erano quelli del padre. Nel corso del suo breve regno,
durato dal 1553 al 1558, ella tentò una feroce restaurazione della Chiesa cattolica
in Inghilterra. La sua politica contro gli oppositori protestanti fu così dura da
guadagnarle l’appellativo di Maria la Sanguinaria. Malgrado la formidabile serie di
esecuzioni e incarcerazioni, Maria era perlopiù sostenuta dai suoi sudditi, rimasti
in gran parte legati alla vecchia religione. Inoltre, arrivata alla soglia dei 38
anni, la sovrana necessitava di rafforzare la propria posizione trovando un marito
per assicurarsi una discendenza. Dietro suggerimento del cugino, l’imperatore Carlo
V, la scelta cadde sul figlio di quest’ultimo, Filippo, erede al trono di Spagna,
di 11 anni più giovane. Si celebrò così un matrimonio, ma una serie di condizioni contrattuali sfavorevoli,
tra cui il non godere del titolo di re regnante ma solo di re consorte, non guadagnarono
il cuore di Filippo alla causa inglese, benché Maria, pare, ne fosse realmente innamorata.
L’unione non mancava comunque di una profonda coerenza politica. L’obiettivo di questi
campioni della cattolicità era riportare definitivamente il regno inglese nel campo
di Roma, e generare un successore che ne assicurasse la continuità. La coppia sembrava
vincente. Tuttavia, come spesso accade, il destino aveva in serbo qualcosa di diverso.
Non solo l’unione tra Maria e Filippo non generò prole, ma la regina morì presto di
tumore ovarico, il 17 novembre 1558. Per il partito cattolico al potere, guidato da
Thomas Howard, IV duca di Norfolk, era chiaro che con la morte di Maria, in mancanza
di figli, mantenere l’Inghilterra nella sfera di Roma sarebbe stato impossibile.
Il trono era finalmente destinato a Elisabetta, protestante convinta. Per sventarne
l’incoronazione, Norfolk cercò di convincere la regina morente a firmarne la condanna
a morte, ma senza successo. Filippo, per parte sua, non fu colpito dal decesso della
consorte. Piuttosto, egli non aveva alcuna intenzione di rinunciare al trono inglese.
Per questo motivo, si propose subito a Elisabetta, la figlia dell’odiata Anna Bolena.
La nuova regina lo rifiutò senza esitare, così come fece con tutti quelli che si candidarono
per la sua mano. Memore della difficile infanzia, passata tra esilio e prigionia,
sopravvissuta all’esecuzione della madre e delle sue tante matrigne, Elisabetta sapeva
che era infine giunto il suo momento di regnare. Una donna, sola per scelta, protestante
per vocazione, avrebbe preso in mano le redini del regno d’Inghilterra, e nulla, d’ora
in poi, sarebbe più rimasto uguale.
2. Il mondo non basta
Il 1559 doveva rivelarsi un momento decisivo per le sorti d’Europa. Tutte le condizioni
per l’inizio della guerra sembravano essere riunite. Elisabetta, in quel momento,
aveva nemici sia in patria che fuori. Il 15 gennaio di quell’anno la sua incoronazione
si svolse in tono dimesso, senza sfarzo né pompa. Molti vescovi inglesi le si opponevano
poiché la ritenevano illegittima. La questione religiosa, per la nuova regina, fu
da subito scottante, come lo sarebbe stata nell’avventura di Drake e Nuno da Silva.
Quello stesso anno, dietro consiglio di William Cecil, I barone Burghley, la sovrana
emanò l’Atto di Uniformità, rendendo obbligatorio per la liturgia l’uso del Book of Common Prayer. Il testo prevedeva una sintesi fra tradizione cattolica e innovazioni protestanti
per garantire il più possibile la concordia religiosa. Sempre nel 1559, Elisabetta
emanò un nuovo Atto di Supremazia, il secondo dopo quello del padre, obbligando i
pubblici ufficiali a prestarle giuramento di fedeltà e a riconoscere la sua autorità
religiosa. La regina assunse anche il titolo di supremo governatore della Chiesa d’Inghilterra,
causando forti scontenti tra il clero e in ampie fasce di popolazione.
In questo clima di tensione, una formidabile rivale per la figlia di Enrico VIII sorse
in sua cugina, Maria Stuarda regina di Scozia. Nel momento dell’incoronazione di Elisabetta,
approfittando della sua difficile situazione, Maria si dichiarò legittima sovrana
d’Inghilterra, sperando così di abbatterne il fragile regno. In quel momento, la Stuarda
si trovava in Francia come moglie dello sfortunato re Francesco II di Valois. Dopo
la morte di questo, rimasto sul trono per poco più di un anno, nel 1561 Maria tornò
in Scozia inaugurando un lungo periodo di tensione politica, tra complotti e persecuzioni
religiose.
In questa situazione, il rifiuto della regina alla proposta di matrimonio di Filippo
aveva esacerbato l’animo di quest’ultimo, quanto mai determinato a far valere i propri
diritti sulla corona inglese. Il re di Spagna, all’indomani dell’ascesa al trono della
rivale, disponeva di incredibili risorse materiali, umane e militari. La pace di Cateau-Cambrésis,
firmata nell’aprile del 1559, aveva messo fine a mezzo secolo di guerre combattute
in Italia tra Francia e Spagna per il dominio sulla penisola. Il conflitto vide il
completo trionfo spagnolo, che acquisiva di fatto il controllo di quasi tutto il territorio
italiano, estromettendo una volta per tutte il nemico francese.
Gli eserciti di Filippo erano ora una macchina da guerra letale. I suoi soldati, provenienti
da Spagna, Italia, Fiandre, Sardegna e Sicilia, erano stati forgiati da decenni di
battaglie in Africa, Europa e America; un’eterogenea massa umana tenuta insieme dalla
comune fedeltà al sovrano, al suo Dio e al suo denaro. Questa ricchezza proveniva
in gran parte dalle miniere del Potosí, nel viceregno del Perù, strappato con la forza
anni addietro all’impero inca. Lo storico rivale di Filippo, il regno di Francia, si trovava adesso sull’orlo del
baratro, e non avrebbe rappresentato una minaccia. Nel 1560, dopo la morte di Francesco
II di Valois, cattolici e calvinisti erano al vertice della tensione, pronti a iniziare
quarant’anni di guerre spietate, in cui entrambe le parti avrebbero versato fiumi
di sangue, macchiandosi di crimini impronunciabili.
Filippo, tuttavia, oltre che ambizioso era anche un uomo di giudizio, non era avventato.
Non approfittò del suo vantaggio strategico per aggredire l’Inghilterra; non subito
almeno. La Spagna possedeva già metà del mondo, perché sprecare preziose risorse quando
il regno di Elisabetta sarebbe presto crollato per le difficoltà che lo attanagliavano?
Meglio aspettare che gli eventi facessero il loro corso. Il grande impero spagnolo,
infatti, aveva un solo punto debole: l’enorme dimensione. La sua estensione globale
ne aveva allungato e assottigliato le vie di comunicazione, rendendolo fragile. In
fondo, era un gigante dai piedi d’argilla. Incrinare una sola parte della sua delicata
ossatura di trasporti e vie di comunicazione, terrestri e marittime, avrebbe rischiato
di far implodere l’intero sistema.
Malgrado la sproporzione tra le forze in campo, la Spagna di Filippo II non poteva
permettere a nessuno di metterne in discussione il primato. L’Inghilterra, la cui
proiezione sui mari del mondo era ancora ai primordi, lottava invece per sopravvivere
e per ritagliarsi un posto al tavolo delle grandi potenze. Soccombere davanti al gigante
iberico avrebbe rappresentato la fine dei sogni di gloria della corona inglese. Elisabetta
sapeva bene di non avere alcuna speranza contro la Spagna in una guerra europea. Qualsiasi
tentativo di sbarco sul continente sarebbe stato annientato in un sol colpo dai temibili
tercios spagnoli, unità militari d’élite composte da picchieri, moschettieri e archibugieri,
addestrati da decenni di feroci battaglie. Consapevole di questo, la regina decise
di spostare la guerra là dove il suo nemico era più debole. Avrebbe colpito lontano
dalla tormentata Europa, oltre gli oceani, nel Nuovo Mondo, selvaggio e non ancora
addomesticato. Nei primi anni del suo regno, la sovrana iniziò a concepire un piano,
non facile da realizzare, la cui attuazione avrebbe richiesto anni: colpire la Spagna
dove si sentiva più sicura, nell’Oceano Pacifico da poco scoperto.
Il conflitto tra Elisabetta e Filippo, tra Spagna e Inghilterra, rappresentò una delle
più drammatiche lotte che insanguinarono il Cinquecento. Davide contro Golia. Questo
scontro fu più cose in una, in primis una guerra di religione, per definizione una guerra totale. Il nemico non era solo
un avversario, ma l’Anticristo, con cui non poteva esistere un compromesso. Le parti
coinvolte, cattolici e protestanti, erano convinte di lottare per la verità, e per
la salvezza delle proprie anime.
Fu anche una guerra tra potenze moderne in lotta per la supremazia sul mondo. Soprattutto,
il conflitto di cui stiamo parlando fu un duello tra due personalità i cui tratti
marcarono indelebilmente un’epoca e i rispettivi mondi. Ci stiamo muovendo nell’Inghilterra
dell’Amleto, nella Spagna del Don Chisciotte. I castelli del Nord sono abitati da fantasmi barocchi, allucinato presagio dei drammi
di un prossimo dominio globale. Le campagne del Sud sono percorse da pìcari, furfanti
e nobili in disgrazia; profezia di una Spagna che non riuscirà a interpretare il grande
vantaggio accumulato sul mondo. Siamo davanti all’epocale scontro tra la Regina vergine
e il Re cattolico, sulle cui ambizioni nessun dubbio era lasciato dal motto Non sufficit orbis: il mondo non basta.
3. «Sea Dogs»: i segugi della regina
Dopo aver visto lo scenario che fece da sfondo all’ascesa di Elisabetta e al suo conflitto
europeo, spostiamoci adesso sul principale teatro di questa storia: il mare. Per portare
la guerra sugli oceani del Nuovo Mondo la regina aveva bisogno di una marina militare
adeguatamente organizzata. La Navy Royal, com’era chiamata in questo periodo la flotta da guerra inglese, era stata rafforzata
pochi decenni prima da Enrico VIII per poterla usare nelle guerre di inizio Cinquecento
contro il suo storico nemico: la Francia. Nel 1547 la flotta reale poteva contare
su 58 vascelli, alcuni di essi espressamente costruiti per la guerra. Il battesimo
del fuoco per la nuova marina militare era avvenuto nel 1545 con la battaglia del
Solent, nel Canale della Manica, contro un’imponente armata francese di 200 navi.
I capitani inglesi non ne uscirono vincitori, ma ressero l’urto, impedendo agli odiati
vicini di invadere la madrepatria.
Anche questo era un successo.
Tuttavia, nonostante gli ammodernamenti, una forza navale permanente costava molto
denaro; non conveniva mantenerla in tempo di pace. Tra la morte di Enrico VIII e l’incoronazione di Elisabetta I, le travagliate vicende
dinastiche inglesi misero in secondo piano le ambizioni talassocratiche della corona.
La nuova sovrana, all’indomani della sua ascesa al trono, non poteva contare su nulla
di simile alle potenti armate dei regni iberici, Spagna e Portogallo, che controllavano
con la forza le vaste acque degli oceani Atlantico e Indiano. Per poter affrontare
la potente Armada spagnola, Elisabetta non poteva quindi usare una strategia basata sulla forza dei
soli numeri di navi e cannoni. Si decise di optare per una tattica diversa, per una
sorta di guerriglia dei mari. Le navi della Navy Royal, affiancate da vascelli di proprietà privata, avrebbero attuato una serie di incursioni
contro i porti e le navi spagnole che, cariche d’oro e argento, tornavano in Europa
attraversando l’Atlantico.
Fu in questo momento che emersero alcune personalità eccezionali al servizio della
regina. Costoro erano la punta di diamante della marina inglese: un gruppo di impavidi
mossi da un rapace desiderio di ricchezza, da un’insaziabile fame di avventura, ma
anche da un alto senso dell’onore e di servizio dello Stato. Questi cavalieri del
mare vennero chiamati Sea Dogs, i corsari elisabettiani. Un corsaro, a differenza di un pirata, nell’epoca in cui
ci troviamo era un privato cittadino autorizzato dallo Stato, in questo caso dal re
o dalla regina, con un documento chiamato ‘lettera’ o ‘patente di corsa’, ad attaccare
le navi di altri paesi per trarne un bottino. La condizione era che il guadagno ottenuto
dal corsaro avrebbe dovuto essere spartito con il sovrano che gli aveva concesso la
patente. In altre parole, i corsari erano dei mercenari incaricati di sopperire alle
mancanze degli apparati militari regolari. La guerra di corsa diventò presto un formidabile
strumento di guadagno per gli Stati dell’Europa moderna.
Tra i corsari inglesi, i nomi più famosi rimasti nei registri della storia sono quelli
di John e Richard Hawkins, Thomas Cavendish, Humphrey Gilbert, Martin Frobisher, Walter
Raleigh, e il protagonista di questa storia: Francis Drake. Costoro, però, non possono
essere definiti dei semplici mercenari. Con le loro gesta scrissero alcune delle pagine
più gloriose della marineria inglese. Le loro personalità sono troppo complesse, sfaccettate
e contraddittorie per essere rinchiuse in anguste categorie. L’avidità personale,
la cupidigia, la brama di ricchezze erano certamente stimoli potenti per intraprendere
la guerra di corsa. Le navi spagnole di ritorno dal Nuovo Mondo, rigurgitanti di tesori,
rappresentavano un bersaglio appetitoso e relativamente facile. Tuttavia, essi erano
anche animati da un alto senso civico e morale.
I corsari della regina erano spesso nobili e cortigiani; in molti casi amici personali
di Elisabetta. Essi sentivano un forte legame con la sovrana, che servivano con lo
slancio di antichi cavalieri medievali. Vi era nel loro agire una sorta di patriottismo.
Oltre a ciò, i Sea Dogs erano anche convinti protestanti, sostenitori della lotta contro l’imperialismo ispano-cattolico
e contro il papa di Roma, ai loro occhi la nuova Babilonia. La guerra di corsa nel
vasto oceano diventava così un’altra guerra per la redenzione dell’anima. Come è stato
scritto nel XIX secolo, il potere inglese sui mari fu il figlio legittimo della riforma
protestante.
Abbiamo detto che le vicende dei Sea Dogs furono avventurose e controverse, contraddistinte da eroici atti di coraggio, ma
anche da azioni turpi e disumane. Sir John Hawkins, nel 1562, fu il primo inglese
a trafficare in schiavi tra l’Africa e le Americhe in quel sistema che prese il nome
di commercio triangolare. Ovviamente, per fare questo, Hawkins dovette sfidare il
monopolio mercantile nell’Atlantico di Spagna e Portogallo, diventando il primo grande
corsaro della regina Elisabetta. Hawkins passò la vita al servizio della sovrana,
di cui fu amico, e per la quale svolse diverse mansioni come quella di spia e di agente
segreto. Nel 1571, fingendosi amico dell’ambasciatore spagnolo in Inghilterra, Don
Guerau de Espés, Hawkins salvò la vita della regina sventando un intrigo ordito dalla
sua nemica, Maria Stuarda, passato alla storia come il complotto Ridolfi. In premio
ottenne un seggio in parlamento in rappresentanza di Plymouth, diventando tesoriere
della marina. Egli fu colui che, dopo i fasti di Enrico VIII, riformò la flotta inglese
avviandola verso il futuro dominio degli oceani.
Un altro politico che seguì la via del mare fu Thomas Cavendish, originario di Ipswich,
nella contea del Suffolk. Nel petto di questo gentiluomo batteva un cuore selvaggio,
amante dell’eccesso e dell’avventura, tanto da valergli in seguito il soprannome di
Navigator. Dopo gli studi a Cambridge e l’attività in parlamento, dilapidò in pochi anni l’enorme
ricchezza ereditata dal padre con uno stile di vita lussuoso e sregolato. Rimasto
senza soldi, decise di rifarsi una fortuna in mare. A soli 25 anni, nel 1585 Cavendish
acquistò un bastimento che battezzò Elizabeth, e partecipò alla spedizione in Virginia condotta da un altro famigerato Sea Dog, Richard Grenville. L’anno successivo, esaltato da quel primo viaggio e ispirato,
come vedremo, dal giro del mondo compiuto da Drake, decise di seguirne le orme riportando
la guerra di corsa nel Pacifico. Dopo una serie di spettacolari attacchi contro navi
spagnole, Cavendish fu il primo a catturare il cosiddetto Galeone di Manila, facente spola tra le coste del Messico e delle Filippine carico di argento. Dopo
aver navigato per gli arcipelaghi asiatici e l’Oceano Indiano, portando con sé due
viaggiatori giapponesi, nel 1588 rientrò in Inghilterra. Aveva appena 28 anni.
Per chiudere questa galleria di corsari, non possiamo non parlare di Sir Walter Raleigh,
tra i personaggi più affascinanti e caleidoscopici dell’età elisabettiana. Oltre che
navigatore e politico, Raleigh fu poeta e scrittore. Egli combatté insieme a Drake
nell’eroica difesa dell’Inghilterra contro il tentativo di sbarco dell’ArmadaInvencible spagnola nel 1588, e fu tra i primi esploratori delle coste dell’America settentrionale.
Nel 1585 fondò la colonia a cui diede nome Virginia, in onore della sua venerata sovrana,
Elisabetta, la Regina Vergine. La sua fama è anche legata a uno dei più oscuri miti
di fondazione dell’America coloniale. In Virginia, il primo insediamento inglese fu
creato da Raleigh sull’Isola di Roanoke, al largo dell’attuale Carolina del Nord.
Al popolamento della colonia partecipò anche Drake, il quale, navigando in prossimità
di Roanoke, rispose all’appello degli abitanti lasciando 15 uomini a protezione del
forte.
I primi anni a Roanoke furono molto difficili. Gli scontri con le tribù native erano
iniziati subito dopo l’approdo degli europei a causa dei furti compiuti dai nuovi
arrivati, stremati dalla fatica e dalla fame. Al giungere di una seconda nave con
117 coloni nel 1587, degli uomini lasciati da Drake erano rimaste soltanto le ossa.
L’orrore, però, non era ancora finito. A causa della guerra contro la Spagna, Raleigh
non riuscì a mandare soccorsi e provviste alla colonia, che fu raggiunta solo nel
1590 dal suo amico John White. Al suo arrivo, White non trovò nessuno, la colonia
era completamente sparita. Nessuna traccia di lotta, nessun cadavere, niente resti;
solo la scritta sul tronco di un albero: croatoan. Si trattava del nome di un’isola vicina, sulla quale, probabilmente, i coloni si
rifugiarono assimilandosi con la tribù di nativi locali.
Il mistero però rimase e, malgrado le ricerche, di quella gente non si seppe più nulla.
Raleigh, sentendosi responsabile, non si diede pace, e inviò negli anni successivi
ben cinque spedizioni di ricerca a proprie spese, senza alcun successo. Dopo la morte
di Elisabetta nel 1603, Raleigh cadde in disgrazia presso il nuovo sovrano, Giacomo
I Stuart. Troppo fedele alla sua regina, intimorito dall’ascesa al trono della dinastia
rivale, fu coinvolto in una congiura contro il re, venendo scoperto. Alternò così
una serie di periodi in carcere a nuove esplorazioni del continente americano, fino
alla condanna a morte, nel cortile del palazzo di Westminster, dove fu decapitato
nel 1618.
Torniamo ora alla storia del protagonista di questo libro, Sir Francis Drake. La vicenda
del Drago si intreccia con quelle dei Sea Dogs finora descritti. John Hawkins ne fu il mentore, Thomas Cavendish l’imitatore, Walter
Raleigh il compagno in battaglia. Drake incarnò fino in fondo lo spirito della sua
epoca; un mondo di contraddizioni drammatiche e laceranti, in cui la vita umana valeva
meno della reputazione di un uomo, e immense fortune si costruivano sul sangue di
migliaia di schiavi rapiti dalla propria terra. Un mondo in cui si uccideva in nome
di Dio, e in cui nuovi mondi potevano essere scoperti e conquistati grazie all’intraprendenza
di pochi. Un mondo in cui si forgiavano i capolavori dell’arte e del pensiero, eterni
monumenti del genio umano, ma si poteva finire bruciati per le proprie idee, o torturati
per aver pronunciato una preghiera nella lingua sbagliata. Per seguire le tracce di
Francis Drake in questo scenario crudele e avventuroso, volgiamo la nostra attenzione
al luogo dell’infanzia del futuro corsaro, un attimo prima del suo salto nel blu profondo
dell’oceano.
4. La terra del Drago. Streghe, diavoli e folletti
Il borgo di Tavistock sorge nel Devon, al confine con la Cornovaglia, tra le falde
dell’altopiano del Dartmoor e il porto di Plymouth, quindici miglia più a sud. Una
cittadina commerciale sferzata dai venti spiranti dal mare e dalle frequenti piogge
atlantiche, dove il grido dei gabbiani si perde nello stacco tra il cielo metallico
e la verde erba dei prati. Le guglie gotiche dal severo profilo della parrocchia di
Sant’Eustachio e dell’abbazia di San Rumone sorvegliano, immobili testimoni, il fluire
lento della vita degli abitanti. Nascita, vita, morte. Lì venne al mondo Francis Drake;
più precisamente nella tenuta di Crowndale Farm, le cui rovine possono essere ammirate
ancora oggi. Non è noto con precisione quando, probabilmente nel 1540 o nel 1541. In quell’Inghilterra ancora fieramente medievale, la data di nascita dei bambini
raramente veniva registrata: troppo alta la possibilità che morissero nei primi mesi
di vita.
Francis era il maggiore dei dodici figli nati dall’unione tra Edmund Drake e Mary
Mylwaye, una coppia di abbienti contadini. Il padrino del piccolo fu nientemeno che
Francis Russell, II conte di Bedford, il signore locale, del quale prese il nome,
a riprova di una condizione sociale più che agiata. Lord Russell era un protestante
convinto. Durante la feroce restaurazione cattolica di Maria Tudor, anni dopo, avrebbe
assaggiato l’amaro sapore del carcere. Anche il padre del giovane Drake aveva aderito
alla Riforma, diventando sacerdote e veemente predicatore antipapista: un tratto che
avrebbe passato al suo primogenito.
Tuttavia, Edmund non trasmise al figlio soltanto lo zelo religioso, egli era anche
una testa calda e nutriva un certo gusto per la violenza e la sopraffazione. Nel 1548,
in due occasioni, con l’aiuto di alcuni complici attaccò e rapinò, armi alla mano,
alcuni malcapitati, cavandosela senza gravi conseguenze grazie alle sue relazioni
altolocate. Questi episodi rivelano già un aspetto della personalità che troveremo nel Drago.
Non dobbiamo però pensare che simili situazioni fossero insolite nel mondo in cui
ci stiamo avventurando. In quegli anni, travagliati da disordini politici e tensioni
religiose, non era infrequente che odi personali, faide familiari o fedeltà particolari
si sovrapponessero alle ragioni dello spirito, senza che ciò fosse percepito come
una contraddizione. A ogni modo, forse in seguito a queste aggressioni o nel corso
di una rivolta antiprotestante, nel 1549 Edmund Drake fu costretto a fuggire, rifugiandosi
a est, nel Kent.
Prima di continuare, vale la pena soffermarsi ancora un poco sull’infanzia di Francis.
Gli anni passati a Tavistock dovettero lasciare una traccia profonda nella sua personalità.
Non sappiamo granché di quel periodo, ma possiamo immaginarlo passato a giocare, sognando
battaglie e avventure, correndo per le brughiere, facendo sassaiole con le bande di
ragazzini dei villaggi vicini, o tra figli di cattolici e di protestanti. Anche i
bambini, a modo loro, partecipavano alla grande politica. Fu in questo periodo che
si radicarono in Drake il fascino dell’ignoto e il gusto dell’impresa. L’altopiano
del Dartmoor, dalla bassa curva color ruggine, ondulata e malinconica, la brughiera
costellata di case in granito e antichi castelli, fu la culla di storie di fantasmi,
fate e folletti.
Il folklore celtico è sempre stato forte in quella terra. Per questo è lecito concederci
una suggestione, una fantasia plausibile. Immaginiamo Francis bambino, una scena senza
tempo, uguale nei secoli. Gli occhi sgranati davanti al focolare crepitante nelle
lunghe sere invernali, il vento che fuori urla spietato, ascolta miti e leggende,
eredità di un passato ancestrale, prima di crescere e spostare lo sguardo sullo sconfinato
orizzonte del mare. Sperduta in un deserto d’erba, la tomba in pietra del ricco cacciatore
Childe, morto nella brughiera durante una tempesta di neve. La leggenda della bestia
del Dartmoor, un’enorme creatura nera che si diceva aggirarsi per quelle campagne.
Il diavolo stesso ne percorreva i sentieri, a volte manifestandosi, come avvenne,
secondo le cronache, durante il grande temporale del 1638 a Widecombe in the Moor.
Anche di questo si nutrì il futuro predatore degli oceani. Tra la magia e il mare
il passo non era lungo: entrambe le cose, a quel tempo, simboleggiavano il mistero
di forze primordiali, incontrollabili. Lo avrebbe raccontato bene Shakespeare nella
Tempesta, dove creature magiche abitano isole sperdute e inaccessibili, o quasi, agli umani.
Come a Roanoke, coloro che giungono sull’isola vanno incontro a terribili conseguenze.
«Voi siete tre uomini di peccato il cui destino – che governa questo basso mondo con
quelli che vi sono – costrinse il mare insaziato a trarvi su quest’isola dove essere
umano abitare non deve, voi che siete ora indegni di vivere. Io vi ho resi pazzi»,
è ciò che il Bardo fa dire ad Ariel, lo spirito dell’aria, agli uomini che si erano
spinti fin lì. Shakespeare conosceva di persona molti esploratori e colonizzatori; egli stesso
investì denaro nella Virginia Company, la società commerciale che continuò i tentativi
d’insediamento nelle coste nordamericane iniziati da Raleigh e da Drake.
Più in generale, gli anni dell’infanzia di Francis rappresentarono per l’Inghilterra
un momento di forte tensione sociale. Alla base di molti dei patrimoni che permisero
ad armatori e mercanti di intraprendere i viaggi di esplorazione e colonizzazione
vi fu l’espropriazione delle terre comuni di molti villaggi. I prati e i boschi che
per secoli avevano sfamato con i loro prodotti, e riscaldato con la loro legna le
case degli abitanti delle campagne inglesi venivano ora recintati e confiscati dai
nobili. Tra loro vi erano anche diversi tra i Sea Dogs che abbiamo visto. Siamo agli albori del capitalismo moderno. Sopraffazione, violenza
e furto non avvenivano solo in mare. La guerra di corsa, in un certo senso, era stata
già collaudata in terra. Ciò, tuttavia, non mancò di sollevare reazioni. Le rivolte
dei contadini tormentarono il lungo regno di Elisabetta, venendo puntualmente soffocate
nel sangue. In più, le tradizionali esportazioni di pannilana, che avevano tenuto
in piedi per secoli l’economia inglese, stavano declinando. L’Inghilterra stava diventando
sempre più una terra di vagabondi senza lavoro in marcia da un borgo all’altro, mendicando
senza scopo e senza occupazione.
In quest’epoca di incertezza si diffuse il timore che alla base di tutto vi fosse
l’azione del diavolo e delle streghe, che dal principe del male traevano il potere
di diffondere morte e discordia. Nel 1557, vagando nelle campagne inglesi, non era
difficile imbattersi in impiccagioni di donne accusate di stregoneria; nella seconda
metà del Cinquecento ebbero luogo in Inghilterra 94 condanne a morte. Un picco di esecuzioni si ebbe tra il 1590 e il 1597, al quale ne seguirono altre
nei decenni successivi. Non solo donne, però, venivano condannate. Il bandito Luke
Hutton, mandato a morte nel 1598 per aver rubato strumenti chirurgici, dedicò al suo
boia una ballata composta nel 1596 intitolata The Black Dog, il Cane nero. La storia era ispirata alla leggenda della bestia del Dartmoor. Nell’opera,
il cane nero incarnava un essere diabolico che, assumendo le sembianze di uno spazzino,
puliva le strade divorando i vagabondi fuggiti dalle campagne a causa delle espropriazioni
di terra. La metafora è quanto mai chiara. Fu in questo clima di sopruso e vessazione, di
superstizione e fervente religiosità che il giovane Drake imparò a muoversi nel mondo.
Il destino di Francis non era ormai lontano dal compiersi. Aveva seguito il padre
fuggitivo verso la regione sud-orientale del Kent, lontano dalla violenza delle rivolte
religiose. Come raccontò lo stesso Drake in età adulta, la famiglia trovò riparo sulle
sponde del fiume Medway, il più lungo della regione, non lontano da Londra. La modesta abitazione che ospitò per un periodo la famiglia in fuga fu lo scafo
di una nave da guerra abbandonata. La foce del Medway era il luogo dove Enrico VIII
aveva fatto erigere i cantieri per la costruzione della sua grande flotta da guerra.
Gli scheletri di quei relitti, vestigia di una gloria prematuramente tramontata, fungevano
ora da riparo per vagabondi e marinai oziosi in attesa di un impiego. Malgrado la
crisi economica avesse indebolito il flusso degli scambi tra l’Inghilterra e il continente,
l’estuario del Medway, a pochi chilometri da quello del Tamigi, restava un’affaccendata
zona di traffici e commerci. In quel sottobosco di moli e baracche di legno marcio,
tra il fango delle sponde fluviali si muoveva un’umanità ferita ma palpitante. Erano
principalmente uomini di mare, pescatori, armatori, mercanti, braccianti, predicatori,
soldati senza causa, a cui si erano aggiunte persone scappate dalle varie parti del
regno in cerca di un’opportunità o di una vita più tranquilla. Nel mezzo di questa
società smarrita, Edmund Drake riuscì a rifarsi un’immagine e un ruolo di spicco con
quel che gli riusciva meglio: predicare. Quelle anime impaurite trovarono un nuovo
punto di riferimento nel veemente predicatore anticattolico.
Anche per Francis l’arrivo nel Kent rappresentò un momento di svolta. La vicinanza
del mare, le storie di terre lontane narrate dai marinai nelle notti brumose, ma anche
le possibilità offerte dalle attività commerciali instillarono nel giovane il desiderio
di prendere il largo. Dall’iniziale rifugio nel ventre della nave abbandonata, grazie
alla nuova posizione di Edmund, la famiglia Drake si stabilì nella cittadina portuale
di Chatham, oggi poco più di un sobborgo di Londra. In quegli anni, Francis iniziò
a navigare sulle rotte commerciali tra la Manica, il Mare del Nord e le coste europee.
Il giovane, ormai adolescente, doveva apparire già robusto, la chioma bionda quasi
fulva, lo sguardo fiero nei profondi ma gelidi occhi azzurri. Insieme ai tratti della
maturità, con l’acquisizione dei rudimenti della navigazione cresceva in lui anche
il desiderio di un orizzonte più vasto.
Francis sapeva che alcuni parenti del padre residenti a Plymouth, nella sua regione
d’origine, erano impegnati in commerci lucrativi su scala molto più ampia delle brevi
rotte della Manica. Si trattava nientemeno della famiglia di John Hawkins, il primo
inglese a commerciare schiavi nelle acque dell’Atlantico. Alla soglia dei vent’anni,
Drake decise di raggiungere il cugino per imparare da lui molto più di un mestiere.
Egli voleva conoscere la tecnica della navigazione oceanica. Apprese invece l’arte
della guerra e della pirateria. A Chatham, Francis aveva vissuto nel mondo del piccolo
ma industrioso mercato inglese con la vicina Europa. Plymouth era invece la porta
dell’Inghilterra sul mondo e sui nuovi orizzonti globali, aperti pochi decenni prima
dalle esplorazioni condotte dai portoghesi e dagli spagnoli.
5. Schiavi e galeoni
Nei decenni centrali del Cinquecento la presenza inglese sui mari non era lontanamente
paragonabile a quella dei regni iberici, che nel 1494, nella località spagnola di
Tordesillas, si erano spartiti il mondo in due emisferi di influenza. Alcuni sovrani
avevano ironizzato sul diritto dei re lusitani e castigliani di monopolizzare il nascente
commercio globale, ma la verità era che lotte intestine, guerre di religione, e conflitti
dinastici avevano assorbito tutte le risorse della maggior parte degli Stati europei,
affossandone lo slancio sui mari. L’inizio del lungo regno di Elisabetta Tudor, come
abbiamo visto, aveva riportato la volontà politica necessaria per rilanciare la corsa
inglese agli oceani. Le personalità più intraprendenti del regno non persero tempo
e iniziarono a organizzarsi. Tra questi vi era appunto John Hawkins, alla cui famiglia
apparteneva anche Francis Drake.
John era di dieci anni più vecchio del cugino, il quale, quando entrò al suo servizio,
nei primi anni ’60 del Cinquecento, ne aveva circa venti. Hawkins aveva intuito quale
fosse il commercio più lucroso (e turpe) alla portata degli inglesi: gli schiavi.
I navigatori al servizio della regina Elisabetta non erano ancora pronti per competere
sulle lunghe distanze con i colleghi iberici. Era fuori discussione, in quel momento,
raggiungere le lontane Molucche, nell’Asia sud-orientale, per contendere gli enormi
profitti resi possibili dal commercio delle spezie. La secolare pratica nelle difficili
correnti dei mari nordici, però, aveva reso gli inglesi familiari con la navigazione
atlantica. Un primo tentativo era stato fatto da Enrico VII Tudor, che aveva inviato
alla fine del Quattrocento due spedizioni esplorative verso l’America del Nord, affidate
al veneziano Giovanni Caboto. A questi viaggi seguirono quelli di suo figlio Sebastiano al servizio di Enrico
VIII, ma le guerre europee affossarono ogni velleità di esplorazione oceanica inglese.
John Hawkins seppe quindi cogliere l’occasione. Se non poteva raggiungere l’Oceano
Indiano o il Pacifico, attraversato quarant’anni prima da Ferdinando Magellano, Hawkins
si sarebbe fatto strada nell’Atlantico. Lo scacchiere era già molto affollato, ma
la torta, pensava John, era abbastanza grande perché ne mangiassero tutti. Gli schieramenti
erano così disposti. Quasi tutta la costa africana era monopolio portoghese, come
pure buona parte della costa sudamericana corrispondente all’odierno Brasile. Il resto
dell’America, da nord a sud, apparteneva alla Spagna, che aveva il suo centro di più
antico insediamento negli arcipelaghi del Mar dei Caraibi. Muoversi in questo spazio
gremito non sarebbe stato facile, ma l’esempio era stato dato da un precursore dei
Sea Dogs, John Lok, che nel 1555 aveva portato in Inghilterra il primo gruppo di schiavi dal
Ghana. Lo scopo di Lok era far imparare loro l’inglese per usarli come mediatori al
fine di sviluppare l’ignobile commercio, ma il tentativo restò lettera morta.
Hawkins decise allora di raccoglierne il testimone. Tra il 1562 e il 1563, dopo aver
ottenuto gli investimenti di alcuni ricchi mercanti e armatori londinesi, navigò verso
la Sierra Leone al comando di tre navi con lo scopo di comprare, o catturare, alcuni
nativi da vendere come schiavi in America. Il progetto riuscì, in sfregio a ogni legge
umana e divina. In Africa, Hawkins riuscì a catturare 300 uomini e a venderli con
enorme profitto ad alcuni latifondisti dell’Isola di Hispaniola, oggi divisa tra la
Repubblica Dominicana e Haiti. Tutto ciò, ovviamente, violava il monopolio commerciale
ispanico nei Caraibi, ma il miglior prezzo offerto dal corsaro inglese per la preziosa
merce umana fece cadere ogni scrupolo. Cattolici, protestanti, spagnoli, inglesi,
poco importava; se il denaro non ha odore, tantomeno ha confessione religiosa. John
Hawkins, con questo viaggio, aveva definitivamente aperto il vaso di Pandora. Siamo
alle origini dell’osceno traffico conosciuto come commercio triangolare, che avrebbe
sradicato milioni di uomini dalla propria terra.
Da questo momento, per secoli, folle di innocenti trovarono la morte sulle navi negriere
provenienti dall’Europa e dirette in America. Questi vascelli erano vere macellerie
per esseri umani. La nave negriera si sarebbe evoluta nel corso dei secoli, fino al
Settecento, come strumento di deportazione; fu definita prigione del mare, carcere
galleggiante. Immaginiamo decine, centinaia di persone, nella penombra, uomini, donne,
bambini, stipati, coricati, forzati in scompartimenti troppo bassi per stare in piedi.
Vi era appena lo spazio che un corpo ha in una bara. In questo inferno di legno e
acqua salata, l’odore di escrementi, orina, sangue, vomito si fondeva fino a stordire
le persone. Ad attendere i sopravvissuti (e i loro discendenti), nelle piantagioni delle Americhe,
era un futuro di sopraffazione, umiliazione e deprivazione culturale. È vero che la
tratta degli schiavi era iniziata almeno un secolo prima, a metà del Quattrocento,
quando le navi portoghesi portarono a Lisbona i primi uomini dalla Guinea. Il viaggio
di Hawkins, tuttavia, si sposava simbolicamente con le nuove logiche di un mercato
ormai compiutamente mondiale, aprendo così una nuova era. I moderni imperi globali,
oltreché sul commercio di spezie e pregiate merci orientali, si sarebbero fondati
sulla carne e sul sangue del continente africano.
In Inghilterra, comunque, il viaggio di Hawkins fu considerato un successo. La regina
Elisabetta ne fu tanto entusiasta da voler finanziare una seconda spedizione. Nel
frattempo, Francis Drake era rimasto in patria a curare gli affari del cugino come
agente di commercio. Non gli era ancora concesso di prendere parte a una spedizione,
ma le notizie dei grandi guadagni, i racconti sui selvaggi in agguato nelle foreste,
la sfida lanciata agli arroganti spagnoli accendevano la sua immaginazione, e lo rendevano
impaziente di unirsi al cugino. Il suo momento, però, non era giunto, e la seconda
spedizione di Hawkins partì ancora senza di lui. Era il 1564. Questa volta gli era
stata concessa per espresso volere della sovrana la vecchia nave ammiraglia della
flotta inglese, la Jesus of Lubeck, una grande caracca di 700 tonnellate, acquistata vent’anni prima da Enrico VIII
e riammodernata per l’occasione.
La rotta tenuta da Hawkins fu la stessa del viaggio precedente. Partito da Plymouth,
dopo una sosta in Africa occidentale per fare scorta del penoso carico, si diresse
verso Hispaniola. Al suo arrivo la transazione fu più difficile rispetto al primo
exploit. Questa volta i latifondisti spagnoli erano riluttanti, poiché temevano le
ritorsioni delle autorità coloniali, venute a sapere dell’acquisto di schiavi di due
anni prima. Per obbligarli a comprare, Hawkins dovette minacciarli di bombardare coi
suoi cannoni il piccolo borgo di Rio de la Hacha, dove molti di essi risiedevano.
È possibile, però, che la minaccia fosse in realtà un pretesto per deresponsabilizzare
i compratori di schiavi agli occhi del governo coloniale. Quel che è certo, è che
gli ufficiali locali non erano più disposti a tollerare ingerenze straniere nel dominio
spagnolo sul Nuovo Mondo.
Hawkins tornò a Plymouth verso la fine del 1565, ancora più ricco della prima volta.
La vergognosa fortuna portata in patria riverberava negli occhi del più giovane Drake,
che scalpitava per fare il suo esordio nel profondo blu del vasto oceano. L’occasione
era ormai dietro l’angolo. Le ripercussioni diplomatiche con la Spagna a seguito del
contrabbando di schiavi a Hispaniola, infatti, suggerivano prudenza: John Hawkins
non sarebbe ripartito subito per un terzo viaggio. Gli enormi profitti garantiti da
quelle spedizioni, tuttavia, rendevano imperativo continuare il commercio. Questa
volta, quindi, al comando di tre navi sarebbero partiti John Lovell, un capitano al
servizio di Hawkins, e finalmente anche Francis Drake.
La partenza fu fissata per il freddo mattino del 6 novembre 1566. Questo viaggio portò
Drake più lontano da casa di quanto fosse mai stato. Nel corso dei mesi successivi
avrebbe imparato la durezza della navigazione oceanica, il furore della guerra, ma
anche l’avidità predatoria per le ricchezze americane. Il suo battesimo del fuoco
arrivò non molto dopo la partenza. L’occasione si presentò davanti alle coste dell’arcipelago
di Capo Verde, antica colonia portoghese. Con un atto di deliberata pirateria, Lovell
e Drake attaccarono alcune navi cariche di schiavi dirette a Lisbona. Lo scontro fu
brutale, ma breve. In un inferno di schegge impazzite, le caracche inglesi colsero
di sorpresa le navi lusitane, impedendo loro di difendersi. Questa manovra, per la
sua ferocia, sarebbe rimasta impressa nella mente di Drake; l’avrebbe usata ancora
in futuro. Spesso. Quest’attacco, in barba al diritto e alla diplomazia, presentava
due decisivi vantaggi. Da un lato tagliava i tempi di viaggio, eliminando il bisogno
di fermarsi a mercanteggiare con intermediari locali sulle coste africane. Dall’altro,
spingeva ancora più in là lo scontro con le potenze cattoliche, affermando una volta
per tutte che un nuovo, aggressivo giocatore reclamava il suo posto sulla scacchiera
del mondo.
Drake e Lovell giunsero qualche settimana dopo nel Mar dei Caraibi. Fecero sosta prima
nel porto di Borburata, nell’odierno Venezuela, e successivamente a Rio de la Hacha,
a Hispaniola. Gli affari, a ogni modo, non furono fruttuosi come i due si aspettavano.
Le trattative andarono per le lunghe e alla fine dovettero abbandonare gli schiavi
più cagionevoli di salute prima di ripartire. Era chiaro che i coloni spagnoli avevano
sempre più remore a contrabbandare con gli inglesi. La morsa del controllo coloniale
si stava stringendo, e il business della tratta umana rischiava di non essere più
lucrativo come lo era stato fin lì. Per Francis Drake era sempre più chiaro che la
soluzione al problema sarebbe giunta solo con l’uso delle armi. Il momento, però,
arrivò molto prima di quanto immaginasse.
6. La disfatta di San Juan de Ulúa e la beffa di Nombre de Dios
Nel 1567, al suo ritorno a Plymouth, Francis trovò il cugino indaffarato a preparare
un nuovo viaggio. Drake capì che questa era l’occasione che aspettava; stavolta i
due uomini sarebbero partiti insieme. La flotta riunita da Hawkins contava questa
volta sei navi. Al comando vi era ancora l’anziana Jesus of Lubeck, possente ma di difficile manovra con le sue 700 tonnellate. La vecchia nave, malgrado
il suo passato glorioso, era lenta e fragile dopo trent’anni di onorato servizio,
ma non si poteva rifiutare il vascello offerto dalla regina. La seconda nave, chiamata
Minion, di 350 tonnellate, era più adatta alla guerra di corsa. La squadra era completata
dalla William and John, dalla Swallow, dalla Judith, e dalla Angel, tutte intorno alle 50 tonnellate.
La piccola flotta prese il largo da Plymouth il 2 ottobre 1567. Nonostante la fragilità
della Jesus of Lubeck e le ridotte dimensioni di quattro delle sei navi, la squadra riunita da Hawkins
doveva incutere un certo timore se avvistata in alto mare. Per governare i vascelli
erano stati arruolati 408 uomini, e non si era lesinato sugli armamenti. Hawkins sapeva
che se avesse incontrato navi spagnole avrebbe dovuto rispondere al fuoco; sapeva
di essere il principale ricercato dell’Atlantico. Per tutto l’anno precedente alla
partenza, infatti, l’ambasciatore di Madrid a Londra insistette con la regina Elisabetta
chiedendo di impedire la partenza del corsaro. Spagna e Inghilterra non erano formalmente
in guerra, ma per mesi la tensione intorno a Hawkins fu palpabile. Filippo II non
avrebbe più accettato ingerenze nel suo monopolio commerciale con le Americhe. A Drake,
Hawkins diede il comando della piccola ma agile Judith, e nelle settimane successive Francis non lo avrebbe deluso.
Il viaggio iniziò sotto macabri auspici. Il giorno prima, a Roma, erano stati decapitati
e bruciati al rogo l’umanista Pietro Carnesecchi e il francescano Giulio Maresio.
Questi campioni della libertà religiosa avevano aderito alle dottrine protestanti,
cadendo così nelle inesauste fauci dell’Inquisizione romana. Hawkins e Drake non potevano
sapere di queste esecuzioni, ma in quel mondo di lutti inferti in nome di Dio, essi
sapevano che la loro guerra non era solo per il commercio o per la politica, ma per
la verità. Appena usciti dal porto di Plymouth, nella rada antistante, avvistarono
in lontananza sette navi da guerra spagnole venute a dar loro un tacito ma inequivocabile
monito. Gli inglesi dovettero caricare i cannoni prima che i vascelli spagnoli sparissero
all’orizzonte. Da entrambe le parti si esibivano i muscoli, in un’ormai aperta strategia
di deterrenza.
Come se ciò non bastasse, lungo la rotta per l’Africa una tempesta obbligò le navi
di Hawkins a trovare riparo a Tenerife, nelle Canarie. Il governatore dell’isola scrisse
allora a Madrid informando che senza dubbio quei pirati eretici sarebbero tornati
in America. Dopo la sosta forzata ripresero il loro corso verso l’Africa occidentale.
Lo scopo era sempre lo stesso, prendere uomini da vendere ai latifondisti spagnoli.
Quando furono in vista delle coste africane trovarono una nave portoghese che aveva
appena catturato un vascello francese, anch’esso in cerca di schiavi e fortuna. Hawkins
e Drake non persero l’occasione. Memori della tattica messa in atto da Lovell qualche
tempo prima, invece di scendere a terra a mercanteggiare preferirono assalire i due
bastimenti, sequestrando navi, equipaggi e carico. Guadagnarono così 450 schiavi in
un sol colpo. Tuttavia, Hawkins, non ancora sazio di preda, voleva dare ulteriore
prova della sua forza di fuoco. Decise allora di bombardare un villaggio vicino alla
foce del fiume Tagarim, nell’attuale Liberia. Tra i miseri resti delle capanne bruciate, i sopravvissuti,
disorientati, feriti, urlanti di dolore, scapparono verso la spiaggia. In quel modo
gli inglesi si assicurarono altre 250 persone da traghettare nell’inferno delle piantagioni
americane.
La maggior parte dei deportati sopravvisse al viaggio di otto settimane nell’oceano.
Il 12 agosto 1568, Drake e Hawkins oltrepassarono lo stretto che divide Cuba dalla
Florida. Quel mattino, come ogni giorno, gli equipaggi si riunirono per le orazioni
religiose: i salmi, il Credo recitato in inglese, e una predica per l’equipaggio.
Probabilmente sulla Judith era Drake stesso a tenere il sermone, memore delle concitate e ferventi orazioni
del padre. Quel giorno, tuttavia, non vi fu molto tempo per rincuorare o ammonire
gli animi dei marinai. Un’altra tempesta, dopo quella di Tenerife, stava sorgendo
alle loro spalle; si trattava probabilmente di un uragano, come spesso accade in quell’area
in tarda estate. Furono otto giorni terribili; le navi vennero trascinate a ovest
della Florida dalla forza dei venti e delle correnti. La William and John venne inghiottita dalle acque e nessuno la rivide mai più, mentre la grande Jesus of Lubeck iniziò a imbarcare quantità d’acqua inquietanti. Drake cercò senza successo di trovare
un riparo sicuro mentre i vascelli erano spinti inesorabilmente verso sud-ovest, dritti
tra le braccia del nemico.
La maggior parte degli uomini sopravvisse, miracolosamente. Non sapremo mai se ai
loro occhi l’uragano apparve come una punizione divina o se il fatto di sopravvivere
fosse accolto come segno del favore di Dio. Una nave spagnola di passaggio li informò
che l’unico porto raggiungibile si trovava a San Juan de Ulúa, a 15 miglia da Veracruz
e a 200 miglia da Città del Messico. Hawkins e Drake sapevano che in quelle condizioni
non sarebbero andati lontano. San Juan era uno dei più importanti porti messicani
nei Caraibi; cercarvi riparo avrebbe significato concedersi alla totale mercé del
nemico. Tuttavia le navi erano in condizioni disperate; la Jesus stava lentamente affondando, le scorte di cibo e di acqua stavano finendo. La posta
in gioco non era solo il mancato guadagno, ma la vita stessa di tutti gli uomini.
Lo sapevano bene. La scelta fu drammatica, e dopo giorni di dolorosa riflessione i
capitani decisero di chiedere aiuto a San Juan, dove giunsero il 16 settembre.
Come abbiamo visto, la diplomazia non era il punto forte di Hawkins e Drake, e la
richiesta di aiuto avvenne in modo del tutto particolare. All’ingresso nel porto,
con azione fulminea, un manipolo di inglesi prese possesso dei cannoni spagnoli sulla
banchina, puntandoli contro la torva fortezza posta su uno scoglio a guardia della
baia. Dopodiché gli inglesi inviarono al governatore una lettera assicurando di essere
venuti in pace, e pronti a pagare per l’assistenza e i rifornimenti. Il blitz avrebbe
anche potuto avere successo, ma con grande sorpresa degli inglesi il giorno dopo spuntò
alle loro spalle un’imponente flotta spagnola di tredici navi. Si trattava del nuovo
viceré del Messico, Don Martín Enríquez, fresco di nomina in arrivo da Siviglia. La
situazione era in stallo. Con i cannoni sequestrati, Drake e Hawkins avrebbero potuto
impedire agli spagnoli di entrare nel loro stesso porto, ma così facendo rischiavano
di essere annientati alle spalle dalle superiori forze di cui disponeva il nemico.
In altre parole, da qualsiasi parte si girassero, avrebbero avuto la schiena scoperta.
La tensione era al massimo, ma dopo tre giorni di negoziati trovarono un accordo.
Le navi ispaniche sarebbero potute entrare nel porto, e gli inglesi avrebbero potuto
fare le dovute riparazioni, ripartendo senza subire molestie. Don Enríquez, però,
aveva ordito un tranello. Per il viceré le trattative erano state solo un pretesto.
Egli non aveva alcuna intenzione di trattare con quegli eretici senza Dio, e nel frattempo
aveva mandato dispacci a Veracruz per far accorrere soldati. La mattina del 23 settembre
...