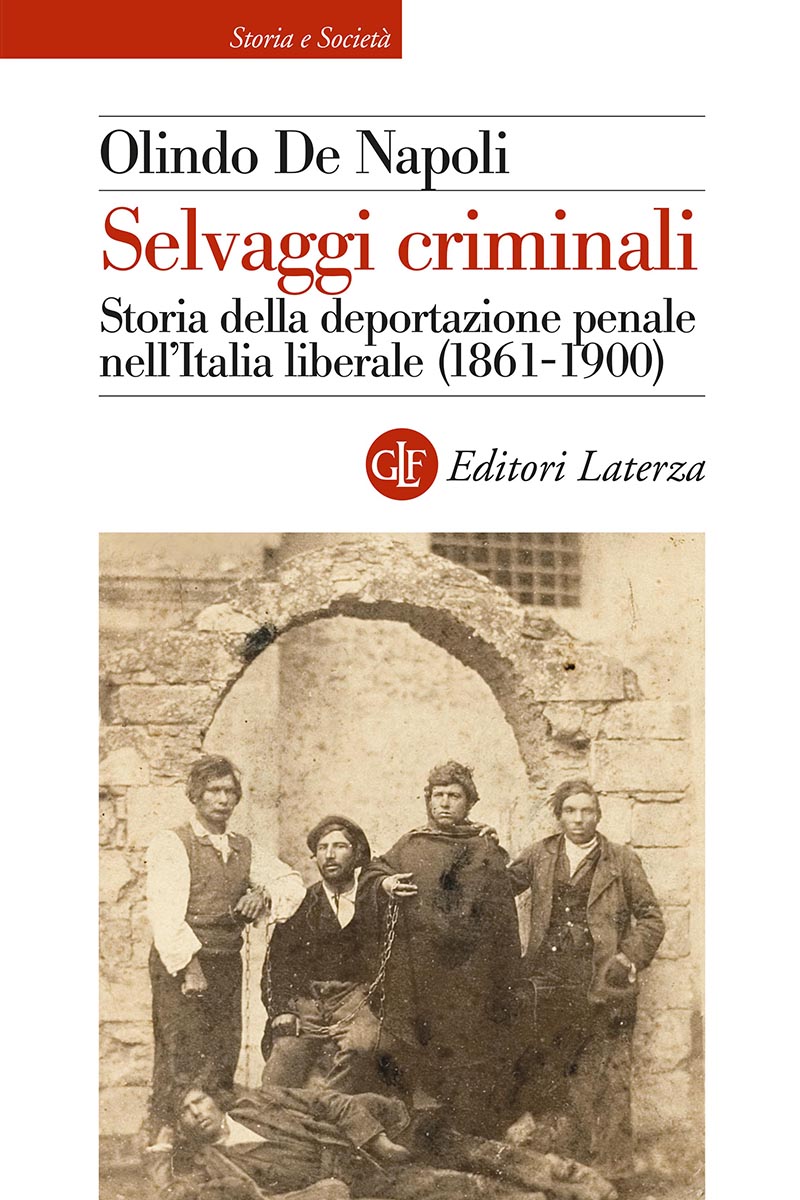1. La deportazione possibile alla «nascita del carcere»
Questo libro ricostruisce la storia della deportazione penale nell’Italia dell’Ottocento,
prendendo in considerazione dibattiti non solo giuridici, progetti, esplorazioni,
iniziative politiche e, infine, il caso dei 196 trasportati ad Assab nel 1898-1899,
che rimase l’unico caso dell’età liberale. Esso si basa sulla convinzione che, per permettere una comprensione profonda del
tema, sia indispensabile integrare la storia della cultura giuridica con una prospettiva
più ampia di storia intellettuale e con la storia politica.
Questo studio mostra come la deportazione sia stata a lungo una proposta realmente
in campo, che veniva vista tutt’altro che come un’ipotesi anacronistica o un ferro
vecchio che la modernità penale avrebbe sconfitto. I discorsi che la riguardavano
non solo ispirarono numerose iniziative politiche, che ci riportano agli albori dei
tentativi di espansione coloniale italiana, ma influenzarono anche vasti campi del
sapere nonché il dibattito pubblico italiano dell’Ottocento, finendo per riaffiorare
in modo tutto particolare e con maggiore concretezza nella crisi di fine secolo, all’ombra
sinistra dell’emergenza. Quanto di questi dibattiti e iniziative fu «coloniale» piuttosto
che «penale» è oggetto di discussione di questo libro, che ambisce a decifrare le
intersezioni, i rimandi reciproci e i relativi accrescimenti che si verificarono tra
i due ambiti.
Per vari secoli, milioni di condannati sono stati deportati in località lontane. Per
fermarsi al periodo precedente alla conclusione della Grande guerra, il paese con
il più alto numero di deportati è stata la Russia zarista: tra il 1590 e il 1917 furono
deportate per lo più in Siberia – cioè seguendo una rotta continentale – circa 1.900.000 persone, di gran lunga la cifra più elevata (che sarebbe stata
seguita da quella ben maggiore dell’Unione Sovietica). Per gli altri casi, si trattò
soprattutto del trasporto di detenuti oltremare, in isole lontane dalla madrepatria,
da parte di imperi coloniali. Le rotte erano dunque intra-imperiali: seguivano le
traiettorie oceaniche degli imperi, non solo nella direzione che va dalla metropoli
alla colonia, ma anche da una colonia a un’altra. Molti dei grandi imperi d’oltremare
praticavano la deportazione penale: quelli iberici, quello britannico e quello francese
in modo particolare. L’impero britannico tra il 1618 e la fine del secondo conflitto
mondiale arrivò a deportare 376.000 persone, e quello francese in un periodo simile
(1541-1953) circa 100.000.
Quando l’Italia si unificò, la Francia aveva da poco intensificato la sua politica
di deportazione coloniale. Napoleone III aveva fondato nel 1852 la colonia penale
dell’Isola del Diavolo alla Caienna, nella colonia della Guyana, sia per espandere
l’impero che per contribuire all’arricchimento della metropoli. La colonia penale
alla Caienna, famigerata anche per essere usata come esilio di prigionieri politici,
ebbe un esito disastroso, con migliaia di morti tra i condannati, tanto che a partire
dal 1864 il flusso dei deportati si diresse verso un’altra colonia, la Nuova Caledonia. La Gran Bretagna, invece, a partire dagli anni Cinquanta, andava diminuendo il flusso
dei detenuti verso l’Australia, anche a causa delle forti proteste provenienti dallo
stesso mondo coloniale, fino alla totale abolizione della transportation nel 1867.
Soprattutto negli anni Settanta, i protagonisti del dibattito italiano sulla deportazione
penale guardarono proprio a questi due esempi, valutandoli di volta in volta come
casi virtuosi oppure fallimentari. Lo stesso partito favorevole alla deportazione
era diviso al proprio interno sul modello da seguire tra coloro che, come l’esploratore
Cerruti, ammiravano la deportazione australiana e coloro che, come il giudice de Foresta,
indicavano piuttosto l’esempio francese. Gli Stati preunitari, invece, fornivano esempi
poco spendibili ai patrioti divenuti élite politica del Regno d’Italia. Il goffo tentativo
borbonico del 1859 di deportare all’esilio negli Stati Uniti alcuni detenuti politici
– tra cui Pica, Poerio e Spaventa – era finito malamente, con il dirottamento della
nave in Irlanda dove i deportati erano stati accolti come eroi dai gruppi italofili.
Perciò, per alcuni versi, la deportazione era associabile alla repressione dei dissidenti
politici e al «borbonismo» penale.
Eppure, nell’Italia liberale il discorso sulla deportazione mostrò una notevole forza:
questa non solo rispondeva allo scopo di allontanare criminali, ma anche e soprattutto
permetteva lo sfruttamento di lavoro coatto e il rafforzamento demografico in zone
liminari o di frontiera. I condannati erano stati utilizzati in vario modo dagli imperi
e dagli Stati nazionali in espansione: la loro mobilità era fondamentale per ottenere
e progettare colonie, gestire zone di frontiera, spianare la strada all’immigrazione
libera, estrarre lavoro coatto. Quest’ultimo, del resto, era un tratto tipico delle società coloniali ottocentesche. Tanto che si è affermato che sarebbe difficile configurare nella prima età moderna
un colonialismo di popolamento senza il sistema della transportation e del lavoro coatto che ad essa si associava.
Sebbene all’alba dell’Unità italiana la deportazione penale fosse dunque praticata
ampiamente in vari imperi, le nuove tendenze penalistiche potevano in parte indurre
a porne in dubbio l’utilità, come nel caso di Jeremy Bentham. Dalla fine del Settecento, i riformatori di alcuni paesi avevano immaginato una
riforma complessiva della penalità con l’intento di punire in maniera più umana, ma
anche più efficace, all’insegna della centralità del sistema-carcere. Negli Stati preunitari la discussione sulla riforma della pena era connessa a un
movimento europeo che ebbe la sua massima intensità tra il 1835 e il 1845, e che affondava
le radici nella cultura illuministica del tardo Settecento.
Nel neonato Regno d’Italia la questione della pena era particolarmente urgente, per
motivazioni sia umanitarie che politiche. Dal primo punto di vista, già negli anni
Sessanta si rese evidente la questione delle pessime condizioni di vita dei condannati,
che ammontavano alla fine del decennio a circa 60.000 persone su una popolazione totale residente di meno di 28 milioni. Quello che probabilmente
fu il miglior riformista del suo tempo, il deputato Federico Bellazzi, denunciò l’abbandono
e l’arretratezza del sistema penitenziario italiano. Nei bagni penali, dove i condannati
lavoravano forzatamente sotto l’amministrazione della Marina, le condizioni di vita
erano durissime, con umiliazioni e frequenti evasioni, e il lavoro non era retribuito. L’influente penalista Luigi Lucchini all’inizio degli anni Ottanta ne avrebbe parlato
come di «bolgie di inferno». Più tardi, le statistiche del crimine violento avrebbero mostrato che l’Italia era
nelle peggiori posizioni in Europa, cosa che gli intellettuali collegavano all’arretratezza
e alla mancata civilizzazione di larga parte del paese.
Dal punto di vista politico, poi, questo disastro aveva delle gravi conseguenze. La
situazione dell’esecuzione penale era in stridente contrasto con la pretesa modernità
dei codici ottocenteschi, una contraddizione che rappresentava un problema cruciale agli occhi di politici
e giuristi dell’Italia unita. Essa prestava il fianco a una critica assai tagliente
allo stesso processo di unificazione. Infatti, la cultura risorgimentale aveva fatto
leva sulla denuncia delle orribili carceri borboniche e austriache, associando la
disumanità di tali sistemi punitivi al carattere anacronistico delle due monarchie. Ovviamente, pesava la fede nell’incivilimento, tipica del pensiero risorgimentale. Per il bavarese Karl Joseph Anton Mittermaier, molto ascoltato in Italia, l’incivilimento
imponeva «un nuovo senso della pena detentiva», nella direzione del tramonto del «principio
di intimidazione» in nome dell’emenda. In poche parole, il movimento nazionale italiano aveva forgiato un elemento considerevole
della sua identità proprio a partire dal tema della penalità, ma nell’Italia unita
le condizioni dell’esecuzione penale non erano migliori che nel regno borbonico o
in Austria. Come disse Pasquale Stanislao Mancini di fronte alla guerra al brigantaggio,
l’Italia sembrava voler usare mezzi repressivi che non erano che «un’apologia retrospettiva
del Governo borbonico». Le condizioni di «prigioni e prigionieri nel Regno d’Italia», per riprendere l’espressione
di Bellazzi, non potevano che diventare una questione nazionale.
C’era poi un terzo aspetto, di tipo morale. Al di là, infatti, della concreta utilità
della deportazione per lo Stato unitario, per alcuni l’argomento era un’occasione
per lanciare una polemica sui caratteri e i vizi degli italiani: una misura energica
come la deportazione ne avrebbe innalzato il livello morale. Il discorso sulla deportazione
era dunque parte di una cultura nazionalista che era imperialista e positivista assieme,
e proponeva una sorta di ortopedia sociale, che d’altronde non riguardava solo i criminali e la popolazione carceraria. Leone
Carpi indicava come modelli di un’Italia più ardimentosa proprio quegli uomini intrepidi,
liberi da eccessive ritrosie teoriche, che avevano lavorato a progetti di colonizzazione
penitenziaria.
Negli anni Sessanta non era affatto chiaro quale direzione avrebbe preso lo Stato
unitario sul tema della penalità. C’era l’esempio della Toscana dei Lorena, che aveva
da fine Settecento abolito la pena di morte e aveva sperimentato un attivo riformismo
in materia. L’opinione intellettuale favorevole all’abolizione della pena di morte
era in crescita, in particolare tra i professori di diritto penale. Eppure, a parte la crescente sensibilità contraria alla pena capitale, il resto
delle questioni non sembrava prendere una direzione univoca e la deportazione poteva essere ben considerata come un’alternativa plausibile.
Le pene erano tutte connesse l’una all’altra nel momento in cui si doveva discutere
del sistema penale in generale. Così, la stessa proposta di abolire l’estremo supplizio
poteva accrescere il sostegno a un istituto come la deportazione, altrettanto efficace
dal punto di vista dell’espulsione dei soggetti più pericolosi dal corpo sociale ma
aperto alla possibilità dell’emenda e meno efferato, da porre al vertice della scala
penale in sua vece. D’altro canto, anche la polemica sulle pessime condizioni degli
istituti di pena poteva produrre argomenti a favore della deportazione, che prometteva
di liberare l’Italia dai soggetti più pericolosi. Si trattava di un’alternativa percorribile?
Molti intellettuali e politici ritennero che lo fosse.
I trent’anni che vanno dall’Unità al codice Zanardelli furono segnati dal problema
dell’unificazione penale: le leggi dei vari Stati preunitari in materia penale erano
diverse e bisognava trovare una quadra che non fosse un semplice compromesso, ma il
frutto della formazione di una nuova coscienza giuridica nazionale. Che ci fosse bisogno
di una transizione verso un nuovo modello era chiaro a tutti; eppure, verso quale
direzione si stava andando? L’immagine, proposta per primi da Foucault e Rothman,
di una marcia inesorabile verso un sistema carcero-centrico, in quanto collegato al
capitalismo emergente e agli interessi della classe borghese, oltre a non rispecchiare i percorsi diversificati dei vari paesi (e delle colonie),
è incapace di leggere la presenza, accanto ai nuovi penitenziari, di altri tipi di
pena che continuarono ad esistere nell’età contemporanea, e non corrisponde a quanto
emerge dagli archivi sulle pratiche penitenziarie. Una serie di studi recenti ha enfatizzato con ragione «la persistenza di forme di
internamento non strettamente riconducibili alla ‘moderna’ carcerazione penale». Come ha notato John Braithwaite, la visione secondo cui c’è stato un passaggio dalla
punizione dei corpi alla «punizione delle anime» con il cosiddetto «avvento del carcere»
è uno schema incapace di spiegare la persistenza di modi alternativi di punire come
la colonia penale. Tra Otto e Novecento la deportazione era tutt’altro che inattuale: l’utilizzo dei
condannati e le colonie penali creavano nuove gerarchie, permettevano di incorporare
territori negli imperi e sviluppavano nuove connessioni tra metropoli e colonie.
La deportazione continuò dunque ad essere praticata a lungo da vari Stati europei,
ben oltre la metà dell’Ottocento. In Italia vi fu sul tema un dibattito vivace e la
stampa produsse un vero «modello panacea», secondo il quale l’istituzione della deportazione
avrebbe risolto molti mali della nazione, quali il problema penitenziario, l’emergenza
della criminalità, i crescenti costi dell’esecuzione penale; e avrebbe dato risposta
a necessità fondamentali, come l’espansione coloniale e il superamento del deficit
nei commerci internazionali. L’idea di una marcia inesorabile verso il penitenziario
modellato sul panopticon benthamiano, se calata nel contesto dei tentativi di riforma
all’alba dello Stato unitario italiano, non restituisce le reali possibilità in campo
né il punto di vista degli attori storici coinvolti. Fu un processo più aperto di
quanto non sia stato teorizzato, e l’idea di mantenere una pluralità di pene diverse
era sul tavolo, come si legge nei documenti della Commissione governativa per la riforma
penitenziaria del 1865 che si chiedeva se adottare un sistema basato su una pena unica
oppure dovessero «esservi più sistemi e più nomi, e quindi più specie di pene».
A partire dagli anni Sessanta e per molto tempo, la deportazione fu vissuta come un’alternativa
realmente percorribile, e l’argomentazione che l’Italia non possedeva colonie dove
inviare i detenuti, utilizzata durante la discussione parlamentare sulla repressione
del brigantaggio, non fermò i sostenitori della colonia penale e non deve essere sopravvalutata
in sede di giudizio storico. In primo luogo, il passato recente forniva esempi di
deportazione tramite accordi internazionali, e dunque senza possedere colonie. La
convenzione stipulata l’11 dicembre 1819 fra il Regno di Napoli e il Regno unito del
Brasile, del Portogallo e di Algarve aveva reso possibile, nel 1820, il trasferimento
in Portogallo di circa 300 detenuti, la maggior parte dei quali raggiunse il Brasile.
In tempi più recenti, erano stati esperiti altri tentativi presso il governo del Cile
(nel 1851), mentre il 9 ottobre 1856 era stata firmata una convenzione con la Repubblica
Argentina per l’invio di 6000 detenuti politici. In secondo luogo, bisogna considerare che in quegli anni si ridefiniva il quadro
territoriale nazionale, e la possibilità di nuove acquisizioni perfino in luoghi remoti
era vissuta come realistica da una schiera di uomini d’azione tra cui spiccano reduci
dell’epopea garibaldina come Nino Bixio.
L’ipotesi della deportazione, e quindi di colonie penali d’oltremare in cui si potesse
sfruttare il lavoro coatto, era del resto plausibile anche perché, al contrario di
quanto asseriva Marx, l’economia liberale ottocentesca prevedeva ancora forme di coercizione
normativa del lavoro. Tuttavia, a parere di chi scrive, il tema generale non è tanto o non solo la persistenza
delle forme giuridiche dell’antico regime, quanto il fatto che esse potessero essere reinterpretate e rifunzionalizzate in
chiave moderna. La deportazione coloniale nel dibattito ottocentesco doveva essere
in linea con le nuove teorie della pena: possibilità dell’emenda, efficacia, difesa
sociale, segregazione cellulare, controllo dell’organizzazione sociale, necessità
di favorire il lavoro in funzione riabilitativa, diminuzione della recidiva, individualizzazione
della pena secondo categorizzazioni scientifiche dei criminali. La deportazione, lungi
dall’essere percepita come un residuo dell’antico regime, un rottame di cui liberarsi
speditamente in nome della modernità, fu al contrario intesa da molti come una proposta
non solo valida, ma anche moderna. Se da una parte la scienza penalistica non poteva
assecondare di condizionare la pena ad esigenze ad essa esterne come l’espansione
coloniale, dall’altra l’idea di colonie penali transoceaniche poteva apparire in linea
col postulato moderno di una pena efficace e morale. Anche il diffuso favore all’interno
della Scuola positiva – l’approccio positivistico applicato alla criminologia era
quanto di più moderno – mostra come la deportazione non fosse affatto concepita come
un residuo premoderno.
2. La pena: un problema non solo penalistico
Del resto, il problema delle pene non può essere compreso all’interno di un dibattito
solo penalistico e questo per due motivi. Anzitutto, c’è l’intreccio con il discorso
antropologico: il dibattito politico dei primissimi anni dopo l’Unità, segnati dall’emergenza
del grande brigantaggio, era intriso di considerazioni antropologiche per le quali
la deportazione sembrava la pena più appropriata per gli speciali caratteri morali
delle popolazioni meridionali, per quei briganti così attaccati alla loro terra e
al loro cielo da non sentire la minaccia della pena capitale come deterrente.
Si attinse a una tradizione che aveva presentato il Mezzogiorno come un mondo esotico
e antropologicamente diverso. Gli anni del dibattito sulle leggi per reprimere il brigantaggio furono un momento
importante, in quanto si immaginò una pena speciale in relazione non al reato che
si doveva sanzionare, bensì ai caratteri antropologici del reo. I politici che costruirono
un discorso del genere non si avvidero della portata notevole dal punto di vista della
teoria giuridica. Quei discorsi ispirati all’emergenza, sebbene immaturi dal punto
di vista teorico, per certi versi anticipavano l’impostazione che sarà della Scuola
positiva di diritto penale nel suo spostare l’analisi dal reato al reo proponendo
di individualizzare la pena in base alle caratteristiche del criminale.
In secondo luogo, c’è il discorso coloniale: nei primi dibattiti sulla deportazione
entrarono pesantemente quei pensatori, per lo più non giuristi, che avevano in mente
una politica coloniale per la grandezza della nazione più che gli aspetti tecnici
del problema penitenziario.
Superato il periodo dell’emergenza e della legislazione speciale, il governo Menabrea,
alla fine degli anni Sessanta, fu protagonista di varie iniziative per dare avvio
all’espansione coloniale, molte delle quali prevedevano la cosiddetta colonizzazione
penitenziaria. Fu un periodo di intenso attivismo e di un certo livello di imprecisione.
Nella penisola andavano nascendo i primi circoli intellettuali pro-coloniali, per
i quali le colonie erano una questione non solo di grandezza nazionale, ma di concrete
possibilità di modernizzazione sociale ed economica. Diplomatici energici, navigatori
e uomini alla scrivania dei ministeri si dedicarono con insistenza a proporre soluzioni.
Il discorso sulla deportazione era, dunque, anche il discorso sulla «colonizzazione
penitenziaria», cioè un discorso colonialista. Secondo i politici, unanimi su questo
punto, la colonia penitenziaria era da fondarsi «al di là dei mari», cioè in un luogo,
meglio se un’isola, molto lontano dalla madrepatria e le ipotesi che furono fatte
includevano la costa atlantica del Marocco, isole del Sud-Est del Pacifico, dell’Indiano
o postazioni dell’Africa subsahariana, fino alla da poco indipendente Argentina. La
mappa di tutti i luoghi su cui esistette un qualche progetto di fondare una colonia
penale italiana mostra un’ampiezza di mire impressionante, o – se si vuole – un impressionante
velleitarismo (fig. 1). Mostra altresì una notevole concentrazione delle iniziative
su due quadranti: quello asiatico, compreso tra il Mar delle Andamane e la Melanesia,
nell’ottica di costruire basi per il commercio con la Cina; e quello africano, della
zona compresa tra la costa occidentale del Mar Rosso e l’altipiano etiopico, conseguenza
in buona parte delle prospettive aperte dal canale di Suez.
Fig. 1. Progetti di deportazione coloniale concepiti in Italia tra il 1861 e il 1900,
con indicazione dell’autore, del luogo e dell’anno o periodo in cui furono prodotti.
La lontananza estrema era apparentemente un modo di garantire che i criminali non
potessero «evadere» e rientrare nel territorio italiano, vanificando così il tentativo
di erodere le reti criminali. In realtà, si trattava di molto più di questo. Secondo
la vasta letteratura, giuridica e non, il concetto di deportazione implicava che la
colonia penale fosse installata in un territorio selvaggio, in un’isola disabitata
oppure abitata da popolazioni non civilizzate. I territori abitati da genti incivili,
appartenenti a un altro tempo storico o addirittura extrastoriche, avrebbero costituito, per motivi diversi a seconda degli autori, l’ambiente ideale
ad accogliere i soggetti criminali. Si è sostenuto che la colonia rappresentava uno
«spazio anacronistico»: la sua lontananza spaziale corrispondeva a una lontananza
temporale. Come osservò l’amministratore coloniale H.S. Maine, per lo scarto cronologico esistente
tra metropoli e colonia l’amministratore coloniale doveva possedere un orologio sincronizzato
su due longitudini assieme. Ora il punto è questo: tutti gli scritti che insistevano sul deportare in un’isola
«al di là dei mari», tutta questa abbondante letteratura che asseriva che non c’è
vera deportazione per i briganti e i delinquenti se non in luoghi spazialmente molto
distanti, non intendevano forse indicare luoghi posti anche ad una distanza temporale enorme, proprio come le colonie? Il cosiddetto spatial turn storiografico ha riflettuto sul fatto che il linguaggio di solito ricorre a «metafore
spaziali per rappresentare il tempo».
L’Italia aveva chiare ambizioni territoriali da potenza di medio cabotaggio e, agli
occhi di chi promuoveva quei primi tentativi, la colonizzazione penitenziaria era
un modo per avviarsi all’espansione coloniale e dei commerci. L’ambiguità di una serie
di iniziative prese tra ufficialità e segretezza per timore diplomatico verso l’amica
storica, quella Gran Bretagna che era stata italofila durante il Risorgimento e che
aveva per prima riconosciuto lo Stato italiano, e l’accortezza politica degli anni Settanta ne decretarono il fallimento, ma l’idea
di un’espansione coloniale ottenuta attraverso la deportazione continuò ad attrarre
consensi. La caldeggiavano, in particolare, gli studiosi e attivisti impegnati sul
tema dell’emigrazione italiana, unendo i due temi all’insegna dell’ideologia del colonialismo
demografico. Tutto un côté di scrittori di vario tipo e di vario orientamento, raramente di giuristi, vide nella
deportazione lo strumento con il quale l’Italia avrebbe avviato l’espansione coloniale:
le colonie penali avrebbero fatto da apripista a colonie libere, dove gli emigrati
italiani avrebbero vissuto sotto le leggi italiane e liberi dallo sfruttamento a cui
andavano incontro altrove. Fu un filone destinato alla sconfitta: il colonialismo
italiano nacque e si strutturò su altre basi, in particolare sul discorso della missione
civilizzatrice, senza colonizzazione penitenziaria, e la storia vuole che ciò avvenisse
per iniziativa di Mancini, ministro degli Esteri negli anni Ottanta, cioè del principale
giurista nemico della deportazione. Eppure, una volta fondata la prima colonia italiana,
l’istanza a favore dell’istituzione di una colonia penale nel Corno d’Africa riemerse,
a volte in maniera episodica, negli anni Ottanta e nell’età crispina, anche perché,
secondo alcuni, essa sarebbe stata l’occasione di dare un senso alla colonia primigenia,
che un senso non sembrava avere.
Per tornare al versante penalistico, nell’Ottocento molti si concentrarono sul tema
del lavoro come strumento di riabilitazione, fino a porlo a fondamento della pena, cosa che poteva andare nella direzione di rafforzare, piuttosto che depotenziare,
la strategia della deportazione, la cui narrazione prevedeva che intere masse di condannati
potessero emanciparsi dal crimine attraverso il lavoro in terre selvagge. Soprattutto,
la deportazione era una pena che, più ancora che l’emenda del reo, avrebbe prodotto
un cambiamento radicale dell’individuo, una vera rigenerazione, cioè la nascita di una vita nuova forgiata dal lavoro all’aperto, dall’esperienza
dell’appropriazione e dall’incivilimento. Non si trattava affatto della stessa cosa,
almeno dal punto di vista della tradizione liberale. Beaumont e Tocqueville, inviati
a studiare il sistema penitenziario americano dall’ispettore delle carceri francesi
Charles Lucas, avevano criticato aspramente l’ambizione del sistema penale a una riforma
radicale dell’individuo, che non poteva essere che «un prodotto accidentale del sistema
penitenziario», giacché la società poteva al massimo pretendere che il reo divenisse
un soggetto «più obbediente alle leggi». Nella stessa direzione, per Francesco Carrara la ratio della pena era il ristabilimento dell’ordine esterno turbato dal delitto e il «preteso
diritto di correggere» si prestava per le «norme di un collegio o di un seminario»,
non per quelle dell’autorità; un concetto ribadito più tardi da Pietro Nocito. L’idea della rigenerazione va invece nella direzione di uno Stato che crede di dover
portare, attraverso un certo tipo di programmazione dell’organizzazione sociale della
colonia penale, a una riforma radicale, quasi a una riprogrammazione dell’individuo.
Persino il capo dei positivisti, Enrico Ferri, in un dibattito parlamentare ma di
carattere fortemente scientifico col suo avversario, Luigi Lucchini, aveva proclamato
la necessità di un sistema fondato sulla pluralità delle pene in modo da trovare per
ciascun reo quella più adatta alla «guarigione» del condannato/malato. Perciò, il discorso sulla deportazione/rigenerazione rappresentò una sfida alla
cultura giuridica liberale.
La discussione sulla deportazione si può comprendere solo se proiettata in un dibattito
sulla pena in una prospettiva transnazionale, visto l’intenso scambio intellettuale
che avveniva a livello almeno europeo, se non atlantico. Magistrati, accademici e
funzionari parteciparono a congressi internazionali, leggevano e traducevano quanto
si scriveva altrove su questi temi. In Italia le osservazioni di Mittermaier, che
con i suoi scritti proiettava la questione italiana in uno scenario più vasto, trovarono
spazio fin dagli anni Sessanta. Di tutto questo dibattito transnazionale sulla pena, però, le prime proposte di
introdurre la deportazione in Italia non tenevano alcun conto, essendo dettate dalla
stretta emergenza del brigantaggio. In quel momento, la discussione fu più politica
che penalistica e si svolse per lo più nel Parlamento e nelle sue commissioni: la
ricezione delle discussioni internazionali sulla deportazione, pur avviata su riviste
come l’Effemeride carceraria, non fu oggetto di riflessione a livello dei decisori. Il contrario di quanto avvenne
negli anni Settanta, quando un tecnico del penitenziario come Martino Beltrani Scalia
scelse di internazionalizzare il dibattito italiano sulla deportazione al fine di
disinnescare la forza propulsiva dei diffusi argomenti a suo sostegno, mostrando come
in Europa quasi nessuno ormai la sostenesse.
La cosiddetta «armata del crimine» era descritta come una setta, una parte distinta
della società, che viveva secondo regole e rituali speciali, che poteva rinsaldare
le classi marginali al mondo della sovversione. Rispetto a questo repertorio, a partire
dagli anni Settanta, la cultura criminologica positivista operò un salto di qualità
con la nascita della categoria dei «criminali nati», la cui natura era incorreggibile
in quanto affetta da atavismo. L’atavismo rappresentava la persistenza dell’elemento
violento del mondo pre-civilizzazione nella società odierna. Per quei positivisti
che promuovevano la deportazione (quasi tutti, con l’eccezione di Lombroso), i selvaggi
criminali italiani sarebbero stati dunque incivili tra altri incivili.
3. Grandi progetti e politica dell’emergenza: il penale eccezionale
A promuovere la deportazione lungo quattro decenni di storia unitaria furono uomini
di avventura e ambasciatori, navigatori e ufficiali, giuristi e giornalisti, romanzieri
e scienziati, utopisti e reazionari: autori eterogenei per formazione e orientamento,
ma accomunati dall’idea che la sua introduzione avrebbe segnato un’era di grandi vantaggi.
Si è detto del tema della rigenerazione del reo. A questo elemento si legava un altro
tema, egualmente potente dal punto di vista immaginativo: quello della rigenerazione nazionale, portata dalla nascita di nuove società di italiani a partire da ex galeotti mandati
a colonizzare terre lontane. Alla rigenerazione dei delinquenti corrispondeva, in sostanza, la rigenerazione
dell’Italia, mutata in una società nazionale e imperiale: la nazione si sarebbe «ri-generata»
nella colonia, dando vita a nuove società d’oltremare sorte dalla sua razza, che si
doveva espandere a danno di altre razze più deboli. I progetti utopici promettevano
molto; ma l’utopia penalistica diventava anche nazionale. «Roma, covo prisco di ladri,
diventò nido di eroi... Siate Roma!» si leggeva al termine del romanzo Lacolonia felice di Carlo Alberto Pisani Dossi. Nella cartina della colonia penale immaginata da Lanzerini
alle Nicobare (sulla scorta del progetto di Caranti) campeggiava, al centro dello
stabilimento, una «piazza della Nazione» con una colonna monumentale in onore di Vittorio
Emanuele II «Padre della Patria» (fig. 2). Si trattava, peraltro, di utopie modernizzate,
che cioè ambivano ad applicare i principi positivistici dell’organizzazione sociale
e non erano affatto in contrasto con le esigenze della difesa sociale, risolvendosi
in un tipo di discorso sincretico che sapeva mischiare rigenerazione e repressione.
Fig. 2. «Piano d’iniziamento della Città di Sambelonga presso il Golfo di Ganges»,
in appendice a A. Lanzerini, Progetto di colonia transoceanica, Ungher, Pisa, 1889.
Il discorso sulla deportazione, insomma, fu anche il riflesso di progettualità grandiose.
Furono idee grandiose non solo nei numeri – nei vari progetti, da Caranti a Scovasso,
si prevedeva di arrivare gradualmente a deportare decine di migliaia di persone, l’intera
popolazione detenuta – ma anche nell’ambizione generale che la deportazione rappresentava,
come occasione di espansione nazionale, di riscatto sociale per intere masse e di
risoluzione della questione della criminalità, che vedeva l’Italia ai primi posti
in Europa per la diffusione del crimine violento. Altri, come i positivisti, più che
utopie penalistiche immaginarono semplicemente progetti avveduti e scientificamente
fondati, vuoi per eliminare dal corpo sociale i criminali incorreggibili, in linea
con la loi des récidivistes approvata in Francia nel 1885, vuoi per dare la possibilità ad autori di reati d’occasione
di ottenere la sospensione condizionale della pena lavorando in colonia. In questi
casi, la deportazione, pur non essendo oggetto di progetti grandiosi, rimaneva comunque
segno di una progettualità pensata, che si voleva fondata su basi scientifiche e si
indirizzava a soggetti ben precisi.
Colpisce allora che, di contro a tutti questi discorsi ambiziosi o tecnicamente elaborati,
l’unico caso di deportazione messo in atto fu realizzato in maniera frettolosa, disorganizzata
e incoerente con qualsivoglia teoria penale. I 196 deportati ad Assab nella crisi
di fine secolo scontarono l’assenza di una qualsivoglia teoria del recupero sociale
come base di quell’organizzazione e finirono per essere trattati semplicemente come
detenuti da punire e contenere. Poiché il codice penale aveva segnato la vittoria
finale dei liberali ostili alla deportazione, tra cui spiccava Giuseppe Zanardelli,
non era possibile applicare la pena della deportazione a nessuno degli autori delle
sommosse del maggio 1898. Come aggirare quest’ostacolo?
L’istituto «italianissimo» del domicilio coatto, strumento amministrativo di repressione
di soggetti ritenuti pericolosi che però avevano già scontato la pena, stava lì, da
tempo al centro di diffuse polemiche, a fornire una possibilità. Lo spostamento di
una sede di domicilio coatto nella colonia Eritrea fu esplorata per primo da Crispi,
che aveva sentito il disperato bisogno di nuove località per incrementare le assegnazioni
a domicilio coatto senza dover liberare nessuno. Nel 1898, Rudinì nel brevissimo volgere
di qualche giorno ne riprese il progetto e decretò di deportare 196 domiciliati coatti
ad Assab, uno dei posti peggiori della colonia Eritrea, vissuto come luogo di punizione
informale per ufficiali coloniali, del quale varie indagini avevano già mostrato l’inadeguatezza
ad ospitare una colonia penale. Lo stesso Sapeto, autore dell’acquisto di Assab alla
fine degli anni Sessanta, aveva sempre negato che la località avesse i requisiti per
fungere da colonia penale. Ma nel 1894 era stato il governatore in persona, Oreste
Baratieri, a indicare Assab alla missione italiana inviata da Crispi, per la sola
ragione che lì vi erano un paio di caserme dismesse. Ora, dopo la repressione dei
moti del maggio 1898, nell’ottica di Rudinì si trattava di fare un esperimento: la
colonia di coatti di Assab avrebbe dato le basi empiriche per far riprendere il favore
per la deportazione, convincere il Parlamento a riformare il codice penale appena
entrato in vigore, e infine passare a una colonizzazione penitenziaria di massa dei
peggiori criminali italiani. Dopo quasi quarant’anni di dibattito, sulla soglia del
XX secolo l’ipotesi della deportazione era ancora viva.
Si trattò di una mossa azzardata, ma ciononostante assecondata dai vertici del Ministero
dell’Interno, persino da quel Beltrani Scalia che aveva combattuto contro la deportazione
negli anni addietro. Per Rudinì, però, l’esperimento andava fatto – era il suo modo
di combattere contro «l’Uragano della rivoluzione» – e le forzature erano necessarie,
come anche le pressioni sul Consiglio di Stato chiamato in causa per sancirne la legalità.
Nella deportazione ad Assab il lavoro – così centrale nella teorica della pena del
codice – e la vita all’aria aperta ebbero un ruolo assai marginale, giacché i deportati
dovevano essere «tenuti chiusi», come insistè Rudinì. I deportati subirono un regime
punitivo terribile che comprendeva, in caso di semplici proteste, torture fisiche
insopportabili, aggravate dalle terribili condizioni climatiche. L’esperimento Assab
fu, insomma, una contraddizione macroscopica rispetto a tutto quanto si era sostenuto
nei decenni precedenti.
Il quadro in cui comprendere tutto ciò è dunque quello dell’eccezione. L’emergenza
politica della crisi di fine secolo giustificava l’eccezionalità dei provvedimenti
di Rudinì. Si è argomentato che, a differenza dei sistemi giuridici di antico regime
in cui l’eccezione era intesa come extraordinarium e ricompresa nella vita del diritto, nel passaggio all’età dei codici e del diritto
legislativo l’eccezione si traduceva direttamente in una sospensione del diritto,
giustificando quindi provvedimenti eccezionali e generando, in questo modo, un doppio
livello di legalità che caratterizzò lo Stato otto-novecentesco. Queste norme eccezionali erano in qualche modo necessarie per il sistema «per evitare
che l’impianto del diritto penale codificato entrasse in frizione con le insuperabili
contraddizioni dell’ordine liberale». Questo fu vero, nella crisi di fine secolo, per quei provvedimenti che sospendevano
l’ordine costituzionale come lo stato d’assedio: si trattava di leggi eccezionali. Il caso dell’esperimento Assab, però, fu diverso, perché non vi fu alcuna nuova
legge motivata dall’eccezione, ma solo dei provvedimenti amministrativi al livello
più basso della fucina normativa, che violavano il sistema legislativo.
Come scrisse il Corriere della Sera, la deportazione ad Assab divenne «una pena che non era scritta nel codice» né in
alcuna altra legge. Si tratta di una suggestione che va seguita: la detenzione prevista per i deportati
ad Assab dava a quell’esperimento di deportazione il carattere di fatto di pena e non più solo come misura di sicurezza quale era il domicilio coatto. Se tale era,
si trattava di una pena che non corrispondeva a un reato, inflitta senza le garanzie
della giurisdizione e senza una previsione legislativa. A ciò si aggiunga che la deportazione
in colonia era una decisione illegale a monte, perché nulla consentiva di espellere
dal territorio dello Stato dei cittadini senza una legge che lo prevedesse esplicitamente,
non essendo la colonia territorio dello Stato.
Si trattava, dunque, di norme di carattere penale che sfuggivano surrettiziamente
al principio di legalità penale. Questo, che era stato recepito dal codice Zanardelli
del 1889, aveva in teoria un valore assoluto, simbolo dell’incivilimento in materia
penale, ma aveva mostrato ben presto tutta la sua fragilità, giacché per politici
e giuristi quel limite invalicabile iniziava ad essere sentito come soffocante. Ad ogni modo, gli atti normativi che portarono alla deportazione di domiciliati
coatti ad Assab tracimarono da qualsiasi discussione sui limiti e le frontiere del
diritto penale e del principio di legalità. È qui possibile parlare di un diritto penale eccezionale in via amministrativa, sul quale la pubblicistica del tempo, pur avvezza alle critiche alle misure preventive,
non produsse un’adeguata riflessione.
I tratti di storia sociale narrati alla fine di questo libro mostrano che almeno una
parte dei deportati (non solo gli anarchici) fosse pienamente consapevole degli aspetti
di illegalità di quella singolare «colonia penale di coatti», proprio a partire dal
loro trasporto in colonia. Non foss’altro che per la loro esperienza, i deportati
capirono che il regime cui erano sottoposti era assolutamente diverso da quello previsto
per i domiciliati coatti, che con molte limitazioni vivevano all’interno di piccoli
comuni liberi di muoversi e cercare lavoro. Alcuni dei deportati venivano dal movimento
anarchico, che aveva costituito una forma di alfabetizzazione politica, ed erano già
familiari alla polemica, condotta da giornali militanti come l’Avanti! e L’Agitazione, contro le misure preventive di sicurezza. Alcuni dei deportati protestarono apertamente
contro la violazione dei loro diritti davanti al direttore dello stabilimento, il
quale, in coerenza con le istruzioni ricevute, reagì con durissime punizioni, perché
quelle proteste erano una minaccia all’ordine della «colonia penale». Nella premessa
al libretto di denuncia che l’ex deportato Ferruccio Borsoni pubblicò clandestinamente
appena rientrato in Italia, i «socialisti anarchici» accostavano l’ordine repressivo
degli «spietati governanti» italiani a quello degli zar che deportavano in Siberia,
o a quello del governo borbonico spagnolo che due anni prima aveva recluso e torturato
400 anarchici a Montjuïc. La propaganda anarchica tentava di insistere sulle contraddizioni
di un regime che si voleva liberale, ma era in realtà autoritario come lo erano stati
i governi borbonici. Il sistema punitivo, ancora una volta, era preso a cartina al
tornasole dello scarso liberalismo (e dell’ipocrisia) degli «Stati di forme liberali,
illiberalmente governati». Se quella penitenziaria era stata una questione nazionale fin da subito, alla fine
del secolo essa mostrava non più solo la scarsa civilizzazione del paese, ma anche
l’illiberale ambizione a reprimere i nemici politici – paradosso dello Stato liberale
– contestata peraltro da alcuni giuristi liberali. Come qualche decennio prima per Mancini (o prima di lui per Cattaneo), anche per
Borsoni e i suoi compagni era in gioco una questione di diritto. Come i lettori vedranno,
questa storia della deportazione nell’Italia liberale è al fine anche la storia di
un piccolo gruppo di subalterni e delle loro strategie di sopravvivenza e di contestazione
di un ordine repressivo illegale.
1. Popolazioni «invaghite del proprio cielo»: i primi progetti per la repressione del
grande brigantaggio
Dopo la tragedia di Pisacane a Sapri, il mito di un Meridione pronto alla rivoluzione
si invertì: riprendendo stereotipi che datano dalla fine del Settecento, i meridionali
furono descritti come inaffidabili, indisciplinati, violenti, impulsivi e corrotti.
Nel Mezzogiorno il passatismo e la superstizione incrociavano la violenza del brigantaggio.
Si attinse così a una tradizione che aveva presentato il Mezzogiorno come un mondo
esotico e antropologicamente diverso, e che in parte era stata originata dalla letteratura
di viaggio di autori stranieri che avevano visto nell’Italia stessa la quintessenza
del paese meridionale. Come anticipato, il dibattito su come reprimere il brigantaggio segnò un momento
fondamentale, in quanto si tentò di costruire una pena su base antropologica più che
per gli specifici reati commessi. Gli anni del dibattito sulle leggi per reprimere
il brigantaggio furono un momento importante, in quanto si immaginò una pena speciale
in relazione non al reato che si doveva sanzionare, bensì ai caratteri antropologici
del reo. I politici che costruirono un discorso del genere non si avvidero della portata
notevole dal punto di vista della teoria giuridica, ma di fatto anticiparono alcuni
elementi del dibattito suscitato più tardi dalla Scuola positiva del diritto penale.
Quei discorsi ispirati all’emergenza, sebbene immaturi dal punto di vista teorico,
per certi versi anticiparono l’impostazione che sarebbe stata della Scuola positiva
di diritto penale.
Fu nella Commissione di studio sulla relazione del generale Alfonso La Marmora sulla
lotta al brigantaggio che emerse la proposta di deportare i briganti a causa di una
loro diversità antropologica. Come si è osservato, il dibattito parlamentare sulla
relazione, che si tenne il 3-4 maggio 1863, fu quasi del tutto gestito da deputati
meridionali. Il relatore, Giuseppe Massari, un patriota pugliese legato alla Destra, sostenne che i tribunali militari dovevano comminare la pena di morte solo ai briganti
colti in flagranza di resistenza a forza pubblica, mentre negli altri casi sarebbe
stata preferibile la deportazione. Quasi tutti «gli onorandi magistrati e giureconsulti» interrogati – sosteneva –
avevano lodato l’«intrinseca efficacia» di tale pena alla quale si aggiungeva un effetto
derivante «dall’indole delle popolazioni meridionali, affezionatissime al proprio
suolo, invaghite del proprio cielo, ritrose ad ogni credere al pensiero dell’allontanamento
dal tetto natìo».
Ma che cos’era la deportazione? Il deputato chiariva che per deportazione si intendeva
una pena che implicava il trasferimento in «terre lontane e di là dai mari», poiché
l’efficacia della pena dipendeva dalla distanza: «la deportazione alle Tremiti non
produrrebbe effetti così decisivi». La Commissione dunque non si stava riferendo a
una soluzione del genere, ma al trasporto in località molto più lontane. Questione forse più spinosa, era ormai necessaria una nuova legge anche per far
fronte all’illegalità dei mezzi con cui si stava procedendo contro i briganti a partire
dal 1861. Il progetto, agli articoli 15 e 16, prevedeva che chi fosse ritenuto colpevole del
reato di brigantaggio sarebbe stato fucilato se avesse opposto resistenza, altrimenti
sarebbe stato condannato alla pena della deportazione. La pena capitale era una «lugubre
necessità» che però andava ristretta ai casi in cui i briganti fossero colti, con
le armi alla mano, «sul teatro stesso dei loro misfatti in modo pronto, vigoroso,
esemplare». Per gli altri casi di arresto senza flagranza e senza armi, il progetto
della Commissione prevedeva la pena della deportazione: era una pena che tutti costoro
stimavano «efficacissima» per colpire i briganti e i loro complici, che erano quelli
«contro i quali maggiormente reclama[va] la pubblica opinione».
Di più Massari non diceva: non una parola sulla funzione della deportazione come pena,
sulle sue caratteristiche generali, né sulla sua complicata attuazione per un paese
che non aveva colonie. Il progetto della Commissione prevedeva la deportazione a vita
nei casi di «componente di banda armata» che andasse per «le pubbliche strade o la
campagna per commettere crimini o delitti di qualunque natura» (ex art. 14, n. 1); la deportazione a vita o a tempo per individui non partecipi della
banda che vi si fossero uniti momentaneamente, per coloro che dessero sostegno a –
o fossero in corrispondenza con – una banda, e per coloro che fornissero, «di libera
volontà», «alloggio, o luogo di riunione o di ricovero» (ex art. 14 nn. 2, 3, 4).
Si comminava, invece, la pena della deportazione a tempo agli evasi da luoghi di detenzione,
ai disertori, ai renitenti alla leva e agli «sbandati di un disciolto corpo di esercito»
che fossero trovati in possesso di armi. Secondo l’art. 17, la pena della deportazione
sarebbe stata espiata «in una terra od isola lontana» secondo modalità previste in
regolamenti appositi, e sarebbe stata «eguale nei suoi effetti e per la graduazione»
a quella dei lavori forzati.
Poco di più si diceva a inizio luglio nella relazione di una nuova commissione incaricata
di valutare quel progetto di legge. Il relatore, Raffaele Conforti, pur auspicando
l’abolizione della pena di morte, sosteneva che finché ciò non fosse avvenuto non
si sarebbe potuto fare «un’eccezione a favore de’ briganti». D’altra parte, tale «pena
terribile» aveva un’applicazione ristretta, essendo sostituita nei casi sopra descritti
proprio dalla deportazione. Nelle nuove proposte, l’applicazione della deportazione non subiva quasi alcun cambiamento. È da qui che la discussione sulla deportazione come pena speciale per i briganti
prese avvio.
2. La legge Pica e l’alternativa della deportazione
Il procedimento legislativo sul brigantaggio prese un’altra strada rispetto a questi
progetti. Artefice ne fu l’abruzzese Giuseppe Pica, professore di diritto criminale
all’Università di Modena dal 1859. Pica aveva alle spalle una storia significativa:
come attivista liberale era stato più volte arrestato dal regime borbonico per essere
stato tra gli esuli napoletani che furono deportati nel 1859 verso gli Stati Uniti
e che erano riusciti a dirottare la nave e arrivare in Inghilterra. Facendosi portavoce di un’esigenza di celerità, Pica propose di sospendere la discussione
sulla legge per il brigantaggio e trarre da essa una proposta più breve, ridotta a
tre punti sostanziali da discutere e votare in tempi rapidi. La proposta ebbe l’appoggio
del ministro dell’Interno Ubaldino Peruzzi, per il quale c’erano due punti essenziali
da approvare subito: la sostituzione della giurisdizione militare a quella ordinaria,
e un provvedimento che disponesse l’allontanamento momentaneo dalle province meridionali
delle persone che si trovassero già «in condizioni speciali» e che si ritenessero
«grandemente pregiudicievoli alla pubblica sicurezza», ma che difficilmente potessero
essere colpite dalla giustizia con le forme ordinarie. Pica da parte sua dichiarava che il suo progetto abbracciava «i punti capitali»
del progetto della Commissione Massari, che erano la definizione di brigantaggio, la competenza dei tribunali militari e
l’allontanamento di persone sospettate di favorire i briganti, per le quali si dava
la possibilità al governo di stabilire un domicilio coatto di massimo un anno. Tale
legge avrebbe avuto vigore provvisoriamente, solo fino alla fine dell’anno, per permettere
intanto l’approvazione di una legge di più ampia portata. Anche il ministro della
Giustizia, Giuseppe Pisanelli, appoggiò la proposta Pica, che a questo punto divenne di fatto il progetto del governo.
Nella breve discussione che seguì, il deputato Giuseppe Ricciardi propose di sostituire
la pena della fucilazione per i briganti che resistevano mano armata alla forza pubblica
con la «deportazione perpetua». Ricciardi era un politico napoletano, liberale e contrario
alla pena di morte, che definì «l’ultimo avanzo dell’antica barbarie». Proponeva di applicare la deportazione non per i reati di brigantaggio meno gravi,
come i progetti fino a quel momento prevedevano, ma ai casi più gravi in sostituzione
della pena di morte; per i casi meno gravi, quelli dei complici dei briganti, proponeva
piuttosto la deportazione temporanea da modulare a seconda della gravità del reato,
per attenuare la durezza della legge e infrenare l’arbitrio dei prefetti e dell’autorità
militare.
La strategia argomentativa del deputato non era però destinata a successo. Ricciardi
piuttosto che lodare gli sforzi dell’esercito per sedare il fenomeno, come facevano
quasi tutti gli altri deputati, affermò che la strategia seguita fino a quel momento
era fallita, come dimostrava l’alto dispendio di vite degli stessi soldati. Del recente
assassinio a Venosa di 21 cavalleggeri di Saluzzo incolpava direttamente il generale
La Marmora, accusandolo «di non sapere dirigere i soldati». Si trattò di un attacco sbilenco, in quanto prefigurava un’improbabile rotta dell’esercito. Con queste premesse, le sue pur ragionevoli argomentazioni contro la pena di morte
(condivise da molti deputati) difficilmente potevano aver successo. La proposta di
surrogare la deportazione alla fucilazione – spiegava Ricciardi – presentava due grandi
vantaggi. Il primo era quello di «rendere graduate le pene», giacché con la pena capitale
per definizione non vi era modo di «far graduazioni», mentre con la deportazione si
potevano distinguere vari gradi: la deportazione poteva essere perpetua o anche solo
per pochi anni; e graduare le pene era necessario, poiché «v’è forza punire egualmente
colui che commise i più atroci delitti e colui che fu semplicemente preso colle armi
alla mano». In secondo luogo, una volta sparita la pena di morte, i tribunali militari
non avrebbero più fatto paura: «finché c’è vita c’è speranza, dice il proverbio, e
quando fosse riconosciuta l’ingiustizia di una sentenza, vi sarebbe sempre il rifugio
della prerogativa della Corona, il ricorso per grazia». Il sistema della deportazione avrebbe ridotto il banditismo a minime proporzioni,
soprattutto per motivi legati alla psicologia delle popolazioni meridionali:
La deportazione, o signori, è molto più temuta da quelle popolazioni, che non la pena
di morte. I briganti in generale muoiono siccome eroi, e dalle popolazioni ignoranti
sono considerati come martiri. [...] Nelle Murate di Firenze vi sono 70 camorristi,
tenuti nel miglior modo possibile in quel modello delle prigioni. Or bene, signori,
la mia casa in Napoli, che sfortunatamente è il refugium afflictorum, è assediata ogni giorno dalle donne, dalle famiglie di quei camorristi, le quali
mi vengono a supplicare affinché io insista presso il Governo onde vengano trasportati
a Napoli, preferendo che sieno cacciati nei più orribili [reclusori] criminali, purché
non istieno a Firenze. Ora se i briganti sapessero di dover essere deportati, non
dirò in America, ma in Affrica, lontano lontano dai loro cari, immenso, indicibile,
sarebbe il loro sgomento.
Ricciardi, poi, denunciava l’abuso che si era fatto della pena capitale: le popolazioni,
a forza di vedere spargere il sangue con tanta facilità, si abituavano «al sangue
e alle crudeltà». Ma ciò valeva anche per i soldati, che magari seguivano la disciplina puntigliosamente
nelle città, mentre si davano a violenza indisciplinata nelle campagne, causando malumori
che non avrebbero giovato alla causa italiana. «Invero credete voi – chiedeva retoricamente
Ricciardi – che i parenti dei fucilati non bramino vendicarli?». Sarebbe stata una
«gloria» per la nazione italiana cogliere questa occasione per abolire la pena di
morte, «la più terribile e insieme la più inutile delle pene».
L’intervento di Ricciardi sollevò proteste. Peruzzi e Massari contestarono le gravi
accuse a La Marmora, mettendola sul piano della difesa dell’orgoglio nazionale. Pisanelli,
che pure era contrario alla pena capitale, sostenne che trattare il tema in questa
occasione era «cosa inopportuna, strana ed improvvida»: si stava discutendo di norme
da applicare dalla giurisdizione militare in uno stato di guerra e l’argomento della
pena di morte nella legislazione penale ordinaria era un fuor d’opera. In effetti, così facendo, ministri come Conforti e Pisanelli si trovarono a svolgere
un ruolo non molto compatibile con la loro immagine di liberali formatisi nella lotta
contro gli abusi del potere: il liberale Pisanelli, in nome dell’emergenza, finì per contrastare le proposte
abolizioniste di Ricciardi. Pica rimproverò Ricciardi di aver difeso «uomini colpevoli
di mille delitti», «veri cannibali», che non erano uomini ma «fiere».
L’emendamento di Ricciardi che avrebbe introdotto la deportazione fu ovviamente respinto.
Un emendamento non molto diverso fu però proposto da Antonio Ranieri, anch’egli deputato
napoletano, il quale proprio in quegli anni andava approfondendo l’impegno contro
la pena capitale. La sua proposta dava al giudice la possibilità di scegliere tra la fucilazione e
la deportazione, «secondo le circostanze». Era opportuno, infatti, non «fare una forza
al giudice di applicare la morte».
Fu a questo punto che intervenne Mancini, che negli anni sarebbe stato il più duro
avversario della pena della deportazione. Mancini aveva presentato nel dicembre precedente un progetto di legge (peraltro
mai discusso) abbastanza simile, che conteneva misure molto severe ma prevedeva come
alternativa alla fucilazione i lavori forzati, non la deportazione. Secondo Fozzi,
nella brevissima discussione sulla legge per la repressione del brigantaggio, l’opposizione
di Mancini risultò a tratti indebolita da quel suo precedente progetto di legge che
conteneva misure che andavano al di là di qualsiasi garanzia costituzionale. Mancini conveniva che la decisione sulla morte di una persona era enorme, e che
si trattava di giudicare su «un abisso» incommensurabile. Però, appunto perché si trattava di una decisione così importante, non sarebbe stato
giusto lasciarla completamente all’arbitrio del giudice, trasformandolo in legislatore.
La legge doveva specificare che solo «concorrendovi circostanze attenuanti» si potesse
evitare la sentenza di morte e «discendere a quella inferiore». Il giurista riteneva
che questa pena di grado inferiore non poteva essere la deportazione, per cui chiedeva
a Ranieri di «condiscendere che nella diminuzione di penalità da lui bramata» fosse
piuttosto prevista la pena dei lavori forzati a vita. Fu un passaggio importante:
La deportazione, o signori, è una pena che non dovrà entrare, quasi diremmo, di sorpresa
nel sistema penale italiano, senza che, a suo tempo, il Parlamento ne faccia argomento
dei suoi studi e di una seria e matura riflessione. Avendo io consacrato molti anni
agli studi della ragion penale ed all’insegnamento di questa importantissima disciplina,
appresi a considerare assai gravi, dal punto di vista de’ principii, le obbiezioni
che teorici e pratici muovono contro la legittimità, la moralità e la sociale utilità
della pena della deportazione.
Mancini ricordava pragmaticamente che l’introduzione della pena della deportazione
avrebbe richiesto una serie di provvedimenti ulteriori e forse anche negoziazioni
con altri governi «per ottenere la cessione di qualche lontanissima isola». Altrimenti, la deportazione sarebbe stata una pena «ineseguibile». Non si poteva
escludere che in futuro si potesse considerare la deportazione (anche se era chiara
la sua contrarietà), ma si trattava di una «questione gravissima» che in quel momento
non si poteva assolutamente affrontare.
L’emendamento Mancini-Ranieri fu alla fine approvato. In quel momento l’atteggiamento
di Mancini fu quello di lavorare per un miglioramento della legge, ma sarebbero rimaste
alcune critiche più radicali sullo sfondo: negli anni successivi si sarebbe impegnato
contro la reiterazione della legge Pica, definendola un esempio della «scandalosa
riproduzione del vecchio dispotismo dei Borbone» e ricordando l’opinione di Cavour secondo la quale il governo italiano non doveva,
«con vergognosa imitazione», governare il Mezzogiorno «con gli stessi iniqui mezzi
adoperati dai Borboni».
L’esclusione della deportazione dal testo licenziato dalla Camera non passò sotto
silenzio. Al Senato, Giovanni Audiffredi arrivava a sottolineare la «mitezza di questa
legge». Certo, era «penoso» che il giudizio militare si sostituisse al civile, ma
c’era ragione di sperare che in avvenire si sarebbe potuto mitigare «il rigore della
fucilazione» con la deportazione, che era uno strumento «forse più efficace», poiché
«quando un essere si rende insoffribile alla società, essa acquista il giusto diritto
di liberarsene», e ciò valeva soprattutto nei tempi difficili che l’Italia meridionale
stava vivendo. Una perplessità simile veniva da Giuseppe Vacca, un magistrato napoletano, che assicurava
di sapere che molti dei capi e dei gregari delle bande armate si erano dichiarati
«prontissimi a metter giù le armi» a condizione di aver salva la vita e di «veder
cangiata la pena capitale in una deportazione». Era un discorso da meridionale che dichiarava di conoscere il materiale umano su
cui si stava legiferando. Sulla stessa linea, il settentrionale Paolo Farina, pur
dichiarando di non possedere «sufficiente conoscenza delle tendenze, delle abitudini,
dei pregiudizi degli individui di quelle località», era stato tuttavia assicurato
che per molti di costoro riusciva «di maggior spavento l’idea di una deportazione
che non l’idea della morte». Qui la deportazione veniva proposta in quanto deterrente di maggior peso. Seppur
con argomentazioni diverse, la deportazione era sostenuta con forza dai senatori.
Il ministro dell’Interno Peruzzi rispondeva che, vista l’eccezionalità della situazione
delle province meridionali, tutti i governi unitari avevano sempre considerato l’adozione
della deportazione almeno come misura transitoria. Non era però convinto che presso
quelle popolazioni la deportazione avesse l’enorme effetto deterrente descritto da
Farina. Il vero problema era la difficile applicabilità della pena: dove trasportare
i briganti? Finora si erano incontrate molte difficoltà per trovare un luogo adatto,
ma il governo non interrompeva le ricerche e, anzi, sperava di poter presentare al
più presto un progetto di legge al riguardo.
Quella che prese il nome di legge Pica passò attraverso un dibattito tutt’altro che
«senza rumori», come affermò Marco Minghetti, pur trovando, alla fine, una larghissima
maggioranza, di 174 contro 33 alla Camera e una ancora più ampia al Senato. Nel dibattito
un ruolo importante fu svolto da parlamentari meridionali. Si è scritto che, per la
loro esperienza a contatto con un fenomeno secolare quale il brigantaggio, essi avevano
una capacità analitica maggiore. In effetti, alcuni meridionali vantarono la loro speciale conoscenza della psicologia
dei briganti e dei costumi delle genti del Mezzogiorno per sostenere la causa della
deportazione; però, alla fine fu proprio un meridionale, cioè Mancini, il politico
a cui si dovette l’eliminazione della norma che la prevedeva.
La legge Pica, emanata infine il 15 agosto 1863, introdusse l’istituto del domicilio
coatto, che aveva precedenti nella legislazione borbonica, una misura di polizia per
soggetti ritenuti pericolosi destinata a diventare un potente strumento di repressione
del crimine comune e dell’attivismo politico. L’istituto, pur comportando la relegazione in un territorio lontano dalla provincia
dove il brigante agiva, tendenzialmente un’isola, non era associato al concetto di
deportazione. Questo è un dato importante: da come la discussione sulla repressione
del brigantaggio fu impostata, la deportazione era associata a luoghi molto lontani,
al di fuori del territorio nazionale, «terre lontane e di là dai mari»: espressione
che sembrava implicare l’ubicazione in isole in un oceano, o forse in qualche territorio
del continente africano. Lo aveva spiegato lo stesso Mancini: la deportazione non
era certo la relegazione in un isolotto delle ridenti coste italiane. In più, c’era
una differenza giuridica di fondo: la deportazione era una pena, mentre il domicilio
coatto era una misura di polizia. Questa impostazione del problema sarebbe rimasta
in tutto il dibattito futuro, come una premessa definitoria accettata quasi da tutti.
L’estrema lontananza della colonia penale non aveva qui ancora i tratti del luogo
coloniale o esotico e non si specificava se i deportati avrebbero vissuto sostanzialmente
liberi, ristretti solo dall’impossibilità di far ritorno in patria, come nell’esilio,
o in penitenziari appositamente costruiti, o, ancora, dovessero essere assegnati a
proprietari terrieri come lavoratori coatti. Nella rapidità del dibattito su una legge
urgentissima, non si discusse su cosa dovesse essere una «colonia penale» italiana
nell’oltremare.
Altra caratteristica di quel dibattito fu che, all’insegna della lotta contro i briganti,
il tema della deportazione si intrecciava con quello, ben più pregnante, della pena
di morte.
3. La grande riforma: la questione della pena di morte
Dopo le leggi sull’unificazione legislativa del 1865, rimaneva aperta la grande questione
dell’unificazione del diritto penale, legata soprattutto al tema della pena capitale.
La questione si pose in particolare dopo l’annessione della Toscana del marzo 1860,
in quanto lì vi era una tradizione abolizionista consolidata e la pena di morte non
era in vigore. Gli intellettuali toscani non erano disponibili a rinunciare alla legislazione
abolizionista, mentre non vi erano ancora le condizioni per abolirla nel resto del
regno. A tuonare contro la fretta nel ricercare e imporre il codice penale unificato era
il toscano Francesco Carrara, che predicava un «aspettare e sperare che non significava
fatalismo e assenza di impegno, quanto piuttosto fiducia nel lavoro della scienza
giuridica e ammonizione del lungo lavoro che la aspettava». Nella dottrina era diffusa poi una fondata critica all’imperfezione del codice sardo,
che alimentava malumori per la sua estensione.
In questo contesto molti pensavano che la deportazione potesse rappresentare una soluzione
idonea per sostituire la pena di morte al punto più alto della scala penale e quindi
raggiungere l’accordo per un codice penale unificato.La deportazione, insomma, poteva costituire la chiave per arrivare all’unificazione
penale.
Nel marzo 1865, a schierarsi a favore della deportazione fu il deputato fiorentino
Stefano Siccoli, un ex volontario garibaldino che aveva fama di eroe. Siccoli si diceva «per l’abolizione assoluta della pena di morte» in quanto cristiano,
in quanto deputato e come italiano. L’abolizione avrebbe dato alla nazione «il vanto
di una grande vittoria» che avrebbe rinfacciato allo straniero, al papato e agli austriaci
il brutale uso della forca, che era il loro normale «ausiliare». A chi accusava i
patrioti italiani di non aver resuscitato che una «vieta forma d’unità politica»,
si sarebbe risposto: «l’Italia appena libera ha pensato a tutti. L’Italia per la prima
redime oggi l’umanità dal tributo del sangue!». Era incomprensibile come una società
che si vantava di essere «civile e cristiana» e si sentiva forte contro i pericoli
più gravi non sapesse trovare altro modo di difesa contro «i grandi colpevoli» che
non fosse basato sullo spargere il loro sangue, rubando così «a Dio il diritto di
un fatto irreparabile». Alla pena di morte si poteva supplire subito con due nuove pene: uno speciale sistema
di «carcere penitenziario», sul quale però non si diffondeva, e la deportazione sul
modello degli inglesi. D’altra parte, quale profitto si sarebbe avuto «da tutte quelle
esistenze che fin qui abbiamo prodigate al carnefice?». Sarebbe bastato un anno per
ottenere il trattato per l’acquisizione e l’impianto di una colonia penale, in una
terra nel Sud dell’Africa dal Portogallo, oppure in un territorio del Cile nello stretto
di Magellano. Nella colonia penale si dovevano inviare «quelle famiglie di manutengoli
oggi mandate a domicilio coatto» e «quei briganti che oggi fucilate, perché presi
colle armi alla mano», mentre i briganti rei dei maggiori delitti si dovevano destinare
al carcere.
Siccoli riprendeva alcuni punti emersi durante la discussione sulla legge Pica, in
particolare le considerazioni antropologiche sui briganti: le «popolazioni immaginose
del Mezzogiorno» sarebbero state spaventate più dalla deportazione che dalla morte:
«mentre quasi tutti i briganti vanno indifferenti al supplizio, piangono e chiedono
mercé allorché si annunzia loro che vanno a cambiar cielo, anche per tempo determinato».
Per inciso, questo elemento aveva colpito anche un altro deputato, l’irpino Filippo
Capone, che sottolineò in quell’occasione «l’indifferenza colla quale in generale
sono andati alla morte i tanti briganti fucilati in questi ultimi tempi». All’opposto, le fucilazioni di briganti avevano dato alla loro resistenza «la tenacità
di vendetta, il furore del fanatismo, e l’aureola così immeritata del martirio». Se Siccoli era ritenuto un irregolare della politica e aveva dato più di un grattacapo
all’establishment, buona parte dei suoi argomenti doveva, però, sembrare ragionevole a molti.
Anche il ligure Stefano Castagnola, un ex mazziniano ormai vicino ai moderati, si pronunciò a favore dell’abolizione della pena di morte e della contestuale introduzione
del sistema della deportazione. Castagnola si diceva un abolizionista moderato, cioè
«non nel senso radicale ed assoluto» di Siccoli. Non era di per sé contrario alla legge Pica, ma bisognava impedire che provvedimenti
eccezionali divenissero «mezzo abituale di Governo». Era la stessa esperienza dell’applicazione
dei mezzi previsti dalla legge Pica ad averlo convinto della necessità di abolire
la pena di morte. Il deputato aveva constatato che prima della Commissione d’inchiesta
nelle province meridionali (1862), e dunque prima dell’entrata in vigore della legge
Pica, «non vi era capitanuzzo di guardia nazionale che non si arrogasse il diritto
di vita e di morte». Bastava additare una persona come brigante perché fosse fucilato.
La diffusione di questa pratica non aveva affatto estinto il brigantaggio, che anzi
«rincrudiva sempre più». La legge Pica aveva regolarizzato la procedura di condanna a morte e ridotto enormemente
il ricorso alle esecuzioni, con la conseguenza che «si scorse che a misura che scemarono
i supplizi contro i briganti scemò anche il brigantaggio». Il ragionamento di Castagnola era del tutto opposto a quello di Siccoli, ma perveniva
alla stessa conclusione. Le galere, «questo residuo di istituzione del medio evo»,
erano del tutto inadatte a colpire i criminali: in quelle napoletane regnavano i camorristi
e la pena non poteva essere considerata affatto «afflittrice» ed «emendatrice». «La
galera – sosteneva il deputato – non corregge, ma corrompe».
Se dunque né la pena di morte né la galera erano pene con le quali si potessero «colpire
i grandi misfatti», con cosa le si poteva sostituire? La risposta di Castagnola era
il carcere con isolamento (cioè il modello filadelfiano del quale si discuteva in
quegli anni), oppure la deportazione. Delle due, però, la deportazione era la migliore,
perché parlava di più «all’immaginosa fantasia degli Italiani» e li atterriva di più. D’altra parte, come aveva affermato la Commissione d’inchiesta sul brigantaggio,
«quei manigoldi che andavano impavidi alla morte, senza dare segno di emozione, all’idea
di essere strappati dal luogo natale, trasportati a tremila miglia di distanza, a
dovere fertilizzare un vergine suolo col timore di non rivedere mai più la terra che
li vide nascere» lo avrebbero ritenuto un supplizio tanto forte quanto la morte.
All’obiezione che proprio in quegli anni l’Inghilterra si stesse ritirando dal sistema
della deportazione avendo verificato che essa aveva dato cattiva prova, il deputato
rispondeva che l’errore degli inglesi era stato quello di usare la deportazione esclusivamente
come strumento di colonizzazione, trattandola «come mezzo di pena in via meramente
secondaria». I deportati venivano presto liberati per diventare coloni liberi, con risultati
disastrosi per le persone oneste. A questo punto il deputato compiva un coup de théâtre: inseriva nel suo lungo discorso una breve citazione di Carlo Cattaneo, che in realtà
era stato un grande avversario della deportazione. Cattaneo aveva ben stigmatizzato
tutte le incertezze della pena in un passaggio rimasto celebre:
Io ti condanno, sentenzia il giudice, io ti condanno; ma non so a qual pena; – forse
alla burrasca e al naufragio; – forse al tifo; – forse alla fame; – forse ai pesci
e alle bestie feroci; – forse ad èssere divorato dai canìbali; – forse, al contrario,
a divenire in altra terra un facultoso signore; – va, tenta la tua fortuna; muori
o pròspera; soffri o godi: la nave che ti porta, mi tolga l’aspetto del tuo bene e
del tuo male!
Si trattava di una condanna della deportazione in quanto tale. Invece, nella rappresentazione
strumentale di Castagnola, Cattaneo aveva voluto esprimere un giudizio negativo su
quella pena solo in quanto essa era usata per l’espansione coloniale. Si trattava, ovviamente, di una notevole forzatura, che tralasciava di proposito
tutte le stringenti critiche penalistiche che Cattaneo aveva mosso, anche sulla scorta
del pensiero di Jeremy Bentham. Al contrario di Siccoli, Castagnola additava l’esempio
della Francia. È vero che il nome della Caienna era diventato odioso, soprattutto
perché lì erano stati spediti detenuti politici, cosa di per sé «sempre odiosa». Però,
se la cosa era considerata sotto il punto di vista penale e penitenziario, si poteva
constatare che i risultati ottenuti nelle colonie penali francesi erano assai migliori
di quelli ottenuti dall’Inghilterra, e si avvicinavano agli scopi che si era prefisso
il governo italiano.
La discussione approdò in Senato il 15 aprile 1865. L’Ufficio centrale del Senato,
contrario all’abolizione della pena di morte, si mostrò favorevole alla deportazione,
e per bocca del relatore, il senatore Giovanni de Foresta, fece voti «affinché si
potesse un giorno attuare quel sistema che si ravvisasse il migliore, per purgare
la società dai delinquenti incorreggibili e per assicurare così la tranquillità dell’ordine
sociale, senza ricorrere alla pena di morte». Il Senato apriva così alla deportazione, mandando un chiaro messaggio alla Camera,
cioè che l’abolizione della pena di morte avrebbe avuto un prezzo. Non solo: si iniziò
a sentire la prima voce di un giurista favorevole alla deportazione: Tancredi Canonico,
che fu tra i primi a contribuire al dibattito giuridico sulla deportazione, sostenne
che la relazione di de Foresta era stata «bellissima» proprio in quanto conteneva
«un solenne omaggio al principio della deportazione».
A causa del rigetto del progetto e del disaccordo tra le due Camere, nel novembre
1865 il ministro dell’Interno Giuseppe Natoli istituì una commissione per riassumere
e completare gli studi sulla riforma dell’ordinamento e sulla portata delle pene;
poco dopo, il ministro della Giustizia Giovanni De Falco nominò una commissione incaricata
dell’elaborazione del progetto di codice penale. Le due commissioni parallele lavoravano
insieme ed erano entrambe presiedute da Pisanelli.
Fin dalla prima riunione della prima commissione, nel gennaio 1866, la possibilità
di introdurre la deportazione fu al centro del dibattito, poiché De Falco riconobbe
che molti la ritenevano una pena particolarmente adatta alle condizioni sociali dell’Italia. Nella riunione successiva si precisava che la Commissione doveva lavorare alla soppressione
dei bagni penali con l’ormai inaccettabile sistema del lavoro forzato, e conseguentemente
indicare se a questi si potesse sostituire la deportazione, non secondo l’esempio
inglese che ebbe «funestissime conseguenze», ma in un modo che fosse «in armonia colla
odierna civiltà». Nella sintesi delle domande sulla portata delle pene presentate l’11 marzo 1866,
la questione della deportazione figurava al primo punto.
Nel marzo 1866 due dei massimi esperti di diritto penale dell’epoca, Francesco Carrara
ed Enrico Pessina, furono nominati membri della seconda commissione. I due, pur appartenenti
ad ambienti e generazioni diverse, erano esponenti della tradizione nazionale, che
i positivisti con certa forzatura avrebbero battezzato come «Scuola classica», e incarnavano
il modello del giurista liberale, essendo allo stesso tempo professori, avvocati e
parlamentari. Erano poi appassionati avversari della pena capitale. Il 25 marzo 1866, Carrara
e Pessina concordarono sull’affermazione che il nuovo codice dovesse stabilire una
scala penale che non avesse la pena capitale al «suo sommo gradino». Approvata all’unanimità
tale dichiarazione, iniziò la discussione sull’eventuale introduzione della deportazione. Pessina fu il primo oratore e affermò che sia ragioni pratiche che scientifiche
si opponevano a questa pena. L’esperienza britannica aveva portato a «conseguenze
disastrose», tanto che ragioni di umanità, prudenza ed economia suggerivano di non
proseguire quell’esperimento. Del resto – affermava – il fatto che l’Italia non possedesse
né una colonia né un’isola lontana faceva risultare l’idea poco praticabile. Tutt’al
più – precisava – la Commissione avrebbe potuto considerare il diverso istituto della
transportation, che non era una pena di per sé, ma solo una fase di una pena. Altri membri della Commissione confermarono il punto di vista di Pessina, e alla
fine la deportazione non fu ammessa nella nuova scala delle pene. Carrara non aveva
espresso la sua posizione, ma verosimilmente a tutti sembrò che in qualche modo la
sua scuola lo avesse fatto.
Da quel momento la Commissione non lavorò più sulla deportazione coloniale ma sull’idea
di Federico Bellazzi della «deportazione perpetua all’ergastolo» nelle isole italiane,
che era in realtà un modo per disinnescare la forza della deportazione vera e propria
(nel suo scritto del 1866 sulla questione del sistema carcerario, il deputato dichiarava
la sua totale opposizione alla deportazione coloniale). Nello stesso anno, però, usciva anche l’Introduzione allo studio del diritto penale di Canonico, che invece era favorevole. La questione, insomma, rimaneva controversa.
L’anno successivo, ad occuparsi della deportazione fu l’Accademia dei fisiocritici.
L’istituzione scientifica senese, nata alla fine del Seicento per promuovere gli studi
del mondo fisico attraverso il metodo sperimentale, aveva una classe di scienze morali,
di fronte alla quale Luigi Rubechi presentò una memoria sul tema. L’autore era un
magistrato toscano, e in quanto tale – recitavano gli Atti dell’Accademia – non poteva che avere «parola di maledizione» per la pena di morte.
La deportazione era quindi presentata anche qui come surrogato della pena capitale.
Dall’alto della sua lunga esperienza nell’organo giudiziario, Rubechi sapeva che «vi
sono uomini incorreggibili nel misfare, divenuti tali per tradizione, per educazione
e costume uniforme che s’è cambiato in natura». Contro tali soggetti, la società non
possedeva che «armi impotenti», per cui c’era necessità di espellere dal corpo sociale
«queste parti infette e minacciose per la cancrena morale». La deportazione, dunque, era utile sia come pena che surrogava l’estremo supplizio,
sia come strumento di allontanamento degli incorreggibili. Gli accademici si compiacevano che la memoria fosse arrivata in tempo «per accrescere
nuovi lumi, che non sono mai soverchi» alla Commissione incaricata della riforma penale.
4. Una pena per i briganti
I briganti furono al centro della costruzione di un immaginario, ben lumeggiato dalla
storiografia. Dalla fine del Settecento si era affermata l’idea che i briganti formassero una
«classe distinta», nonché una «società organizzata» costituita attorno a particolari
riti, tradizioni e costumi, magari anche con linguaggi segreti. Nel corso dell’Ottocento,
all’immagine dei briganti nelle campagne si affiancò quella dei criminali nelle società
urbane, entrambe le realtà essendo descritte come «un mondo a parte», insomma una
specie di «luogo parallelo», separato dal mondo civile ma al tempo stesso prossimo
ad esso. Tra gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, si costruì un immaginario secondo cui
i criminali non solo costituivano una classe sociale a sé, ma anche vivevano il crimine
come un mestiere ereditario. Il tema era, in generale, quello delle «classi pericolose», contrapposte alle classi
laboriose, che potevano rappresentare una saldatura tra le realtà marginali e il mondo della
sovversione.
Lo scrittore Pietro De Angelis negli anni Venti aveva sottolineato il carattere politico
dei briganti, che erano gli unici «uomini pubblici» che i governi dispotici della
penisola tolleravano: il loro ruolo sociale era dunque legato alla corruzione del
potere. Erano il Regno borbonico e lo Stato pontificio, con la loro tirannia e inefficienza,
ad aver favorito lo sviluppo capillare di bande criminali. Dal punto di vista del
carattere, i briganti avevano «un’innata propensione alla libertà e all’indipendenza»,
che era il prodotto del malgoverno dispotico, e non un fatto d’indole. Liberi da qualsiasi legame ed esonerati da tutti i doveri, i briganti erano ricaduti
nello stato di natura, dove le azioni sono governate dalle passioni che non conoscono
alcun freno se non quello della forza. Essi vivevano in uno stato di animalità, dominati dalle passioni e dagli istinti,
in una parola da «sentimenti non civilizzati». Per De Angelis – come per vari autori – i loro costumi e il loro carattere sembravano
«appartenere all’epoca in cui gli uomini, agitati dalle passioni e spinti dai bisogni,
non aspiravano che a distruggersi gli uni gli altri», più che all’età moderna. Tanto
che si poteva dire che essi riproducevano «l’immagine dell’istato primitivo del genere
umano».
Anche come conseguenza dell’iperpoliticizzazione delle rivoluzioni ottocentesche,
al criminale (brigante delle campagne o criminale urbano) furono attribuite precise
caratteristiche morali, oltre che fisiche e sociali. Allo scoppiare della guerra contro
il grande brigantaggio, gli esponenti della classe politica moderata videro in esso
l’esplosione di una criminalità «strutturata, endemica e violenta», rappresentando
«un miscuglio di depravazione plebea e abominio morale» nutrito dal governo borbonico. A differenza del discorso primottocentesco, attribuirono i caratteri del brigante
alla loro indole e, più in generale, discutevano dell’indole dei meridionali.
Tutto ciò contribuisce a spiegare il contesto in cui si affermò così fortemente l’idea
che la deportazione fosse una pena particolarmente utile per questa speciale categoria
sociale del Mezzogiorno d’Italia, che nello specifico torno di tempo qui analizzato
costituiva una minaccia all’ordinamento politico. I briganti erano esseri vicini all’animalità
e allo stato di natura, carnalmente legati alla propria terra ma incuranti della morte,
«eroi sociali» per i ceti plebei, che essi potevano corrompere portandoli alla sedizione
e della cui complicità potevano godere. Il discorso – politico più e prima che penalistico
– sulla pena per i briganti mise in gran risalto considerazioni di tipo antropologico:
la deportazione era la pena più adatta a quel tipo di popolazioni «affezionatissime
al proprio suolo», refrattarie a ogni minaccia di morte e attaccate come animali alla
propria terra, persone «invaghite del proprio cielo», sempre secondo Massari, un’espressione
non spiegata che forse rimanda a quell’innata propensione alla libertà e all’indipendenza
e a quel sentimento di assenza di doveri sociali di cui si diceva poc’anzi. Anche
Siccoli fece riferimento al terrore di allontanarsi dal proprio «cielo» nel momento
in cui sottolineava la caratteristica dei meridionali di essere «popolazioni immaginose».
Questo discorso, all’intersezione tra il diritto criminale e l’antropologia, era svolto
piuttosto inconsapevolmente rispetto ai problemi epistemologici ben prima della nascita
dell’antropologia criminale lombrosiana e della Scuola positiva del diritto penale
di Enrico Ferri, che avrebbero mosso i loro passi rispettivamente dalla metà degli
anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta, teorizzando in maniera organica che
l’antropologia doveva essere alla base dell’individuazione della pena, peraltro in
linea con un movimento europeo e americano per la pena indeterminata.
C’era poi la questione dei legami sociali: Ricciardi spiegò la sua propensione per
la deportazione dicendo che la pena capitale avrebbe reso i briganti dei martiri presso
«le popolazioni ignoranti», e anche Siccoli parlò dell’«aureola immeritata del martirio»
che essi avrebbero guadagnato con la morte. Le esecuzioni non avrebbero reciso i legami
strutturati e capillari di cui tali banditi godevano, ma li avrebbero anzi rafforzati,
radicalizzando il potere di tali gruppi sulle masse plebee. Inoltre, i briganti potevano
contare su reticoli di aderenze che poggiavano su oziosi e malviventi vari. La soluzione era pertanto allontanarli da quella terra e soprattutto recidere, relegandoli
in terre «al di là dei mari», quelle reti capillari di relazioni criminali.
Insomma, il discorso sulla deportazione in relazione alla repressione al brigantaggio
era sì velato di intenzioni umanitarie, che aspiravano alla cessazione delle esecuzioni
in linea con un discorso morale e penalistico crescente contro l’estremo supplizio,
ma era anche un discorso repressivo tutt’altro che umanitario, ispirato a un accumulo
di considerazioni antropologiche sul tipo speciale di criminali rappresentato dai
briganti meridionali.
5. Una colonia penale in concessione?
Sebbene per alcuni fosse superfluo discutere dell’introduzione della deportazione
nell’ordinamento italiano in quanto l’Italia non aveva colonie, proprio in quegli
anni ebbero vita iniziative concrete per la fondazione di una colonia penale.
Secondo quanto riportato una trentina di anni più tardi da un soggetto bene informato,
il diplomatico Giacomo Gorrini, nel 1862 l’Italia iniziò trattative con il Portogallo
per l’ottenimento di una località tra i suoi possedimenti coloniali africani. L’occasione
fu data dalle nozze reali tra la figlia del re italiano, Maria Pia di Savoia, e il
re del Portogallo Luigi I, avvenute a Lisbona il 6 ottobre di quell’anno. Secondo
Gorrini, «gli amichevoli scambi d’idee fra eminenti funzionari delle due monarchie
si accentuarono, e stettero per giungere a concreto risultato». L’Italia voleva ottenere dal Portogallo un punto in Mozambico, in Angola o nel Congo,
che era allora ancora nei radar della monarchia portoghese. Il diplomatico lasciava
intendere che il Portogallo avrebbe accettato una tale concessione, ma la trattativa
saltò perché il governo italiano esigeva la piena sovranità sul territorio ceduto,
in modo da potervi «estendere l’autorità delle proprie leggi ed eliminare la possibilità
di conflitti internazionali d’ordine giuridico o politico». L’Italia dunque non cercava semplicemente un luogo dove deportare parte della propria
popolazione carceraria, ma cercava una vera colonia sulla quale estendere la propria
sovranità. Su tale punto si verificò la rottura delle trattative, che furono riprese,
inutilmente, nel 1869. «Vaghi discorsi» – riferiva il diplomatico – furono avviati anche con l’Inghilterra
per le Falkland, con la Danimarca per la Groenlandia e con la Russia per una località
nelle isole del Mare di Bering. Ma senza approdare a nulla, ché «mancava un programma
o una direttiva, rimanendosi sempre nel campo di meri tentativi e di vaghe aspirazioni». Va detto che negli atti diplomatici italiani e nell’Archivio storico del Ministero
degli Affari esteri non sono stati rinvenuti documenti che attestino queste trattative.
Gorrini, però, è un personaggio affidabile per il fatto che negli anni Novanta lavorava
proprio all’archivio del Ministero degli Esteri. Nel suo archivio personale si trovano
alcune carte, evidentemente sottratte al Ministero in cui lavorava, che testimoniano
di quelle prime trattative italiane. Si tratta di lettere che intercorrono tra un
deputato impegnato sulla questione carceraria, il già citato Bellazzi, e un alto funzionario
degli Esteri.
Bellazzi era rimasto insoddisfatto del lavoro di una prima commissione governativa
del 1862 di cui avevano fatto parte Giuseppe Boschi, il direttore generale delle carceri,
e Carlo Peri, il noto riformatore toscano. Il problema generale era quello di dare uniformità al sistema delle pene, dopo l’estensione
al Regno della legislazione piemontese sugli istituti penali da cui fu esentata la
Toscana, che poteva vantare un primato riconosciuto per il suo riformismo penale.
Il modello piemontese prevedeva cinque tipi diversi di pena, ognuno con un diverso
regolamento, e dunque la pena rimaneva frammentata. La Commissione aveva proposto
l’adozione del modello filadelfiano, basato sulla segregazione cellulare e l’obbligo
di lavoro, facendo voti per l’abolizione del lavoro forzato con i ceppi. Fu istituita, poi, nel novembre 1865 una nuova commissione governativa per la riforma
della scala delle pene e del sistema penitenziario, e Bellazzi ne entrò a far parte.
Dall’esperienza nella Commissione, il deputato ricavò i dati e le riflessioni contenuti
nel libro sul problema penitenziario pubblicato nel 1866, in cui si esprimeva contro la deportazione, pur dopo aver interrogato a riguardo
alcuni personaggi chiave di vari ministeri. In questo contesto si trovano tracce di
alcune trattative intavolate dall’Italia per ottenere una concessione per una colonia
penale.
Nel marzo 1866 Bellazzi inviò al segretario generale del Ministero degli Esteri Marcello
Cerruti una lettera che intendeva dare seguito a una conversazione svoltasi de visu il giorno precedente «intorno alle pratiche che già si disse essere state iniziate
da cotesto Ministero degli Esteri per avere una località d’oltremare ove deportare
i nostri condannati ai Bagni marittimi». Se il deputato milanese era un personaggio notevole, non da meno era il suo corrispondente
agli Esteri, essendo stato console a Belgrado, in America Latina e nell’Impero ottomano,
dove aveva cercato su incarico di Cavour di far arrivare armi ai rivoluzionari ungheresi.
Al suo ritorno in Italia alla fine del 1862, dopo una parentesi in Persia, Cerruti
era stato nominato segretario generale agli Esteri, incarico che avrebbe tenuto fino
al 1866.
Bellazzi chiese all’esperto diplomatico se realmente il Ministero avesse iniziato
pratiche per ottenere da un’altra potenza «una località per stabilire colonie penali
d’oltremare», e se il governo avesse dato istruzioni «perché le nostre navi veleggianti
nell’Oceano Indiano» andassero alla ricerca di qualche isola da occupare allo scopo
di deportazione. Era poi vero che il governo italiano aveva aperto trattative con
potenze estere per ottenere «una terra qualunque» ove deportare i condannati alle
pene più gravi? Il giorno precedente, nella conversazione de visu, l’alto diplomatico aveva passato «in rivista di volo» i tentativi fatti dal governo
con Portogallo, Inghilterra, Repubblica di Venezuela e altre potenze. In quella occasione,
Cerruti aveva anche svolto osservazioni sugli effetti che la deportazione in zone
di clima tropicale avevano «sul carattere e sul temperamento» di persone del Nord
Europa, e Bellazzi, che aveva bisogno di risposte documentate da presentare ai membri
della Commissione, chiese di avere queste note per iscritto. In particolare, Cerruti
aveva raccontato di esser stato testimone in Brasile della «sovreccitazione di istinti
brutali» nei deportati da paesi europei. Inoltre, a quanto ricordava Bellazzi, Cerruti
aveva pure discettato della convenienza di deportare «in regioni più nordiche della
nostra Italia» condannati che avrebbero forse trovato nella stessa Russia un clima
non troppo diverso da quello che domina nella Valle d’Aosta, ed «elementi di amore
al lavoro e di calma alle naturali tendenze». Il deputato chiese poi la sua valutazione
sull’eventuale colonizzazione penitenziaria delle isole Nicobare, a cui il ministro
dell’Agricoltura Luigi Torelli stava lavorando in quegli anni, come si dirà.
L’alto funzionario, dopo aver espresso preoccupazione per la riservatezza delle informazioni
che gli avrebbe fornito (si trattava di «materia gelosissima», poiché in caso di divulgazione
delle informazioni nessun governo avrebbe più voluto intavolare trattative con l’Italia), chiarì che fino a quel momento, in realtà, non c’erano stati veri negoziati con
alcuna potenza al fine di acquistare un possedimento d’oltremare da destinare a colonia
penitenziaria, ma solo «qualche scambio d’idee». Erano dei fili esili non ancora spezzati:
con la Russia per una delle isole Aleutine (nelle fonti «Aleuzie») nel Mar di Bering;
coll’Inghilterra per le isole Falkland o Malvine all’est dello stretto di Magellano;
con la Danimarca per un punto della Groenlandia; col Portogallo per un territorio
africano. Ma tutti questi primi approcci si erano bloccati per una ragione di fondo
tutt’altro che secondaria, «una difficoltà che può chiamarsi radicale»:
Tutti i Governi posseditori di ampie ed in parte disabitate terre d’oltre mare sarebbero
più o meno propensi a permettere che l’Italia deportasse in qualche punto da stabilirsi
i suoi condannati. Ma nissuno vorrebbe far una cessione che includesse rinuncia ai
proprii diritti di sovranità e per conseguenza l’Italia dovrebbe assoggettare i suoi
condannati alla giurisdizione locale, né potrebbe liberamente fare per il buon andamento
delle colonie penitenziarie, per la custodia dei deportati, per la coltivazione delle
terre quei provvedimenti che le paressero più acconci. Il Portogallo sarebbesi persino
mostrato disponibile ad incaricarsi esso stesso della custodia dei deportati, ma con
patto dipendessero dalle sue autorità. Quindi nascerebbe l’ardua quistione se il Governo
Italiano possa affidare ad autorità straniere l’esecuzione delle sentenze dei suoi
tribunali e la persona dei suoi condannati.
L’Italia voleva dunque ottenere una cessione di sovranità e non una semplice concessione.
Cerruti spiegava la pretesa non in forza del fatto che il governo volesse sfruttare
tale primo possedimento oltremare come base per un’espansione coloniale, ma con argomentazioni
contenute all’interno del perimetro dei problemi della pena: sarebbe stato assurdo
agire nella «concessione» rispettando le leggi di un altro paese, e altrettanto impossibile
assoggettare i deportati a una giurisdizione straniera. Ancor più assurdo sarebbe
stato accettare che fosse il Portogallo ad occuparsi in toto dell’esecuzione della pena... quale legge italiana avrebbe mai potuto permettere
una cosa del genere? Si trattava di argomentazioni ragionevoli. Per ovviare al problema
– raccontava Cerruti – si stava considerando la proposta di acquistare un’isola nella
Malesia, nelle parti settentrionali dell’isola di Sumatra, contrattando direttamente
col sovrano indigeno locale. Si erano chieste intanto informazioni sul luogo al governo
olandese, ma queste erano troppo vaghe, per cui si stava per dare mandato al comandante
della nave militare «Magenta» perché al ritorno dalla missione in Giappone e in Cina
visitasse Sumatra e lì si procurasse tutte le informazioni necessarie. Intanto il
soggetto proponente era stato incaricato di raccogliere «dati sovra altri punti che
si potessero prestare allo stabilimento di colonie penitenziarie». Nonostante le notevoli
difficoltà che il progetto di deportazione comportava, l’opinione dell’alto funzionario
degli Esteri era favorevole, «specialmente per recare efficace rimedio al brigantaggio
senza compromettere la pubblica sicurezza con grosse agglomerazioni di forzati».
Per quanto riguarda, infine, le considerazioni sui climi più adatti alla deportazione,
Cerruti confermava al deputato quanto detto a voce. Era sua opinione che le località
caratterizzate da climi troppo caldi non convenivano alla moralità dei condannati
e ad un serio esperimento di colonizzazione. «Il clima caldo eccita i sensi e snerva
la tempra – argomentava l’alto funzionario – e gli europei ne risultano molto più
danneggiati che gli indigeni». La conseguenza di ciò era l’impossibilità di far lavorare
i deportati, e «la quasi inevitabile necessità dell’ozio» sarebbe stata «il maggior
fomite di ogni pervertimento». In più, anche la forza pubblica e gli agenti di custodia
difficilmente avrebbero potuto resistere alle malattie, rendendo il lavoro di custodia
quasi impossibile. Cerruti suggeriva quindi di trovare una località in cui il clima
fosse temperato o anche freddo, dove il lavoro non fosse gravoso e riuscisse «indispensabile
per procacciarsi il vitto e per difendersi dalla rigidezza della cattiva stagione».
Ad ogni modo, non essendo facile procurarsi un territorio del genere, vista l’urgenza
della situazione, sarebbe stato meglio averla una colonia penitenziaria, seppure in
luogo molto caldo «in regioni meridionali».
Insomma, dalla conversazione e dallo scambio epistolario con Marcello Cerruti, Bellazzi
veniva a sapere di iniziative messe in campo praticamente appena all’indomani dell’Unità
per ottenere una località ultramarina da destinare a colonia penale.
Due elementi sembrano emergere. Anzitutto, questi tentativi non furono vere e proprie
trattative ma piuttosto approcci non formalizzati e anzi tenuti nel massimo segreto,
e ciò forse spiega l’assenza di documenti diplomatici che ne riferiscano. Ciò porterebbe
a credere che questi «scambi di idee», non formalizzati e non dotati di direttive
precise, avvenissero a livelli molto alti e forse attraverso conversazioni, come lascia
intendere la sottolineatura di Gorrini che furono le nozze portoghesi di Maria Pia
di Savoia ad aprire la possibilità di un’intesa. Colpisce poi che Cerruti, a distanza
di cinque anni dai tentativi col Portogallo, chiedesse a Bellazzi di non far parola
in pubblico di questi fatti. Questo probabilmente significa che i tentativi degli
Esteri erano ancora in corso. Ovviamente, significa pure che il governo del neonato
Regno d’Italia non aveva alcuna intenzione di subire un pubblico smacco a causa dei
reiterati dinieghi di questa o quella potenza.
In secondo luogo, è molto rilevante che, pur a livello ufficioso, gli Esteri in pochi
anni si fossero rivolti a numerose potenze. Questo notevole attivismo sembrerebbe
motivato dalla percezione dello scoppio di una vera emergenza, collegata alla guerra
che nel Mezzogiorno continentale si stava in effetti combattendo. Stando allo scambio
tra Bellazzi e Cerruti, al centro di quest’affannosa ricerca di una meta per la deportazione
sembrerebbe esserci la sola questione penitenziaria e la questione della repressione
del brigantaggio: in particolare, nelle parole dell’alto funzionario non vi erano
cenni all’intenzione di sfruttare la colonizzazione penitenziaria per l’avvio di una
politica di espansione coloniale. Certo, bisogna tener conto del contesto della risposta
di Cerruti: le sue parole erano in effetti dirette a un deputato che si stava occupando
della questione penitenziaria e dunque a quella egli si riferiva. Non si può, pertanto,
escludere che le iniziative descritte, di cui con tutta probabilità era uno dei protagonisti,
non fossero animate anche da un fine «coloniale», del quale non sentiva il bisogno
di parlare a Bellazzi. Però, al centro di tutto sembra esserci la guerra che si stava
combattendo al Sud contro i briganti, la quale aveva riempito i vari istituti di pena
su suolo italiano di un numero eccessivo di criminali. Alla data del 1871, ben il
59% di tutti i detenuti nei vari istituti di pena provenivano dal Mezzogiorno, isole
comprese. Alcuni iniziarono a interpretare questo disequilibrio regionale nell’ottica dello
stereotipo di un Sud arretrato e incline al crimine violento, mentre iniziative politiche
erano prese per allontanare fisicamente i soggetti più violenti o più pericolosi per
lo Stato. L’emergenza brigantaggio era anche un’emergenza penitenziaria. Gorrini,
venuto in possesso dei documenti su riportati, scrisse negli appunti preparatori al
suo saggio sulle colonie penali:
Costituitosi il regno italico parte l’idea di stabilire una colonia penitenziaria
e ciò per purgare le prigioni, principalmente nelle province meridionali, d’una quantità
strabocchevole di camorristi, briganti ed altra gente pericolosissima per tranquillità
e pace pubblica.
Espressioni colorite, destinate ad essere in parte emendate nella pagina pubblicata, ma che probabilmente coglievano lo spirito di quelle iniziative.
Quanto a Bellazzi, al fine della sua investigazione sul tema della deportazione, la
sua opinione fu contraria all’introduzione della pena, come ebbe modo di scrivere
in una lettera del luglio 1866, rivolta al ministro dell’Agricoltura e del Commercio
Filippo Cordova:
Incaricato dai miei colleghi della Commissione dell’altro studio della convenienza
e della possibilità di adottare in Italia il sistema della deportazione quale in Inghilterra
è per essere abolita, dopo funestissime esperienze, e quale in Francia è in vigore
da pochi anni con incerto esperimento – [...] mi dichiaro assolutamente contrario
alla pena della deportazione in alcuna isola perduta dell’Oceano.
Nella sua pubblicazione sulla questione carceraria, Bellazzi rimase fedele alla riservatezza
richiestagli da Cerruti e spiegò, senza entrare in dettagli, che l’ipotesi di introdurre
la deportazione era «ineseguibile dal momento che né le isole Nicobare, né alcun’altra
l’Italia possiede nell’Oceano, né pratiche furono fatte dal Ministero degli Esteri
per procurarne, o andarono fallite». Proponeva piuttosto di destinare a penitenziario alcune isole italiane come Lampedusa,
come già nei progetti del regno borbonico, o di adoperarsi per l’istituzione di colonie
penali agricole. Ad ogni modo, al di là delle questioni pratiche, il suo giudizio
generale sulla deportazione era decisamente negativo; e comunque, non possedendo l’Italia
alcuna colonia, non si poteva che abbandonare questa prospettiva, «lieti di non aver
neppure la possibilità di fare quel triste esperimento».
6. La stampa e il modello panacea
La Gazzetta piemontese, che nel 1894 avrebbe preso il nome La Stampa, pose la questione della deportazione fin dal suo primo anno di vita, il 1867. In
forza del pensiero di Romagnosi, secondo il quale il governo doveva essere «una grande
tutela ed una grande educazione», il giornale si schierava dalla parte della deportazione,
«che soccorre piuttosto che punire i delinquenti, e li mette in grado di provvedere
ai propri bisogni con mezzi onesti». Altra questione centrale era quella delle eccessive spese del bilancio per la sicurezza
interna. Nel 1867 il bilancio per il «servizio segreto della pubblica sicurezza» passò
da 800.000 lire a 1,2 milioni, «per essersi riconosciuta insufficiente a mantenere
quella estesa ed accurata sorveglianza che il servizio di pubblica sicurezza esige».
Era una somma stanziata senza un reale controllo al Ministero dell’Interno, del cui
uso non si sapeva nel dettaglio, ma che verosimilmente era diretta al mantenimento
della sicurezza nelle irrequiete campagne meridionali. La deportazione avrebbe ridato
«sicurezza vera alle campagne», avrebbe aiutato «potentemente a spegnere il brigantaggio
e il malandrinaggio», e intanto avrebbe preparato «una fiorente colonia nel mare indiano»
che sarebbe servita da scuola permanente alla Marina. Tale colonia avrebbe portato
considerevoli risparmi e avrebbe contribuito «assai meglio che non le carceri al vero
miglioramento morale dei condannati». La pena avrebbe dovuto applicarsi soprattutto
ai recidivi per reati contro la proprietà:
non inutile pompa di pene e di castighi noi vogliamo, sibbene crediamo indispensabile
alla floridezza del civile consorzio quella tranquillità e quella sicurezza che l’esperienza
ci dimostrò che non si possono ottenere coi costosissimi e rovinosi mezzi attuali.
Un successivo articolo ritornava sul tema, sostenendo l’utilità della deportazione
per alleggerire il bilancio. Il 28 agosto 1867, la Gazzetta piemontese dedicò finalmente l’intero articolo di apertura della prima pagina al tema della deportazione.
L’istituto era presentato come bandiera del progressismo, al pari dell’istruzione
obbligatoria, precipitato dei doveri di uno Stato educatore. «Difendere la società migliorando gli uomini, ecco a che tender debbe il Governo» e tra gli uomini da migliorare vi erano in primo
luogo coloro che avevano commesso reati. Se tale «civile principio» avesse ispirato
la legislazione dei popoli, non sarebbe stato necessario ancora nel XIX secolo parlare
di deportazione. Il discorso progressista, che inquadrava l’istituto come mezzo efficace per difendere
la società «senza calpestare la persona umana», si mescolava con il solito insistere
sulle necessarie economie di bilancio. In verità la deportazione era descritta come
una vera panacea, la soluzione di molti mali, certamente di quelli che più inquietavano
le élites del paese: i problemi del bilancio, il numero dei delitti e dunque la pubblica
sicurezza, l’inadeguatezza delle case di pena; rispondendo al contempo alla necessità
di una riforma penale illuminata ispirata al principio della riabilitazione del reo
e della fondazione di una colonia.
L’articolo si soffermava dunque anche sull’aspetto penalistico. Per il giornale piemontese
il sistema penale italiano era ancora influenzato dal principio della esemplarità
della pena, mentre doveva preoccuparsi che la pena fosse «riformatrice»: «non merita
la stima pubblica se non quella pena che lo migliora e lo restituisce alla società
capace di tornarle tanto benefico quanto prima le ero nocivo».
D’altra parte, la società aveva parte delle colpe che imputava agli «infelici che
gemono in fondo alle carceri», spesso vittime dell’ingiustizia sociale più che rei.
La storia aveva mostrato esempi di violenze prodotte da ingiustizie sociali, come
nel caso degli irlandesi «malandrini» vittime della terribile carestia indotta dall’oppressione
del governo inglese; e così ogni crisi economica e ogni rivoluzione, «imputabili spesso
agli errori dei governi», trascinavano nella miseria e nel delitto «una moltitudine
di sventurati». La campagna di stampa iniziata dalla Gazzetta piemontese avrebbe presto risuonato tra i soggetti interessati all’espansione italiana.
1. Uomini intraprendenti, località esotiche
A partire dalla metà degli anni Sessanta, sulla spinta della pressione carceraria
nata dalla repressione del brigantaggio, da una parte, e di alcuni individui o gruppi
che volevano promuovere l’espansione coloniale, dall’altra, si pose mano a una serie
di progetti per avviare la colonizzazione penitenziaria. Tali progetti arrivarono
a diversi gradi di concretizzazione senza mai essere portati a compimento. Protagonisti
ne furono uomini con storie e carriere diverse e di diverso orientamento, ma che credevano
che la colonizzazione penitenziaria avrebbe lanciato un’Italia più audace in un futuro
di prosperità. Si trattava di uomini politici, avventurieri, militari di carriera
e anche uomini alla scrivania che sognarono l’avventura coloniale in forza di piani
più o meno circostanziati di fondazione di colonie penali. Nei progetti che si esamineranno
in questo capitolo, il discorso sul problema penitenziario si mischia al sogno coloniale
e sembra a tratti cedervi il passo. A partire dal «modello panacea» di cui si è detto,
l’espansione coloniale tramite colonizzazione penitenziaria sembrava poter proiettare
l’Italia verso un ruolo di primo piano nei commerci internazionali e verso l’affermazione
di sé come potenza.
Biagio Caranti era stato da giovane un militante del movimento nazionale. Partito
per la Sicilia nel 1860 con altri volontari, aveva preso parte alla battaglia del
Volturno rivestendo nell’ottobre di quell’anno la carica di ministro degli Esteri
della dittatura garibaldina a Napoli. Era poi caduto in disgrazia agli occhi di Cavour,
che ebbe a definirlo «ragazzaccio» per certi suoi comportamenti spavaldi; era entrato,
infine, nell’amministrazione statale, fino ad ascendere alla nomina a capo della prima
divisione presso il Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio. Intanto aveva
pubblicato vari libri, tra cui un paio di catechismi politici per indottrinare i ceti
popolari all’idea nazionale, e un opuscolo sulla questione romana dal contenuto quantomeno
originale. Non estraneo alle imprese avventurose, Caranti fu incaricato dal ministro Torelli
di indagare la possibilità di iniziare una colonizzazione penitenziaria.
Per capire questo passaggio bisogna spiegare il coinvolgimento del Ministero dell’Agricoltura,
industria e commercio. L’amministrazione delle pene non era monopolio di un Ministero
in particolare. Le pene costituivano ancora un universo frastagliato, di misure molto
diverse tra di loro – come i bagni penali e il carcere, la pena di morte e le colonie
agricole, le galere e i lavori forzati –, un mondo non ancora avviatosi a quella «modernità»
che consistette nella cosiddetta «invenzione del carcere», ossia la nascita di un
sistema punitivo incentrato sul carcere. In questa situazione, della questione penitenziaria si occupava una molteplicità
di istituzioni: in primo luogo il Ministero dell’Interno con la Direzione generale
delle carceri (che solo alla fine del 1922 sarà spostata alla Giustizia); il Ministero della Marina per quanto concerneva l’amministrazione dei bagni penali,
che nel 1866 passarono agli Interni; la Giustizia per quanto riguardava gli studi e i progetti di riforma; oltre alle
varie commissioni parlamentari di cui si è parlato; infine, per il torno di tempo
qui analizzato, furono coinvolti gli Esteri per la prospettiva di contrattare l’acquisto
di una colonia d’oltremare. Si trattava, dunque, di un universo disomogeneo, con una
molteplicità di attori coinvolti.
Il Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio era uno di questi, perché una
delle possibilità punitive era rappresentata dalle colonie penali agricole. In particolare,
il Ministero aprì un fascicolo per studiare ciò che si faceva all’estero a riguardo
delle colonie agricole, in vista dello sviluppo della colonizzazione penitenziaria. In realtà, la penisola non era nuova al tema: era stato il Granducato di Toscana
a impiantare per primo una colonia agricola, a Pianosa nel 1858, per iniziativa di
Carlo Peri, sovrintendente agli stabilimenti di pena.
Nel marzo 1862 fu prodotto un «memorandum di alcune idee sullo stabilimento di una
colonia penitenziaria» in Abissinia. Questo documento è forse il primo in cui il problema
della deportazione non è riguardato da una prospettiva di riformismo penale, ma nell’ottica
dell’espansione nazionale. «L’Italia, fatta unica e grande nazione – scriveva l’intendente
militare Giuseppe De Franco, già in servizio nell’esercito borbonico – essendo per
sua natura eminentemente marittima, deve fra non molto ingrandire la sua Marina militare». Per De Franco il nodo era aumentare il commercio con l’estero, «unica sorgente di
ricchezza». Quanto alla gente che si sarebbe trasferita in colonia, «un cambiamento
di cielo» poteva essere per gente così «la più efficace medicina, lo specifico il
più calmante», specie quando si trattava di un trasferimento volontario, e per questo
bisognava agevolare l’emigrazione. I condannati ai ferri e ai lavori forzati erano
un grave peso per lo Stato, anche perché, «non lavorando per proprio impulso», non
curavano di migliorarsi e, anzi, avviliti e oppressi, rifuggivano ogni idea di «miglioramento
morale». De Franco produsse un’interessante descrizione dei bagni penali, concludendo
che la pena che lì si scontava era del tutto inutile perché non in grado di formare
«un cittadino emendato», e qui entrava in gioco la deportazione. L’Italia doveva accoppiare alla deportazione
una emigrazione libera di operai, in modo da favorire il commercio. Era una strategia
diversa da quella intentata solo pochi anni prima dal Regno delle Due Sicilie, che
aveva stipulato un accordo per la deportazione con l’Argentina: lo scopo di quel progetto
era stato solo quello di «sbarazzarsi di gente che gli recava fastidio colle sue aspirazioni
liberali», mentre il progetto italiano era pensato a «servir di base per l’ingrandimento
del commercio». Era una bella differenza, che doveva rimarcare la distanza morale
dell’appena cessato regno borbonico.
A questo punto, il problema era stabilire dove creare una colonia di deportati. L’imminente
apertura del canale di Suez suggeriva di seguire la rotta del Mar Rosso, per cui «una
Colonia Italiana» – si notino le maiuscole dei grandi progetti – lì sarebbe stata
una scelta felice. L’Abissinia era la zona ideale: il cristianesimo garantiva dal
fanatismo islamico diffuso in altre zone del Mar Rosso; i suoi diversi climi, un suolo
fertilissimo e la posizione geografica che la proiettava «all’interno dell’Africa»
la rendevano la meta migliore. Le referenze di De Franco erano l’Atlante geograficouniversale di Francesco Marmocchi e alcuni resoconti di viaggi in Egitto e Sudan del patriota
e militare Emilio Dandolo, scomparso tre anni prima. Si indicava una possibile meta: Massaua (Messoah nel testo), «per ora la più importante
per la sua posizione nel Mar Rosso». Il problema era come agire: non bisognava mostrare
fin dall’inizio l’intento di stabilirvi una colonia penitenziaria, per non «paralizzarne
il compimento» insospettendo altre potenze. Bastava installare basi commerciali, nascondendo
con «somma cura» il piano. Infine, si suggeriva la creazione di «una Commissione di
scelte capacità» che potesse preparare un progetto di legge da discutersi in Parlamento