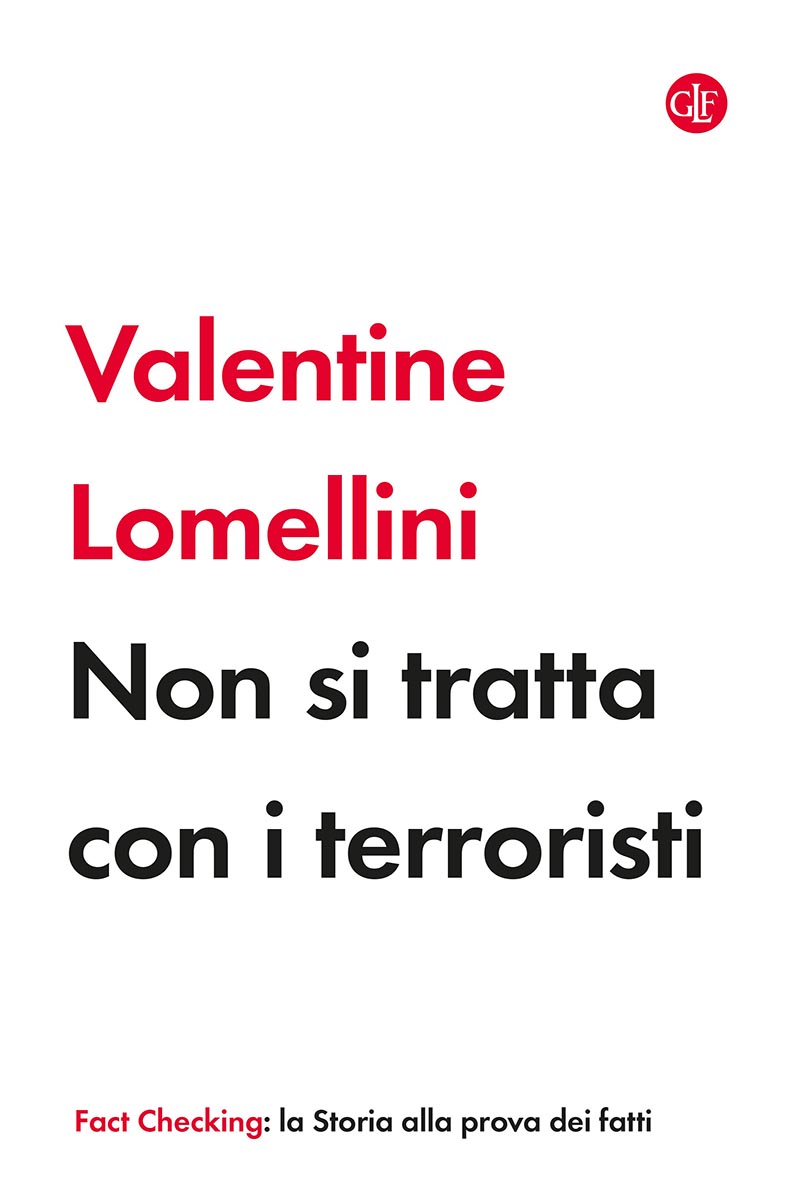Caro Lettore, ti scrivo.
Se hai preso in mano questo libro e conti di trovare una risposta definitiva all’annoso
quesito “è giusto negoziare con i terroristi?”, temo che resterai deluso.
Mi dispiace. Forse finirai la lettura di queste pagine con più dubbi e più domande.
Ma forse sarai anche un po’ più informato e consapevole – o almeno così spero.
Quando scrivo queste pagine, le immagini degli attentati terroristici si susseguono
sugli schermi. In particolare, i fotogrammi di uno dei più recenti – quello del 7
ottobre 2023, contro Israele. Non sappiamo con esattezza quanti sono ancora i sequestrati
nelle mani di Hamas. Ostaggi ancora vivi o corpi esanimi in ostaggio. Sappiamo invece
che sono circa 38.000 le vittime dell’attacco militare di Israele contro i territori
della Striscia di Gaza; non conosciamo, invece, quante saranno alla fine del conflitto,
perché quella fine ancora non si intravede.
Tu, da che parte stai? Sei solidale con gli ostaggi israeliani, la cui sorte è sconosciuta? Partecipi ai
cortei filopalestinesi e chiedi la creazione di uno Stato palestinese che vada “dal
fiume al mare”? Non ti interessa per niente la questione, perché tanto è lontana nello
spazio e produce morte e devastazione da prima che tu nascessi?
È davvero necessario decidere da che parte stare, se non – semplicemente – contro
ogni genere di violenza?
E se ci fossi tu, tra quegli ostaggi? E se tuo fratello o tua sorella fossero stati
trucidati in una strage? E se fossi una vittima, viva ma irreversibilmente segnata
da una ferita fisica o da un lutto irrisolto e irrisolvibile?
Tu, proprio tu, vorresti che qualcuno negoziasse per liberarti?
O saresti disponibile ad accettare che lo Stato negozi la pace, trattando con i responsabili
della morte di un tuo caro?
Il terrorismo è un fenomeno senza tempo e senza fine. La negoziazione è stata così
a lungo un tabù da impedire un’approfondita riflessione intorno alla razionale possibilità
di svilupparla e al modo migliore per farlo.
Pensiamoci. Parliamone. Cercando di lasciare fuori posizioni “senza se e senza ma”.
Contestualizziamo, problematizziamo e utilizziamo la Storia per lo strumento prezioso
qual è. Un navigatore vecchio tipo da usare in un divenire sconosciuto, che ci offre
qualche coordinata portandoci, auspicabilmente, a destinazione.
Questo libro è il frutto di un percorso di ricerca e di insegnamento degli ultimi
cinque anni: alcune riflessioni sono nate e sono state condivise con gli studenti
del corso Terrorism and Security in International Historyche insegno presso l’Università di Padova. Un sincero ringraziamento a Giuseppe Laterza
e Giovanni Carletti per avermi dato la possibilità di scrivere questo volume, che
ambisce ad affrontare fatti tanto attuali con un respiro storico. Sono grata a Carlo
Greppi per aver accettato di ospitare le mie riflessioni per i tipi della serie “Fact
Checking”, e per avermi accolto con tanto calore nello straordinario gruppo di studiosi
della collana. Benedetta Tobagi, Ilaria Moroni, Mario Calabresi, Rogelio Alonso, Tim
Wilson, Bernhard Blumenau, Matteo Re, Guido Panvini, Alba Lazzaretto e Chiara Zampieri
mi hanno offerto, in occasioni diverse, i loro preziosi punti di vista, contribuendo
– direttamente o indirettamente – alla stesura di queste pagine e alla mia crescita
personale e professionale. Il ringraziamento più affettuoso va ai miei figli, Federico
Dimitri e Noemi, che hanno atteso con inaspettata pazienza che finissi di scrivere
questo volume per poter adempiere alla promessa che ci siamo fatti.
ACS: Archivio Centrale di Stato.
ADEF: Archives Diplomatiques des Affaires Étrangères.
AGA: Archivio Giulio Andreotti.
ASILS: Archivio Storico Istituto Luigi Sturzo.
ASPR: Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.
CDAF: Centro documentazione Archivio Flamigni.
DAR: Divisione Affari Riservati, Fondo Silvano Russomanno, detto anche Fondo della
Circonvallazione Appia (FCA).
FOIA: Freedom of Information Act.
MAE: Ministero degli Affari Esteri.
UKNA: United Kingdom National Archives.
1.
Il terrorismo. Quando la minaccia non passa mai
1. L’impossibile definizione di terrorismo
Se avete letto la premessa, ora sapete perché ho deciso di scrivere questo libro e
probabilmente intuirete per quale ragione è necessario riflettere in primo luogo sulla
definizione di terrorismo.
Nell’opinione pubblica, il terrorista è un cattivo; il combattente, il membro della
Resistenza è, invece, un buono. Peccato che non tutti concordino sulla scelta dell’appellativo.
David Rapoport sottolinea provocatoriamente che il numero di persone che, nel passato,
sono state qualificate come terroristi e che hanno ottenuto il premio Nobel per la
pace (Menachem Begin, Anwar Sadat, Nelson Mandela e Yasser Arafat) è superiore al
numero di presidenti americani che hanno conseguito questo importante riconoscimento
mondiale.
Cosa accade se la medesima persona è considerata da alcuni un terrorista e da altri
un combattente per la libertà?
Le difficoltà emergono su diversi piani, per cui vi è necessità di una definizione
il più possibile condivisa. Innanzitutto, è necessaria per stilare una legislazione
coerente, prevenire, ostacolare la crescita del fenomeno e valutare delle pene specifiche;
per sviluppare una cooperazione internazionale che consenta il contenimento globale
del fenomeno; per impedire che l’utilizzo di questa particolare tipologia di violenza
venga vista con favore da parte della popolazione. Inoltre, distinguere tale forma
di violenza da altre tipologie può contribuire alla delegittimazione delle stesse
organizzazioni terroristiche.
Il terrorismo può essere considerato, al pari della guerra, come la continuazione
della politica attraverso altri mezzi, ma anche l’attribuzione dell’etichetta “terrorista” può entrare a far parte di una
guerra di natura psicologica. L’utilizzo del termine “terrorismo” può produrre effetti
negativi inconsapevoli e consapevoli, nel caso in cui venga strumentalizzato a fini
politici. Pensiamo, ad esempio, all’uso del termine “terrorista” che oggi se ne fa
nell’ambito del conflitto ucraino-russo. Nel marzo 2024, in seguito all’attacco contro
il teatro Crocus City Hall di Mosca che ha provocato circa 140 vittime, Putin sostiene
apertamente che i terroristi sono stati finanziati e manovrati dall’Ucraina. D’altro canto, nell’estate 2022, è Zelensky a sostenere che la “Russia è uno Stato
terrorista e deve essere riconosciuto come tale”.
Ça va sans dire che tale termine è ampiamente utilizzato nel contesto dello scontro israelo-palestinese:
qui gli esempi sono innumerevoli e implicano sanzioni politiche ed economiche da ambo
le parti. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l’Unione Europea ha ritenuto
di dover sanzionare chi sostiene, facilita o rende possibili azioni violente da parte
di Hamas e della Jihad islamica palestinese, individuando, nello specifico, sei individui
che si sarebbero resi responsabili di tali atti. Ma anche l’attacco di Israele sul territorio di Gaza è stato considerato come un
atto di “terrorismo di Stato”: è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdoan a definire Israele come “uno Stato terrorista che commette crimini di guerra e
viola il diritto internazionale a Gaza”, mentre il Sudafrica ha accusato il governo
di Benjamin Netanyahu di “atti genocidi” di fronte alla Corte penale internazionale.
Nel senso comune così come nell’arena politica, l’etichetta di “terrorista” è utilizzata
per disapprovare, biasimare, financo delegittimare un attore politico: il suo ampio
utilizzo dimostra che è usata per definire una varietà molto ampia di fenomeni che
non sono, scientificamente e necessariamente, rispondenti alla stessa tipologia. Gli
addetti ai lavori sostengono dunque che il termine “terrorismo” sconti due limiti:
quello del condizionamento dato dal punto di osservazione di chi utilizza tale parola,
e quello relativo alla iper-estensione del concetto (stretching and traveling problems). In altri termini, quali sono le caratteristiche che possono definire il concetto
di terrorismo e che lo distinguono dalle altre forme di violenza (e, in particolare,
di violenza politica)?
Il terrorismo è spesso identificato sulla base della distanza fisica e/o sociale che
esiste tra l’atto in questione e il suo osservatore. Vale a dire che, per quanto sia
onesta la mia buonafede, sarò naturalmente più incline a definire come terrorista
un atto/organizzazione che sento lontani nel tempo e nello spazio, di cui non condivido
gli scopi (o non li conosco). Viceversa, apprendendo e magari sposando, in linea di
massima, gli obiettivi di una organizzazione (ad esempio, liberare un Paese dal giogo
nemico), l’osservatore è naturalmente più incline a non attribuire l’etichetta di
“terrorista” a tale movimento, quanto piuttosto a optare per una definizione che contenga
una gemma di positività – come ad esempio, freedom fighter, combattente per la libertà, resistente.
Vi è poi il problema della iper-estensione del termine. Comunemente, siamo orientati
a pensare al terrorismo come a un fenomeno che comporta delle vittime (morti e/o feriti).
In tempi relativamente recenti, si è tuttavia affermata una nuova forma di terrorismo:
il cyberterrorismo. Ebbene, questo non miete vittime – o, almeno, non implica il decesso
o il ferimento fisico di esseri umani. Non necessariamente implica l’uso della violenza
o della minaccia della violenza corporale. Eppure, il cyberterrorismo è ritenuto –
appunto – una forma di violenza politica ed è una delle più gravi minacce alla sicurezza
che la nostra società si trova ad affrontare, con ricadute potenzialmente gravi per
l’intera società, talvolta anche di natura fisica (se un hacker blocca il Sistema sanitario nazionale e non mi è possibile usufruire di una cura
per questo, l’effetto indiretto è il mio disagio o addirittura un danno alla mia persona).
Il terrorismo viene utilizzato principalmente in tre diversi contesti, in cui l’uno
non esclude l’altro: la repressione illegale per mano dello Stato; l’agitazione propagandistica
da parte di attori non statuali in tempo di pace o al di fuori dalle zone di conflitto;
le tecniche di combattimento irregolare (irregular warfare), sviluppate da entrambe le tipologie di attori menzionati (Stati e movimenti).
Il terrorismo può assumere molte forme, a seconda del contesto e dell’obiettivo finale
perseguito. La prima categoria che sovviene è quella di un singolo atto di violenza
letale, come ad esempio l’esplosione di una bomba o un assalto armato. Come ci ha
ricordato la cronaca del quadrante mediorientale degli ultimi mesi, il terrorismo
consiste anche di attentati che comportano il pericolo di vita sviluppati in due fasi
(è il caso della presa di ostaggi, dei dirottamenti – eventi nel corso dei quali si
sviluppa abitualmente un processo di negoziazione). Ma non solo. La violenza fisica
si concretizza anche tramite una sequenza di azioni come le sparizioni ripetute (evidente
il riferimento al caso dei desaparecidos in America Latina, ma anche alle purghe anti-staliniane degli anni Trenta), la detenzione
segreta, la tortura e l’assassinio mirato.
In tutti i casi, difficilmente ci si trova dinnanzi a un atto isolato. Comunemente,
la società si trova ad affrontare un ciclo di atti violenti: una campagna terroristica.
Se state perdendo la pazienza e desiderate arrivare a una definizione compiuta, sappiate
che essa non trova concordi nemmeno gli esperti. L’Handbook of Terrorism Research, curato da Alex Schmid, dedica ben 11 pagine alle definizioni del terrorismo, contandone
260 (e il volume è di tredici anni fa).
Tuttavia, volendo fare il punto, quali sono le principali caratteristiche che gli
addetti ai lavori attribuiscono a questo fenomeno?
Nel 1985, il già citato Schmid tenta di identificare quali sono gli elementi più ricorrenti
nelle definizioni accademiche di terrorismo. Raccoglie 109 definizioni ufficiali,
elaborate da studiosi, al fine di analizzare le loro principali componenti. L’elemento
più importante è quello della violenza, menzionata nell’83,5% delle definizioni. Segue
l’idea che il terrorismo abbia scopi di natura politica (citata nel 65% dei casi).
Metà delle definizioni analizzate (51%) sostiene l’idea che il terrorismo sia un fenomeno
che infligge paura e terrore. Piuttosto singolare, ma coerente con l’epoca dello studio
ivi riportato, la bassa percentuale associata all’arbitrarietà e all’indiscriminazione
nella scelta dei target (21%) e al coinvolgimento di civili e non combattenti. Trascorrono quasi trent’anni
e, nel 2004, Weinberg, Pedahzur e Hirsch-Hoefler sviluppano una nuova ricerca nel solco di quella di Schmid. Questa volta gli studiosi
analizzano 73 definizioni di terrorismo pubblicate sulle principali riviste scientifiche
in lingua inglese nell’ambito dei Terrorism Studies (“Terrorism”; “Terrorism and Political Violence” e “Studies in Conflict and Terrorism”).
Nuovamente, è l’uso del termine “violenza” associato all’idea che il terrorismo sia
una “tattica politicamente motivata” ad attestarsi in cima alla lista delle definizioni.
Vi sono, tuttavia, alcuni elementi innovativi che vanno considerati. La ricerca di
visibilità e l’utilizzo dei media a scopi propagandistici sono considerati tra i principali
tratti distintivi del terrorismo. Contestualmente, non viene più valorizzata la distinzione
tra vittime civili e non. Emerge qui una differenziazione tra gli studiosi sulla base
della loro provenienza geografica. Gli esperti dell’Europa occidentale e del Nord
America utilizzano come elemento discriminante quello delle vittime civili. Tra gli
studiosi dell’area mediorientale, invece, la caratteristica dirimente pare essere
quella di un fenomeno che instilla “paura”.
Che cosa possiamo trarre da questi studi? Non solo che anche le definizioni sono influenzate
dagli elementi sotto indagine (quali riviste considerate? quali studiosi coinvolti?),
ma anche e soprattutto che esse sono condizionate dall’evoluzione dei movimenti terroristici.
Lo studio di Schmid, condotto e pubblicato alla metà degli anni Ottanta, tiene in
considerazione l’ondata di terrorismo politico sviluppatasi a partire dalla fine degli
anni Sessanta in vari Paesi europei, così come in quelli dell’America Latina. È il
periodo in cui compare (anche) un terrorismo che individua target selettivi: il caso delle Brigate Rosse è, in questo senso, rappresentativo. Nel portare
l’attacco al cuore dello Stato, le BR colpiscono in modo mirato rappresentanti delle
istituzioni, dei media, dei partiti politici che simboleggiano – ai loro occhi – l’odiato
“Stato imperialista delle multinazionali”. Dall’inizio degli anni Ottanta, ma con maggior vigore e visibilità in Occidente
dai primi anni del decennio successivo, si afferma il terrorismo religioso (accanto
a quello – a lungo attivo – nazionalista). Tale tipologia è orientata a causare stragi
di massa e conferisce una particolare attenzione (non inedita ma senza precedenti
per grado di importanza) agli aspetti della comunicazione. Questa è una delle ragioni
per le quali, nell’analisi di Weinberg, Pedahzur e Hirsch-Hoefler, assumono una dimensione
rilevante l’aspetto del rapporto con i media e l’elemento della paura – uno dei principali
tratti dell’organizzazione terroristica (instillare paura nella popolazione) e della
sua ricaduta nella società (produrre comportamenti sociali dettati dalla paura).
Come possiamo, dunque, definire il terrorismo? Intanto possiamo circoscrivere il campo
e dire cosa non è: non è una forma di criminalità comune. Esso va dunque distinto da altre tipologie
di crimine organizzato e di guerra non tradizionale, come ad esempio la rivolta o
la rivoluzione che hanno proprie caratteristiche specifiche. Le organizzazioni criminali possono utilizzare il terrorismo ma non vi è una totale sovrapposizione tra i due fenomeni;
così come atti di terrorismo possono essere espletati durante una guerra, senza che
vi sia identificazione tra questi due tipi di conflittualità.
Tentando di delineare le caratteristiche principali del terrorismo (operazione senza
la quale chi scrive potrebbe poggiare la penna in questo momento) al fine di avere
una definizione operativa, propongo qui una definizione basata sulle elaborazioni
concettuali del sopracitato Schmid, tra i fondatori dei Terrorism Studies, e di Bruce Hoffman, uno dei più eminenti studiosi del fenomeno, docente alla Georgetown
University e autore di un seminale volume sull’argomento, Inside Terrorism.
Possiamo dunque definire il terrorismo come un fenomeno intrinsecamente politico negli
obiettivi e nelle ragioni. Tutti gli atti terroristici comportano l’uso o la minaccia
della violenza. L’intento è di ottenere ripercussioni psicologiche di vasta portata
al di là delle singole vittime e/o dell’immediato bersaglio individuato. Le vittime
dirette, generalmente civili, non costituiscono l’obiettivo ultimo dell’azione ma
servono come “generatore di messaggi” che raggiungono un’audience più vasta.
Lo scopo del terrorismo è quello di incutere paura e quindi intimidire un target più ampio di quello direttamente e, abitualmente, colpito da un attentato: esso può
includere un gruppo rivale (etnico o religioso), un governo o un partito politico
nazionale, l’opinione pubblica in termini generali o, addirittura, un intero Paese.
Il terrorismo si fonda, infatti, su un processo di comunicazione basato sulla minaccia
(threat-based communication process) che ha, tendenzialmente, due interlocutori. Il primo è il target finale, ossia individui, gruppi, governi, società o parti di essa che i terroristi
hanno intenzione di influenzare con le proprie azioni. Il secondo sono invece alcuni
possibili sostenitori (constituencies): con i propri atti eclatanti, i terroristi cercano dunque di acquisire un supporto
da parte di alcuni gruppi (determinati su base etnica, religiosa, politica) che trovano
condivisibili i loro obiettivi e, anche se non è una condizione che si presenta costantemente,
anche gli strumenti per raggiungerli. Negli ultimi 15-20 anni, l’ultima generazione di studiosi del fenomeno, a cui sento
di appartenere, propone di utilizzare il termine in un’accezione che sia a-morale,
ossia che prescinda dalle valutazioni etiche che, nel tempo, ne hanno condizionato
l’uso. L’attenzione si sposta dunque dalla actorship ai mezzi utilizzati. Vale a dire: un’organizzazione non è, per definizione, terroristica;
essa può compiere, nel proprio ciclo di attività, atti terroristici (per poi abbandonarli,
ad esempio, in una fase successiva che in genere comporta l’accreditamento come forza
politica).
Veniamo ora alle altre peculiarità.
Chi perpetra atti di terrorismo? Rispetto a questo elemento, il fenomeno ha conosciuto un’ampia evoluzione. Comunemente,
siamo orientati a pensare ai terroristi come a individui legati a un gruppo subnazionale
o a un’entità non statale, a un’organizzazione – in sostanza – che abbia una catena
di comando identificabile e/o una struttura di “cellule”. I fatti più recenti, tuttavia,
ci hanno insegnato che il terrorismo può essere compiuto anche da individui o da piccoli
gruppi direttamente influenzati ma non direttamente correlati a questi ultimi, o ispirati
dagli obiettivi ideologici o, ancora, dall’esempio di un movimento terroristico esistente
e/o dei suoi leader. In verità questo aspetto, che a molti ricorderà il fenomeno contemporaneo
dei “lupi solitari” (lone wolves), trova un precedente storico di grande spessore durante il periodo di sviluppo del
terrorismo anarchico, tra Otto e Novecento (ne parleremo più approfonditamente tra
poche pagine). Individui, raggruppamenti e organizzazioni, dunque. Ma non solo: ad
essi va aggiunta la categoria degli Stati. Alcuni governi utilizzano il terrorismo
per controllare e reprimere l’insieme dei propri cittadini o alcuni segmenti sociali
(il caso del nazismo o del comunismo sono senz’altro i due esempi più evidenti, nel
corso del Novecento); oppure possono adoperarlo come arma non convenzionale di politica
estera. Come vedremo a breve, alcuni governi si sono infatti serviti del terrorismo
per influenzare gli orientamenti dei membri della comunità internazionale, al fine
ultimo di ridisegnare l’assetto delle relazioni internazionali sul piano regionale
e/o globale.
Quali effetti produce? Il terrorismo è un processo dinamico, i cui effetti sono diffusi e modificati nel
corso del tempo. Il terrorismo può avere effetti dirompenti sulla vita di una società
e anche di uno Stato: può trasformare le caratteristiche fondamentali di questi ultimi
mediante cambiamenti rivoluzionari, oppure può produrre mutazioni minori nel breve
periodo, che, tuttavia, possono alterare il carattere dello Stato, nel lungo periodo.
In ogni caso, come ha sottolineato la “madre” dei Terrorism Studies, Martha Crenshaw – negli anni Settanta autrice, nemmeno trentenne, di uno degli articoli
che ha aperto questo filone di ricerca e oggi professoressa emerita della Stanford
University –, il terrorismo ha un effetto sulla distribuzione generale del potere
politico. Esso condiziona infatti gli orientamenti governativi, sia nell’ambito della politica
estera (decidendo, ad esempio, se intervenire o ritirarsi da uno scenario geopolitico
– come è avvenuto per Enduring Freedom, l’operazione militare statunitense, con l’appoggio delle truppe britanniche, condotta
in Afghanistan per eliminare la base di Al Qaeda, in risposta agli attacchi del 2001),
sia nell’ambito della politica interna (stabilendo, ad esempio, di limitare le libertà
dei propri cittadini, o favorire lo smantellamento delle organizzazioni terroristiche
utilizzando il pentitismo – così come è stato in Italia sin dagli anni Settanta).
Ma il terrorismo non produce effetti solo nelle sale del potere. Condiziona intrinsecamente
la vita dei cittadini, del Paese colpito o dei suoi alleati. Pensiamo, ad esempio,
a quanto accade dopo l’11 settembre 2001, quando quattro aerei entrano nello spazio
aereo statunitense, colpendo le Torri gemelle e il Pentagono (il quarto cade in Pennsylvania,
ma solo grazie all’azione di contrasto dei passeggeri nei confronti dei terroristi).
L’effetto degli attentati va ben oltre le quasi tremila vittime causate da Al Qaeda.
Chi ha qualche anno alle spalle ricorda il crollo dei prezzi dei voli, la paura di
prendere l’aereo, l’aumento dei controlli agli aeroporti con strumenti di vario tipo,
sino a giungere all’utilizzo del body scanner (introdotto in Italia per la prima volta nel 2010).
Infine, un attentato terroristico può avere effetti anche sugli esiti elettorali (o
può tentare di condizionarli, come nel caso dell’attentato contro la stazione madrilena
di Atocha e le elezioni spagnole del 2004). E può influenzare la percezione dell’“altro”. Pensiamo, ad esempio, alle manifestazioni di islamofobia che hanno colpito le società
occidentali, quella statunitense su tutte, dopo gli eventi delle Torri gemelle del
2001.
Da ultimo, ma non certo per importanza, lo sviluppo del terrorismo condiziona la stessa
evoluzione delle organizzazioni terroristiche. Avremmo conosciuto il fenomeno dei
“lupi solitari” se Al Qaeda e l’ISIS non fossero assurte all’onore delle cronache
internazionali?
Ma qual è il fine ultimo del terrorismo? Esso è evidentemente quello del perseguimento di un cambiamento politico, sia in
un contesto nazionale sia a livello internazionale.
E cosa spinge un individuo, un’organizzazione o uno Stato a compiere atti terroristici,
a finanziarli o a sostenerli indirettamente? Una delle risposte è senz’altro legata all’asimmetria del conflitto. Se due attori
politici intendono utilizzare la violenza per gestire la conflittualità, essi dovranno
necessariamente valutare le proprie possibilità di vittoria. Come potrete facilmente
intuire, esse sono estremamente ridotte se l’attore politico A ha un manipolo di 50-60
combattenti disposti all’azione violenta, e l’attore politico B possiede un esercito
o può contare sulle forze dell’ordine interne, con relativo armamento e addestramento.
Il terrorismo consente, per certi versi, di riequilibrare il rapporto tra due attori
che hanno possibilità diverse, evitando lo scontro frontale e – potenzialmente – finale
per l’attore che ha risorse nettamente inferiori dell’altro. Hoffman, infatti, sostiene
che “il terrorismo è concepito per creare potere dove non ve n’è o per consolidare
il potere dove ve n’è poco”. Grazie alla visibilità generata dall’utilizzo della violenza,
i terroristi tentano di ottenere la leva, l’influenza e il potere che altrimenti non
avrebbero per provocare un cambiamento politico su scala locale o internazionale.
Da qui una chiosa necessaria. Da tutti gli elementi analizzati finora, possiamo trarre
una conclusione importante, per quanto sintetica.
Il terrorismo è uno strumento politico razionale. E razionalmente viene scelto da attori politici che ritengono sia uno strumento più efficace rispetto
ad altri nella propria specifica situazione e per raggiungere i propri scopi.
L’immagine del terrorista come pazzo, squilibrato o soggetto borderline, ai margini della società, non corrisponde, nella maggioranza dei casi, alla realtà.
2. Gli anarchici
Se, scorrendo l’indice di questo libro, avete letto il titolo di questo paragrafo,
forse vi aspetterete che si parli del caso Cospito, l’anarchico italiano detenuto
per atti di terrorismo, che ha fatto parlare di sé nel 2023 per le sue proteste contro
il regime del 41-bis. Mi spiace deludervi; qui tratteremo di un fenomeno del passato, vale a dire quello
del terrorismo anarchico tra Otto e Novecento. Per sollevarvi dalla prostrazione in
cui potreste essere scivolati, spezzo una lancia a favore di questo argomento di natura
squisitamente storica: è, inaspettatamente, uno dei temi nei confronti del quale i
miei studenti (giovani universitari nati dopo gli anni Duemila) mostrano maggior interesse.
La spiegazione è semplice. Il terrorismo anarchico è la prima forma di terrorismo
transnazionale dell’epoca moderna, e mostra tratti di similitudine operativa e organizzativa
con le più recenti formazioni terroristiche (Al Qaeda su tutte). In aggiunta, si tratta
di un terrorismo che ha imperversato per svariati anni in vaste parti del mondo (quasi
tutti i Paesi europei, gli Stati Uniti, l’America Latina...) e che ha causato un significativo
numero di vittime “eccellenti”.
Una delle modalità principali dell’attuazione di attentati terroristici da parte degli
anarchici del XIX e XX secolo è stata, infatti, il regicidio – ovvero l’assassinio
dei sovrani e degli eredi al trono. Ma di questo tratteremo tra poche righe. Ora facciamo
un passo indietro e procediamo con ordine. Nel 1871, l’esperimento della Comune di
Parigi, in cui i radicali riescono a prendere e mantenere il potere per tre mesi,
viene osservato con crescente interesse dai movimenti rivoluzionari in Europa che
lo interpretano come un precedente senza precedenti (mi si perdoni il gioco di parole)
perché dimostra la capacità del popolo di lanciare un’insurrezione di successo contro
l’ordine prestabilito. Agire, dunque, per generare un cambiamento radicale della società.
Anche da qui, e contestualmente allo sviluppo dell’ideologia anarchica, ci si orienta
verso una politica attivamente orientata a rivoluzionare lo status quo.
La cosiddetta “propaganda con i fatti” (propaganda by the deed), teorizzata dall’anarchico francese Paul Brousse e sviluppata in termini di rivolta
popolare anche dagli italiani Carlo Cafiero e Errico Malatesta, viene adottata come
politica dal Congresso internazionale degli anarchici.
Che la “propaganda con i fatti” corrispondesse in modo lineare all’attuazione di attentati
terroristici, nelle intenzioni degli anarchici, non è mai stato chiarito in via definitiva.
La pedissequa equazione terrorista = anarchico (e viceversa) è senz’altro falsa, anche
se questa è la visione proposta dalle autorità governative, che rivelano una tendenza
piuttosto spiccata a criminalizzare e delegittimare l’anarchismo come ideologia politica.
Ora, va detto che la dialettica tra anarchismo e violenza non è lineare. Da Proudhon
a Bakunin, da Malatesta a Kropotkin, il tema del ruolo degli intellettuali nel giustificare
l’uso della violenza a fini politici durante il periodo anarchico (e oltre) necessiterebbe
lo spazio di un altro volume. In sintesi, possiamo concludere con Jensen che l’ondata
di terrore anarchico che attraversa l’Europa sul finire del XIX secolo trae la sua
forza crescente da una singolare combinazione di atti di anarchici ideologicamente
impegnati e di azioni violente perpetrate da autori che avevano flebili (o nulli)
legami con l’anarchismo.
Sappiamo con certezza, tuttavia, che alcuni intendono associare la propaganda alla
dinamite, inventata solo cinque anni prima da Alfred Nobel: un’azione politica al
servizio della rivoluzione. Analogamente, è storicamente provato che, sul finire del
secolo XIX, una campagna di assassinii mirati colpisce alcuni degli esponenti più
in vista dei governi europei.
È il 1878, in particolare, l’annus horribilis: vengono attaccati il capo della polizia di San Pietroburgo, il Kaiser tedesco (che
sfugge a morte certa grazie a una miccia bagnata che evita lo scoppio di sette chili
di dinamite), sono assaliti i re di Spagna e d’Italia. Trascorrono pochi anni e, nel
marzo 1881, un’organizzazione segreta di populisti russi lancia una bomba contro lo
zar Alessandro II. L’organizzazione responsabile dell’attentato prende il nome di
Narodnaja Volja (“Volontà del popolo”): non è anarchica quanto piuttosto caratterizzata
da populismo, da una rigida gerarchia e da un certo autoritarismo. Il suo fine ultimo
è la creazione di una dittatura popolare dopo aver eliminato lo zar e rovesciato lo
zarismo. L’utilizzo della dinamite è qui fondamentale non solo per i suoi effetti
letali, ma anche per i risultati propagandistici che produce. Si ritiene, difatti,
che un assassinio eccellente causato da un’esplosione possa causare un impatto psicologico
molto maggiore di un attentato compiuto con mezzi – potremmo dire – più tradizionali.
È la ricerca di un atto che lasci il mondo stupefatto, attonito, incredulo e terrorizzato,
ciò che muove l’organizzazione dell’attentato contro Alessandro II. Un attacco di
tali proporzioni avrebbe infatti espresso “un nuovo stadio del movimento rivoluzionario”
invece di essere interpretato come “un ordinario assassinio”.
La morte dello zar, che sancisce la fine di ogni illusione di riformismo in Russia
e lo smantellamento di Narodnaja Volja, ha poco a che fare con l’ideologia anarchica;
ciò nonostante – secondo uno dei più eminenti studiosi di questo fenomeno, Richard
Bach Jensen – l’anarchismo, soprattutto quello di orientamento comunista, crea l’humus ideologico congeniale allo sviluppo di questa ondata di terrorismo (anarchist wave, secondo la categorizzazione del terrorismo moderno proposta da David Rapoport).
Si arriva all’ultimo decennio del XIX secolo: le rivolte sociali si espandono. Italia,
Francia, Spagna, Germania, Russia e anche gli Stati Uniti vengono coinvolti da un’ondata
di disordine globale dovuta a gravi problemi sociali che colpiscono un’ampia parte
della popolazione, ai quali i governi rispondono con la repressione. Vasti settori
della società vivono con crescente frustrazione la dicotomia tra i “consumatori-produttori”
(la classe lavoratrice) e i “consumatori-sfruttatori” (i “padroni”): per utilizzare
una goffa metafora, si auspica che la dinamite faccia esplodere il sistema della società
capitalistica borghese, minando la centralità dello Stato e favorendo la creazione
di regimi di consumo basato su modelli cooperativi.
La campagna terroristica assume ora una forma più precisa e – mi sento di affermare
– estremamente moderna. Le azioni terroristiche si specializzano contro due obiettivi:
le folle e i sovrani. Il decennio che inizia nel 1890 è segnato da attacchi terroristici
contro caffè gremiti, processioni religiose e spettacoli teatrali. È uno scatto operativo
e organizzativo piuttosto rilevante perché è una scelta che coinvolge le grandi masse
della borghesia. Nel novembre 1893 muoiono trenta persone durante mise-en-scene di un’opera di Gioacchino Rossini nel Gran Teatro di Barcellona. La strage è causata
da una “bomba Orsini” – così chiamata perché inventata proprio da quel Felice Orsini
che, nel 1858, aveva attentato alla vita dell’imperatore Napoleone III.
Allo stesso modo non vengono risparmiati i monarchi. Tra il 1892 e il 1901 si sviluppa
un’impressionante ondata di “regicidi”. Non sempre gli attentati riguardano i sovrani:
la definizione sta piuttosto a indicare una campagna terroristica che colpisce le
principali autorità governative a livello globale. Nel 1894, a Lione, viene colpito
a morte il presidente francese Marie-François-Sadi Carnot. Nell’agosto 1897, quattro
colpi di pistola crivellano il corpo del primo ministro spagnolo Antonio Cánovas del
Castillo e lo conducono alla morte nel giro di un’ora.
Trascorre un anno esatto quando viene assassinata anche la principessa Elisabetta
d’Austria, meglio conosciuta come Sissi. Nell’agosto 1898, l’imperatrice d’Austria
si trova in incognito in Svizzera, nella località turistica del lago Lemano. Diffusa
la notizia del suo arrivo, un simpatizzante del movimento anarchico, sperando di ottenere
una certa visibilità politica, pugnala Sissi che muore, a causa delle ferite inferte,
a distanza di poche ore.
L’anarchismo, già piuttosto diffuso nella penisola, si intreccia con le dinamiche
migratorie, propagandosi tra i sudditi italiani costretti all’estero dalle difficili
condizioni economiche del proprio Paese, aggravate dall’impresa coloniale italiana
verso l’Africa e dallo smacco della perdita del protettorato italiano sull’Etiopia,
dopo la tragica battaglia di Adua del 1896. Il malcontento monta e Milano diventa
presto uno degli epicentri degli scontri: nel corso dei moti del maggio 1898, il generale
Bava Beccaris dà l’ordine alla polizia di sparare sulla folla. I morti dei moti di
Milano vanno vendicati – pensano alcuni italiani. Fra essi, Gaetano Bresci, un emigrato
che presta il proprio braccio per assassinare il re Umberto I di Savoia, mentre saluta
la folla dopo aver assistito a un concorso ginnico a Monza, il 29 luglio 1900.
Trascorre un nuovo anno, ed è ancora di un anarchico la responsabilità per l’assassinio
del presidente degli USA a Buffalo, nel settembre 1901. Il repubblicano William McKinley,
venticinquesimo presidente degli Stati Uniti in carica dal marzo 1897, viene colpito
otto volte e muore dopo poco più di una settimana di agonia.
Il cambiamento non è legato solo alla modalità di attuazione degli attentati: si assiste
anche a un’espansione geografica delle zone colpite. Negli anni Ottanta dell’Ottocento,
la Germania, l’Austria e gli Stati Uniti vengono ripetutamente interessati da attacchi.
Nel decennio successivo, il baricentro del terrorismo anarchico si espande all’asse
occidentale e meridionale dell’Europa: Francia, Belgio, Italia, Spagna e Portogallo.
Sono soprattutto i grandi centri urbani (Parigi, Barcellona) a rientrare nel mirino
dei terroristi che individuano target dicotomici: i potenti e la gente comune. Anche l’organizzazione pare espandersi,
almeno agli occhi delle autorità di pubblica sicurezza. A Parigi, nel 1892, viene
arrestato uno dei più celebri e temuti terroristi anarchici: è François Claudius Kœnigstein,
meglio conosciuto come Ravachol, trentenne originario della Loira. Agli occhi dell’opinione
pubblica, è un passo importante per la sicurezza della Francia, sebbene il suo arresto
non comporti la fine degli attentati nel Paese d’oltralpe. La figura di Ravachol e
la sua esecuzione comportano, paradossalmente, la diffusione del suo mito. Contagiosamente,
si diffonde così, per le strade di Parigi, La Ravachole, un’allegra ballata che incita contro i “magistrati venduti”, i ricchi finanzieri,
i “deputati disonesti”. Per “assassini e boia”, “macellai in uniforme”, per i “generali”
e tutti “questi furfanti”, il popolo – tramite la canzone popolare – dice “basta alla
guerra a metà” e alla “pietà vigliacca”. E propone una soluzione eloquente e definitiva:
“viva il suono dell’esplosione”, “morte alla borghesia”.
L’uso della dinamite e il suo effetto spettacolare sono al centro delle attenzioni
dei terroristi. In realtà, il suo utilizzo si rivela ben presto più complicato del
previsto. La dinamite è meno letale di quanto ci si aspetti: bisogna saperla maneggiare
con cura perché compia i danni auspicati ed evitare che la sua potenza si ritorca
contro gli stessi attentatori.
Purtuttavia, nonostante i limiti nell’utilizzo di questo nuovo strumento, le autorità
di pubblica sicurezza entrano in uno stato di allarme generalizzato. Esattamente com’era
avvenuto per la Rivoluzione francese del 1789, i governi assumono l’idea che esista una vasta e strutturata cospirazione transnazionale
per rovesciare il potere in essere. La simultaneità delle azioni terroristiche in
vari Paesi – sia che si tratti di assassinii mirati, sia che vengano colpiti obiettivi
di massa grazie all’uso della dinamite – induce l’establishment e l’opinione pubblica a ritenere di essere al centro di un piano per il rovesciamento
del potere.
Il primo timore che si insinua è quello dell’escalation nell’utilizzo delle armi: alcuni osservatori temono che gli anarchici possano passare
dalla dinamite ad altri mezzi di distruzione di massa, incluso il bioterrorismo. In
effetti, le autorità di pubblica sicurezza annunciano la scoperta di un piano anarchico
che prevede l’immissione di nitroglicerina nelle tubature dell’acqua di Parigi, il
cui possibile effetto è quello di provocare esplosioni nelle case private della capitale.
Nuove armi e una diffusione globale. I governi sotto attacco rilevano l’esistenza
di una rete internazionale del terrore, con antesignani freedom fighters (spesso poveri emigrati) che prestano la propria opera per assassinare eminenti personalità
fuori dai confini del proprio Paese d’origine.
Il secondo elemento di allarme è infatti radicato nell’evidente transnazionalità del
movimento. Terroristi di diversa nazionalità cooperano per abbattere il potere costituito:
sono questi i già citati casi degli attentati ai danni del presidente francese Marie-François-Sadi
Carnot per mano dell’anarchico italiano Sante Caserio, e del primo ministro spagnolo
Antonio Cánovas del Castillo da parte di Michele Angiolillo, un giovane anarchico
foggiano che così intende vendicare i suoi cinque compagni torturati e assassinati
nella tristemente celebre prigione di Montjuïc a Barcellona.
Sul versante degli estremisti, si sviluppa una cooperazione tra italiani, francesi
e spagnoli. Già alla fine dell’Ottocento, la globalizzazione del terrorismo conosce uno sviluppo
significativo, imponendo contestualmente una risposta che sia altrettanto globale.
Le politiche di sicurezza in un Paese, così, sono talvolta condizionate dall’evoluzione
del terrorismo in un altro. Il Parlamento italiano, ad esempio, promulga una legislazione
anti-anarchica estremamente severa sotto il condizionamento degli avvenimenti terroristici
in Francia e in Spagna. L’“infezione” del terrorismo si espande e, con essa, si consolida
la tendenza delle autorità di pubblica sicurezza a ingigantire il fenomeno, la sua
potenziale pericolosità e l’associazione diretta tra anarchici e terroristi. Come
ha ben posto in rilievo Jensen, solo un numero limitato di anarchici si rende responsabile
di atti di violenza. E, in ogni caso, non tutti i terroristi presentati come anarchici
dalle autorità di pubblica sicurezza lo sono realmente.
Il coinvolgimento teorico e pratico di alcuni nella realizzazione di azioni violente
induce, tuttavia, gran parte della borghesia e diversi governi a ritenere che l’Internazionale
sia un’organizzazione che può vantare un immenso potere. Un’organizzazione sanguinaria,
che colpisce e intimorisce la classe media utilizzando i pugnali e le bombe.
Quanto questa percezione corrisponde alla realtà? Qual è l’ampiezza del movimento?
Quanti sono gli anarchici alla fine dell’Ottocento? E quanti, potenzialmente, sono
disponibili a utilizzare la violenza per raggiungere i propri scopi? Sarebbe utile
poter valutare concretamente la minaccia.
Come nel caso della definizione del terrorismo, la comunità scientifica offre elementi
diversi. Sappiamo che l’anarchismo è diffuso in vari Paesi. Italia, Francia, Spagna,
Svizzera, Germania, Impero austro-ungarico, Stati Uniti e Argentina: esso si sviluppa
in Paesi che conoscono un forte tasso di immigrazione. Alcune fonti indicano che il
terrorismo anarchico può contare su circa 60.000 aderenti nella sola Spagna. In Italia,
sarebbero circa 32.000 i seguaci del bakuninismo; l’anarchico Pietro Gori riferisce
di 5-6.000 anarchici attivi solo a Milano nel 1894. Nello stesso anno, si contano
circa 100.000 sostenitori del movimento in Francia. I dati sono molto diversi tra
loro, ma indicano che il fenomeno conosce una consistenza significativa.
La provenienza di questi anarchici è molto varia: dalla nobiltà al proletariato, dalle
classi sociali più umili e analfabete agli intellettuali borghesi, gli aderenti all’anarchismo
sono – in larga parte – delusi dalla società esistente, dagli abusi della classe dirigente,
e/o affascinati da un futuro alternativo che valichi i confini di separazione tra
le classi sociali.
Nei primissimi anni del XX secolo il terrorismo sembra conoscere un momento di stasi.
La repressione esercitata dai governi dà i propri frutti e il crescente coinvolgimento
degli attivisti politici nei movimenti sindacali, la cui nascita avviene proprio in
questi anni, drena le fila di coloro i quali sono disposti all’uso della violenza
per cambiare la società. L’atteggiamento meno settario e più progressista di alcuni
governi (in Italia, Francia e Stati Uniti) produce un effetto analogo, spostando la
conflittualità sociale su un piano di confronto politico. Dal 1905, tuttavia, una
nuova ondata di terrorismo riaffiora, segnando una globalizzazione ancora più ampia:
dall’Europa, il fenomeno interessa ora anche il Nord e il Sud America, l’Asia e l’Africa.
La globalizzazione economica, che si sviluppa tra il 1890 e il 1914, e uno dei flussi
migratori più intensi della storia producono un impatto diretto sullo sviluppo globale
del terrorismo. La Russia e la Spagna, due tra gli Stati che non avevano conosciuto
le aperture progressiste di cui si è detto, sono al centro delle violenze e, al contempo,
sono luogo di provenienza di terroristi che compiono attentati al di fuori del suolo
nazionale. Nella Russia zarista a cavallo della rivoluzione del 1905, vengono assassinati
il ministro dell’Interno Vjaeslav von Pleve (luglio 1904) e il granduca Sergej Aleksandrovi (febbraio 1905).
A Londra ha luogo lo spettacolare e sanguinoso assedio di Sidney Street del gennaio
1911; tra il 1903 e il 1909, sono otto gli ordigni che esplodono a Barcellona. A Buenos
Aires la polizia rende noto di aver sventato un piano per far saltare in aria l’acquedotto
pubblico e la principale centrale elettrica. Nel 1909, lo stesso capo della polizia
della capitale viene assassinato e tra il 1905 e il 1910 un gruppo di terroristi anarchici
russi, spagnoli e argentini tenta due volte di eliminare l’inquilino della Casa Rosada
(il presidente argentino). In Spagna, dopo il fallimento di un attentato nel maggio
1905, una potente bomba viene lanciata contro il corteo reale in parata in occasione
della cerimonia per le nozze di Alfonso XIII, uccidendo circa trenta persone e causando
un centinaio di feriti. Un ulteriore tentativo di attentare alla vita del re si concretizza
nell’aprile 1913. Devono affrontare la minaccia del terrorismo anche la Svezia, la
Grecia, il Giappone, la Cina e l’Egitto, dove viene assassinato il primo ministro
copto Boutros Ghali Pascià (nonno di quel Boutros Boutros-Ghali che sarebbe diventato
Segretario generale delle Nazioni Unite tra il 1992 e il 1996).
L’attentato più
...