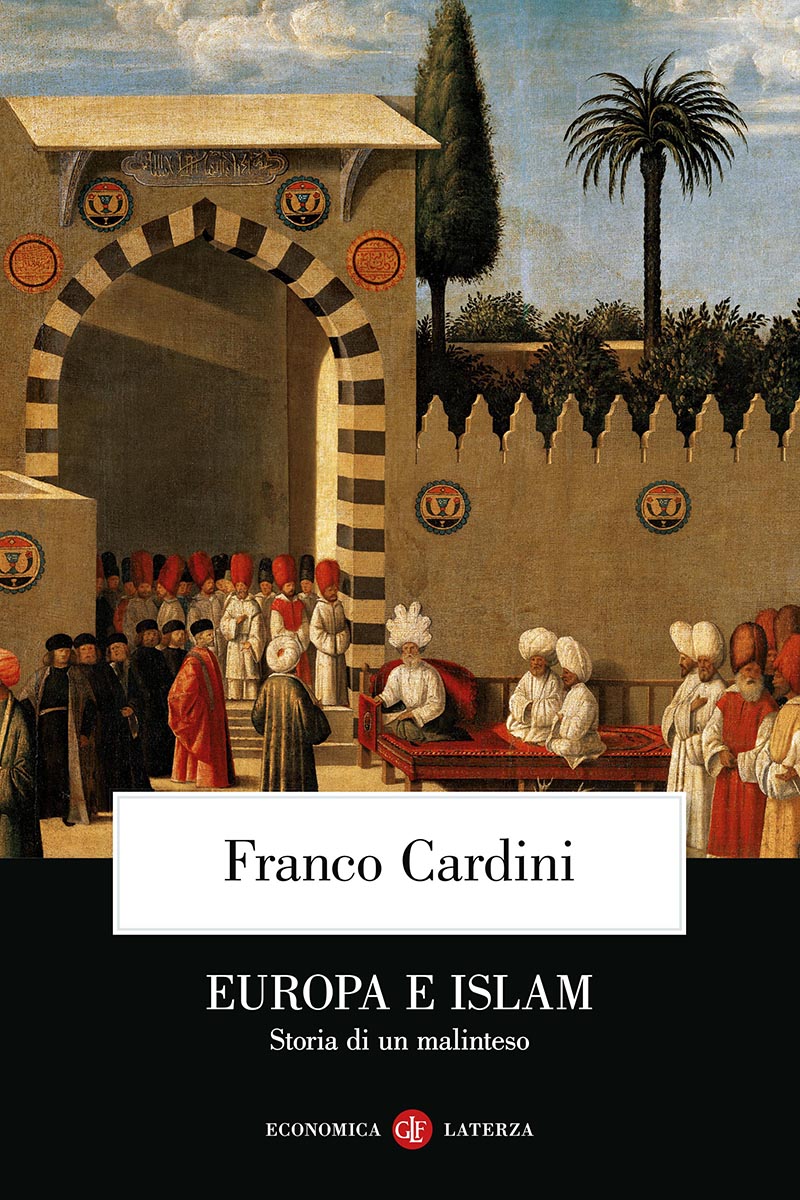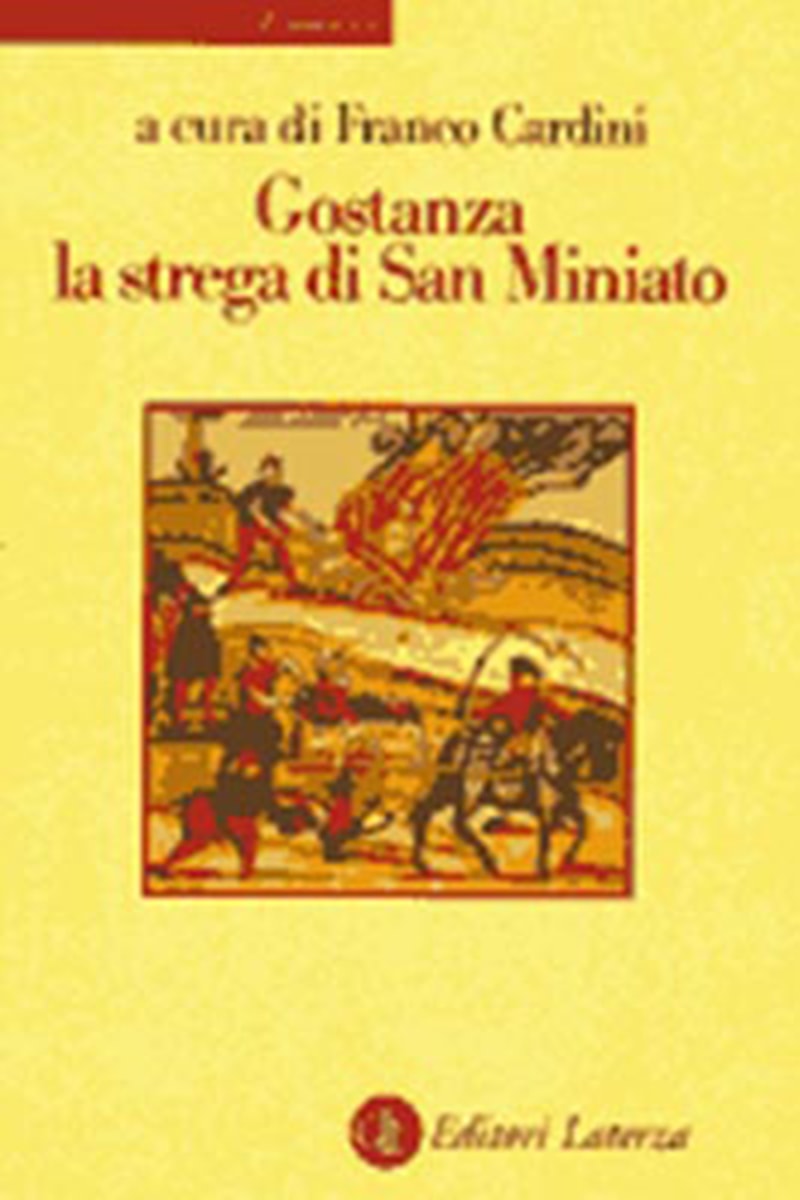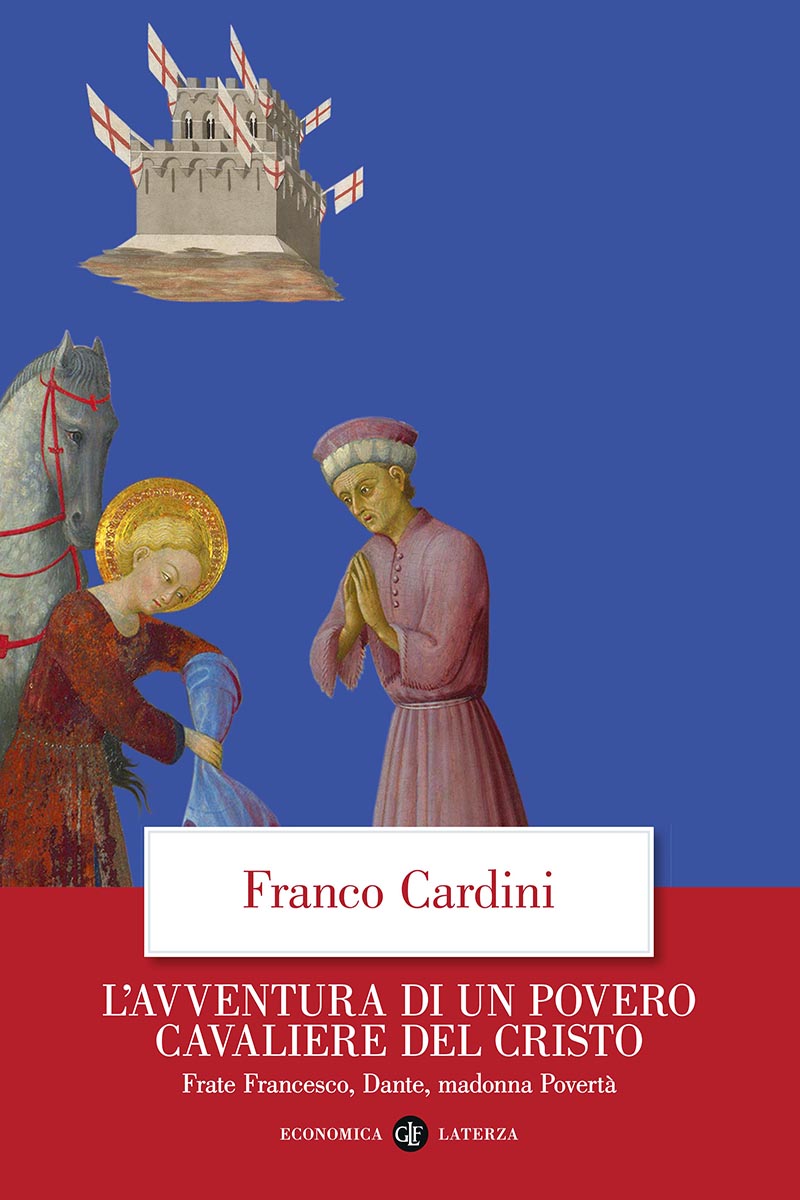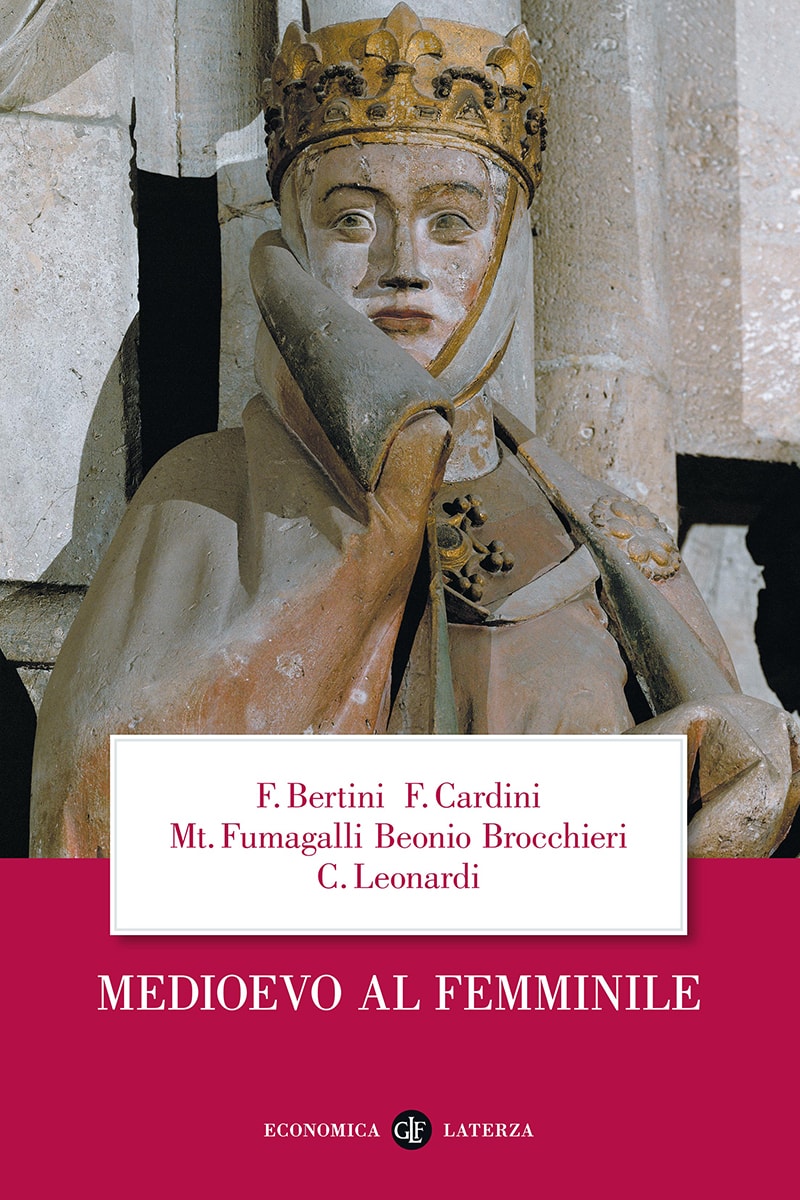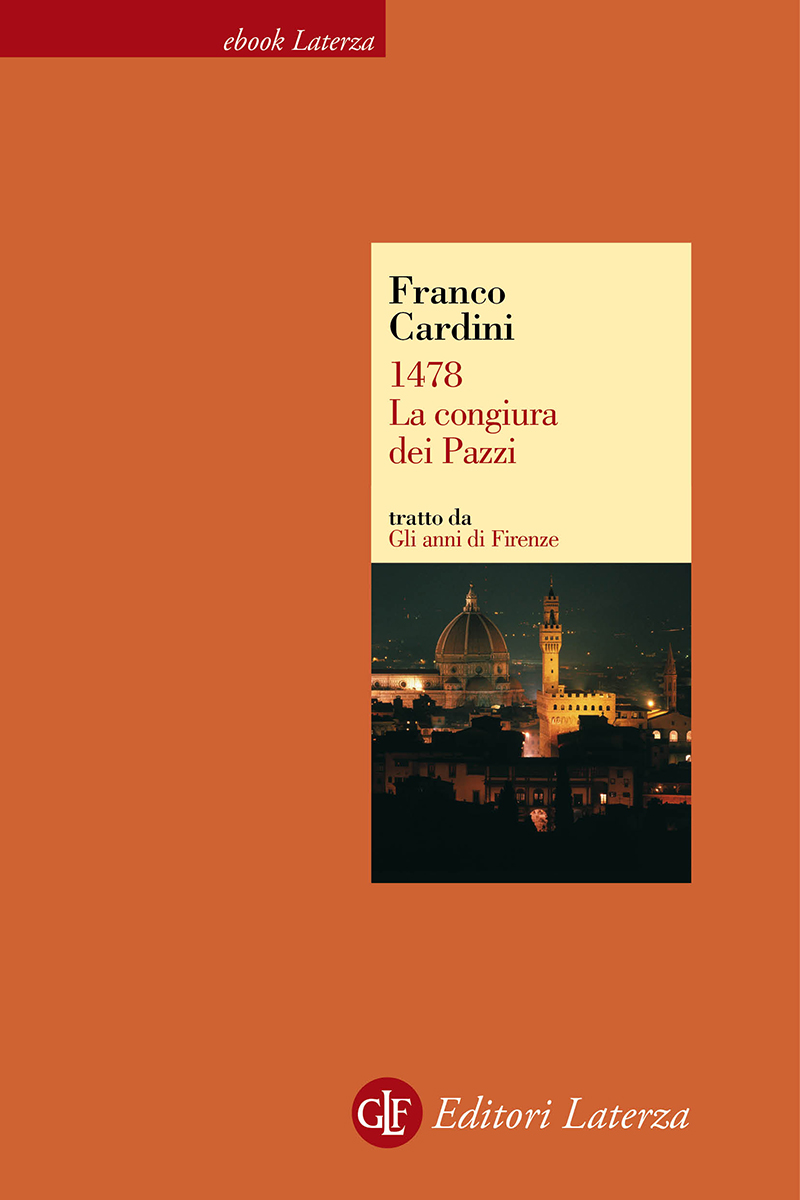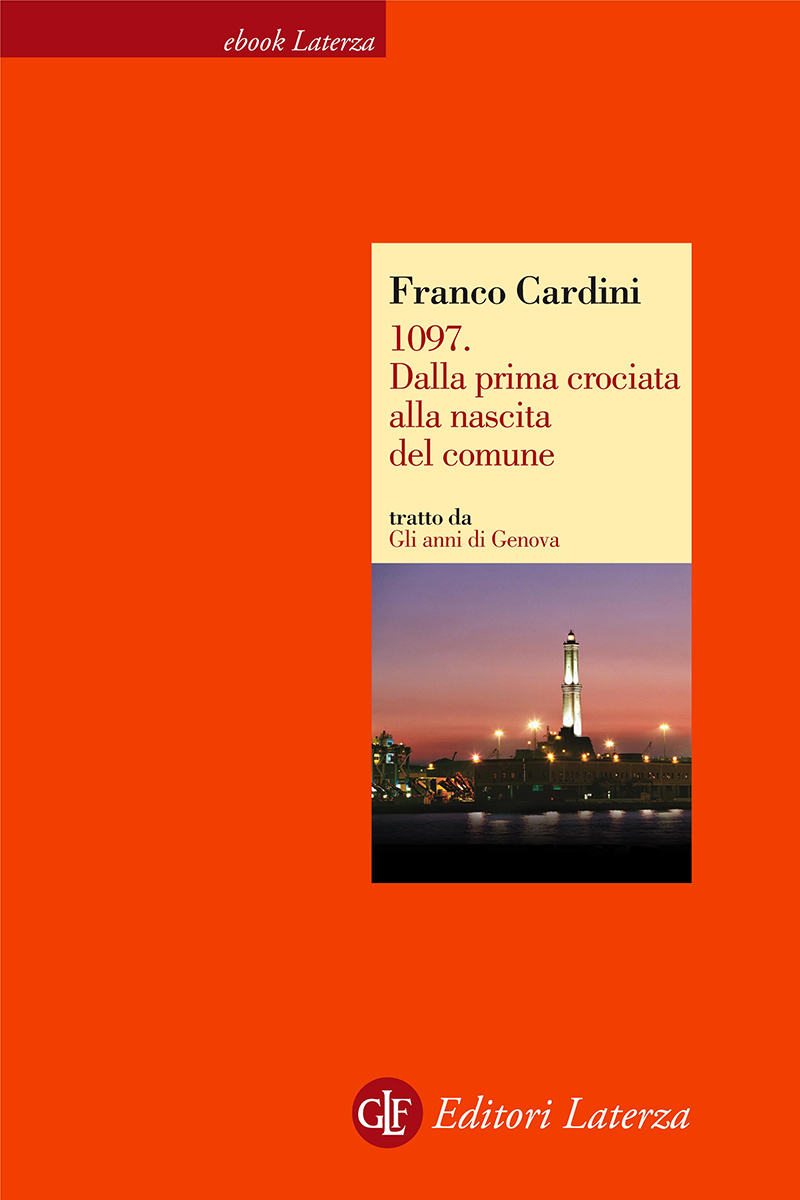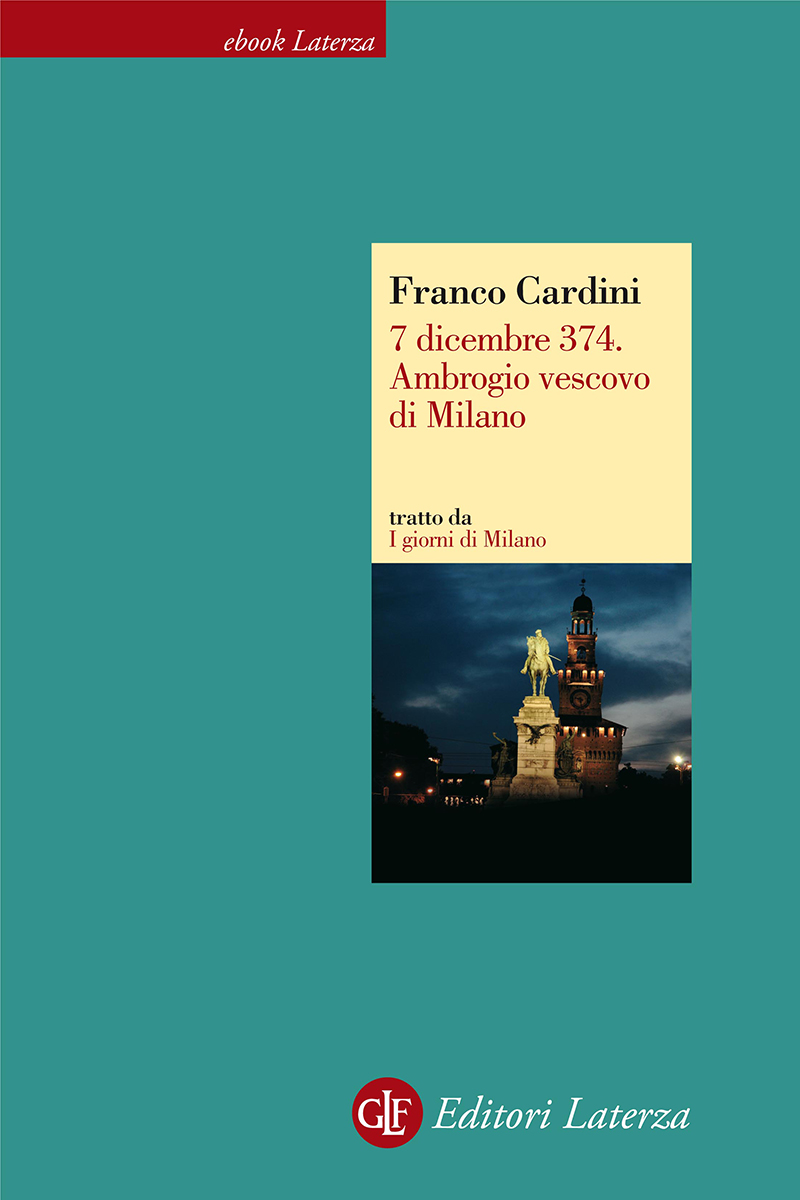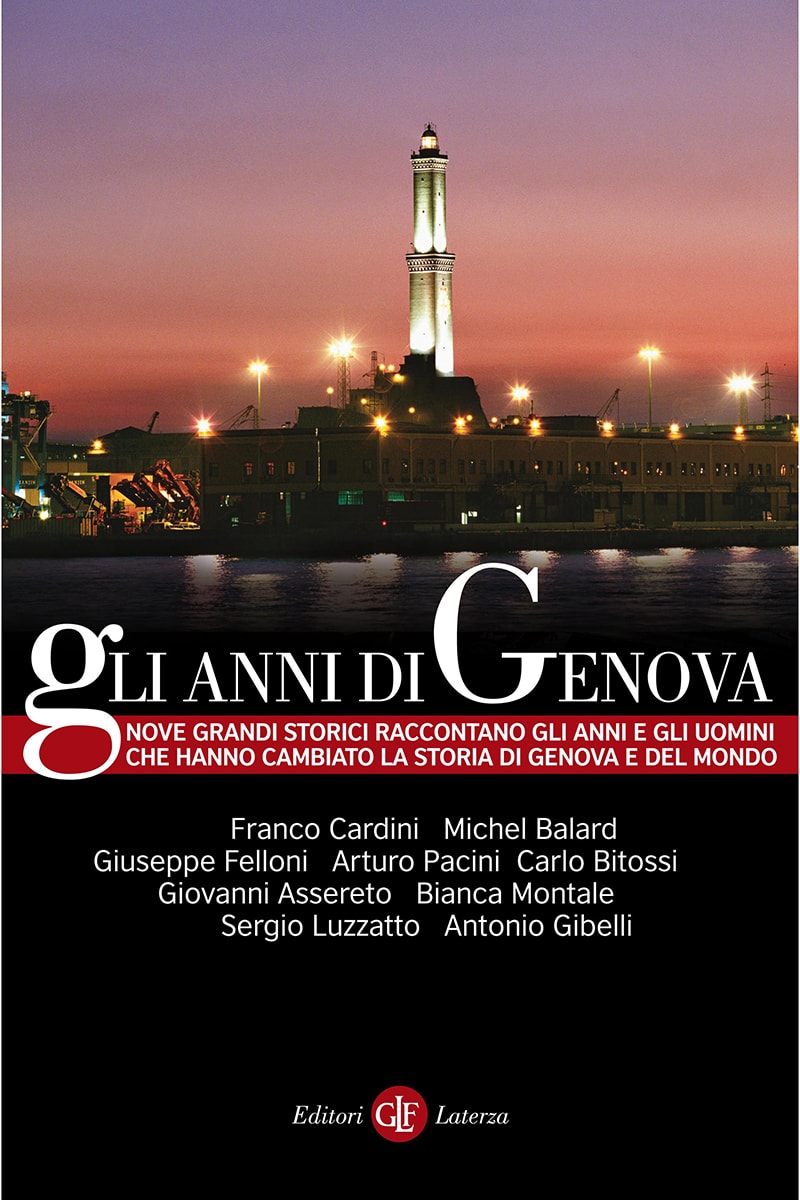Sommario
Prefazione alla prima edizione
Nota dell’Autore
Premessa
1. Un profeta e tre continenti
Europa e Asia, Cristianità e Islam: raffronti ed equivoci
I musulmani oltre il «Maghreb al-Aqsa»
Carlomagno, tra al-Andalus e Baghdad
2. Tra due millenni
Una contesa per mari, isole, coste
Crisi e trasformazione nell’Islam. L’Oriente
Crisi e trasformazione nell’Islam. L’Occidente
3. La «risposta» dell’Europa. «Reconquista» e imprese marinare
Il Cammino di Santiago
Eroi e martiri
Marinai tirrenici e guerrieri normanni
4. Il ruolo della Città Santa
Al-Quds
La crociata
Dagli ayyubidi ai mamelucchi
5. Scontri e incontri nel XII e XIII secolo
«Gesta Dei per Francos»
Vittorie in Occidente, sconfitte in Oriente
«Amors de terra londhana»
6. Il tesoro di Faraone
La «bella prigioniera»
Federico di Svevia e Alfonso di Castiglia
Francesco d’Assisi e il francescanesimo
7. I signori della paura
L’ombra della magia
Minacce ed eclissi
I figli di Othman
8. «Inimicus crucis, inimicus Europae». La minaccia ottomana
Alla caccia del Rosso Pomo
La tiara o il turbante?
Come cadde la Nuova Roma
9. L’Europa rinascimentale e i turchi
Simmetrie e dissimmetrie della longitudine
«Teucri et Turci»
Islam e Riforma
10. Sultani, corsari e rinnegati
Il Magnifico Legislatore
Corsari, rinnegati, prigionieri
Verso la nascita dell’islamistica
11. Secolo di ferro e secolo dei Lumi
Eclisse della mezzaluna
L’ultima Grande Paura
«Turqueries»
12. Dalla «malattia» dell’impero ottomano alla «terza ondata» islamica
Nuovi pellegrini, nuovi «crociati»
Padiglioni lontani
Un discorso aperto
Cronologia
Nota bibliografica
Prefazione alla prima edizione
L’Europa si costruisce. È una grande speranza che si realizzerà soltanto se terrà
conto della storia: un’Europa senza storia sarebbe orfana e miserabile. Perché l’oggi
discende dall’ieri, e il domani è il frutto del passato. Un passato che non deve paralizzare
il presente, ma aiutarlo a essere diverso nella fedeltà, e nuovo nel progresso. Tra
l’Atlantico, l’Asia e l’Africa, la nostra Europa esiste infatti da un tempo lunghissimo,
disegnata dalla geografia, modellata dalla storia, fin da quando i Greci le hanno
dato il suo nome. L’avvenire deve poggiare su queste eredità che fin dall’antichità,
e anzi fin dalla preistoria hanno progressivamente arricchito l’Europa, rendendola
straordinariamente creativa nella sua unità e nella sua diversità, anche in un contesto
mondiale più ampio.
La collana «Fare l’Europa» nasce dall’iniziativa di cinque editori di lingua e nazionalità
differenti (Beck a Monaco di Baviera, Basil Blackwell a Oxford, Crítica a Barcellona,
Laterza a Roma e Bari, Seuil a Parigi) e vuole gettar luce sulla costruzione dell’Europa
e i suoi punti di forza non dimenticabili, senza dissimulare le difficoltà ereditate
dal passato. Nella sua tensione verso l’unità, il continente ha vissuto discordie,
conflitti, divisioni, contraddizioni interne. Questa collana non li nasconderà: l’impegno
nell’impresa europea deve compiersi nella conoscenza del passato tutto intero e nella
prospettiva dell’avvenire. Di qui l’intitolazione «attiva» della collana. Non ci sembra
infatti che sia giunta l’ora di scrivere una storia sintetica dell’Europa. I saggi
che proponiamo sono dovuti ai migliori storici odierni, anche non europei, già affermati
e non. Essi affronteranno i temi essenziali della storia europea nei diversi campi
– economico, politico, sociale, religioso, culturale – appoggiandosi alla lunga tradizione
storiografica che si estende da Erodoto alle nuove concezioni che, elaborate in Europa
nel corso del Novecento, e segnatamente negli ultimi decenni, hanno profondamente
rinnovato la scienza storica. Grazie alla loro volontà di chiarezza, questi saggi
sono accessibili anche a un ampio pubblico.
E la nostra ambizione è di apportare elementi di risposta alle grandi domande che
stanno dinanzi a coloro che fanno e faranno l’Europa, e a quanti nel mondo intero
s’interessano all’Europa. «Chi siamo? Donde veniamo? Dove andiamo?»
Jacques Le Goff
Premessa
Scopo di queste pagine è seguire sinteticamente il cammino che l’Europa ha percorso
nell’entrare in contatto con l’Islam, i modi e le ragioni in cui ciò è avvenuto, il
processo storico secondo il quale i rapporti si sono sviluppati, la pluralità di aspetti,
di concezioni e di forme di pregiudizio e di disinformazione-antinformazione che hanno
configurato e condizionato la visione del secondo da parte della prima. A questo libro
manca volutamente (nonostante i molti riferimenti che in esso il lettore rintraccerà:
una totale assenza di tale punto di vista sarebbe stata inconcepibile) la prospettiva
reciproca, per accedere alla quale punto eccellente di partenza potrebbero essere
lavori come quello di B. Lewis, I musulmani alla scoperta dell’Europa, trad. it., Roma-Bari 1991.
L’Islam qui preso in considerazione è anzitutto e soprattutto quello mediterraneo.
Ciò è legittimo e sotto un certo profilo obbligatorio vista la realtà del processo
storico preso in esame, dal momento che è con esso che gli europei sono entrati presto
e sono rimasti soprattutto in contatto. Non si dimentichi d’altronde che l’Islam non
è per nulla una realtà omogenea: esiste anzi una pluralità di Islam – come una pluralità
di Cristianità –, che ha coscienza dell’unità profonda che lega l’umma di tutti i credenti ma che al tempo stesso si è sviluppata lungo la storia in forme
e secondo caratteri diversi. La tradizione e la cultura storico-filologica euromeridionali
sono sensibili talora in modo esclusivo o comunque eccessivamente limitato ai soli
Islam turco, vicinorientale e nordafricano, del resto profondamente correlati tra
loro. Per questo, chi in tale tradizione e in tale cultura si riconosce deve guardare
con attenzione ad altri ambiti europei nei quali il discorso storico e anche politico
si è sviluppato in modo diverso: ché nel mondo ad esempio tedesco, polacco, russo
(in qualche misura anche baltico e mitteleuropeo) l’attenzione fin dal Sette-Ottocento
si è andata puntando anche sulla complessa realtà mediorientale e centroasiatica;
mentre in quelli inglese, portoghese e olandese si è sviluppata una sensibilità attenta
anche per l’India e l’Asia orientale che la prospettiva dei paesi euromeridionali
solitamente esclude dal suo raggio. Alludo, quanto meno, a un àmbito di conoscenza
media, condizionato dall’insegnamento scolastico e dagli standardmassmediali. A tale riguardo, ho costantemente tenuto presente la distinzione tra
un Near East,un Middle East e un Far East, evitando di definire «Medio Oriente» l’area inclusa tra Mar di Levante, Eufrate
e penisola arabica (altri hanno fatto una scelta diversa: ad esempio, il punto di
vista espresso da Massimo Campanini nel suo saggio intitolato appunto Storia del Medio Oriente, Bologna 2006,è molto interessante). Mi chiedo naturalmente se tali espressioni non siano «occidentocentriche»:
ma lo sarebbero anche quelle «Asia occidentale», «Asia centrale», «Asia orientale»,
dal momento che la nozione stessa di continente è frutto della tradizione culturale
occidentale. Forse, ogni conato politically correct è qui ancor più sviante che altrove: dal momento che qualunque lingua si usi un più
o meno accentuato etnocentrismo culturale è inevitabile, connaturato com’è al tessuto
lessicale e strutturale della lingua stessa. Cfr. ad ogni modo le considerazioni,
da me condivise, del compianto amico e collega G. Vercellin, Fine della storia, storia orientale e orientalistica, in «Studi storici», 32, 1, 1991, pp. 97-110.
Molti amici e colleghi mi sono stati di valido e generoso aiuto nella stesura di queste
pagine. Per me, ohimè non orientalista né arabista né islamista, preziose sono state
soprattutto le indicazioni di Stefano Allievi, Salvatore Bono, Paolo Branca, Massimo
Campanini, Alessandro Cancian, Ennio Concina, Khaled Fouad Allam, Mirella Galletti,
Enrico Galoppini, Renzo Guolo, Sergio Noja, Mahmoud Salem Alsheikh, Clelia Sarnelli
Serqua, Bianca Maria Scarcia Amoretti, Giorgio Vercellin e di tanti altri amici. Un
ringraziamento particolare a Jean-Pierre Bardos per la sua attenta e intelligente
lettura. Una speciale gratitudine debbo altresì al collega Max Lejbowicz, che segnalando
impietosamente alcuni miei errori mi ha molto aiutato a migliorare le mie pagine;
e all’amico Tariq Ramadan, un intellettuale e studioso – ma anche uomo di fede e organizzatore
politico – discusso e «ingombrante», tuttavia inaggirabile. Sono molto riconoscente
alle due principali associazioni che rappresentano i musulmani d’Italia, la Comunità
religiosa islamica (Coreis) e l’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii):
per quanto in frequente disaccordo tra di loro, sono sempre state con me molto amichevoli
e generose d’informazioni. Infine, un grazie sincero alla paziente e volenterosa équipe di amici, colleghi e allievi che gratuitamente mi aiuta sia nel lavoro del Centro
di studi sulle arti e le culture dell’Oriente (Csaco), da me diretto presso l’Università
internazionale dell’arte di Firenze, sia nella redazione del quadrimestrale «La Porta
d’Oriente» (Edizioni Pagine, Roma).
Per molte altre indicazioni, delle quali sono debitore, mi limito ad un collettivo
ringraziamento. Naturalmente, non è né retorica né ipocrisia ricordare che la responsabilità
degli errori è esclusivamente mia.
1. Un profeta e tre continenti
Europa e Asia, Cristianità e Islam:
raffronti ed equivoci
Il confronto tra Europa e Islam, comunque lo si voglia impostare, comporta sempre
un sentore di contrapposizione: forse perché si continua a considerarlo – o almeno
a implicitamente avvertirlo – come una sorta di continuazione o di ripresa dell’incontro-scontro
fra Cristianità e Islam; per quanto è ormai impossibile il riferirsi ancora all’endiadi
Christenheit oder Europa, proposta dal Novalis, considerandola appunto come un’endiadi. Il processo di secolarizzazione,
connaturato alla Modernità occidentale, impedisce di continuare a considerar l’Europa
non solo come la Cristianità, ma anche semplicemente come una Cristianità. Tuttavia, almeno da quando il mondo occidentale – a sua volta non più
identificabile tout court con l’Europa – segue con preoccupazione crescente il diffondersi dei movimenti islamici
impropriamente detti «fondamentalisti» (per quanto non si possa certo identificare
per intero l’Islam con i differenti e molteplici volti della galassia «fondamentalista»),
si registra in Europa una diffusa tendenza a vedere nell’Islam un almeno potenziale
avversario. Tendenza che si potrebbe ritenere nuova: ma che molti europei vivono piuttosto
come un revival, un ritorno, il ricorso d’un déjà vu, la ripresa d’una contrapposizione antica e, per così dire, connaturata a una realtà
geostorica e geostrutturale profonda.
Ci sarebbe dunque da chiedersi se il confronto tra Europa e Islam, nella misura in
cui è definibile o quanto meno coglibile come una contrapposizione, non sia spesso
vissuto da una parte come sinonimo imperfetto di quello tra Occidente e Islam (o tra
Modernità e Islam: il che introdurrebbe un ulteriore elemento di complicazione, implicito
nella tendenza a considerare inscindibili Occidente e Modernità), dall’altra come
la prosecuzione di un «confronto-duello» classico e antico, quello tra Europa e Asia,
già intravisto da Eschilo ne I Persiani e interpretato quindi nel De aeribus d’Ippocrate in termini di valori tanto climatico-ambientali quanto politico-istituzionali
(le stagioni miti e il governo monarchico renderebbero imbelli gli asiatici, le stagioni
più aspre e le istituzioni di libertà attivi e bellicosi gli europei) e nella Politica di Aristotele come esito di una «naturale» differenza d’indole. Ma certo, se ardua
e ormai improponibile appare l’endiadi Cristianità-Europa, a maggior ragione impossibile
sarebbe qualunque riduzione dell’Asia all’Islam o viceversa: non tutta l’Asia è musulmana,
com’è noto, e d’altronde il dar al-Islam, la «terra della fede», si estende ben oltre i limiti del continente asiatico.
A ciò si aggiunga l’«asimmetria» almeno apparente fra i termini stessi di «Europa»
e «Islam»: l’uno indica difatti un continente, l’altro una religione. Ma – ed eccoci
a una prima chiave concettuale per uscire dal nostro dilemma – osserva al riguardo
Bernard Lewis:
L’asimmetria è più apparente che reale. «Europa» è un concetto europeo, così come
l’intero sistema geografico dei continenti, fra i quali l’Europa fu il primo. L’Europa
ha concepito e fatto l’Europa; l’Europa ha scoperto l’America, le ha dato il nome
e in un certo senso l’ha fatta. Secoli prima, l’Europa aveva inventato sia l’Asia
che l’Africa, i cui abitanti, fino al XIX secolo – l’era della supremazia mondiale
europea – erano del tutto inconsapevoli dei nomi, delle identità e persino di queste
classificazioni inventate dagli europei a loro uso e consumo.
L’Islam non è un luogo; è una religione. Ma per i musulmani la parola «religione»
non ha la stessa connotazione che ha per i cristiani o che aveva per i cristiani del
medioevo [...]. Per i musulmani l’Islam non è soltanto un sistema di fede e di culto
[...] Esso indica piuttosto il complesso della vita e le sue norme comprendono elementi
di diritto civile, di diritto penale e persino di quello che noi chiameremmo diritto
costituzionale.
Ma la contrapposizione tra Europa e Asia, al pari di quella tra Occidente e Oriente,
conosce uno statuto geostorico e geopolitico di lunga durata che va al di là della
tensione tra l’Europa e l’Islam; per quanto non manchino quanti propongono che in
certi periodi – ad esempio nell’età delle crociate, o in quella dell’egemonia turco-ottomana
sul Mediterraneo orientale e sui Balcani – il duello euroasiatico e quello occidentale-orientale
abbiano assunto l’aspetto di quello che (con molta inesattezza, almeno a livello simbolico)
si usa indicare come il «duello tra la croce e la mezzaluna». Ora, se – al di là delle
indicazioni dei geografi antichi – ci poniamo il problema di come e quando sia nata
una coscienza moderna dell’Europa e dell’identità europea, ci rendiamo conto di quanto
e fino a che punto l’Islam ne sia, magari «al negativo», tra i fattori che l’hanno
aiutata a definirsi. La reiterata aggressione musulmana all’Europa – tra VII-VIII
e X secolo, quindi tra XIV e XVIII secolo –, obiettivamente effettiva o comunque come
tale dagli europei interpretata, è stata una «levatrice violenta» d’Europa. E se qualche
storico ha (paradossalmente?) salutato dunque il Profeta come «padre fondatore» d’Europa,
c’è da chiedersi se analogo ruolo non sia più tardi spettato anche ai sultani turchi
Maometto II e a Solimano il Magnifico che, obbligando il continente a difendersi e
a cercare le vie e i modi per un’azione unitaria, lo hanno indotto anche, in prospettiva,
a meglio definirsi dinanzi a se stesso e all’«Altro».t
I musulmani oltre il «Maghreb al-Aqsa»
Che l’Europa fosse la sede per eccellenza – se non in esclusiva – della Cristianità,
era avviso errato forse ma si può dir concorde degli autori medievali. Con esso, era
radicata l’idea che chi non fosse cristiano, se anche dimorasse in territorio europeo,
vi si fosse installato da estraneo e da invasore. Così l’anonimo chierico toledano
che, verso la metà dell’VIII secolo, proseguiva nella sua Continuatio Hispanica le Historiae avviate da Isidoro di Siviglia, salutava come Europenses gli austrasiani vincitori della battaglia di Poitiers del 732 (in realtà combattuta,
secondo altri, nel 733). Ma ci si può chiedere se egli si sentisse a sua volta Europensis in quanto cristiano, o semplicemente nella misura in cui la penisola iberica rientrava
nell’Europa secondo i termini geografici romani; o se tale non ritenesse – con rammarico
– di poter più dire nemmeno se stesso, da quando gli arabo-berberi invadendo la penisola
iberica l’avevano inglobata nel dar al-Islam. Il che postulerebbe, appunto, confini mobili e rigorosa alterità tra Europa e dar al-Islam; ed escluderebbe la possibilità di parlare di una «Europa musulmana» quando si volesse
alludere ai territori del continente europeo conquistati dall’Islam e insediati da
genti già musulmane o alla nuova fede di recente convertite.
È antiquata e oziosa la discussione se Poitiers abbia arrestato l’invasione musulmana
dell’Europa, o sia stata piuttosto il sintomo d’una stanchezza degli invasori, i quali
ormai non avevano più lo slancio per procedere troppo oltre: sia perché ormai il peso
di quel fatto d’armi appare del tutto circoscritto, sia perché è improprio, dinanzi
all’espansione dell’Islam nei secoli VII-X, parlare d’invasione. Gli arabi non avrebbero
mai potuto disporre, all’interno del loro àmbito etno-geografico, di guerrieri tanto
numerosi da occupare in pochi decenni un territorio esteso dalle Colonne d’Ercole
all’Indo e al Sir Darya nel senso della longitudine e dal Caucaso al Corno d’Africa
in quello della latitudine: fin dalle campagne dei califfi immediati successori del
Profeta, a partire cioè dagli anni Trenta del VII secolo, l’espansione dell’Islam
non corrispose mai a una torrenziale, inarrestabile conquista militare – e tanto meno
a una Völkerwanderung –, bensì piuttosto a un processo non sempre coerente e continuo di conquista e di sostanzialmente
mai provocata e tanto meno imposta conversione di gruppi afferenti a società stanche
o in crisi – fossero i cristiani monofisiti di Siria e d’Egitto, trattati con durezza
dal governo del basileus di Bisanzio, o le genti soggette allo shah sasanide –, desiderose di scrollarsi di
dosso vecchie e sclerotiche signorie e di ridefinirsi senza rinnegare il monoteismo
abramitico attorno a un catalizzatore nuovo, il verbo della sottomissione a Dio propagandato
dal Suo rasùl Muhammad; per quanto molti preferissero poi restare invece fedeli al loro credo accettando
di pagare per questo la tassa di capitazione(jizya) e l’imposta dovuta dai non-musulmani sulla terra (kharadj) nonché di venire considerati, in quanto ahl al-Khitab («genti del Libro»), dhimmi – quindi «protetti», ma anche «soggetti» –; e mostrando insomma di ritenere il governo
degli infedeli migliore di quello dei correligionari.
Comunque il mito di Poitiers, auspice una suggestiva pagina di Edward Gibbon, ha percorso
e contribuito in certo senso a razionalizzare l’intera storia dell’Europa come storia
della contrapposizione rispetto all’Islam: senza Poitiers e l’eroismo di Carlo Martello
– è stato detto e ripetuto più volte e in vari modi – il nome di Allah sarebbe stato
annunziato dai muezzin dall’alto delle torri di Oxford, in quella celebre università si sarebbe studiato
il Corano e le vicende di tutto il mondo sarebbero state diverse.
Inutile ridimensionare il peso e il ruolo della battaglia di Poitiers: per quanto
sia giusto invitare alla prudenza nelle minimalizzazioni e nelle «demitizzazioni»,
va pur detto che ormai nessuno fra gli specialisti, gli studiosi seri e il pubblico
più attento crede più a una sua importanza risolutiva. Il «mito» di quello scontro
sopravvive oggi soprattutto come luogo comune massmediale: ma, d’altro canto, non
v’è nulla di più arduo a sradicarsi d’un luogo comune massmediale. Sappiamo bene che
è stata la propaganda franca e pontificia a esaltare la vittoria conseguita sulla
strada fra Tours e Poitiers, qualche chilometro a nord-est della confluenza della
Vienne con la Creuse, per confermare la gloria della nazione «primogenita della Chiesa
di Roma». Al tempo stesso, c’era forse l’intenzione di eclissare la fama del basileus Leone III Isaurico, che nel 718 aveva obbligato i musulmani ad abbandonare l’assedio
posto l’anno precedente a Costantinopoli e che avrebbe validamente contrastato il
loro potere sui mari mantenendo il controllo di Mar Nero, Egeo e Mediterraneo centrale
fino a dissuaderli per molto tempo dal compiere ulteriori tentativi di penetrare nella
penisola anatolica. Ma i fedeli della Chiesa latina non potevano certo onorare Leone
III, un iconoclasta; più tardi gli si sarebbe rimproverata anche l’appartenenza a
quella civiltà bizantina che un tenace pregiudizio occidentale ha indotto per lungo
tempo a descrivere come vile, decadente, degenerata. Quel che il mito di Poitiers
ha contribuito a dissimulare a noi moderni è piuttosto, se non proprio il silenzio,
le scarse e poco precise voci delle fonti europee coeve rispetto all’Islam. È noto
d’altronde che il periodo corrispondente alla grande esplosione delle conquiste musulmane
fu anche un lungo momento di forte depressione del mondo euroccidentale: silenzio
o notizie inadeguate sono pertanto dovuti anzitutto a disinformazione e a ignoranza.
Tuttavia, vero è anche che nel clima di allora riusciva forse difficile, e tutto sommato
inutile, distinguere i musulmani da altri invasori o incursori: né avrebbe avuto senso
attribuire loro importanza e significato particolari. È stato scritto che quella dell’impero
romano d’Occidente, nella seconda metà del V secolo, era stata una «caduta senza rumore»;
probabilmente, per l’Europa almeno dell’VIII secolo anche l’avanzata islamica fu,
del pari, senza rumore. O meglio, il suo rumore si confondeva con altri. Al confronto,
ad esempio, di Poitiers parlano di più le fonti musulmane, che conoscono l’episodio
come «Balàt al-Shuadà’», la «Strada dei Martiri», e gli attribuiscono una sia pur
mediocre importanza.
Non ci si può certo meravigliare di quel che accadde nel depresso e sottosviluppato
Occidente europeo, dal momento che le stesse ben più avvertite fonti bizantine si
accorsero relativamente tardi che i musulmani non erano barbaroi come gli altri; né si resero subito conto dell’importanza dell’Islam come nuova fede.
E attraverso Bisanzio giunge all’Europa altomedievale un dono inatteso e sconvolgente.
Una parola magica: Sarraceni, poi corretto e nobilitato in Saraceni e con una forma molto inesatta di lectio facilior interpretato come «figli di Sara». Il termine era improprio, giacché serviva a indicare
originariamente un popolo le asserite origini del quale stavano nell’Arabia felix,collegandolo con la progenie uscita secondo il racconto del Genesi dall’unione di Abramo non già con la consorte legittima Sara, bensì con l’ancella
egiziana Agar. Ora, se la tradizione consolidata considerava le genti del deserto
come figlie del Patriarca e della schiava – quindi sorellastre bastarde del popolo
d’Israele attraverso il figlio, quell’Ismaele da quei due generato (da cui il nome
di Ismailitae) –, il termine che sarebbe stato per loro più appropriato, e che difatti è autorevolmente
e ordinariamente attestato, è semmai Agareni.Ma che la parola Saraceni derivi da Sara è forse spiegazione pseudoetimologica a posteriori, sulla base della semiomofonia e del fraintendimento d’una voce derivata dall’arabo
o dal siriaco. Essa è stata avvicinata ad alcune parole arabe: è improbabile che derivi
da sharq, «Oriente», dal momento che la prima ondata musulmana che investì la Siria veniva
semmai da sud – a meno che il termine non abbia origine egiziana –, mentre molto suggestivo
sarebbe il rapporto che la collega al vento del deserto Sharuq (da non confondersi con Sharqiyya, lo Scirocco). Altri hanno tenuto invece d’occhio il carattere di moltitudine che
gli scorridori del deserto presentavano, o la loro caratteristica di associarsi fra
tribù per compiere i loro raids: e hanno chiamato in causa i concetti di shark, «gente riunita», o di sharika, «società», «compagnia». È stato proposto altresì che i saraceni siano stati chiamati
così dai sedentari che erano i loro antagonisti e non di rado le loro vittime in rapporto
al concetto di sarq («rapina», «furto») e al verbo saraq («rubare»), da cui i concetti analoghi di sâriq, «ladro», e di sarrâq,«rapinatore», borsaiolo».
Quelli che i testi definiscono Ismailitae,o Agareni,o Sarraceni, si affacciano presto alla ribalta delle nostre fonti. Troppo poco sappiamo dell’accusa
mossa a papa Martino I (649-653) di aver cercato contatti con i saraceni per contrastare
il basileus Costante II e il suo monotelismo: si trattava comunque dei primi assaggi islamici
di conquista del Mediterraneo, che in quegli anni preoccupavano Bisanzio. Certo è
che, alla fine del VII secolo e ai primi dell’VIII, quella congerie di genti eredi
nella sostanza della tradizione ricevuta dalla Pars occidentis dell’impero romano, scaturita alla fine del IV secolo dalla sistemazione teodosiana,
cui si erano aggiunti gli apporti «barbarici» e le monarchie che ne erano nate – insomma,
gli «europei occidentali», come già possiamo chiamarli –, non disponeva di strumenti
in grado di prepararla al fatto che, di lì a pochi decenni, anche sulle sue coste
e nei mari ad esse prospicienti si sarebbe abbattuta la tempesta saracena.
Ma l’avventura della conquista islamica del Mediterraneo era già cominciata. Dopo
che la Siria e la Palestina erano state invase dagli arabi tra 633 e 640 e l’Egitto
tra 639 e 646, i marinai siriaci ed egiziani avevano abbracciato la nuova fede o si
erano comunque messi presumibilmente non senza piacere – loro, cristiani in maggioranza
monofisiti e quindi perseguitati e discriminati dall’amministrazione imperiale bizantina
– al servizio dei seguaci del Profeta. Nel 649 un capo destinato al califfato, il
governatore di Siria Muhawyya ibn Abu Sufyan – cugino del califfo Othman e futuro
fondatore della dinastia califfale umayyade –, attaccò Cipro; nel 652 si verificò
già qualche modesta scorreria in Sicilia, appartenente ancora all’area dominata da
Bisanzio; tre anni dopo, una grande battaglia navale non lontano dalle coste della
Licia segnava la crisi della talassocrazia romano-orientale. Vi fu sconfitto lo stessoCostante II, ch’era pur a capo d’una flotta di 500 navi.
Di tutti questi avvenimenti, le genti della depressa Europa occidentale del tempo
– ancora prevalentemente mediterranea: i suoi confini orientali erano al Reno e quelli
settentrionali all’alto corso del Danubio – non sapevano e non sarebbero comunque
riuscite a capire quasi nulla. Ma, per renderci conto un po’ più da vicino di un silenzio
o di troppo scarse informazioni, non dobbiamo insistere sull’ignoranza del fenomeno
islamico da parte delle fonti occidentali – che senza dubbio pur c’era –, bensì semmai
e soprattutto sul loro disinteresse. Difatti il cronista franco noto come Fredegario,
che scriveva verso il 658, alludeva a profezie di tipo astrologico circolanti nell’impero
al tempo del basileus Eraclio, secondo le quali la compagine bizantina sarebbe stata battuta e conquistata
da una razza di circoncisi e mostrava di conoscere varie cose sulla prima espansione
islamica in Asia Minore. Sempre nel mondo franco, ai primi dell’VIII secolo, un certo
monaco Pietro forse siriano traduceva dal greco in latino un testo il cui originale
siriaco proveniva dalla Mesopotamia settentrionale: si tratta delle Revelationes del cosiddetto Pseudo-Metodio, più volte poi usato in seguito nella propaganda escatologica
a carattere politico. Secondo tale testo gli ismailiti provenienti dal deserto di
«Ethribum» (quindi di Jathrib, la città prediletta del Profeta, Medina) avrebbero
conquistato l’Oriente, attaccato la Sicilia e sarebbero giunti fin presso Roma; le
loro gesta avrebbero sconvolto anche i boschi, le montagne, le città. Quell’assalto
degli ismailiti avrebbe dovuto immediatamente precedere l’avvento dell’Anticristo:
ma un imperatore cristiano avrebbe alla fine sottomesso le avanguardie del Nemico.
Insomma, qualcosa si sapeva: ma lo si registrava distrattamente.
L’occupazione musulmana della penisola iberica e della Settimania (Linguadoca), nel
corso del secondo decennio del secolo VIII, dovette un po’ cambiare le cose. Nel mondo
visigoto di Spagna – percorso dai residui della controversia ariana e dalle rivalità
interne alla sua aristocrazia – ci si era preoccupati per tempo dinanzi alle notizie
dell’avanzata araba lungo le coste dell’Africa settentrionale. Durante il concilio
di Toledo del 694 il re Egica aveva lanciato l’allarme. Si andava spargendo la voce
che gli ebrei, esasperati a causa delle misure vessatorie assunte nei loro confronti,
si apprestassero a dar man forte ai nuovi barbari che stavano avanzando nel Nordafrica
in direzione est-ovest. Imperversava intanto una guerra civile fra i pretendenti al
trono goto di Toledo e sembra che uno di essi, per evitar di soccombere, si rivolgesse
chiedendo aiuto ai Mauri, agli arabi conquistatori ma anche ai berberi arabizzati e islamizzati che ormai
erano con loro: quelli che da allora e per sempre sarebbero stati los moros, i feroci e affascinanti nemici-compagni degli spagnoli cristiani. È stato d’altronde
proposto che anche in Spagna e nella Settimania, com’era accaduto in gran parte delle
regioni ex bizantine conquistate dai musulmani, i nuovi arrivati sarebbero stati tutt’altro
che malvisti da una parte almeno della popolazione e il loro giogo preferito – perché
ben meno pesante e vessatorio – a quello dei dispotici principi cristiani.
L’antica provincia romana d’Africa, che gli arabi chiamavano Ifriqiya (comprendente
la Tripolitania, la Tunisia e l’Algeria attuali), era stata invasa dai musulmani nel
647; ma solo una quindicina d’anni più tardi la resistenza bizantina e soprattutto
berbera aveva cominciato a cedere. Gli arabi distinguevano, nell’area che stavano
conquistando, tre elementi etnosociali: i rum, un termine che indicava principalmente i bizantini, cioè i sudditi dell’impero romano
(dal greco Romàioi),ma che sul litorale africano ad ovest della Sirte designava genti d’origine o comunque
di lingua latina; gli afriki, autoctoni ormai cristianizzati; e infine i berber, dal latino barbarus, ch’erano rimasti fuori dalla civiltà romana e che si erano cristianizzati solo in
parte e in data recente. Essi finirono con l’accettare l’Islam, però non si assimilarono
mai agli arabi. Erano a loro volta, al pari di quelli, refrattari alla vita di mare:
ma l’apporto dei marinai siriani ed egiziani consentì comunque presto loro di guardare
al Mediterraneo. Già dal 665 i musulmani usavano la base navale di Jaloula, strappata
ai bizantini; nel 670 fu fondata la città di Qayrawan, che assunse il nome dal termine
che in arabo indica il campo militare; dall’anno 700 un buon porto fu organizzato
in Tunisi, dove si trasferì un centinaio di famiglie egiziane esperte nell’arte delle
costruzioni navali; da lì a circa cinque anni dopo, tutta l’Africa settentrionale,
sino a quello che per gli arabi era «il lontano Occidente» (al-Maghreb al-Aqsa), il Marocco, era nelle mani dei conquistatori, mentre si avviava il faticoso processo
d’islamizzazione e di arabizzazione almeno linguistica dei berberi. Fu probabilmente
alla fine del luglio del 711 che una grossa flotta musulmana, al comando del berbero
Tariq ibn Ziyàd, prese terra nella baia di Algeciras, che già l’anno prima era stata
razziata. Le forze arabo-berbere ascendevano forse a 10.000 uomini circa. Sconfitte
le truppe del re goto Roderico, gli invasori puntarono senza indugio su Siviglia,
occuparono quindi Córdoba e nel 713 s’impadronirono di Toledo. L’Aragona fu conquistata
l’anno successivo; entro il 720, i musulmani avevano occupato anche la Catalogna e
la Settimania, vale a dire tutti i territori della monarchia visigota a sud e a nord
dei Pirenei. La rapidità della conquista di quella che gli arabi chiamavano al-Andalus (avevano imparato a definirla così in Africa, dov’essa era ancora «la terra dei vandali»)
fu tale che, per spiegarla, si fece ricorso all’alibi della complicità degli ebrei,
degli eretici e della fazione gota nemica di Roderico.
Dopo aver occupato Narbona nel 718, gli arabi si erano presentati dinanzi a Tolosa
nel 721 e avevano preso Nîmes e Carcassonne nel 725. Ormai, l’intera Provenza col
bacino del Rodano era teatro delle loro gesta. Autun fu incendiata nel 725, o secondo
altri nel 731.
Dalla Spagna e dalla Settimania al sud della Gallia, dominato dai franchi fin dall’inizio
del VI secolo – ma dove le istituzioni erano fragili e le strutture sociali labili
–, il passo poteva esser breve. Il vescovo di Roma Gregorio II, che seguiva con attenzione
tutte le vicende riguardanti il popolo franco «figlio primogenito» della sua Chiesa,
incoraggiò Oddone duca d’Aquitania a resistere nel 721 ai musulmani, dinanzi a Tolosa;
e come eulogia gli inviò alcuni tessuti che erano serviti come copertura per l’altare di San Pietro.
Ridotti in frammenti, essi furono inghiottiti dai guerrieri cristiani a titolo parasacramentale.
Ma la conquista saracena della penisola iberica non era totale; fra le asperità dei
Pirenei e dei Cantabrici sopravvivevano dei focolai di resistenza cristiana. Il goto
Pelagio organizzò nelle Asturie, nel 720, un principato che una ventina di anni dopo
si sarebbe trasformato in regno e avrebbe posto più tardi la sua capitale in una nuova
città, Oviedo, fondata nel 760. Le genti basco-navarresi – che avevano tenuto testa
anche ai visigoti – seppero mantenere dal canto loro l’indipendenza: e si organizzò
così di fatto nel terzo-quarto decennio del IX secolo tra galiziani, cantabrici e
asturiani, con l’appoggio d’un pugno di guerrieri visigoti rifugiati presso di loro,
il piccolo principato di Navarra, che sarebbe divenuto regno circa un centinaio d’anni
più tardi. Dalle Asturie, dalla Navarra e dall’Aragona settentrionale avrebbe preso
l’avvio di lì a poco il movimento della Reconquista.
La battaglia di Poitiers è certo quindi, di per sé, meno importante del mito cui ha
dato origine: ma, per dare un’idea del contesto nel quale va collocata, non si debbono
dimenticare altri episodi molto meno conosciuti ma forse più significativi. Come quello
del capo berbero Munnuz o Musura, che s’insediò a cavallo dei Pirenei orientali, in
Cerdagna, e sposò una figlia del duca Oddone d’Aquitania prima di venire sconfitto
nel 729 dall’emiro di Córdoba al quale si era ribellato; o quello del duca di Provenza
Moronte, che nel 734 aprì ai musulmani le porte di Avignone.
Poitiers non aveva comunque fermato gli infedeli: nel 734 veniva non solo occupata
Avignone, ma anche saccheggiata Arles e corsa l’intera Provenza; nel 737 fu raggiunta
addirittura la Borgogna dove si razziò un’enorme quantità di schiavi da condurre in
Spagna. Ciò provocò le continue campagne di Carlo Martello contro i musulmani del
sud della Gallia fra 736 e 739: ma il doppio gioco e il tradimento imperavano, per
cui nessuna di queste azioni fu davvero efficace. Gli arabo-berberi, con i loro raids, facevano parte di una complessa lotta politica, alla quale solo molti decenni più
tardi sarebbe stato possibile – nella memoria collettiva, nutrita e magari condizionata
dall’epica – attribuire motivi anche religiosi.
Fatti come questi danno comunque ragione alle ansiose voci che cominciavano a levarsi
in Occidente: dalla traduzione latina dello Pseudo-Metodio elaborata nel monastero
benedettino di Saint-Germain fino alle note del Venerabile Beda che, revisionando
nel 735 – quando era ormai prossimo ad abbandonare questa valle di lacrime – la sua
Historia ecclesiastica gentis Anglorum, richiamava con preoccupazione i progressi dei saraceni e menzionava il fatto d’armi
di Poitiers. Le fonti anglosassoni sono un discreto osservatorio per farci comprendere
che forse dell’Islam si conoscevano, sia pure in modo discontinuo e rapsodico, più
cose di quante non si creda: ad esempio, da due sinodi tenuti in quell’area nel 786
si viene a sapere che, probabilmente attraverso l’informazione dei legati papali e
le notizie pervenute dai monaci benedettini nell’isola tanto diffusi, era in qualche
modo conosciuta la tradizione del Ramadhân.
La plurisecolare storia dell’Islam ha peraltro, come sappiamo, conosciuto solo brevi
e rari momenti di unità effettiva: a differenza di quel che si sarebbe ritenuto nel
corso del medioevo, quando si tendeva a scorgere nella sua compagine un’unità simile
a quella che non c’era nemmeno tra i cristiani, per quanto concordemente si dicesse
che avrebbe dovuto esservi. A noi, che a distanza abbiamo recuperato la dovuta prospettiva
globale delle cose, sembra tuttavia che questo pregiudizio degli europei del medioevo
quasi si giustifichi – sia pure a causa di una coincidenza –, quando si consideri
la storia dell’espansione islamica nella prima metà dell’VIII secolo in un’area che
da al-Maghreb al-Aqsa giunge alle frontiere con la Cina e dall’Anatolia si spinge fino al Corno d’Africa.
Nel 717 gli arabi si erano trovati ancora una volta – come circa quarant’anni prima
– sotto le mura di Costantinopoli, e a guidarli era Maslamah, il fratello del califfo
umayyade; il basileus Leone III li aveva respinti a fatica, grazie anche all’uso del «fuoco greco». Intanto,
nel primo quindicennio del secolo VIII, il governatore della Mesopotamia al-Haggiag
sottometteva il Kwarezm, passava l’Oxus (oggi Amu Darya), occupava Buchara e Samarcanda,
giungeva al Belucistan: il potente impero persiano, che per secoli aveva tenuto in
scacco i romani e i bizantini, si era dissolto come neve al sole. La battaglia del
Talas, del 751, segnò il confine tra l’espansione musulmana e quella cinese della
dinastia Tang mediante la spartizione dell’area altaica.
Tuttavia, verso la metà del secolo, questo slancio era sembrato dovunque arrestarsi.
I bizantini, grazie allo sforzo instancabile di Leone III, parvero aver ragione della
pressione musulmana in Asia Minore; la spinta a oriente si fermò al confine con l’impero
cinese; gli stessi arabo-berberi che avevano conquistato la penisola iberica (e ai
quali si erano uniti molti cristiani locali convertiti) videro esaurirsi la loro forza
propulsiva. Nel 732 o 733, sulla strada fra Poitiers e Tours, tutto quel che il comandante
musulmano Abd ar-Rahman voleva (e, intendiamoci, non era poco) era saccheggiare il
santuario nazionale dei franchi, San Martino: non era con ogni probabilità sua intenzione
procedere oltre, né aveva le forze per farlo. Ad ogni modo, come abbiamo visto, fu
fermato. Alcuni anni dopo, nel 759, i franchi guidati da Pipino il Breve – il figlio
del trionfatore di Poitiers – cacciavano gli infedeli da Narbona e li inseguivano
sino ai Pirenei. Fu anche l’eco delle guerre tra franchi e musulmani di questo periodo,
accanto alla troppo celebrata battaglia di Roncisvalle del 778 e agli eventi immediatamente
successivi, a fornire materia per canti epici che avrebbero tuttavia acquistato fama
e sarebbero stati fissati per iscritto soltanto più o meno tre secoli più tardi. Comunque,
dopo Poitiers, i franchi d’Austrasia furono attratti in Aquitania: il che segnò forse
l’esaurirsi di un processo, già avviato, che avrebbe condotto il territorio aquitano
a conseguire una sua più forte identità come attivo «cuscinetto» tra franchi e musulmani.
È difficile a dirsi quanto e in che misura il cruento cambio della guardia califfale
tra umayyadi e abbasidi, nel 750, abbia influenzato la crisi e la battuta d’arresto
di questa prima ondata d’espansione islamica. Certo è che il partito fedele ai deposti
califfi damasceni ebbe nella penisola iberica la meglio, ma non senza un duro confronto
con i partigiani della nuova dinastia: e l’emirato di Córdoba, di formale impronta
legittimista, non ebbe nel paese la vita facile. Anche il frazionamento dell’Islam,
l’insorgere di nuovi califfati, l’offensiva delle «sette» sciito-ismailitiche e la
feroce repressione abbaside furono fattori di fondo del disgregarsi della compagine
musulmana e dell’insorgere di quella crisi, di quella battuta d’arresto nell’espansione.
Carlomagno, tra al-Andalus e Baghdad
Nel 777 il re dei franchi Carlo, figlio di Pipino, si trovava in territorio sassone,
a Paderborn, in piena campagna militare. Gli si presentò Suleiman ben al-Arabi, wali musulmano di Barcellona, Gerona e Saragozza: aveva attraversato – non sappiamo purtroppo
con quale itinerario, e nemmeno con quali disagi – l’intero regno franco per sollecitare
l’aiuto del suo potente vicino cristiano contro la tirannia dell’emiro di Córdoba;
e prometteva la dedizione di molti centri a sud dei Pirenei, a cominciare dalle sue
stesse floride città. La Spagna musulmana – assicurava Suleiman – era irrimediabilmente
divisa: e pochi sforzi sarebbero stati sufficienti a conquistarla. A onta della posteriore
rivisitazione politica ed epica di tutti questi eventi, che li avrebbe coperti di
una spessa patina religiosa, nessun pregiudizio sembra essere affiorato da alcuna
delle due parti contraenti a proposito della differenza di fede, o del fatto che i
musulmani nemici dell’emiro di Córdoba si sarebbero trovati a combattere a fianco
dei cristiani contro dei correligionari.
Nella Pasqua del 778 il corpo franco di spedizione – confortato dalla benedizione
di papa Adriano I – mosse verso la Spagna. Tutto sembrava andare secondo il previsto,
e i musulmani avversari dell’emiro cordobano davano buone prove di fedeltà alla parola
data: il wali batté le truppe emirali, altri suoi colleghi si unirono a lui. Ma, quando i franchi
decisero di acquartierarsi in Saragozza per farne fulcro di una futura campagna lungo
il corso dell’Ebro, a quanto pare la città si ribellò contro di loro e contro il suo
stesso signore; o forse questi – preoccupato per gli eccessivi successi degli infedeli
o poco sicuro che la sua gente l’avrebbe seguito nel perpetuare la ribellione contro
l’emiro – fece un rapido voltafaccia. Le vicende di quel torno di tempo sono ben altrimenti
che chiare: sta di fatto che, rientrata la ribellione contro l’emiro cordobano, a
Carlo non restò che intraprendere la via del ritorno dopo aver fatto per vendetta
radere al suolo – almeno in parte – le mura di Saragozza. Durante la ritirata si verificò
(il 15 agosto, secondo la tradizione più accettata) l’episodio del massacro della
retroguardia franca nelle gole di Roncisvalle da parte dei selvaggi montanari baschi,
ch’erano comunque cristiani: la trasfigurazione poetica di questo modesto fatto d’arme
– trasformato in uno scontro con i mori – l’avrebbe consegnato nei secoli all’immaginario
epico euro-occidentale.
L’emiro Abd ar-Rahman I non tentò sul momento alcuna ritorsione contro l’invasore
al di là dei Pirenei. Ma suo figlio Hisham (788-796) avviò nel 793 una dura offensiva
contro la Settimania franca governata in quel momento da un cugino del re, il duca
Guglielmo. L’ondata musulmana si abbatté ancora una volta contro Narbona, che tuttavia
non fu conquistata; indi si diresse su Carcassonne. Nonostante le perdite subite la
spedizione, guidata da al-Hakam figlio dell’emiro, fu un successo: col bottino frutto
della scorreria, pare si finanziassero in parte i lavori per la costruzione della
grande moschea di Córdoba. Un gran bell’investimento. Intanto, dalle coste di al-Andalus
e da quelle del Maghreb, partivano le prime incursioni navali saracene contro le Baleari,
la gente delle quali si rivolse al sovrano franco, che nel frattempo aveva cinto a
Roma una corona «imperiale», per ottenere aiuto.
In seguito a questi episodi Carlomagno avviò la campagna che avrebbe condotto alla
formazione della Marca di Spagna: il duca Guglielmo fu il protagonista della nuova
impresa, che condusse nell’801 alla conquista cristiana di Barcellona per quanto non
si riuscisse a raggiungere il confine dell’Ebro e a insediarsi stabilmente nella città
alla foce di tale fiume, Tortosa. Tra Barcellona e Tortosa, anzi, si stabilì una «terra
di nessuno» che sarebbe stata conquistata soltanto nel XII secolo grazie alla nuova
avanzata aragonese. Intanto il nuovo imperatore cristiano – al quale i contatti diplomatici
con il wali di Barcellona e con l’imperatrice di Bisanzio, la basilissa Irene, dovevano aver insegnato sulla vastità e la complessità del mondo molte più
cose di quante potesse apprenderne dai dotti colloqui con Alcuino di York e con Paolino
d’Aquileia – si guardava attorno in cerca di nuovi interlocutori che, direttamente
o indirettamente, fossero in grado di aiutarlo a controllare meglio i suoi rapporti
con la penisola iberica. E ne trovava di eccellenti.
Era stato del resto già ampiamente preceduto. Se la monarchia carolingia – erede di
quella merovingia e alleata col papato e quindi collegata agli orizzonti geoculturali
di entrambi – aveva un’idea abbastanza ristretta della situazione politica nel mondo
eurasiatico-mediterraneo dell’VIII secolo, altrove il panorama si dominava da ben
altri osservatorî. Ad esempio da Costantinopoli e da Baghdad, ben attente a sorvegliarsi
a vicenda e a cogliere quindi, nella scacchiera delle forze in presenza, sia i possibili
alleati sia i potenziali «amici dei nemici» e quindi obiettivamente avversari. Alla
corte califfale insediata da poco nella nuova capitale mesopotamica – a poche miglia
dall’antica e gloriosa Ctesifonte – che, fondata nel 762, aveva dapprima ricevuto
l’augurale nome arabo di Medinat as-Salam, «Città della Pace», già vitali erano forse i germi di quel disinteresse per le civiltà
diverse da quella islamica che è stata nei secoli una caratteristica costante della
cultura uscita dalla rivoluzione religiosa di Muhammad e che, a lungo andare, sarebbe
stata una delle componenti della sua crisi moderna; del resto, si guardava semmai
a Bisanzio, all’India, alla Cina, senza troppo preoccuparsi – e in quel periodo non
a torto – di quei barbari dell’estremo nord-ovest che apparivano ben poco degni di
considerazione. Tuttavia, ci si dovette rendere ben presto conto che essi avrebbero
potuto se non altro procurare qualche problema sia agli umayyadi cordobani che si
ostinavano a non riconoscere la nuova autorità califfale, sia all’impero di Rum, quello che noi chiamiamo Bisanzio.
C’era già stato tra 765 e 768 uno scambio di ambascerie tra l’abbaside Abu Giafar
al-Mansur (754-775) e Pipino. Il figlio di questi aveva due buone ragioni per riallacciare
i rapporti col nuovo califfo, il grande Harun ar-Rashid (786-809), il sovrano delle
Mille e una Notte. Anzitutto la situazione iberica, dov’era ormai endemico lo scontro tra gli emiri
di Córdoba che si rifacevano ancora alla vecchia dinastia umayyade (o che accampavano
questo pretesto per una politica e per il mantenimento di un prestigio politico e
religioso loro propri) e i wali che preferivano guardare al «Principe dei Credenti» residente nella lontana Mesopotamia
(o che consideravano il loro lealismo un comodo pretesto per non soggiacere alla dinastia
umayyade trapiantata in al-Andalus); nel 799 il governatore saraceno di Huesca aveva
fatto avere a Carlo in Aquisgrana doni onorevoli e la promessa che la città gli si
sarebbe data, se egli avesse intrapreso una nuova campagna oltre i Pirenei. In secondo
luogo, la città di Gerusalemme, controllata dagli abbasidi ma visitata da un crescente
numero di pellegrini occidentali: desideroso d’inserirsi in qualche modo nel colloquio
tra i chierici e i santuari della Città Santa e la Cristianità – un colloquio che
egli non intendeva lasciare al monopolio dei basileis –, il re franco aveva ricevuto una missione del patriarca gerosolimitano che aveva ricambiato
e dalla quale aveva ricavato benedizioni e reliquie. Gli Annales regni Francorum parlano addirittura della «consegna delle chiavi» della basilica della Resurrezione
con le cappelle del Calvario e del Santo Sepolcro, forse esagerando qualche espressione
di cortesia diplomatica.
Intanto, Carlo – appena quattro anni dopo l’incursione di al-Hakam, e mentre organizzava
la Marca di Spagna – aveva nel 797 inviato un’ambasceria anche al califfo: essa era
costituita dai laici Lantfrido e Sigismondo e dall’ebreo Isacco, che secondo un testo
proveniente dal monastero di Reichenau, i Miracula sancti Genesii, avrebbero fatto il viaggio d’andata insieme con due ecclesiastici inviati da Gebhard
conte di Treviso con l’incarico di procurarsi in Terrasanta delle reliquie dei santi
Genesio ed Eugenio.
Nel giugno dell’801 l’imperatore, che risiedeva in quel momento in Pavia e che appena
due mesi prima aveva congedato i messi del prelato gerosolimitano, ricevette la notizia
che gli ambasciatori del califfo erano approdati nel porto di Pisa: era la risposta
al suo messaggio di quattro anni prima. Si trattava in effetti di un rappresentante
del califfo e di un inviato dell’emiro di al-Abbasiya (oggi Fostat in Tunisia), i
quali gli annunziarono che l’unico superstite dei tre ambasciatori da lui inviati
alla corte di Baghdad nel 797, l’ebreo Isacco, era di ritorno in Europa con i doni
del Principe dei Credenti: ma si era dovuto arrestare sul litorale africano in quanto
uno di essi era piuttosto ingombrante.
Fu pertanto inviata una squadra navale franca a rilevare Isacco, il quale nell’ottobre
successivo poté sbarcare a Portovenere recando con sé, fra le altre cose, il dono
che l’imperatore attendeva con ansia: l’elefante Abul Abbas. Ma non era certo il caso
di costringere il bestione ad affrontare un viaggio alpino d’inverno, dato che intanto
Carlo aveva fatto ritorno alla sua Aquisgrana. Egli fu costretto dunque ad attendere
il luglio dell’802 prima di potersi incontrare con quell’animale di cui tanto sovente
parlano le storie romane ma di cui non si vedevano più esemplari in Occidente da molti
secoli. Purtroppo Abul Abbas non sopportò a lungo il clima renano, duro per lui che
proveniva dalla calda India (era infatti di là che s’importavano in Persia gli elefanti
domestici). Si spense malinconicamente nel giugno dell’810, accompagnato dal dolore
del sovrano franco che gli si era affezionato e dalla curiosità della gente che si
aspettava di veder le sue ossa trasformarsi in avorio, secondo la leggenda.
È comunque probabile che, a parte l’elefante, Harun avesse offerto a Carlo qualche
prerogativa sia pur soltanto onorifica sul Santo Sepolcro di Gerusalemme (il che era
evidentemente una mossa tesa a ridimensionare la tradizionale auctoritas che il basileus deteneva sui Luoghi Santi cristiani); e che in qualche modo – ma le fonti arabe tacciono
– la vera questione trattata fra i due fosse quella spagnola. Meno probabile che si
sia parlato anche di faccende economiche: i pallia fresonica inviati in dono da Carlo a Harun, buone stoffe di lana, non erano certo tali da abbacinare
comunque col loro splendore la corte di Baghdad; e le molte merci e monete musulmane
segnalate dal cronista Teodulfo d’Orléans nell’812 nella Gallia meridionale, dov’era
attivo il grande porto di Marsiglia, non sembrano comunque poter testimoniare rapporti
particolarmente stretti con l’Oriente (anche perché, a parte le perle, gli articoli
provenienti dal mondo musulmano ivi reperibili dovevano esser tutti di fonte iberica
o nordafricana). Comunque, nell’807, Carlo ricevette un’altra ambasceria dal califfo;
e nello stesso anno un’altra legazione del patriarca di Gerusalemme.
Preoccupato per i rapporti diplomatici tra Aquisgrana e Baghdad e per le continue
sollevazioni all’interno del suo regno, che avevano toccato anche Córdoba e Toledo,
l’emiro umayyade al-Hakam (796-822) si rassegnò ad accettare il fatto che la frontiera
con il regno dei franchi giungesse fino all’Ebro. Ne derivò una serie di trattati
fra lui e Carlo, nel biennio 810-12. Ma le insurrezioni nella Spagna musulmana continuavano:
quella di Córdoba dell’814 poté venir domata solo a prezzo d’una sanguinosa repressione
da parte della guardia emirale, gli schiavi-soldati detti «mamelucchi» (dall’arabo
mamluk, «posseduto», «schiavo»). Né le cose migliorarono con il successivo emiro Abd ar-Rahman
II (822-852), che dovette affrontare la ribellione di Mérida e di Toledo e che tentò
invano di riconquistare Barcellona: una mossa maldestra ch’ebbe anzi l’effetto – anche
grazie alla tempestiva risposta del duca Bernardo di Settimania – di consolidare la
nascente identità catalana.
Nuove nubi si addensavano intanto all’orizzonte mediterraneo, quindi anche euromeridionale.
Le incursioni normanne che attaccarono e desolarono i litorali europei in quel secolo
e nei primi anni del successivo sono considerate – insieme con quelle marittime dei
saraceni e quelle per via terrestre degli ungari – tra i fattori determinanti della
crisi di quel periodo: caratterizzato anche dalla polverizzazione del potere nelle
aree interessate dall’esperienza carolingia, dalle lotte tra i regni della cosiddetta
«eptarchia» in Inghilterra e dalla depressione socioeconomica. Richiamando questo
quadro, si deve però tener presente che l’Islam stava attraversando a sua volta una
fase d’intensi mutamenti. L’immensa compagine del califfato di Baghdad perse progressivamente
il controllo di vasti e ricchi territori periferici, a ovest del Sinai e a nord-est
della Persia propriamente detta. Emersero nuove egemonie dinastiche: gli aghlabiti
si resero autonomi in Tunisia ai primi del IX secolo e intrapresero a partire dall’827
una campagna d’invasione della Sicilia che li avrebbe condotti, in circa settantacinque
anni, al possesso dell’isola; i tulunidi conseguirono il controllo dell’Egitto nell’869;
fra Transoxiana, Kwarezm e Seistan un’area immensa – compresa tra Sir Darya, lago
d’Aral e Oceano Indiano – venne progressivamente controllata da tahiridi, safawidi
e samanidi, mentre alla fine del IX secolo una rivolta di «eretici» qarmati, avviata
nel Bahrein sulla costa araba del Golfo Persico, danneggiava il commercio da e per
Bassora e di conseguenza l’economia della capitale, spostando verso il Corno d’Africa
e il Mar Rosso il flusso delle merci che dall’Estremo Oriente erano dirette all’Egitto,
al Mediterraneo e a Bisanzio.
Intanto i normanni, feroci incursori sulle coste europee, non risparmiavano quelle
di al-Andalus. Nell’844 una cinquantina di poderose navi, dopo aver assalito Nantes
e circumnavigato le coste atlantiche della penisola iberica tentando di saccheggiare
Lisbona, si presentò alla foce del Guadalquivir; da lì, un gruppo di vascelli si diresse
su Cadice mentre il grosso della flotta navigava fino a Siviglia, la conquistava sottoponendola
a un terribile saccheggio e ripiegava sotto la pressione degli ibero-musulmani, che
seppero tuttavia rispondere adeguatamente, sconfissero gli assalitori e li costrinsero
a reimbarcarsi precipitosamente. Un buon numero di prigionieri normanni, catturati
in quell’occasione, sarà andato ad accrescere col tempo la vasta schiera degli spagnoli
musulmani biondi e dagli occhi azzurri, eredi dei vandali e dei goti, cui si sarebbero
aggiunti i molti schiavi provenienti dal mondo slavo (la parola, «schiavo» appunto,
è lì a testimoniarlo).
L’assalto normanno dell’844-45 indusse l’emiro umayyade alla costruzione dei ribat, una catena di fortini costieri non dissimili dalle nostre vecchie, gloriose «torri
saracene» che disseminano le coste europee fino all’Egeo. I ribat furono affidati alle cure di volontari, i murabitùn, che vi si insediarono per adempiervi ai doveri dello jihad e condurvi al tempo stesso una vita di preghiera. Grazie a loro, i normanni furono
da allora in poi tenuti lontani da al-Andalus: per quanto nell’859 riuscissero a incendiare
la moschea di Algeciras mentre oltre un secolo dopo, nel 966, i danesi, guidati nientemeno
che da Harald Blåtand («Dentazzurro»), infliggevano presso Lisbona agli arabo-iberici
un’altra sonora sconfitta.
I musulmani non furono quindi per nulla esclusivi protagonisti delle incursioni lungo
le coste sudeuropee e nelle isole mediterranee che caratterizzarono i due secoli finali
dell’alto medioevo, tra i più duri della storia d’Europa: anzi, ne furono come s’è
visto talvolta le vittime. Certo però gli europei occidentali considerarono gli Agareni i primi e forse più diretti responsabili di esse; col tempo, la memoria degli assalti
nel bacino mediterraneo e delle guerre nella penisola iberica si sarebbe anzi ingigantita,
sarebbe stata ripercorsa e veicolata dalla tradizione epica e sarebbe stata a torto
o a ragione considerata la «sfida» alla quale le crociate si sarebbero incaricate
di fornire una «risposta». Nell’Europa medievale, la memoria delle incursioni normanne
e ungare del IX-X secolo si andò perdendo in quanto quei due popoli si erano convertiti
ed erano entrati a far parte della Cristianità latina. I «saraceni» divennero pertanto
gli unici responsabili dell’assalto dei barbari all’Europa in quei due secoli: e si
andò elaborando quel patrimonio di leggende e di gesta epiche su cui si sarebbe fondata
una lunga tradizione posteriore, rinfrescata nei secoli XIV-XVIII dagli eventi connessi
con la minaccia ottomana e barbaresca, che aveva connotati differenti dalla «prima
ondata» musulmana dei secoli VII-X ma che fatalmente la richiamava.
Una contesa per mari, isole, coste
Non si sono mai davvero placate le polemiche suscitate dalla celebre tesi di Henri
Pirenne a proposito della rottura dell’unità mediterranea dovuta al rapido insorgere
dell’Islam e quindi al ripiegamento dell’Europa occidentale su se stessa, al suo ruralizzarsi,
insomma all’inizio del «medioevo»: da situarsi quindi non più dalla caduta dell’impero
romano d’Occidente, ma dalla seconda metà del VII secolo. Quel che oggi appare comunque
chiaro è che una crisi economica e commerciale era già in atto da ben prima del VII
secolo, e che una forte decadenza segnò traffici e livelli di vita soprattutto mediterraneo-occidentali
fra VI-VII e IX-X secolo: ma che l’una e l’altra furono segnate da un processo lento
e dovute a una serie di concause, e che non è pertanto accettabile il ricondurle al
solo effetto della pressione esercitata dalla marineria saracena. La teoria pirenniana
è stata sostanzialmente confermata nel suo nucleo, ma smentita nella sua genesi. L’attività
corsara dei musulmani ebbe comunque un peso notevole, in qualche caso determinante,
nel prodursi della crisi e negli effetti tanto socioeconomici quanto mentali e culturali
da essa provocati: drastica flessione delle attività nautiche, impicciolirsi o addirittura
scomparire di porti e centri costieri cristiani, impoverimento diffuso, contrarsi
e rarefarsi dell’economia monetaria, ansia e paura diffuse.
Fu dunque dalle coste della Spagna e dell’Africa islamizzate che cominciarono i raids contro le isole e i litorali cristiani del Mediterraneo occidentale. Fin dall’VIII
secolo le incursioni colpivano non solo le isole greche, ma anche la Sicilia e la
Sardegna: esse provocavano la rovina dei nuclei insediativi costieri e la fuga della
popolazione nell’impervio, più sicuro centro isolano. Di solito l’obiettivo degli
incursori era la razzia rapida, il prelievo di gente prevalentemente giovane con cui
alimentare il commercio degli schiavi, l’occasionale imposizione di tributi e di riscatti:
più di rado il raid aveva come esito l’impianto di un «nido» corsaro, che potremmo considerare una piccola
colonia commerciale-militare.
Sappiamo che già dal 798 le Baleari erano state investite, anche se la loro definitiva
conquista da parte di un capo islamo-iberico si sarebbe avuta solo nel 902. L’avvio
dell’occupazione della Sicilia da parte dell’emiro aghlabita Ziyahad Allah I, nell’827,
segnò il vero punto di partenza di quasi due secoli di supremazia saracena in tutto
il vasto specchio d’acque compreso tra penisola iberica, penisola italica e Maghreb.
I bizantini contrastarono comunque con valore l’avanzata musulmana nell’isola, specie
nell’area orientale: solo ai primi del X secolo essa poté dirsi conclusa. La conquista
di Creta nell’827 e di Malta nell’870 aveva tolto a Bisanzio le basi che le consentivano
d’intervenire efficacemente nel Mediterraneo occidentale: da allora, Sicilia e Sardegna
furono abbandonate al loro destino.
Si sono trattati un po’ troppo spesso, in passato, le incursioni e gli insediamenti
o i tentativi d’insediamento saraceni come l’esito di un’autonoma volontà espansionistica,
all’origine della quale c’erano scelte precise. Non sempre capitava così. Al contrario,
spesso i saraceni s’inserivano in contese locali magari prendendo inizialmente partito
per questo o quello dei contendenti: e non di rado erano anzi proprio questi a chiamarli.
Ad esempio, quelli che stavano conquistando la Sicilia, e che anzi avevano da poco
preso Palermo, furono in più occasioni invitati dai reggenti della città di Napoli
ad aiutarli contro longobardi e bizantini. Abilissimi nello sfruttare la confusione
e la debolezza dei differenti poteri che si agitavano discordi nell’Italia meridionale,
i saraceni si ponevano senza scrupoli al servizio ora di questo ora di quello e la
facevano in realtà da padroni.
Troppo tardi le città campane, che avevano creduto di potersi impunemente servire
degli arabo-berberi, si accorsero dell’errore commesso. Si unirono quindi ai principi
longobardi per implorare di nuovo aiuto dall’imperatore romano-germanico Lotario (840-855):
che però non si sarebbe forse mosso se ormai i saraceni che occupavano parte della
penisola non si fossero sentiti tanto sicuri da spingersi nell’846 fino a Ostia, risalire
il Tevere e darsi al saccheggio della basilica di San Pietro.
La misura era piena. Ludovico, figlio dell’imperatore Lotario, scese nella penisola
con un esercito composto di franchi, burgundi, provenzali, cui si erano uniti il papa
Sergio II (844-847), il doge di Venezia e i duchi di Spoleto e di Napoli. Ma intanto
il principe beneventano aveva a sua volta assoldato dei mercenari musulmani che ormai
agivano incontrollati e si erano dati a scorrere e a saccheggiare tutto attorno, spingendosi
fino alle terre del monastero di Montecassino.
Adelchi di Benevento non aveva scrupoli nel servirsi di quei pur indisciplinati mercenari.
Obbligò quindi i baresi, che gli erano rimasti fedeli, ad accettare la protezione
del capo berbero Khalfun, che proveniva forse dalla Sicilia attraverso Taranto: in
pagamento gli permise di saccheggiare e incendiare degli edifici sacri, e il berbero
andò tanto oltre da radere praticamente al suolo la città di Capua, più tardi ricostruita.
Nell’848, Khalfun era finalmente padrone della bella capitale pugliese. Il principe
Ludovico, giunto nel Meridione d’Italia appunto allora, poté soltanto liberare Benevento
dai mercenari che l’avevano in pugno e mettere pace tra i principi longobardi contendenti
fungendo da garante per la suddivisione del territorio beneventano nei due principati
di Benevento e di Salerno e nella contea di Capua.
Non era una soluzione onorevole: e, comunque, papa Leone IV (847-855) – che stava
cingendo di mura l’area di San Pietro trasformandola in cittadella affinché non si
ripetesse la profanazione dell’846 – non ne era né tranquillizzato, né soddisfatto.
Fu sotto il suo patrocinio che nell’849 una flotta messa insieme dai campani batté
i saraceni al largo di Ostia. Si mosse di nuovo contro Bari Ludovico, che intanto
aveva cinto la corona imperiale come coreggente e all’impresa era spinto dalle suppliche
degli abati di Montecassino e di San Vincenzo al Volturno: ma i principi longobardi
lo appoggiarono con tanta pigrizia e tanta ipocrisia da indurlo a ritirarsi indignato
e senza nulla aver concluso. Bari continuò ad esser governata da un emiro che taglieggiava
i beni delle due illustri abbazie e si destreggiava tra i poteri locali, non trascurando
tuttavia di concedere con benevolenza – ma a pagamento – salvacondotti per i pellegrini
europei che dalla sua città passavano per cercare un imbarco verso la Terrasanta e
di trattare con molta cordialità la prospera, dotta comunità ebraica di Oria.
L’imperatore Ludovico II non aveva comunque inghiottito il rospo del suo smacco pugliese.
Una volta rimasto solo a governare ritentò dunque la conquista, sollecitato dall’abate
di Montecassino nonché dai signori longobardi di Benevento e di Capua (ma non da quello
di Salerno, in disaccordo con loro). Ci è stato tramandato il progetto della nuova
impresa, affidato alla Constitutio dell’865 che prevedeva una concentrazione di truppe a Lucera nel marzo successivo.
Occorse tuttavia ancora un anno perché l’imperatore vincesse le diffidenze e sventasse
i doppi e tripli giochi dei suoi infidi sudditi longobardi e campani. La campagna
aperta nell’867 si concluse dopo complesse vicende quattro anni più tardi, nell’871.
Giovandosi anche delle truppe franche inviategli dal fratello Lotario II (ma colpite
da un’epidemia di peste), dell’appoggio d’una flotta bizantina e di una veneziana
con rinforzi croati e dalmati nonché dell’alleanza del principe beneventano Adelchi
e della gente di Gaeta (non di quella di Napoli, che offriva al contrario il suo porto
alle marinerie saracene), l’imperatore poté infine avere la meglio sull’ultimo emiro
di Bari, Sadwan, che si era battuto come un leone – riuscendo anche a saccheggiare,
durante una sortita, il santuario dell’arcangelo Michele sul Gargano – e che ottenne
di ritirarsi a Benevento in dorata prigionia presso il quasi amico principe Adelchi.
Fu un errore la magnanimità dell’imperatore nei confronti dell’emiro? Certo, Bari
era riconquistata e la gloria che dall’impresa egli aveva ricavato era davvero grande.
Ma intanto l’impero bizantino, a sua volta uscito da una lunga crisi, si andava riorganizzando
grazie all’opera energica e spregiudicata di Basilio I (867-886), il fondatore della
dinastia macedone: il quale aveva con la sua flotta molto favorito la vittoria del
«re dei teutoni» Ludovico – si guardava bene dal considerarlo un collega nel rango
imperiale –, ma non aveva alcuna intenzione di consentirgli di affermare la sua autorità
su quell’Italia meridionale che ormai, dai tempi della riconquista della penisola
da parte di Giustiniano, i basileis di Costantinopoli consideravano loro territorio, ch’era ricca di tante importanti
città portuali dominando le quali si controllava l’accesso all’Adriatico e dove la
cultura greca aveva tanto profonde radici. Le trame di Basilio I e di Sadwan ebbero
l’effetto sperato: una rivolta dei longobardi di Benevento rese prigioniero l’imperatore
per quasi due mesi, tra l’agosto e il settembre dell’871, mentre l’emiro di Qairawan
spediva in Puglia un nuovo esercito invasore, stavolta forte di circa 20.000 uomini,
che investiva con furia Calabria e Campania. Ludovico II trovò l’energia di contrattaccare
e vinse i musulmani nell’873 a Capua: ma morì due anni dopo.
Intanto, i saraceni non cessavano di agire dalla loro residua piazzaforte di Taranto,
grande nodo del commercio degli schiavi. Da lì si minacciavano le terre di Puglia
e di Campania fino al Volturno. I baresi non avevano ormai più da parte loro motivo
di mantenere il loro legame con l’impero germanico: difatti, nell’876 si rivolgevano
alle autorità bizantine di Otranto ottenendo che la loro città divenisse il capoluogo
del thema di Longobardia. I bizantini riuscivano nell’880 a riconquistare anche Taranto: ma
non erano in grado d’impedire ai musulmani di perpetrare le loro scorrerie in Adriatico
giungendo addirittura fino a Comacchio e a Grado.
Gli arabo-berberi erano difatti lungi dall’esser battuti. Mentre completavano l’occupazione
della Sicilia con la conquista di Siracusa nell’878 e di Taormina nel 902, essi penetravano
in Campania, si alleavano con Capua e con Salerno, giungevano di nuovo ai territori
controllati dal vescovo di Roma obbligandolo a pagare un tributo, distruggevano le
abbazie di San Vincenzo al Volturno e di Montecassino, stabilivano alla foce del Garigliano
nell’882 una base che consentiva di tenere sotto tiro anche la città di Roma: solo
nel 915 quell’incubo fu rimosso.
Da parte loro gli emiri kalbiti, una volta insediati in Sicilia sotto la formale autorità
dei califfi fatimidi del Cairo, poterono darsi nel corso del X secolo all’attacco
sistematico delle coste dell’Italia meridionale, soprattutto di quelle pugliesi e
calabresi. Occasionali teste di ponte – come Agropoli in Campania e Santa Severina
in Calabria – resisterono molto tempo. Il tentativo dell’imperatore sassone Ottone
II, che lanciò una nuova energica campagna a somiglianza di quel che aveva fatto il
suo predecessore Ludovico II un secolo prima, s’infranse nel 982 presso Capo Colonna.
Da allora, si può dire che l’offensiva saracena nell’Italia meridionale non conoscesse
argine fino alla morte, nel 1036, dell’emiro al-Akhal cui seguì un’irreversibile polverizzazione
politica dell’Islam siculo. Sardegna e Corsica restarono fino ai primi dell’XI secolo
un no man’s land, i cui porti erano tutti controllati dai saraceni.
Si andavano rafforzando frattanto le basi costiere maghrebine, fondamentali punti
di forza della talassocrazia musulmana nel Mediterraneo occidentale. Tra 915 e 920
venne fondata la città-fortezza di al-Mahdiyah sul litorale del Sahel, più o meno
all’altezza dell’isola di Pantelleria; nel 960 il capo berbero Buluggin ibn Ziri fondava
Algeri; più tardi, sulla costa tra Algeri e Bona, era fondata nel 1060 la città di
Bujjiah.
Anche nello scacchiere mediterraneo di nord-ovest la guerra corsara saracena imperversava
partendo dalle basi spagnole e insulari. Verso l’890, cioè quasi contemporaneamente
rispetto all’insediarsi dei saraceni sul Garigliano, altri musulmani erano arrivati
sulla costa provenzale: da lì un gruppo di loro riuscì a organizzare un formidabile
nido a Fraxinetum (oggi La Garde-Freinet), non lontano da Saint-Tropez, da dove non
solo tormentava le coste – fino a Marsiglia, a Tolone, a Nizza – e l’entroterra adiacente,
ma riusciva anche a organizzare spedizioni verso luoghi relativamente lontani. Giunse
addirittura all’arco alpino occidentale, dove assaliva le carovane di pellegrini e
di mercanti in transito: nel 906 distrusse il monastero della Novalesa.
La zona fra il golfo del Leone e il Tirreno era intanto battuta anche dai corsari
provenienti dall’Ifriqiya: come quelli di al-Mahdiyah che, tra 934 e 935, giunsero
ad assalire Genova. Ma i corsari di Fraxinetum, che erano riusciti a stipulare anche
accordi con alcuni domini loci, ad esempio con Ugo di Provenza, finirono con l’esagerare: nel 972-73 misero le mani
– casualmente? involontariamente? – su un monaco cluniacense con l’intenzione di sequestrarlo
e chiederne il riscatto. Quel monaco era san Maiolo, il grande abate di Cluny: tanto
ardire obbligò l’aristocrazia provenzale a muoversi per farla finita una volta per
tutte col nido di Fraxinetum.
Erano solo dei corsari, o addirittura dei pirati, i creatori e gli animatori di questi
nuclei costieri saraceni che sovente riuscivano a controllare anche estese aree dell’entroterra?
La loro attività non si differenzia da quella che di lì a pochi decenni avrebbe cominciato
ad esser caratteristica anche delle città marinare delle coste italiche. Anzi, le
somiglianze tipologiche fra loro sono molto forti, per quanto senza dubbio la precedenza
cronologica, quindi l’iniziativa, spetti ai musulmani; il che del resto, ponendo il
problema della rinascita (o della nascita tout court) delle potenze cittadine costiere dell’Europa occidentale cristiana, colloca l’espansione
islamica tra i fattori che la provocarono. Non a caso i rapporti sul mare tra potenze
cristiane e potenze islamiche (qualunque fosse la loro relativa entità) erano caratterizzati
da colpi di mano e scontri navali alternati a un discreto buon vicinato commerciale.
Va semmai notato come l’iniziativa s’invertì attorno agli inizi dell’XI secolo: prima
di allora erano stati gli insediamenti saraceni quelli costantemente più attivi e
dinamici; da allora in poi essi sarebbero passati sulle difensive mentre quelli cristiani
registravano crescita e potenza sempre maggiori.
Uno dei fattori principali dello sviluppo di queste piccole «repubbliche» di marinai-corsari-mercanti
musulmani (chiamati in arabo «gente di mare», bahriyun)era la cattura e il commercio degli schiavi: tipico al riguardo lo sviluppo di Almeria
durante il X secolo, dovuto appunto principalmente a quella fiorente attività. I saqaliba, gli schiavi bianchi, erano una merce particolarmente ricercata: di un’operazione
specialistica, la loro castrazione, si occupavano gli ebrei della vicina Pechina.
Diversamente andavano le cose nel bacino orientale del Mediterraneo: grazie alla controffensiva
sostenuta dai basileis della dinastia macedone, le isole di Cipro e di Creta rientrarono, nella seconda
metà del X secolo, sotto il controllo bizantino. Anche i commerci, dopo la fase più
critica dell’espansione musulmana sul mare tra seconda metà del VII e primi dell’VIII
secolo, andavano pian piano riprendendosi: per quanto gli europei occidentali non
ne fossero certamente i protagonisti né i clienti migliori. Attorno alla metà del
IX secolo Ibn Khurdhadhbah, nel suo Libro delle rotte e dei regni, parlava di mercanti provenienti dall’Europa occidentale e certo là residenti, ma
non propriamente definibili come europei occidentali: gli ebrei detti «radaniti» (insediati
cioè alla foce del Rodano?) che recavano in Oriente merci occidentali come schiavi,
armi e pellicce, le sbarcavano nei porti del delta del Nilo, di là le facevano proseguire
via terra a dorso di cammello fino al Mar Rosso e le imbarcavano quindi per i porti
arabi di al-Jar e Gedda, poi verso l’India e la Cina. Da quei lontani paesi importavano
poi muschio, legno di aloe, canfora e cardamomo che facevano giungere non solo in
Egitto, ma fin a Costantinopoli e alle pur, al confronto, rozze corti dell’Europa
occidentale. È tuttavia rilevante che il commercio e di conseguenza il sapere geografico
arabo-musulmani non paiano tra IX e X secolo interessati quasi per nulla al Tirreno
a nord di Amalfi o di Gaeta né al mondo europeo occidentale. La tendenza tipica della
cultura musulmana tradizionale, consistente nell’ignorare quelle diverse da lei, si
era manifestata fino dai primi anni dell’Islam.
Naturalmente, tuttavia, le occasioni di contatto – a parte quelle militari e quelle
mercantili – non mancavano. Sovente, una di esse poteva essere la prigionia o la schiavitù,
magari temporanea. Come successe forse alla fine del IX secolo a un tale Harun ibn
Yahya – dal nome non si capisce se cristiano o musulmano – il quale fece, suo malgrado,
un bel viaggio che lo condusse a visitare una dopo l’altra le «due Roma»: la Nuova
e la Vecchia. Difatti, fu catturato sul litorale palestinese forse durante una spedizione
corsara: ma non è chiaro se fosse stato preso da corsari magari bizantini o se appartenesse
egli stesso a un equipaggio corsaro arabo (nel quale non è detto non vi fossero anche
cristiani) che, assalendo una nave greca, aveva avuto la peggio. Fu condotto schiavo
a Costantinopoli: da lì, non sappiamo come né perché (forse al seguito di un’ambasceria
bizantina), risalì la penisola balcanica e attraverso il Veneto giunse in Italia,
che percorse fino alla città di Roma. Le sue peripezie e le sue esperienze ci sono
pervenute attraverso il racconto del geografo Ibn Rusta, del X secolo. Aderendo agli
schemi leggendari, di tipo analogo a quello da cui sarebbero sorti i Mirabilia – già vivi nel mondo bizantino, che li aveva passati a quello islamico –, il testo
che narra quelle peripezie ci parla degli argini di bronzo fra i quali scorre il Tevere,
del prodigioso uccello-automa in cima a una colonna dinanzi a San Pietro, delle infinite
ricchezze e della numerosa popolazione d’una città che invece, tra IX e X secolo,
risulta essere stata alquanto spopolata e depressa.
Più realistici i dati offertici dall’irakeno Ibn Hawqal, che verso la metà del X secolo
compì un lungo viaggio dalla Persia alla Spagna e descrisse la Palermo musulmana,
ma si addentrò anche nel Meridione peninsulare italico allora longobardo e bizantino:
visitò Salerno, Melfi e la stessa Napoli dove afferma di aver apprezzato personalmente
la qualità dei lini, uno dei più pregiati articoli d’importazione della città.
Ma, fra i non troppi articoli d’esportazione che il mondo «franco» poteva offrire
a quello musulmano, il più ambìto era il ferro: soprattutto se sotto forma di quelle
«spade franche» che per solidità e bellezza erano paragonabili solo al gauhar, l’acciaio bianco yemenita, bello – si diceva – come una stoffa preziosa. Altra merce
molto apprezzata, che poteva provenire dal «paese dei franchi» o dal mondo bizantino
attraverso i fiumi russi e il Mar Nero nel dar al-Islam, era il legname. Non stupisce difatti, proprio per questo, che nell’813 papa Leone
III informasse Carlomagno che alcuni ambasciatori saraceni avevano preferito compiere
un viaggio in Sicilia su navi veneziane, «in navigiis Beneticorum». La notizia conferma
non solo la penuria di legname del mondo islamico e quindi le difficoltà con cui le
stesse marinerie maghrebine dovevano lottare, ma anche la frequenza con cui i veneziani
si recavano nei paesi musulmani. A somiglianza di Bisanzio, i veneziani avevano molto
per tempo emanato leggi secondo le quali non si doveva commerciare con Alessandria
e con l’Egitto conquistato dai musulmani, e in genere con nessuna terra occupata dalla
nefandissima gens Sarracenorum. Ma l’episodio del trafugamento da Alessandria a opera di mercanti veneziani, nel
secondo terzo del secolo IX, delle reliquie dell’evangelista Marco parrebbe voler
nobilitare e a modo suo obliterare l’infrazione a una norma che non doveva comunque
essere granché osservata, se ancora nel 960 si ribadiva il divieto della compravendita
di schiavi e del trasporto di passeggeri stranieri su vascelli di Venezia; e nel 971,
in un altro documento, si ammetteva che i veneziani erano soliti recare legname, metalli
e armi da vendere sui mercati di Alessandria. Vero è d’altronde che di lì a poco il
panorama economico e commerciale veneziano sarebbe mutato del tutto col doge Pietro
II Orseolo (991-1008), il conquistatore dell’Istria e della Dalmazia, al quale si
dovette una profonda ridefinizione dei rapporti mercantili sia con Costantinopoli
– come si vede dal celebre crisobollo del 992 – sia con il califfo fatimide del Cairo.
Poco sappiamo riguardo agli accordi con l’Egitto, ma dev’esser comunque già da allora
decollata la solida e duratura amicizia tra Venezia e tale paese: essa sarebbe sostanzialmente
rimasta ben ferma nei secoli superando anche gli shocks del movimento crociato, dell’abbattimento del califfato fatimide nel XII secolo, del
colpo di mano mamelucco del XIII.
La rarefazione di fonti scritte tanto dirette quanto riflesse sul commercio tra mondo
musulmano e mondo «franco» fra IX e X secolo (e pensiamo soprattutto ai fondi, pur
importantissimi, della Geniza del Cairo) è per la verità in parte contraddetta dai
molti reperti messi di recente a disposizione degli studiosi dall’archeologia subacquea
– relitti navali e materiale ceramico –, che proverebbero una discreta circolazione
di merci nel Tirreno settentrionale in quel periodo: le incursioni corsare non impedivano
insomma il commercio, bensì a quel che pare vi si accompagnavano.
L’importanza ormai assunta dal commercio arabo nel Mediterraneo si riscontra anche
dalla diffusione delle monete musulmane, che ben presto affiancarono e in molte aree
sostituirono o comunque in parte soppiantarono l’egemonia del denarius bizantino, il celebre «iperpero» o «bisante». A somiglianza del denarius, il dinar arabo – conosciamo bene le coniazioni arabo-sicule – pesava 4,25 grammi d’oro: ma
più diffuso di esso era il quarto di dinar, il ruba’i, che si diffuse rapidamente non solo in Sicilia ma anche nell’Italia meridionale
peninsulare dove assunse quel nome di tarì (dall’arabo tarid, «fresco»: quindi, moneta appena coniata) che resterà poi tradizionale nella monetazione
di quell’area fino a tempi recenti. Le specie argentee erano essenzialmente rappresentate
dal dirham (il nome, passato attraverso il persiano, deriva da «dracma») di grammi 2,90 e dalla
piccola kharruba di 2 decigrammi. I tarì erano talmente richiesti e diffusi che nel X secolo gli amalfitani e i salernitani
ne producevano imitazioni che tuttavia si riconoscono bene in quanto caratterizzate
da iscrizioni in caratteri cosiddetti pseudocufici, che richiamano l’alfabeto arabo
ma sono, in realtà, privi di senso. Anche nella Rus’ circolava la moneta araba: meno
l’aurea, che probabilmente veniva tesaurizzata con molta cura – anche a causa della
cronica penuria di metalli nobili in quell’area –, molto però l’argentea: «la moneta
antico-russa nogata corrispondeva al dirham arabo e traeva il proprio nome dall’arabo nagd, la ‘moneta buona’».
Crisi e trasformazione nell’Islam. L’Oriente
Commerci e scorrerie s’intersecano strettamente nella storia mediterranea dei secoli
VIII-XI: al punto che non sempre si riesce a distinguere con chiarezza gli uni dalle
altre. Certo comunque è che le condizioni create nel Mediterraneo del VII secolo dall’irruzione
dell’Islam si erano andate modificando non gradualmente – anzi, in modo molto discontinuo
e non esente da fasi di ripetuta inversione di tendenza – soprattutto a partire dalla
seconda metà del X secolo. Per una sorta di simmetria in apparenza – ma spesso anche
nella sostanza – del tutto casuale, magari di una serie di fortuite coincidenze (sostenute
però da elementi obiettivi di crisi istituzionale e strutturale all’interno della
compagine islamica), l’offensiva musulmana in tutto il Mediterraneo occidentale e
nell’entroterra adiacente andò esaurendosi o arrestandosi un po’ dappertutto. Ciò
accadde, per motivi molteplici e indipendenti fra loro, tra la fine del X secolo e
nel corso del primo terzo dell’XI.
L’autorevolezza del califfato abbaside di Baghdad era scossa dalla nascita di due
califfati concorrenti, l’umayyade sunnita di Córdoba nel 929 e il fatimide sciita-ismailitico,
sorto tra i berberi dell’Algeria orientale nel 910 ma insediato nella nuova città
egiziana del Cairo. Essa, fondata nel 969, era destinata a un grande avvenire in quanto
emporio nilotico al quale giungevano le merci provenienti dallo Yemen, da Zanzibar,
dall’Etiopia (ma anche le preziose spezie dell’India e della Cina) che approdavano
ad Aydhab sul Mar Rosso e da lì, superato a dorso di cammello un breve tratto desertico,
proseguivano per via d’acqua lungo il Nilo sino ai porti del delta. Alla metropoli
egiziana affluiva anche l’oro delle miniere non solo della Nubia – ormai in via di
esaurimento – ma anche del Sudan: lo trasportavano gli emissari dei re del Ghana,
che insieme al prezioso metallo giallo commerciavano l’oro bianco (l’avorio) e l’oro
nero (gli schiavi africani). Il nascere della nuova potenza egiziana, ormai indipendente
dal califfo abbaside e in concorrenza quando non addirittura in aperta lotta con lui,
fu solo uno degli aspetti – e da un certo punto di vista dei sintomi – della decadenza
del califfato di Baghdad, che aveva a che fare anche con rivolte continue sostenute
dalle «sette» kharigita e qarmata. Ciò provocò una progressiva tendenza, da parte
dei califfi, ad affidarsi alla protezione dei mercenari turchi provenienti dall’Asia
centrale, che si erano islamizzati nel corso del X secolo ed erano penetrati all’interno
dell’impero anche grazie alla complicità della dinastia persiana dei samanidi ai quali
era affidata la custodia dell’area nordorientale della compagine abbaside. Alla fine
di quel secolo il khan turco Alp-Tegin aveva approfittato della debolezza dei samanidi
per occupare Gazna, nell’odierno Afghanistan, fondandovi una splendida corte ospite
della quale sarebbero stati anche lo scienziato al-Biruni e il poeta Firdusi. Nel
999, intanto, i turchi karakhanidi occuparono la città di Buchara fondandovi una nuova
dinastia. I principi e i governatori persiani vennero un po’ dappertutto soppiantati:
e i califfi dovettero adattarsi ai nuovi arrivati turchi, musulmani sunniti neofiti
e dunque intransigenti. Tra loro si erano ben presto distinti i membri di una federazione
di tribù detta Oghuz, che nella metà del secolo si era andata insediando nei pascoli
a nord del Mar Caspio e del lago d’Aral e che – in omaggio a un capostipite-eponimo
semileggendario, Seljuk – era ormai conosciuta come «selgiuchide».
I turchi selgiuchidi, inizialmente in buoni rapporti con i samanidi persiani, li avevano
poi spazzati via verso il 1040 e si erano sostituiti loro fondando un «impero» esteso
dal Khorasan alla Persia centrale. Una circostanza religiosa – il fatto che all’epoca
il califfo di Baghdad fosse molto condizionato e nella pratica quasi tenuto in ostaggio
da una dinastia di «maestri di palazzo» di confessione sciita, i Buyidi – fornì al
khan selgiuchide Tughrul Beg il pretesto per marciare nel 1055 sulla capitale, occuparla
presentando l’occupazione turca come una «liberazione sunnita» e convincere il califfo
a mettersi sotto la sua protezione. Proclamato sultano, cioè quasi sovrano in temporalibus del califfato, il capo selgiuchide annunciò con solennità un ambizioso programma guerriero
teso non solo a liberare la compagine abbaside dalla crisi che l’attanagliava, ma
a permettere addirittura all’Islam di riprendere quella vittoriosa marcia espansionistica
esauritasi in Asia da tre secoli (e che, come già si è visto e meglio si vedrà tra
poco, nel Mediterraneo si era rallentata da poco più di un secolo e stava ormai cedendo
il passo a una travolgente riscossa dei «franchi» occidentali).
I primi avversari che si paravano dinanzi ai selgiuchidi, ben decisi a riprendere
l’espansione e le conquiste dell’Islam sunnita verso ovest, erano i bizantini e i
califfi sciiti d’Egitto.
Nei confronti dei concorrenti egiziani i turchi avviarono un duro braccio di ferro
per il controllo della Siria e della Palestina: soltanto l’arrivo in quell’area di
quello sconcertante pellegrinaggio armato che siamo ormai abituati a definire la «prima
crociata», nel 1096-99, pose in parte fine all’inimicizia fra abbasidi-selgiuchidi
e fatimidi, complicata dalla rivalità fra turchi e arabi. Ma quando i crociati si
erano affacciati ai confini settentrionali della Siria il califfo fatimide del Cairo
aveva loro inviato ambasciatori incaricati di verificare se fosse possibile allearsi
con i «franchi» o quanto meno utilizzarli contro i turchi.
Contro Bisanzio,il nuovo sultano Alp Arslan(1063-1072) aveva riportato nel 1071 la grande vittoria di Manzikert – oggi Malazgirt – sull’altocorso dell’Eufrate, non lontano dal lago Van; essa consentiva, di lì a pochi anni,
la fondazione del «sultanato di Rum» con capitale Iconio (oggi Konya) grazie al quale i selgiuchidi controllavano il
centro della penisola anatolica. Rum («Roma») era la parola con cui nel mondo arabofono – e quindi nell’Islam – si definiva
la Basilèia ton Romàion, l’impero romano, vale a dire quell’entità che noi siamo impropriamente abituati
a chiamare «impero bizantino» in tutta la sua estensione geografica. L’Anatolia era
dunque Rum. Ormai, solo i Monti Eusini a nord e il Tauro a sud separavano i nuovi conquistatori
musulmani rispettivamente dalle coste del Mar Nero e dei golfi di Antalya e di Alessandretta
sul Mediterraneo, controllati ancora da Bisanzio. Ma nella capitale sul Bosforo si
ricominciava a tremare, come non era più accaduto dall’assedio del 717-18. Il nuovo
basileus Alessio I Comneno (1081-1118), appena asceso al trono, si trovò a dover contrastare
tre quasi contemporanee ondate barbariche: a ovest i normanni che avevano assalito
la costa epirota guidati da Roberto il Guiscardo, il quale stava allora consolidando
– con l’appoggio del papa di Roma – il suo potere sull’Italia meridionale mentre suo
fratello Ruggero aveva già intrapreso la campagna di conquista della Sicilia; a nord
la popolazione uraloaltaica dei peceneghi, più tardi noti come cumani (i polovzi delle fonti russe), che dopo aver razziato i Balcani si spinsero nel 1090 fin quasi
sotto le mura di Costantinopoli e vennero respinti non senza fatica; a est e a sud
i turchi, che ormai si dividevano l’Anatolia centrale e orientale oggetto tuttavia
di contesa tra due sultanati rivali, i selgiuchidi d’Iconio e i danishmenditi di Melitene
(oggi Malatya).
Le nuove conversioni di massicci gruppi etnici turcomongoli fra IX e X secolo, che
allargarono lo spazio del dar al-Islam nell’Asia centrale, avrebbero potuto segnare in modo diverso la storia non solo religiosa
del macrocontinente eurasiatico – e condizionare pertanto i rapporti fra Europa e
Islam –, se altre possibili opportunità d’islamizzazione delle inquiete popolazioni
indoeuropee e turcomongole fossero state colte. Qui, forse, la speciale struttura
dell’umma musulmana, la mancanza al suo interno – come per l’ebraismo – di vere e proprie istituzioni
ecclesiastiche e di ruoli sacerdotali, fu una delle concause che determinarono una
serie di occasioni perdute. Altre etnie affini ai selgiuchidi e ai karakhanidi erano
forse disposte ad accettare la fede coranica. La penetrazione musulmana in quegli
ambiti e in quelle aree sarebbe infatti ripresa: ma solo durante la seconda metà del
Duecento, all’indomani della tempesta delle conquiste genghizkhanidi. In effetti,
pare che attraverso i canali del traffico mercantile l’Islam fosse pervenuto in parecchie
aree dell’Asia centrale fin dal principio del X secolo: si islamizzarono così i bulgari
della magna Bulgaria – la grande ansa del Volga – e gli stessi chazari, i quali – o, quanto meno, la loro
classe dirigente – avevano in precedenza adottato l’ebraismo. La cronaca del monaco
russo Nestore, del XII secolo, sostiene che nel 986 i bulgari, musulmani, si erano
presentati a Vladimir principe di Kiev, ancora pagano, e gli avevano proposto la conversione
all’Islam che peraltro il principe non avrebbe preso in considerazione perché la circoncisione
e l’astinenza dal vino e dalla carne suina non gli andavano a genio. Vladimir (poi
detto «il Grande») optò due anni dopo per il cristianesimo greco che gli veniva proposto
dai bizantini.
I motivi di tale scelta potrebbero sembrare grossolani; o ingenuo, da parte del cronista,
il presentarli in questi termini. Ma, al di là dei suoi orizzonti e del pubblico cui
la cronaca era diretta,
quali conseguenze avrebbe avuto per la storia dell’Europa una eventuale adesione della
Russia all’Islam? L’Europa cristiana si sarebbe trovata presa in una tenaglia: nel
Mediterraneo le flotte variago-slave non si sarebbero battute per i greci, ma per
gli arabi. L’Islam avrebbe eretto un baluardo al fianco orientale dell’Europa, con
la possibilità anzi di propagarsi alla Scandinavia ancor prima che vi potessero arrivare
missionari cristiani!
Una prova di più, questa, del fatto che la storia non solo si può, ma soprattutto
si deve pensare al condizionale, con tutti i «se» e i «ma» possibili: solo così il
peso degli avvenimenti effettivi si mostra in tutta la sua realtà gravida di conseguenze,
in alternativa con il proporsi di quelle possibilità che il gioco del rapporto fra
volontà di singoli e di gruppi, condizionamenti del passato e dell’ambiente e infine
imponderabili emergenze hanno tuttavia scartato.
Crisi e trasformazione nell’Islam. L’Occidente
In Spagna l’emiro Abd ar-Rahman III (912-961), che aveva guidato la dinastia neo-umayyade
cordobana al massimo splendore e che nel 929 si era arrogato la dignità di califfo,
era riuscito a estendere il suo potere anche su una parte del Maghreb occidentale.
La Córdoba del tempo contava a quel che pare circa 300.000 abitanti. Restano ancora,
testimoni di quell’era di splendore, le imponenti rovine della città-reggia di Medina
Azahara, la «Città dei Fiori». Essa rifulgeva di marmo, di cristallo, di mosaici per
i quali si era fatto ricorso ai migliori artisti bizantini; si favoleggiava perfino
di una fontana di «argento vivo», cioè di mercurio, che serviva a stupire gli ospiti
creando scintille e cascate di luce al centro di un salone dai riflessi d’oro.
Arabi e berberi non si erano mai propriamente fusi tra loro: la fiera aristocrazia
di coloro che si consideravano i soli autentici eredi del Profeta disprezzava i parvenus africani. Tuttavia era ben presto prevalsa una moderata ma progressiva integrazione
fra arabo-berberi da una parte e discendenti dei celtiberi, degli iberolatini, dei
gotosvevi dall’altra. La vera distinzione qualificante restava quella tra i musulmani
discendenti dei conquistatori, i locali guadagnati in tempi diversi alla fede coranica
(i muwalladun) e i cristiani rimasti fedeli alla loro religione ma arabizzati nella lingua e nei
costumi per quanto sovente non dimentichi del latino o meglio dell’idioma volgare
che da esso si era sviluppato (i musta’riba, che gli occidentali conoscono meglio col termine, passato attraverso lo spagnolo,
di «mozarabi»).
Gli umayyadi avevano trasmesso sulle prime al mondo ispanomusulmano i caratteri di
fondo della grande cultura siriaca che li aveva caratterizzati; tuttavia, col tempo,
l’attrazione del modello abbaside si era fatta sentire, mediata dalle corti dell’Islam
maghrebino. Questo autentico tesoro intellettuale aveva affascinato gli stessi dhimmi cristiani: già nel IX secolo, Alvaro di Córdoba lamentava che gli studiosi cristiani
sprecassero il loro tempo nell’imitare le lettere arabe a scapito della Scrittura
e delle opere dei Padri della Chiesa.
I rapporti tra i califfi di Córdoba e i «franchi» a nord dei Pirenei erano nel complesso
buoni. Nel 953 era stato ricevuto dal sovrano Giovanni abate di Gorze, inviato di
Ottone re di Germania, che chiedeva al califfo di aiutarlo a liberarsi dei nidi saraceni
sull’arco alpino: il califfo rispose inviando presso il re, divenuto nel frattempo
imperatore, il vescovo mozarabo Ricimondo ben noto come dedicatario dell’Antapodosis di Liutprando vescovo di Cremona.
Dopo Abd ar-Rahman III, il califfato non conobbe altri sovrani del suo livello. Tuttavia,
buon ricordo di sé ha lasciato Hakam II (961-976), che abbellì e ingrandì la città
di Córdoba ed ebbe la politicamente parlando discutibile fortuna di potersi appoggiare
a un ministro e collaboratore tanto energico che parve di fatto soppiantarlo e che
ne proseguì l’opera: Muhammad Ibn Abi ‘Amir, che per le sue gesta fu detto al-Mansur,
«il Vincitore» (l’Almanzor delle cronache e della poesia epica spagnole). D’origine
araba purissima, il wizir fu per un trentennio, fra 978 e 1008, padrone della Spagna e del Marocco: obbligò
il regno cristiano di León a riconoscersi vassallo del califfo e nel 997 conquistò
la città di Santiago de Compostela, peraltro rispettandone il santuario. Alla sua
morte, però, scoppiarono nella famiglia califfale contese dinastiche tali da frazionare
l’intera Spagna musulmana in una dozzina e più di emirati sovente in lotta fra loro,
conosciuti nella tradizione spagnola come reinos de taifas («regni delle fazioni»). Comunque le corti dei principi ripetevano e sovente proseguivano,
magari a più modesto livello, il modello mecenatesco dei califfi.
Gli europei occidentali ignoravano – almeno fino al XII secolo – tutto o quasi dell’Islam
a est di Gerusalemme: al punto che nel 906 Berta marchesa di Toscana scriveva al califfo
di Baghdad al-Muktafi perché solo di recente e per caso (da prigionieri catturati
su vascelli provenienti dall’Ifriqiya) aveva saputo dell’esistenza d’un dinasta musulmano
più importante dell’emiro aghlabita di Qairawan, col quale aveva buoni rapporti (che
naturalmente non escludevano la guerra corsara).
Viceversa, per gli occidentali erano sempre più importanti i reyes de taifas. Uno di essiera l’emiro di Denia, al-Mujahid, il quale nei primi anni dell’XI secolo concepì e
fu a un passo dall’attuare un ampio e coerente disegno politico-territoriale fondato
sul controllo delle Baleari, della Corsica e della Sardegna: il che, in pratica, significava
tutto il Mediterraneo nordoccidentale da Valencia al Tirreno. Al-Mujahid si era fin
dal 1010 ritagliato il suo potere approfittando della crisi del califfato cordobano
e, sostenuto da una buona flotta, signoreggiava le Baleari. Contro questa minaccia
si allearono, sollecitate pare da papa Benedetto VIII, le due città marinare di Genova
e di Pisa, che negli anni precedenti avevano subito non pochi attacchi da parte dei
saraceni: e tra il 1015 e il 1021, in una guerra lunga e difficile, riuscirono alla
fine ad aver ragione dell’avversario. L’impresa dei pisani e dei genovesi contro al-Mujahid
fu, dopo i confusi tentativi del IX-X secolo, la prima delle grandi occasioni nelle
quali forze cristiane si trovavano unite contro un comune nemico musulmano mostrando
– caratteristica questa che affiora nell’XI secolo, anche in rapporto alla vigorosa
elaborazione dei temi religiosi ed ecclesiali sostenuta da centri come l’abbazia di
Cluny – che tale sforzo guerriero comportava, esplicita o implicita, anche una valenza
in qualche modo religiosa.
Fin dall’età costantiniana la Cristianità era abituata a chiamare in causa motivi,
fattori, componenti e simboli religiosi a sostegno e magari addirittura a giustificazione
– si discute se addirittura a sacralizzazione – dei suoi sforzi bellici. A Bisanzio
i temi delle «sacre armate» e della «sacra guerra» erano comuni, nella misura in cui
tutto quel che riguardava l’autorità imperiale era ritenuto sacro: la lotta ai pagani
e la dilatazione del nome cristiano e della fede potevano entrare nella retorica e
nella simbolica militari. La Chiesa bizantina, tuttavia, si era costantemente tenuta
in disparte rispetto al processo di sacralizzazione delle armi e della guerra. Diverso
il caso della Chiesa latina, nella quale ci si era trovati a dover accettare e in
parte neutralizzare, in par
...