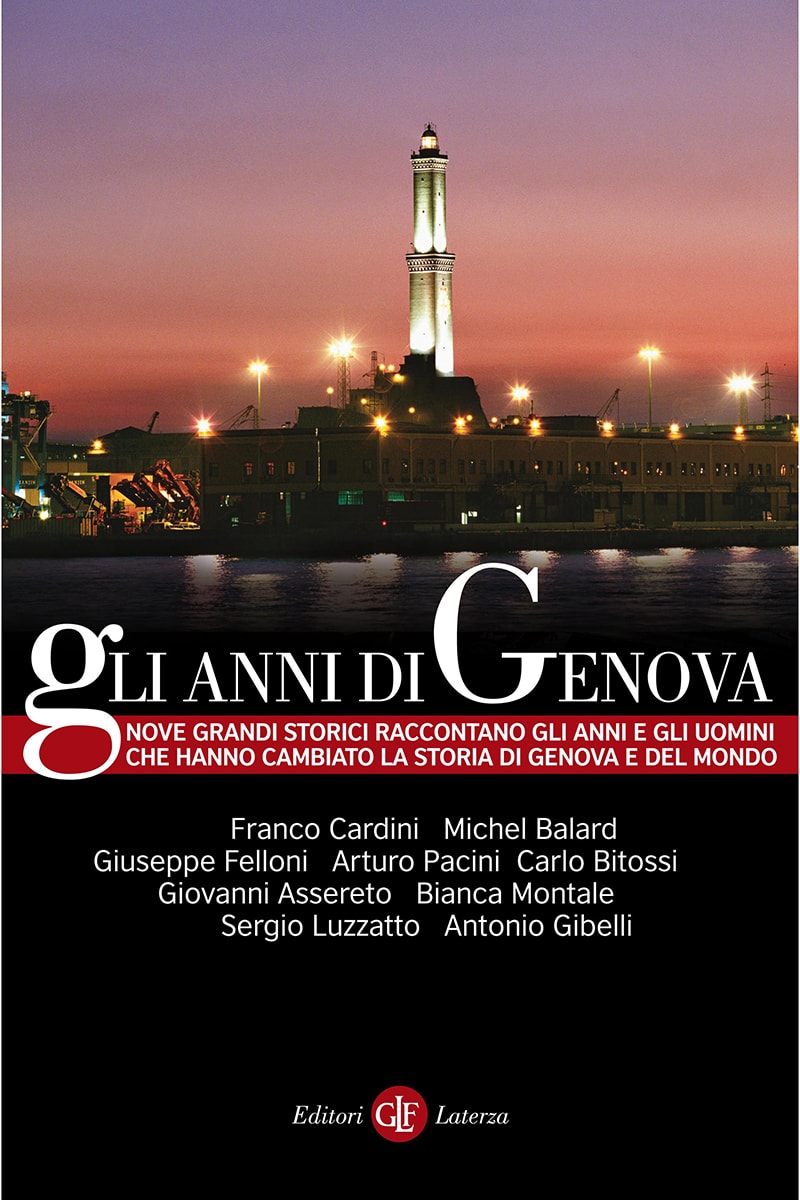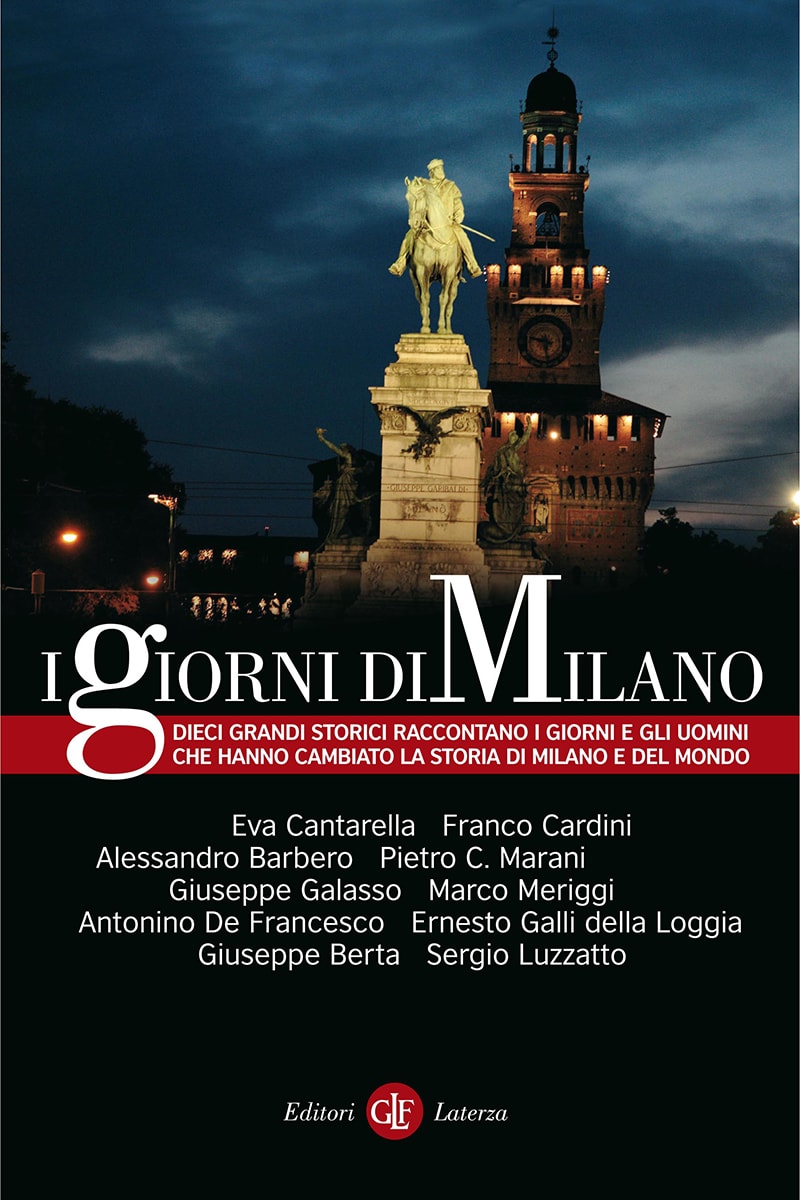Premessa.
di Sergio Luzzatto
Come si studia la storia? E come si racconta? Sono queste, a ben vedere, le due domande
che stanno dietro ogni riflessione possibile sulla cosiddetta “metodologia della ricerca
storica”. Domande semplici all’apparenza, complesse nella sostanza. Tanto complesse
da spingere gli storici, professionisti del passato, alla formulazione di risposte
fin troppo ardue, sofisticate, da addetti ai lavori: istruzioni per l’uso che finiscono
spesso per annoiare piuttosto che aiutare. La metodologia della storia (ha scritto
polemicamente Richard Cobb, il massimo studioso inglese della Rivoluzione francese)
è «un’invenzione di tedeschi tromboni» del XIX secolo, ed è tutt’ora «la rovina degli
sventurati allievi della Scuola Normale di Pisa».
Ma riflettere su come si studia e si racconta la storia può anche diventare una sfida
appassionante: se soltanto gli storici si impegnano a non coltivare l’esoterismo,
e a parlare chiaro. Se, rinunciando a un gergo specialistico o a chissà quale segreto
professionale, coloro che di mestiere maneggiano il passato invitano il pubblico di
oggi – i lettori, gli studenti – dentro la loro officina, per illustrare concretamente
come se ne utilizzano gli attrezzi. Se una tecnica, il buon uso delle “fonti”, viene
messa al servizio di un’arte, l’arte di raccontare attraverso storie istruttive. È
il senso dell’operazione perseguita in questa Prima lezione di metodo storico: dove una decina di storici italiani, variamente specialisti di storia medievale,
moderna o contemporanea, sono stati invitati a scegliere ciascuno una singola fonte,
a lavorarla con i ferri del mestiere, a farne la base per il racconto di una vicenda
esemplare.
Fondato sulla fiducia nelle dimostrazioni empiriche piuttosto che sul gusto per le
disquisizioni teoriche, il libro non ha bisogno di una lunga premessa. Qui, ci si
contenterà di qualche appunto sopra i meriti (e sopra i limiti) di un approccio al
metodo storico che ruoti programmaticamente ed esplicitamente – fin dall’indice del
volume – intorno alla questione delle fonti. Una fonte notarile, una fonte epistolare,
una fonte contabile, una fonte epigrafica, una fonte cronachistica, una fonte oratoria,
una fonte iconografica, una fonte diaristica, una fonte orale, una fonte elettronica,
dal Piemonte del Medioevo al mondo globale di internet: i dieci capitoli del libro
rappresentano le dieci tappe di una visita guidata tutt’altro che ovvia, per una varietà
di ragioni. Perché il concetto stesso di fonte può rivelarsi sfuggente. Perché la
visita guidata avrebbe ben potuto svolgersi secondo altre tappe, cioè esercitandosi
su fonti differenti. Perché lungi dal risolversi nell’isolamento in vitro di una singola tipologia di fonte, il lavoro dello storico consiste spesso in un’opera
di contaminazione ragionata delle fonti più diverse. Perché la ricetta della buona
storiografia, quand’anche comprenda come ingrediente essenziale una “critica delle
fonti”, non è in tutto e per tutto riducibile a essa.
Il concetto di fonte storica può rivelarsi sfuggente, o comunque evolutivo nel tempo.
Per averne una prova, si prenda uno strumento di reference particolarmente autorevole,
il Grande dizionario italiano dell’uso curato da Tullio De Mauro (6 volumi, Utet 1999), e lo si legga alla voce «Fonte».
In quanto riferita al linguaggio degli storici, l’accezione del lemma viene definita
come segue: «spec. al plurale, i documenti scritti da cui trarre dati e testimonianze
per la ricostruzione di un determinato periodo storico». Si tratta – spiace dirlo
– di una definizione inadeguata. Nessuno studioso di storia formatosi durante la seconda
metà del Novecento, meno che mai agli esordi del terzo millennio, sarebbe disposto
a considerare come fonti i soli documenti scritti.
Almeno da mezzo secolo a questa parte, la storiografia si ciba come del pane di una
quantità di fonti che poco o nulla condividono con la scrittura: segni del paesaggio
o vestigia dell’uomo, manufatti artigianali o prodotti seriali. Esistono ormai scaffali
interi di studi storici costruiti a partire da abiti consunti ritrovati in una soffitta,
vecchi mobili corrosi dai tarli, otri da vino affondati per un naufragio, rugginosi
utensili agricoli, sventrati capannoni industriali, povere ceramiche o preziose porcellane,
e inoltre monete, medaglie, caricature, incisioni, manifesti, affreschi, statue, tombe,
monumenti... Né si fa storia unicamente con fonti le quali, senza essere scritte,
restano comunque fonti materiali. Sempre più e sempre meglio, gli storici hanno imparato
a maneggiare fonti immateriali o addirittura vir-tuali: parole registrate in un audio,
immagini girate in un video, fotografie scaricate da un sito. Così, nell’indiceinventario
di questa Prima lezione almeno tre tipi di fonti su dieci – la fonte iconografica, la fonte orale, la fonte
elettronica – non corrispondono esattamente alla definizione di De Mauro.
Del resto, la visita guidata nell’officina degli storici avrebbe potuto svolgersi
secondo percorsi alternativi. Nei dieci capitoli di cui si compone, l’indice del volume
non va considerato esaustivo. E non va ritenuto – sia chiaro – più rappresentativo
di altri indici possibili. Conservando una base decimale, sarebbe facile immaginare
una Prima lezione di metodo storico che non contenga neanche una delle fonti trattate in questa sede, e che pure restituisca
con pregnanza i modi e i significati dell’attività storiografica. Una fonte diplomatica,
una fonte giudiziaria, una fonte demografica, una fonte parlamentare, una fonte giornalistica,
una fonte poliziesca, una fonte agiografica, una fonte clinica, una fonte letteraria,
una fonte cinematografica: ecco altri dieci tipi di fonti assolutamente imprescindibili
nella comune pratica degli storici, e che non figurano qui per motivi estrinseci,
sacrificate non già a un ordine di importanza, ma alla tirannia dello spazio.
Più che inseguire un’ambizione di completezza, si è voluto restituire una modalità
di lavoro. Diversamente dagli storici dilettanti, che sono soliti affidarsi alle sole
“fonti secondarie” (cioè agli studi già esistenti su un argomento), gli storici professionisti
si confrontano obbligatoriamente con le “fonti primarie”: non possono limitarsi al
sentito dire, devono risalire ai documenti originali, scritti o figurati, materiali
o immateriali, reali o virtuali che siano. Prima di ogni altra cosa, la ricerca storica
è questo: è il rapporto diretto che uno studioso instaura con la sua fonte. Una fonte
da identificare, entro la massa piccola o grande di tracce del passato pervenute fino
al presente. Una fonte da analizzare, per capire a quando risalga, chi o che cosa
l’abbia prodotta, come e perché sia stata conservata. Una fonte da interpretare, per
trarre conclusioni significative intorno al periodo di cui essa rappresenta un riflesso.
Grandi libri sono nati dalla moltiplicazione dell’esercizio che scandisce ogni capitolo
della Prima lezione di metodo storico: sono nati – in altre parole – dall’impiego sistematico di un singolo tipo di fonte.
Per esempio, è stato a partire dai testamenti conservati negli archivi notarili di
Provenza che Michel Vovelle ha potuto proporre, nel suo libro Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIème siecle (1973), una nuova interpretazione delle origini “culturali” della Rivoluzione francese;
studiando l’evoluzione nel tempo delle disposizioni testamentarie relative alle messe
in suffragio dei defunti, Vovelle ha scoperto un nesso insospettato e cogente tra
il declino della sensibilità religiosa tradizionale e la crisi della monarchia borbonica
quale società cristiana. Un altro esempio particolarmente istruttivo, che riguarda
le fonti orali, viene dal libro di Alessandro Portelli dedicato all’occupazione tedesca
di Roma nella seconda guerra mondiale e intitolato L’ordine è già stato eseguito (1999): un montaggio di interviste a uomini e donne, giovani e vecchi, testimoni
e non testimoni dei drammatici eventi del 1943-44 da cui emerge, oltreché una ricostruzione
“definitiva” dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, una visione inedita della città di
Roma nel Novecento.
Peraltro, nel momento stesso in cui si insiste sulla centralità del corpo a corpo
tra lo storico e la sua fonte, si rischia di suggerire un’immagine fuorviante del
lavoro storiografico: come se questo fosse rigidamente diviso in compartimenti stagni,
e come se gli storici fossero oggi tenuti a una specializzazione paragonabile a quella
dei medici. Dovrebbero dunque esistere gli specialisti in fonti epigrafiche, in fonti
giudiziarie, in fonti epistolari, così come esistono gli specialisti in dermatologia,
in ginecologia, in otorinolaringoiatria? Sia permesso di dubitarne. Beninteso, il
trattamento dell’una o dell’altra fonte esige la padronanza di tecniche specifiche
e il possesso di conoscenze mirate: è ovvio che studiare un codice del tardo Quattrocento
non equivale a studiare un incunabolo, né una pala d’altare o un sarcofago o uno strumento
di navigazione risalenti alla medesima epoca. Resta il fatto che la maggior parte
degli studi storici, anziché derivare dall’impiego intensivo di una singola fonte,
nascono da una pratica differente, se non proprio da una logica contraria: nascono
da un uso estensivo e dialettico delle fonti più diverse. Nel vissuto quotidiano delle
sue ricerche, lo storico è abituato a transitare continuamente da un ambiente di lavoro
all’altro e da un attrezzo di lavoro all’altro. Dalla filza d’archivio al volume in
biblioteca, dal documento al monumento, dal computer portatile alla macchina fotografica.
A proposito di opere capitali della storiografia novecentesca, riuscirebbe impossibile
decidere su quale genere di fonti siano principalmente fondate. Nel suo libro su La crisi dell’aristocrazia. L’Inghilterra da Elisabetta a Cromwell (1965), ad esempio, Lawrence Stone ha maneggiato una tale panoplia di fonti parlamentari,
contabili, diaristiche, epistolari, notarili, giudiziarie, demografiche, letterarie,
che quasi non basterebbero, per farne l’inventario, due Prime lezioni di metodo storico! Lo stesso potrebbe dirsi del libro di Raul Hilberg su La distruzione degli Ebrei d’Europa (1961), dove il pioniere degli studi sulla Shoah ha fatto tesoro di una documentazione
tanto sterminata quanto variegata: documenti diplomatici, verbali politici, atti amministrativi,
pubblicazioni ufficiose, relazioni ufficiali, informative fiduciarie, lettere private,
corrispondenze commerciali, bilanci aziendali, orari ferroviari...
I libri di storia trattano per lo più di persone morte e di civiltà sepolte; ma quando
sono libri riusciti, pulsano – nel bene o nel male – dell’infinita varietà della vita.
D’altronde, nella lingua italiana, la parola “fonte” non rimanda forse al concetto
di “sorgente”, una vena d’acqua che sgorga spontaneamente e continuamente da un’apertura
del terreno? (E in francese come in inglese, la parola source qualifica altrettanto la sorgente d’acqua che la fonte degli storici.) Sicché l’“andare
alle fonti”, l’“attingere alle fonti” contiene l’idea della ricerca storica come bisogno
di conoscenza, sete di verità. Questo non significa che lo storico voglia, o possa,
o debba raccogliere dal fiume del passato ogni singola goccia: già nella mitologia
greca e romana, accanto al fiume del ricordo scorreva il fiume dell’oblio. Professionista
del passato, non perciò lo storico è un antiquario, cui tutto del passato interessa
semplicemente in quanto antico. Al contrario, il fascino del suo mestiere consiste
nella possibilità di selezionare dall’inesausta sorgente della storia quanto interpella
il presente, lasciando cadere quanto non lo interpella più. Lo storico non fa soltanto
ri-vivere il passato, lo fa anche ri-morire.
Un grande studioso dell’Illuminismo, Franco Venturi, amava dire − gustando il sapore
del paradosso − che «fare lo storico è semplice: basta leggere tutto, e controllare
le citazioni». La battuta suona oggi datata, se è vero che la nostra idea di fonte,
non limitandosi più ai soli documenti scritti, esclude che per fare storia basti leggere tutto. La raccomandazione di Venturi vale comunque a ricordarci come la padronanza
del metodo storico sia qualcosa di faticoso, e insieme di prosaico. Per fare gli storici,
potremmo concludere con un’altra battuta, non serve essere intelligenti quanto i filosofi.
Eppure, il metodo storico non si esaurisce in un sapere tecnico: sia perché, dopo
avere lavorato su una fonte, resta da renderne ragione, sia perché il mestiere di
storico non presume soltanto la dimensione dello studio, presume anche la dimensione
del racconto. Da Erodoto a oggi, la storia è anche (secondo alcuni, è soprattutto)
narrazione. La definizione del campo, la ricerca dei documenti, l’accumulo dei dati,
l’analisi del contesto, la scelta dell’interpretazione, l’onere della prova, non sollevano
lo storico dall’obbligo di entrare in relazione con i suoi personaggi e di farli muovere
sulla scena del passato. Senza nulla inventare, evidentemente; senza mettere loro
in bocca parole che non hanno detto, senza attribuire loro pensieri che non hanno
avuto, senza immaginarli dove non sono stati. Ma senza neppure dimenticare che qualunque
storia è fatta – in ultima istanza – di uomini e donne in carne e ossa: è fatta di
carne umana, spiegò il medievista francese Marc Bloch, forse il massimo storico del
XX secolo.
Maneggiare carne non rende gli storici dei macellai: la loro rimane una professione
dove ci si sporca di polvere più che di sangue. E tuttavia, quello dello storico può
rivelarsi un mestiere delicato. È delicato condividere l’impegno della narrazione
con quanti per mestiere fanno tutt’altro: i romanzieri, i giornalisti. Ed è delicato
comunicare i risultati di una ricerca al pubblico dei non addetti ai lavori, siano
gli studenti di un’aula universitaria o i clienti di una libreria. L’impegno della
narrazione rischia di diventare una sfida in cui lo storico venga spinto – purché
il suo saggio si legga «come un romanzo» – a pasticciare con le regole del gioco:
trascurando di «leggere tutto e controllare le citazioni», ma anche confondendo i
piani del racconto, l’anteriorità o la posteriorità degli eventi, i problemi del presente
con quelli del passato. Quanto alla divulgazione dei risultati, lo storico che voglia
“vendere bene” può imboccare scorciatoie economicamente lucrose per lui, ma culturalmente
rovinose per i suoi studenti o per i suoi lettori.
È pur vero che in Italia, a differenza che in Francia o in Inghilterra, raramente
gli storici di mestiere hanno cercato e cercano di scrivere libri altrettanto leggibili
nella forma che solidi nel contenuto. Ma proprio la riluttanza degli storici professionisti
a raggiungere il general reader ha contribuito alle fortune, qui da noi, di storici dilettanti come i giornalisti
Indro Montanelli o Bruno Vespa, che in una Prima lezione di metodo storico meritano di essere evocati quali contro-esempi. Ai dilettanti càpita infatti di commettere
– soprattutto rispetto al secolo appena trascorso, il Novecento – un errore di metodo
tanto marchiano quanto grave: confondere la memoria con la storia. È ciò che avviene
nel momento in cui si scambia una “fonte d’informazione” (secondo il comune linguaggio
giornalistico) per una fonte di verità, cioè si scambia il testimone di determinati
eventi per un interprete giocoforza attendibile di quegli stessi eventi, e si assumono
i ricordi del suo vissuto di allora come criteri-guida della nostra interpretazione
di oggi. Errore di metodo imperdonabile, poiché il buono storico è esattamente colui
che distingue con attenzione i piani temporali, ed elegge il vissuto retrospettivo
dei suoi personaggi (il travaglio della loro memoria) non già a facile criterio di
verità, ma a ulteriore e difficile materia di studio.
Al pari di altre professioni, il mestiere di storico prevede insomma – se non proprio
un giuramento d’Ippocrate – quanto meno il rispetto di una deontologia; in mancanza
di questa, il cattivo storico può fare danni, sia pure non altrettanto immediati che
il cattivo medico o il cattivo chirurgo. In particolare, il cattivo storico può fare
danni entro un contesto di bancarotta identitaria com’è quello dell’Italia d’oggidì:
dove blasonati docenti universitari fanno a gara con pennivendoli della carta stampata
e con storici della domenica, giocando a chi la spara più grossa sulle Crociate, sulla
Controriforma, sul Risorgimento, sulla Resistenza, sulla Repubblica. In tal senso,
la nostra visita guidata nell’officina della buona storiografia italiana vorrebbe
costituire un antidoto all’inquinamento ambientale prodotto dagli storici finti, dagli
storici servili, dagli storici irresponsabili.
L’idea di un libro come questo mi è venuta, in un giorno ormai lontano, dialogando
con il mio maestro e amico Paolo Viola. Prematuramente scomparso, Paolo è stato uno
storico fra i più apprezzati e influenti della sua generazione. Perciò, io confido
che i nove coautori della Prima lezione vogliano riconoscersi nella dedica del volume alla sua memoria.
Il ronzino del vescovo
Una fonte notarile.
di Alessandro Barbero
1. Gli atti della causa
Nel 1211 il vescovo di Ivrea è in lite con un suo dipendente, Bongiovanni d’Albiano,
per le prestazioni a cui quest’ultimo è obbligato in cambio delle terre che tiene
in feudo dalla Chiesa. Gli atti della causa sono contenuti in quattro pergamene, tre
originali e una copia non autentica di poco più tarda, e si conservano nell’Archivio
vescovile d’Ivrea. Nell’anno 1900 lo storico piemontese Ferdinando Gabotto li pubblicò
in un volume che contiene tutte le carte di quell’archivio fino al 1313, data della
soggezione di Ivrea ai Savoia: è forte dunque la tentazione di studiare la vicenda
servendosi dell’edizione a stampa, ciò che permetterebbe di lavorare in biblioteca
anziché in archivio, di leggere i testi con facilità, e di fotocopiarli per esaminarli
comodamente a casa propria. Ma quando si devono sottoporre pochi documenti a un’analisi
ravvicinata, frase per frase e parola per parola, è bene non accontentarsi delle edizioni,
e andare in archivio a vedere gli originali, magari portandosi dietro la fotocopia
per un raffronto puntuale.
Il nostro lavoro comincia dunque nell’archivio della Chiesa d’Ivrea, dove gli atti
sono conservati per la buona ragione che il vescovo vinse la causa. Se l’avesse perduta,
soltanto Bongiovanni e i suoi eredi avrebbero avuto interesse a conservare la documentazione,
che quasi certamente sarebbe andata persa nell’immenso naufragio degli archivi privati
anteriori al Due-Trecento. Infatti la grande maggioranza delle famiglie di quell’epoca
si sono estinte, e il loro patrimonio documentario è andato disperso; mentre gli archivi
degli enti ecclesiastici, che hanno continuato a funzionare ininterrottamente fino
ad oggi, sono molto meglio conservati.
I documenti che ora abbiamo in mano sono su pergamena, perché la carta comincerà a
diffondersi soltanto fra XIII e XIV secolo, e solo per le scritture più ingombranti
e più effimere, come i registri fiscali. Sono scritti in latino, come quasi tutti
i documenti medievali italiani, e in una grafia irta di abbreviazioni, non immediatamente
leggibile a un occhio moderno: è chiaro che per analizzarli è necessario possedere
talune abilità tecniche, che del resto ogni medievista acquisisce nel corso della
sua formazione. Il primo lavoro da fare è il confronto fra gli originali e il testo
a stampa, da cui ricaviamo la conferma che abbiamo fatto molto bene ad andare in archivio,
perché la lettura dell’editore è stata in più d’un caso frettolosa.
Per non fare che un esempio, nella trascrizione del Gabotto si menziona un certo ser
Giovanni da Rondissone, e si afferma che il vescovo Gaimario aveva sequestrato vacche
e buoi «domini Iohannis de Rondeçone aut Boni Iohannis», ma l’originale dice «avi»,
non «aut»: senza ricorrere all’originale non sapremmo mai che questo personaggio,
il cui nome ricorre spesso negli atti, era il nonno del Bongiovanni protagonista del
processo.
2. Lo svolgimento della lite
Ora che disponiamo di una trascrizione completa e corretta dei documenti, è il momento
di chiederci che storia raccontano, e quali domande possiamo porgli. È chiaro che
qui non siamo di fronte ai grandi eventi della Storia con l’iniziale maiuscola, ma
ad una vicenda quotidiana di gente qualunque; e proprio questo rende preziose le fonti
d’archivio. È ad esse che ricorriamo per capire qualcosa del funzionamento concreto
della società medievale, delle relazioni economiche, delle strutture familiari e dei
rapporti di potere.
Particolarmente utili sono gli atti dei litigi, come questi che ci prepariamo ad analizzare,
perché una controversia obbligava le parti a definire e argomentare le loro posizioni,
e sollecitava i giudici a formulare con precisione le domande da porre ai testimoni
per accertare la verità: è quasi soltanto attraverso le cause giudiziarie che impariamo
come funzionavano davvero istituzioni fondamentali del mondo medievale, quale ad esempio
la signoria. La causa di Ivrea ha a che fare con il diritto feudale, ma la disputa
sui rapporti fra signore e vassallo investe una questione assai più generale, e cioè
il modo in cui quei rapporti determinavano la stratificazione della società: in gioco
– come vedremo subito – è lo status sociale di Bongiovanni, la sua pretesa d’essere
un nobile e non un villano.
Il primo dei quattro atti porta la data del 30 giugno 1211, ed è, dal punto di vista
formale, una notitia: riferisce lo svolgimento della lite tra il vescovo di Ivrea, Pietro, rappresentato
dal suo procuratore (syndicus) Giacomo Carta, e Bongiovanni d’Albiano coi suoi fratelli, fino al momento in cui
è stata pronunciata la sentenza. La causa è stata discussa sub paribus curie, dove con curia s’intende l’assemblea dei vassalli del vescovo: come vedremo, che
Bongiovanni fosse un vassallo – e dunque un nobile – oppure un dipendente di condizione
inferiore era per l’appunto la questione da risolvere, ma in ogni caso gli venne riconosciuto
il diritto di essere giudicato, come un vassallo, dai suoi pari, nominando d’accordo
col signore i “colleghi” chiamati a giudicare. Infatti i giudici sono due cavalieri,
ser Boamondo del Solero e ser Oberto Raimondo, «eletti da entrambe le parti» (notiamo
qui che anche se per comodità di lettura tradurremo la maggior parte delle citazioni,
l’analisi è stata fatta sul testo latino: lo studioso deve interrogare il documento
nella sua lingua originale per poterne apprezzare tutte le sfumature).
Procedendo nella lettura veniamo a sapere in che cosa consisteva il litigio. Il procuratore
del vescovo pretendeva da Bongiovanni e dai suoi fratelli che mettessero un ronzino
a disposizione del vescovo in cambio del feudo che tenevano da lui, «sostenendo che
tengono un feudum de roncino». Il termine “ronzino” non aveva ancora la valenza spregiativa che ha assunto oggi,
ma indicava un cavallo da soma, di scarso valore commerciale e che nessuno avrebbe
potuto confondere con un costoso cavallo da guerra. Chi teneva un “feudo di ronzino”
era dunque obbligato a un servizio non particolarmente onorifico nei confronti del
signore: non combatteva per lui, ma si limitava a portare i bagagli, e difficilmente
poteva aspirare per questo a una condizione sociale privilegiata.
Questo episodio apparentemente secondario è rivelatore della ragion d’essere della
società feudale. La Chiesa d’Ivrea possedeva un esteso patrimonio fondiario; in alcuni
luoghi, come ad Albiano, la maggioranza degli abitanti erano suoi dipendenti, e di
conseguenza il vescovo aveva il diritto di mantenere l’ordine con la forza in quella
zona e farsi obbedire dalla popolazione. Gli abitanti delle campagne erano costituiti
in grande maggioranza da quelli che le fonti chiamano collettivamente homines o rustici: contadini, i quali avevano dei diritti ereditari di sfruttamento della terra, ma
anche dei doveri verso il signore, a cui non potevano sottrarsi unilateralmente. Per
loro, la soggezione all’autorità si traduceva nell’obbligo di pagare le imposte e
contribuire con prestazioni di lavoro gratuite, com’era appunto, in quel caso specifico,
il servizio col ronzino. Ma il vescovo aveva anche dipendenti di rango più elevato,
i vassalli, che poi erano di solito cavalieri (milites). I vassalli erano i proprietari più agiati e influenti della zona, e questo è il
motivo per cui il signore, bisognoso di appoggio politico e di aiuto militare, concedeva
loro la terra a condizioni molto più favorevoli. Non lavoravano i campi con le proprie
mani, ma ne incassavano le rendite, e il loro obbligo verso il signore, sancito dal
giuramento di fedeltà e dall’omaggio vassallatico, era quello di assisterlo nelle
cause giudiziarie e di combattere per lui in sella a un cavallo da guerra.
Senonché la distinzione fra le due categorie di dipendenti non era sempre così limpida,
come dimostra proprio il litigio fra il vescovo Pietro e Bongiovanni d’Albiano. Le
concessioni erano ereditarie e perpetue, e tale avrebbe dovuto essere anche lo status
sociale dei titolari; ma l’epoca conosceva un’impetuosa crescita economica e una vigorosa
mobilità sociale, per cui a distanza di qualche anno la condizione d’un uomo poteva
non essere più simile a quella di suo padre e di suo nonno. Se il contadino cui il
signore imponeva di fornire un ronzino per portare i bagagli si arricchiva, poteva
capitare che i suoi discendenti rifiutassero di continuare a prestare quel servizio,
sostenendo di essere anche loro dei gentiluomini, e di non essere tenuti agli oneri
che gravavano sui rustici. Quando il procuratore del vescovo fece causa a Bongiovanni
e fratelli sostenendo che il loro era un feudo di ronzino, essi negarono e cercarono
di provare che il loro era un feudo nobile («quod multo tempore tenuerunt feudum gentiliter»).
La domanda che a questo punto ci interessa porre al documento è: come si faceva a
provarlo? Nel testo leggiamo che entrambe le parti avevano presentato atti e dichiarazioni
scritte, ma poco probanti; restava la possibilità di addurre dei testimoni. La notitia non contiene i verbali degli interrogatori, limitandosi a dichiarare che il procuratore
del vescovo ha provato la sua affermazione con testimoni validi («per multos testes
ydoneos clericos et laycos»), mentre Bongiovanni e fratelli hanno solo tentato di
provare la propria tesi, ma con testimoni «a cui non fu data fede». I giudici, dopo
essersi consigliati con molti esperti di diritto, erano pronti a pronunciare la sentenza;
ma a questo punto saltò fuori che Giacomo Carta non disponeva d’una procura giuridicamente
valida per rappresentare il vescovo («non reperiebatur legitime creatus syndicus»).
Perciò i giudici chiesero al vescovo di comparire personalmente e attestare sotto
giuramento che i «suoi» testimoni avevano detto la verità.
Il formalismo della procedura, che per l’epoca rappresenta un tratto moderno, si accompagna
a un tratto arcaico come la persistente rilevanza data al giuramento quale elemento
di prova; rilevanza tale che il vescovo Pietro anziché presentarsi preferì chiedere
un rinvio per riflettere, e mentre rifletteva venne chiamato alla cattedra patriarcale
di Antiochia, nel lontano regno crociato di Gerusalemme. La causa fu dunque rinviata
fino all’elezione di un nuovo vescovo, Oberto; a questo punto la procedura venne riaperta,
e Oberto accettò di prestare il giuramento richiesto.
Perciò i giudici – conclude il primo dei quattro atti conservati nell’Archivio vescovile
di Ivrea – hanno condannato Bongiovanni a tenere un ronzino in servizio del feudo:
stabilendo, implicitamente, che la sua condizione era quella d’un semplice villano,
e non un nobile come sostenevano lui e i suoi fratelli.
3. Le deposizioni dei testimoni
Fin qui la vicenda appare piuttosto lineare. Il problema più interessante posto da
questo primo documento è quanto il formalismo della procedura, con la ricusazione
del Carta, non sia in realtà un cavillo adottato dai giudici per evitare di sentenziare,
e per scaricare sulla coscienza del vescovo la soluzione del caso: come sempre accade,
gli atti processuali raccontano la verità a modo loro, e sarebbe ingenuo accoglierla
alla lettera.
Per capire su quali elementi si erano basati i giudici passiamo alla seconda pergamena,
contenente le deposizioni dei testimoni, che vennero trascritte il 29 ottobre 1211,
e dunque quattro mesi dopo la sentenza, «affinché valgano per sempre come se testimoniassero
a viva voce». La causa si era nel frattempo riaperta, e i giudici ritennero opportuno
che le testimonianze già rese, verbalizzate dapprima in modo informale, rimanessero
a disposizione in forma ufficiale. Il verbo usato dai giudici («ordinarono di auctenticare i testi prodotti da entrambe le parti») implica il conferimento di valore giuridico
a un documento tramite la sottoscrizione notarile; senonché in questo caso la trascrizione
a un certo punto venne interrotta, senza neppure registrare il nome del notaio, per
cui tecnicamente il documento non risulta affatto auctenticus (ovvero dotato di auctoritas, nel linguaggio notarile dell’epoca).
Le deposizioni di testimoni rappresentano sempre una fonte straordinaria di informazioni
per lo storico, perché ci consentono di ascoltare la viva voce della gente comune.
Non senza mediazioni, s’intende: i testi parlavano in lingua volgare, cioè nel dialetto
locale, e il notaio traduceva laboriosamente in latino; e quanto all’attendibilità
delle deposizioni, va ribadito che i testimoni non erano convocati dal giudice, ma
presentati dalle parti a sostegno della loro tesi. Nel nostro caso il verbale raccoglie
le deposizioni di venti testimoni, tutti prodotti da Giacomo Carta a carico di Bongiovanni.
Evidentemente la trascrizione venne interrotta prima di arrivare ai testi presentati
dalla controparte, che pure erano preannunciati nell’incipit del documento.
Prima di analizzare le deposizioni è bene verificare nella documentazione coeva l’identificazione
dei personaggi coinvolti: perché all’inizio del Duecento la massa dei documenti pervenuti
fino a noi ha già cominciato a crescere, e ci si può aspettare che almeno i testimoni
di rango sociale più elevato siano presenti in diversi altri atti. Infatti, controllando
le carte dell’Archivio vescovile d’Ivrea pubblicate dal Gabotto, si riconoscono il
cavaliere ser Meardo Ferrero, vassallo del vescovo d’Ivrea e di diversi signori locali
della zona; il canonico ser Bonizo, uno degli esponenti più importanti del capitolo
cattedrale e appartenente come ser Boamondo alla maggiore famiglia nobile di Ivrea,
i del Solero; il canonico diacono Rodolfo Caudera, e il notaio Aldeprando, molto attivo
a Ivrea – soprattutto per conto del vescovo – nell’ultimo quarto del XII secolo e
nel primo decennio del XIII. Altri testimoni sono invece proprietari agiati di Albiano,
e dunque vicini di casa di Bongiovanni: insomma, per provare le sue ragioni il procuratore
è ricorso alla convocazione sia di personaggi importanti di Ivrea, autorevoli per
la loro posizione sociale e legati alla Chiesa, sia di abitanti della località dov’era
situato il feudo in discussione.
In tutti i casi in cui possiamo verificarlo, si trattava di persone di una certa età,
attestate nella documentazione già da diversi decenni, e in grado di ricordare un
passato anche abbastanza remoto. In parecchi casi i testimoni sono invitati a dichiarare
la loro età; e come accade quasi sempre in quest’epoca, nessuno la sa con assoluta
precisione. Interrogati su quanti anni hanno, il canonico Rodolfo Caudera risponde
«che crede di averne più di 50», ser Bonizo «circa 44 o 43», il notaio Aldeprando
«60 e più», Enrico di Bollengo «più di 42», Evrardo di Oggero «50 e più». Questa imprecisione,
che oggi ci colpisce, era normale in un’epoca in cui il conto degli anni non era tenuto
con rigore e non si usava celebrare il compleanno, né indicare nei documenti la data
di nascita.
Lo scopo dell’interrogatorio era di verificare a quali obblighi si erano assoggettati
in passato Bongiovanni, suo padre Gribaldo e suo nonno Giovanni di Rondissone. In
questa società dove la consuetudine aveva forza di legge, tutti sapevano che se determinati
oneri erano stati sopportati a lungo senza protestare, non era più possibile contestarli.
Uno dei testimoni, che i giudici debbono aver ritenuto ben poco interessante, lo è
invece per noi, in quanto enuncia esattamente i termini della questione, anche se
dichiara di non saperla decidere: «sa e vide che Giovanni di Rondissone e i suoi figli
si consideravano uomini del vescovo e che cavalcavano col vescovo dove lui voleva,
ma dice che non sa se sia un feudo di ronzino o di destriero, o se sia servo o libero,
se non che andavano col vescovo sia a cavallo sia a piedi».
Se fossimo al posto dei giudici, potremmo essere interessati a ricostruire la personalità
di ciascun testimone, per valutare l’attendibilità delle sue affermazioni. Ne verrebbero
fuori interrogativi a cui non è facile rispondere: ad esempio, perché mai alla domanda
rituale dei giudici, che chiedono a ciascun testimone se non ha mai avuto una condanna
o un patteggiamento per furto, i due ecclesiastici rispondono scherzando? Ser Bonizo:
«Rispose che non l’avrebbe detto, ma quando vorrà ricevere una penitenza dirà la verità».
Rodolfo Caudera: «Rispose che non si è dato briga, ma quando erano bambini ha ammazzato
gli anatroccoli» («set quando erant pueri interfecit anserotos»).
Per ricavare il massimo profitto dal documento conviene piuttosto smontare le testimonianze,
e ricostruire quali risposte vennero suscitate da ciascuna domanda. Il primo punto
su cui insiste l’interrogatorio è molto concreto: si tratta di stabilire se il padre
di Bongiovanni, Gribaldo, e il fratello di questi Guidotto hanno mai prestato servizio
al vescovo con un ronzino. Qui, a prima vista, le testimonianze sono inoppugnabili.
Più di metà dei testimoni hanno visto i due cavalcare al seguito del vescovo Gaimario
con un cavallo acquistato a loro spese, e sono certi che si trattava d’una bestia
da soma: era «un ronzino color asino con la criniera rasata e i bagagli caricati».
(Notiamo, a margine, che tutti i termini qui tradotti in italiano suonano piuttosto
oscuri a chi conosca soltanto il latino classico, e vanno controllati su un vocabolario
di latino medievale: qui scopriamo ad esempio che quando i testi parlano di «runcino
dosno» usano un aggettivo, dosinus, che indica appunto il colore degli asini). Un altro teste ricorda che il cavallo
era costato tre lire: e anche qui è necessario fare dei raffronti con i prezzi indicati
in altri documenti più o meno coevi per scoprire che si tratta d’una cifra molto bassa
rispetto ai prezzi dei cavalli da guerra, i quali potevano costare diverse decine
di lire.
I giudici, scrupolosi, chiedono se il servizio era prestato proprio in cambio del
feudo di cui i due fratelli erano investiti, e come fanno i testimoni a saperlo. I
più l’hanno sentito dire, ora dal vescovo stesso, ora «da tutti quelli del paese».
Un teste aggiunge di aver sentito confessare dallo stesso Gribaldo «che teneva dal
vescovo un feudo di ronzino»; il canonico Caudera ribadisce «che l’aveva sentito dire
dal vescovo e loro non negavano». Feudi di quel genere erano anche chiamati feudi
da scudiero (scutifer), e infatti uno dei testimoni afferma «di aver sentito dire che Gribaldo padre di
Bongiovanni cavalcava col vescovo portando i bagagli da scudiero». Un altro teste,
Pelagallo, aggiunge che Gaimario pretendeva lo stesso servizio già dal padre di Gribaldo,
anche se dovette litigare per ottenerlo: egli «vide che il vescovo Gaimario prese
(rapuit) i buoi e le vacche di ser Giovanni di Rondissone avo di Bongiovanni», a titolo di
risarcimento «perché non aveva potuto avere il ronzino, e li tenne finché il detto
Giovanni giurò di obbedire all’ordine del detto vescovo».
Tutto chiaro, dunque? No, perché altri testimoni si esprimono in modo più dubitativo.
C’è chi ha visto Gribaldo cavalcare col vescovo Gaimario «ma non sa se lo serviva
per obbligo del feudo oppure no»; chi ammette «che ogni tanto è andato con il vescovo»
ma «non sa se ha fornito il ronzino o no». C’è chi afferma d’averlo visto condurre
un ronzino, ma non per obbligo: Gribaldo andava col vescovo solo quando gli pareva,
«quando non voleva stava a casa»; e comunque «non andava come scudiero, ma come nobile».
C’è chi afferma di averlo conosciuto bene «e non vide mai che tenesse un cavallo né
un ronzino né che andasse col vescovo a Roma o dall’imperatore»: precisazione quest’ultima
non casuale, perché i detentori di feudi di ronzino avevano spesso come obbligo principale
quello di accompagnare i vescovi in queste occasioni; e infatti il canonico ser Bonizo,
quanto a lui, «crede fermamente che Gribaldo andò col vescovo a Roma col suo ronzino».
Nel loro zelo di accertare tutto l’accertabile a proposito del famoso ronzino, i giudici
rischiano talvolta di spazientire i testimoni, come quel tale che «interrogato di
che tipo era quel ronzino, rispose: “Come quelli che ci sono in giro” (“tales quales
currunt per terram”)», per poi concludere la deposizione piuttosto bruscamente: «e
dice che non sa altro: “Cosa devo dirvi di più?”». Ma a questo punto è opportuno lasciare
la prima domanda posta ai testimoni e fermare l’attenzione sulla successiva, da cui
i giudici speravano molto (e da cui non ricavarono invece quasi nulla). A tutti venne
chiesto che cosa tenevano in feudo dal vescovo i predecessori di Bongiovanni, quando
era avvenuta l’investitura, con quale procedura e in presenza di chi. Molti sapevano
che si trattava di terre in Albiano, ma quasi nessuno era stato presente all’investitura
o ne ricordava le circostanze; l’unico che ammette di essere stato presente «non vide
che si facesse menzione d’un cavallo o d’un ronzino». Tocchiamo con mano, qui, quanto
fosse insoddisfacente una procedura come quella feudale che si basava esclusivamente
sull’oralità, e capiamo come mai a quella data si stesse ormai affermando l’abitudine
di registrare per iscritto omaggi e investiture, senza più accontentarsi della pregnanza
simbolica dei gesti.
Ma per i giudici c’era ancora un altro modo di dedurre la natura del feudo. Consisteva
nel verificare se i predecessori di Bongiovanni fossero stati obbligati a subire gli
oneri signorili, pagando l’imposta periodica nota come il “fodro” e prestando i servizi
di trasporto e di guardia al castello (ancora noti coll’antico nome longobardo di
guayta et scaraguayta), come dovevano fare tutti gli abitanti (vicini) di Albiano, ad eccezione dei detentori di feudi nobili. Fra i testimoni provenienti
da Albiano, essi stessi soggetti a quegli oneri, c’è naturalmente la tendenza ad affermare
che Bongiovanni deve farsene carico come tutti. Uno dichiara «che la guaita e la scaraguaita
debbono essere imposti a Bongiovanni come a lui stesso e agli altri»; inoltre ha visto
che Bongiovanni era obbligato a far macinare il suo grano al mulino del vescovo, e
che quando c’era da pagare il fodro era tassato come tutti gli altri: ma interrogato
se gliel’ha visto pagare, deve ammettere di no. Un altro teste dichiara che ha visto
Bongiovanni sottoporsi a tutti i servizi di guardia e di trasporto, «e che quando
si deve pagare il fodro tutti insieme al paese lui viene tassato come gli altri, ma
non sa se lo dà o no».
Da una testimonianza all’altra, il rifiuto di pagare il fodro si rivela come un elemento
costante del conflitto fra le tre generazioni della famiglia e il vescovo; e ci rivela
quanto fosse difficile per l’autorità signorile farsi rispettare dai dipendenti più
insubordinati. Un teste sa che Bongiovanni fa le guardie e i trasporti, ma non ha
mai visto che suo padre pagasse il fodro o la taglia; un altro ricorda che anche il
nonno litigò spesso con i vescovi «e che gli chiedevano il fodro, ma non vide che
lo desse». Senonché il rifiuto di pagare il fodro non era di per sé la prova che il
loro fosse un feudo nobile: anche il possessore d’un feudo di ronzino poteva pretendere
d’essere esentato in cambio del suo servizio. Il canonico ser Bonizo osserva che benché
Gribaldo e Guidotto servissero col ronzino il vescovo, questi non li esonerava dal
fodro, riscuotendolo anche da loro quando lo imponeva agli altri abitanti di Albiano;
«tuttavia loro protestavano dicendo che non dovevano dare il fodro e servire il feudo,
dicendo che li gravava troppo».
Solo a questo punto i giudici passano a una domanda più diretta, chiedendo a ciascun
testimone «se sa che i predecessori di Bongiovanni siano nobili e che tengano il feudo
da nobili (gentiliter) e che siano capitanei», termine quest’ultimo con cui nell’Italia settentrionale si indicavano i maggiori
vassalli dei vescovi. Non potevano cominciare direttamente da questa domanda? In realtà
no, perché nell’Italia dell’epoca essere nobili non era una condizione giuridica precisa
e indiscutibile, svincolata dalle circostanze materiali. Nell’opinione della gente
– lo confermano tutti i processi di questo genere – essere nobili significava vivere
da nobili, non pagare il fodro, tenere cavalli da guerra; non per nulla è su questi
punti che i giudici avevano insistito all’inizio, e il fatto che ora si rassegnino
a chiedere direttamente se gli interessati erano nobili significa che non hanno ricevuto
risposte coerenti, e non sanno più bene come uscirne.
Alla domanda più di un testimone risponde semplicemente dichiarando la propria ignoranza
(«non sa se tenessero il feudo da nobili o da villani»). Altri fanno affermazioni
contraddittorie: un teste dichiara di aver sentito dire «che il vescovo Gaimario impose
il fodro a Gribaldo», ma ha sentito anche «che i predecessori di Bongiovanni erano
nobili». Rodolfo Caudera dichiara «che ha sentito dire che erano nobili», ma pure
«che quando il vescovo prendeva dagli altri uomini di Albiano prendeva anche da loro».
Ser Bonizo, che ha visto Gribaldo e Guidotto servire il vescovo «a turno e spesso
col loro ronzino», alla domanda se fossero nobili risponde «che li teneva pro bonis hominibus et gentilibus, ma non ha visto che fossero cavalieri (milites)». La maggior parte dei testimoni, pur affermando d’aver visto Gribaldo e Guidotto
accompagnare il vescovo Gaimaro col ronzino e i bagagli, concorda «che erano boni homines et gentiles».
È soprattutto il nonno, Giovanni di Rondissone, a emergere nella memoria dei testi
come nobile; del resto essi lo designano col titolo di dominus, corrispondente al volgare “ser”, e riservato ai sacerdoti e ai cavalieri. Il notaio
Aldeprando non ha dubbi che costui viveva come un nobile: «vide ser Giovanni di Rondissone
stare in Albiano bene e nobilmente in casa sua e dice che non vide per questo alcuna
lite, tranne che il detto Giovanni una volta prestò un ronzino al vescovo Gaimario».
Un ronzino venne dunque effettivamente messo a disposizione, ma in prestito, da un
uomo ben lontano dall’immaginare che qualche decennio dopo i suoi nipoti sarebbero
stati trascinati in giudizio per imporre loro un’analoga prestazione. In ogni caso,
il punto cruciale della deposizione di Aldeprando è l’assicurazione che ser Giovanni
viveva «nobilmente» (gentiliter): in questa società in tumultuoso sviluppo, e che non aveva una memoria genealogica
lunga, vivere da nobili significava esserlo davvero, e avere diritto a quelle esenzioni
che ora Bongiovanni si stava battendo per difendere.
Le testimonianze sul genere di vita condotto dai predecessori di Bongiovanni vanno
dunque in senso contrario a quelle sulla prestazione dei servizi di guardia e di trasporto,
giacché tendono a confermare che vivevano al modo dei nobili; e in quel caso non dovevano
certo tenere un umile feudo da scudieri, ma uno nobile, da vassalli. Diversi testimoni
infatti, dopo aver dichiarato che gli antenati di Bongiovanni erano nobili, aggiungono
«che erano vassalli», e servivano il vescovo «perché erano vassalli». L’unico cavaliere
fra i testimoni, ser Meardo, ricorda d’essere stato armato cavaliere dal vescovo Gaimario,
il quale gli regalò un cavallo che era appartenuto in precedenza a «ser Giovanni di
Rondissone», e prosegue sostenendo di aver visto quest’ultimo «servire il vescovo
come facevano lui stesso e gli altri vassalli». Alla richiesta se il servizio fosse
prestato in cambio del feudo che Giovanni teneva dal vescovo, il cavaliere ribatte
tranquillamente: «perché l’avrebbe servito, se non per il feudo?». Interrogato se
gli antenati di Bongiovanni erano nobili, «rispose che loro erano dei più nobili del
paese».
4. L’esito della lite
Ma chi aveva ragione, alla fine? Il procuratore del vescovo, che voleva dimostrare
la natura plebea della concessione fondiaria tenuta da Bongiovanni, o quest’ultimo,
che sosteneva d’essere investito di un feudo da vassallo?
Provocatoriamente, potremmo anche rispondere che questa domanda non ci interessa:
un documento come questo è prezioso per quel che rivela su come la gente dell’epoca
si rappresentava il mondo, non per l’esito d’una specifica lite. Tuttavia lo storico
che ha maneggiato le pergamene dell’Archivio vescovile di Ivrea ed ha acquistato familiarità
con i protagonisti della causa ha il diritto di formulare un’ipotesi. Prima di farlo,
forniamo però ancora un dato: alla domanda se gli antenati di Bongiovanni fossero
(o fossero chiamati) capitanei soltanto due testimoni rispondono affermativamente. Entrambi menzionano una circostanza
specifica, l’autorità sulla chiesa locale e sul suo sacerdote: un dato che nella coscienza
collettiva identificava i capitanei, giacché molto spesso costoro ricevevano in feudo dal vescovo proprio le pievi o
le chiese. Uno afferma «che l’avo di Bongiovanni fu capitaneus di Rondissone» e che «le chiese dei Santi Nicola e Vincenzo erano della sua signoria
e sulla sua terra»; un altro «ha sentito dire che Bongiovanni è cataneus e che ha un sacerdote sotto di sé». Nessuno afferma niente del genere a proposito
di Gribaldo e Guidotto, padre e zio di Bongiovanni; i quali, per contro, sono gli
unici che quasi tutti i testi hanno veduto servire il vescovo col ronzino.
Se aggiungiamo che il nonno di Bongiovanni, ser Giovanni di Rondissone, litigò a più
riprese col vescovo rifiutando il servizio, e che Bongiovanni sta facendo lo stesso,
mentre non risulta che Gribaldo e Guidotto l’abbiano mai fatto, si delinea abbastanza
chiaramente la vicenda d’un personaggio – ser Giovanni appunto – che aveva rivendicato
con forza uno status nobiliare, e agli occhi di tutti l’aveva ottenuto. I suoi figli
non sono stati in grado di conservarlo fino in fondo: hanno ceduto alle pressioni
del vescovo e gli hanno prestato quei servizi modesti cui a rigore forse anche il
padre sarebbe stato tenuto. Ma la famiglia ha continuato a essere considerata come
nobile, forse più ad Ivrea che nella stessa Albiano, dove la faccenda del fodro e
dei servizi di guardia e di trasporto era ben nota ai vicini; sicché Bongiovanni ha potuto tornare a rivendicare uno status pienamente nobiliare,
come il nonno.
Anche se l’ostinazione del vescovo a imporgli il servizio col ronzino lascia pensare
che gli antenati della famiglia fossero davvero semplici contadini, sta di fatto che
Bongiovanni andò molto vicino al successo, e che gli arbitri, scelti fra i più nobili
vassalli della chiesa locale, si dimostrarono molto riluttanti a dargli torto: a riprova
che l’uomo, al pari forse del padre e certo del nonno, era accettato come un nobile
ad Ivrea. La causa, infatti, non finisce con la sentenza del 30 giugno 1211 e con
la successiva trascrizione delle testimonianze rese in quell’occasione. La terza e
penultima pergamena del nostro dossier ci conferma che il procedimento era stato riaperto,
giacché il 4 maggio 1212 i giudici si pronunciarono nuovamente, e stavolta dettero
ragione a Bongiovanni.
Il documento si presenta non come una ricapitolazione della causa ma come una sentenza,
redatta in triplice copia (benché solo una, e non autenticata, sia giunta fino a noi).
A quanto pare, era accaduto che il vescovo, vinta la causa, aveva querelato nuovamente
Bongiovanni, stavolta per chiedergli i danni: dieci lire d’interesse, per non aver
prestato col cavallo il servizio richiesto. La sentenza trascrive il brevissimo memoriale
accusatorio del Carta in cui si sostiene che i predecessori di Bongiovanni erano stati
obbligati a tenere un cavallo a servizio del vescovo d’Ivrea (ed è quanto pareva accertato
con la sentenza precedente, anche se stupisce un po’ che qui non si parli più di ronzino
ma genericamente di equum) e che i loro possedimenti fondiari erano un feudo concesso dalla Chiesa d’Ivrea.
Questa seconda affermazione ci fa capire che la linea difensiva di Bongiovanni era
significativamente cambiata. Essendo stato dimostrato che i suoi predecessori avevano
effettivamente messo a disposizione il cavallo, l’uomo rilanciò sostenendo che in
ogni caso la sua terra non era affatto un feudo concesso dal vescovo, e che perciò
lui personalmente non gli doveva niente. Il fatto è che all’epoca la giustizia civile,
soprattutto nei casi come questo in cui era affidata ad arbitri scelti dalle parti,
nonostante il formalismo delle procedure era poi soprattutto faccenda di pressioni
e di amicizie, il cui peso era tanto più rilevante in quanto le cause si vincevano
a colpi di testimoni. Per quanto la tesi apparisse paradossale alla luce della causa
precedente, Bongiovanni d’Albiano trovò dei testimoni disposti a garantire che la
sua terra non dipendeva affatto dalla Chiesa d’Ivrea. A questo punto gli arbitri si
trovavano in grave perplessità, e infatti il prologo della sentenza riferisce che
ricorsero al parere degli altri pari di curia, del consiglio comunale di Ivrea e di
una commissione di esperti fatta venire da Vercelli. La soluzione fu che Bongiovanni
doveva assumersi la responsabilità di sostenere la sua tesi fino in fondo, giurando
che era vera e che non doveva nulla al vescovo. Bongiovanni giurò e i giudici sentenziarono
che il vescovo non poteva pretendere nulla da lui.
Ma la faccenda non finì qui, perché esiste un quarto documento, conservato in originale,
e anch’esso datato 4 maggio 1212. È una dichiarazione dei giudici, registrata nel
palazzo episcopale davanti all’assemblea plenaria di tutti i vassalli, alla presenza
del podestà di Ivrea e dello stesso vescovo «sedente pro tribunali cum canonicis suis».
Ser Oberto e ser Boamondo riconoscono di aver già sentenziato in passato nella causa
contro Bongiovanni, condannando lui e i suoi fratelli «a servire d’ora in poi il vescovo
d’Ivrea per il feudo che tenevano dalla Chiesa d’Ivrea con un ronzino, perché era
un feudo di scudiero». I due giudici dichiarano «che se avevano detto qualcosa dopo,
lo avevano detto salva la sentenza emessa prima e salvi i diritti della Chiesa»; come
se non bastasse, ammettono che il vescovo già da tempo li aveva ammoniti a non procedere
oltre nella causa, «perché il loro ufficio era finito perché era scaduto il loro triennio»
– una nuova conferma del rigoroso formalismo con cui si procedeva (o si pretendeva
di voler procedere) nella curia vassallatica d’Ivrea.
La dichiarazione, in sostanza, vanificava la sentenza pronunciata il giorno stesso
a favore di Bongiovanni: sia perché la subordinava comunque a quella precedente, sia
perché i giudici ammettevano di averla pronunciata in un momento in cui il giudizio
non competeva più a loro. La difficoltà di trovare una logica in un percorso così
contraddittorio non è insolita quando si cerca di ricostruire l’andamento d’una causa
giudiziaria medievale; e non solo per l’incompletezza del dossier, ma perché, ancora
una volta, s’indovina che verbali e sentenze omettono troppi retroscena.
La convocazione solenne dei due giudici da parte del vescovo, lo stesso giorno in
cui avevano pronunciato la sentenza contro di lui – anche ammesso che i fatti abbiano
davvero avuto luogo alla data dichiarata nel documento, il che non è da dare per scontato
neppure con i documenti che produciamo oggi – fu un colpo di scena che spiazzò tutti,
umiliando ser Oberto e ser Boamondo e costringendoli a rimangiarsi la seconda sentenza,
oppure fu la via d’uscita concordata fra tutti gli interessati per uscire dal vicolo
cieco in cui la causa sul ronzino era andata a finire, evitando che l’una o l’altra
delle parti fosse accusata di spergiuro, e salvando la faccia di tutti? Sono domande
a cui non è facile trovare una risposta nel caso specifico, ma che ci rivelano come
la giustizia medievale non rispondesse alla stessa logica cui risponde la nostra.
In un sistema in cui le dichiarazioni dei testimoni e il giuramento degli interessati
erano spesso i soli mezzi di prova, arrivare a un accordo, anche non dichiarato, e
permettere a tutte le parti in causa di uscirne con onore, poteva essere più importante
che non distribuire equamente il torto e la ragione.
Nota Bibliografica
I documenti analizzati si conservano nell’Archivio vescovile di Ivrea, presso la Biblioteca
Capitolare di Ivrea, scaffale LXXII, mazzo I, e sono pubblicati da F. Gabotto, Le carte dell’archivio vescovile di Ivrea, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società Storica
Subalpina, 5), docc. 59, 60, 64, 65.
Per un’introduzione alla documentazione d’archivio medievale ci si può riferire a
F. Valenti, Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia, Ed. STEM Mucchi, Modena 1961, e A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Quasar, Roma 19993.
Il punto storiografico sulla società feudale in Il feudalesimo nell’Alto Medioevo, Spoleto 2000 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo,
XLVII).
Gli studi sulla giustizia medievale hanno conosciuto grandi progressi negli ultimi
anni; per un confronto segnaliamo C. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del
XII secolo, Viella, Roma 2000; M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, il Mulino, Bologna 2005. Un esempio memorabile di utilizzazione delle testimonianze
processuali è E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324,Gallimard, Paris 1975; trad. it. Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l’Inquisizione (1294-1324), Rizzoli, Milano 1977.
Storie di fantasmi, progetti di crociata
Una fonte epistolare.
di Ottavia Niccoli
1. Sorprese da un grosso volume rilegato di blu
...