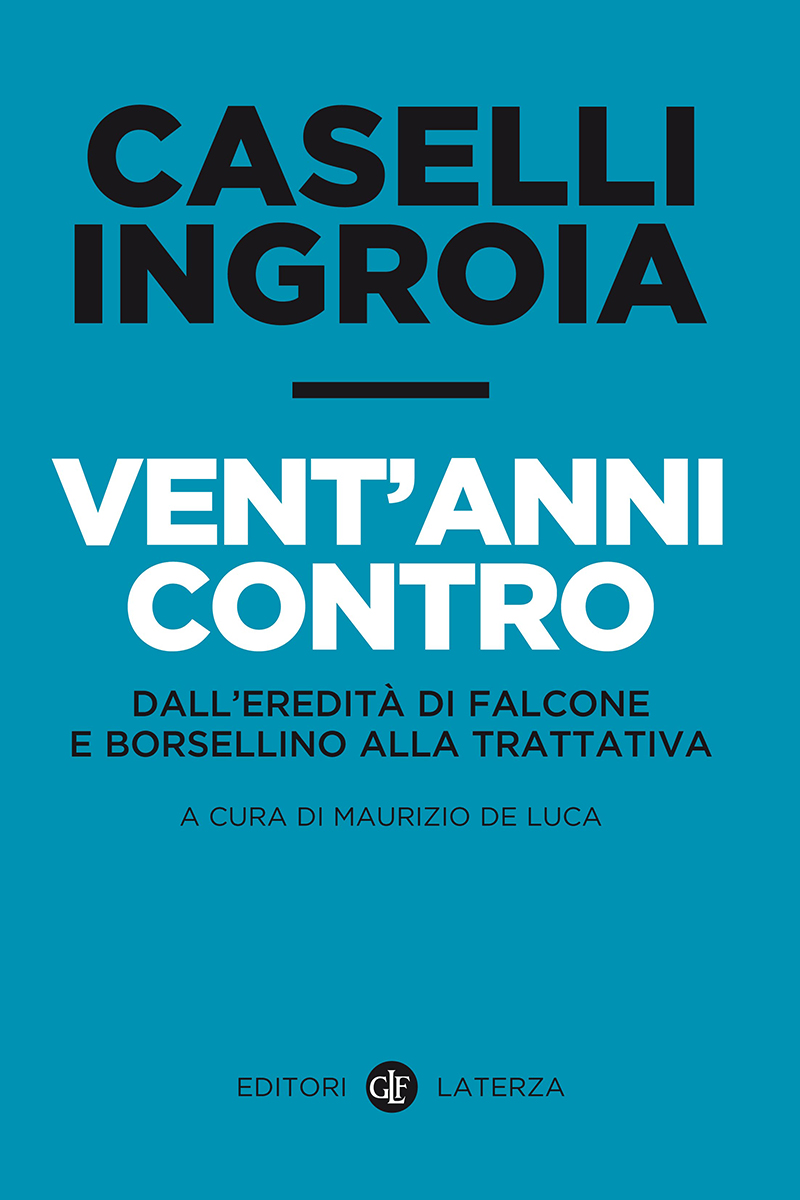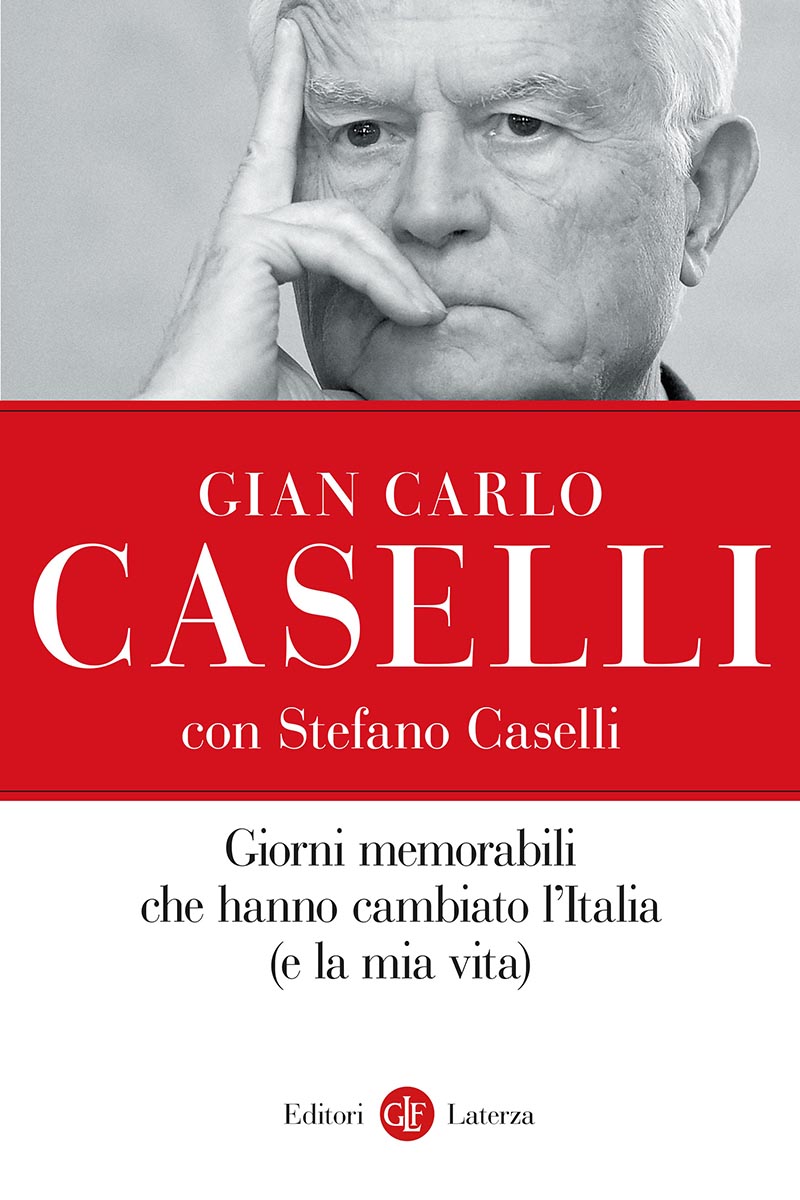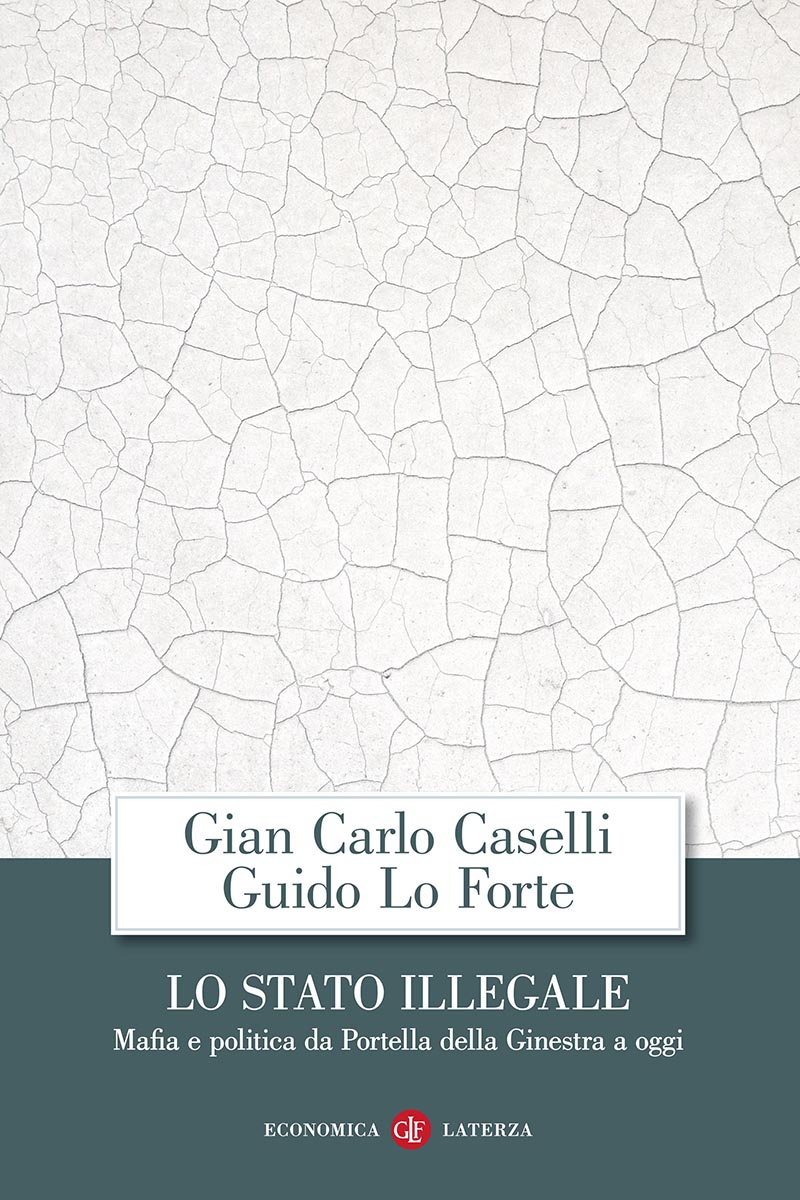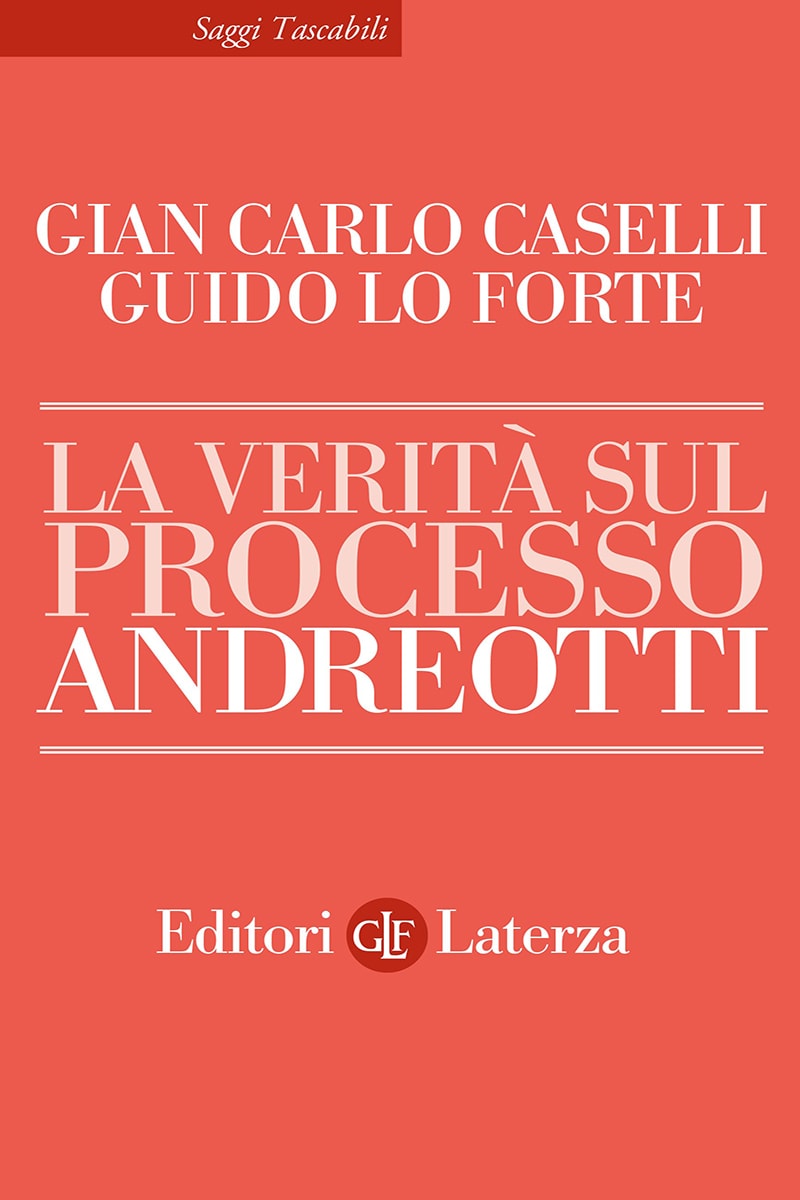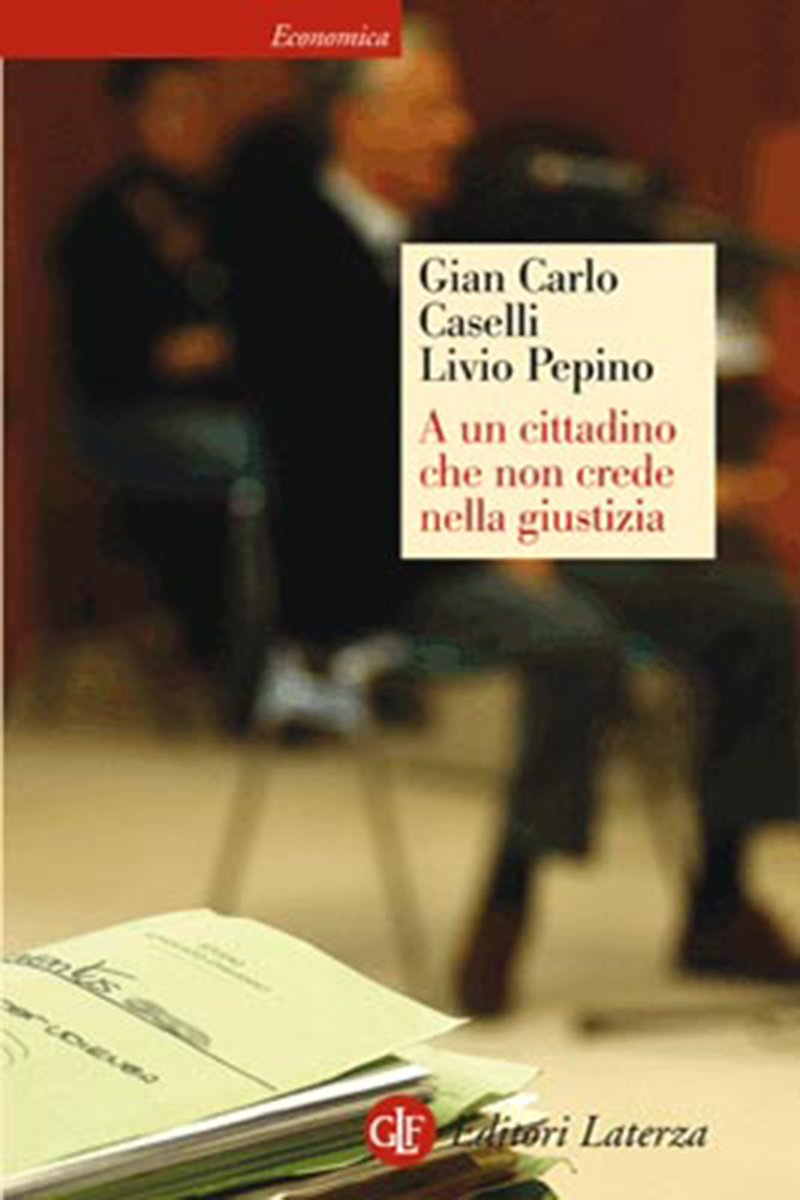Capitolo I
Il silenzio delle mafie
Sulla base dell’esperienza acquisita negli anni a Palermo, sia Gian Carlo Caselli
sia Antonio Ingroia le mafie le riconoscono al primo sguardo. Ed entrambi, qualunque
sia il ruolo che svolgono, intendono combatterle, con gli strumenti che la democrazia
offre. In questi ultimi tempi hanno assistito con preoccupazione crescente all’espandersi
sul territorio nazionale, e anche fuori Italia, delle organizzazioni criminali, capaci
di inquinare i rapporti e gli affari di tutti sul piano politico e su quello economico.
Mentre a Palermo e in generale in Sicilia i mafiosi preferiscono tacere e stare nascosti
dietro i loro silenzi difensivi, che non significano inattività, è nelle grandi regioni
del paese, dove migliore è anche la situazione finanziaria, che i criminali trasmigrano
portandosi dietro i loro delitti e la loro violenza. È uno sviluppo della vicenda
criminale che forse anche Caselli e Ingroia non si aspettavano. L’hanno messo al primo
posto tra gli argomenti su cui confrontarsi in questo loro nuovo incontro. E l’hanno
fatto con la passione che nasce anche nella memoria e con la precisione d’analisi
che ha le radici nel loro lungo lavoro istruttorio al quale con determinazione si
sono dedicati. È un confronto appassionato che si indirizza soprattutto verso chi,
in politica, avrebbe il compito nell’organizzazione istituzionale della Nazione di
affrontare, combattere e sgominare la criminalità e i suoi progetti inquinanti.
Antonio IngroiaSono passati ormai più di venti anni da quando Giovanni Falcone venne ucciso a Capaci
con la moglie e la scorta. È a lui, alle sue riflessioni che bisogna tornare per capire
sempre di più quel che avviene o è avvenuto attorno a noi. Perché Falcone era uno
che rifletteva, intuiva, capiva, spiegava. Fu lui, per esempio, che alla fine degli
anni Ottanta del secolo scorso osservò che, a parer suo, “la mafia era entrata in
Borsa”. Aveva ragione. Era una preziosa constatazione. Si era aperta infatti una nuova
stagione per Cosa Nostra.
Falcone aveva affrontato con determinazione la mafia militare, ma aveva anche già
capito che la mafia, dedicandosi a fondo ai reinvestimenti diffusi e al riciclaggio
delle somme lucrate con le attività criminali, stava cambiando profondamente pelle.
Ed è questa la strada che da allora la mafia ha, incontrastata, imboccato e sviluppato.
Si è così estesa nel paese, ha intrecciato attività insospettabili, ha fatto affari,
insomma ha trovato sempre nuove coperture e di fatto ha cambiato pelle. Ma noi, per
anni, nonostante le intuizioni e gli allarmi di Falcone, l’abbiamo lasciata crescere,
non dico indisturbata, ma quasi. Abbiamo preferito, come organizzazione dello Stato,
non aggiornare a fondo il nostro scenario che ci induceva a contrastare soprattutto
se non esclusivamente la mafia militare, senza troppo impegnarci contro la mafia finanziaria.
Per anni, è vero, la componente finanziaria è stata sottoposta a quella militare.
Ma dopo la sconfitta dei corleonesi, molto è cambiato: hanno raggiunto i vertici uomini
non più selezionati con i vecchi criteri esclusivamente criminali. Sono emersi laureati,
liberi professionisti, come medici, architetti e così via. Anche il rapporto con i
politici è cambiato. Non si è trattato più di contatti funzionali solo al raggiungimento
di singoli obiettivi. Credo che la maggiore presentabilità dei nuovi esponenti di
Cosa Nostra abbia reso possibili rapporti più costanti, frequentazioni maggiori tra
esponenti politici e laureati di Cosa Nostra.
Insomma, di fronte a questo cambiamento sostanziale e organizzativo della criminalità
organizzata, ci siamo ritrovati privi di leggi aggiornate per garantire un contrasto
efficace contro quella mafia che, come aveva lucidamente anticipato e intuito Falcone,
era entrata in Borsa. Né leggi aggiornate, né un numero adeguato di uomini per una
repressione ben mirata sul piano finanziario, né una sempre maggiore preparazione
specifica per riuscire a seguire il volteggio internazionale dei capitali sporchi
alla ricerca di una indispensabile purificazione.
Almeno da questo punto di vista, i venti anni dall’omicidio Falcone sono trascorsi
inutilmente. Dal punto di vista nostro, cioè dello Stato che non intende proprio venir
meno ai suoi doveri di contrasto in nome della legalità.
Gian Carlo CaselliSono anni che non ci confrontiamo, ma condivido buona parte della tua riflessione.
C’è stata, come tu dici, l’espansione a lungo insufficientemente contrastata delle
mafie nel paese e in particolare al Nord. C’è stato il forte e talvolta addirittura
prepotente intreccio tra mafie – non più soltanto militari – e politica, tra mafie
e mondo degli affari. C’erano stati, è vero, gli allarmi di Falcone, c’era stato tutto
quel che in questi anni avete visto voi a Palermo e, per esempio, tutto quel che mi
è capitato di vedere in quei sette anni in cui ho guidato la Procura della Repubblica
di Palermo prima di approdare a Torino, dove ho continuato a vedere perfidi intrecci
tra mafie e affari, tra mafie e politica. E ho visto anche una risposta spesso in
ritardo e poco consistente per contrastare e reprimere adeguatamente questa soffocante
coltre in perenne agguato contro lo Stato. È stato difficile in questi venti anni
andare avanti, non abbassare mai la guardia, individuare il nemico e dargli sempre
battaglia.
Anche a me è capitato di riflettere, e molto, su alcune preziose intuizioni sempre
di Falcone. Fu lui a constatare che la forza della mafia si basava anche sui rapporti
con la politica e con i centri di potere occulti. Ricordo una sua frase degli anni
Ottanta: “Se è vero, com’è vero, che una delle cause principali, se non la principale,
dell’attuale strapotere della criminalità mafiosa risiede negli inquietanti suoi rapporti
col mondo della politica e con centri di potere extra-istituzionale, potrebbe sorgere
il sospetto, nella perdurante inerzia nell’affrontare i problemi del pentitismo [ci
si opponeva ad una legge sui “pentiti” che Falcone invocava, N.d.C.], che in realtà non si voglia far luce sui troppo inquietanti misteri di matrice
politico-mafiosa per evitare di rimanervi coinvolti”. E il vero spartiacque nella
storia di Cosa Nostra fu, credo, l’assassinio di Salvo Lima. Rappresentò la rottura
di rapporti, di coperture. Torneremo in seguito sull’argomento “processo Andreotti”:
voglio però subito dire come sia stata messa in atto, in occasione di quella sentenza,
un’operazione di profondo e smaccato ribaltamento della verità. Si è detto che Andreotti
è uscito assolto da questo processo. Comunque la si giri è falso. Non è stato condannato
solo perché i gravissimi reati provati e commessi fino al 1980 sono finiti in prescrizione.
Ma restano “commessi” e confermati anche in cassazione. Voglio sottolineare che contro
la sentenza d’appello che ha dichiarato prescritto ma commesso il reato ascritto all’imputato
fino al 1980, questi e la sua difesa hanno fatto ricorso in cassazione. E non esiste
in natura che un imputato ricorra contro la sua assoluzione! Allora non è vero che
Andreotti era stato assolto. E per di più va detto che alla prescrizione, che naturalmente
è un diritto, un imputato può anche soggettivamente rinunciare (lo si è visto di recente
nel caso Penati), ma non mi risulta che Andreotti ci abbia mai fatto un pensiero...
Invece di prendere atto della verità giudiziaria accertata dal processo, si è preferito
mettere tutto in archivio sotto la falsa etichetta di assoluzione e attaccare violentemente
la Procura della Repubblica di Palermo di cui avevo la responsabilità, come se fosse
stata formata da una massa di magistrati inquirenti assatanati di giustizialismo.
Ma torneremo in maniera più approfondita su questo tema, delicato e importante, per
capire le forze e gli interessi davvero in campo.
Ora, alla citazione di Falcone sui rapporti della mafia con politica e poteri occulti
voglio affiancarne una di Carlo Alberto dalla Chiesa (tratta dall’ultima intervista
da lui concessa a Giorgio Bocca nell’agosto 1982, pochissimi giorni prima di essere
assassinato a Palermo), che testimonia un altro essenziale profilo della mafia: il
suo sforzo di passare inosservata e la sua capacità di mimetizzarsi. dalla Chiesa
rileva come la pratica del soggiorno obbligato, superata dalla rivoluzione tecnologica,
delle informazioni e dei trasporti, sia stata un boomerang. “Ricordo [sono le parole
del prefetto antimafia] che i miei corleonesi, i Liggio, i Collura, i Criscione si
sono tutti ritrovati stranamente a Venaria Reale, alle porte di Torino, a brevissima
distanza da Liggio con il quale erano stati da me denunziati a Corleone per più omicidi
nel 1949 [sempre assolti per insufficienza di prove, N.d.C.]. Chiedevo notizie sul loro conto e mi veniva risposto ‘Brave persone’. Non disturbano.
Firmano regolarmente. Nessuno si era accorto che in giornata magari erano venuti qui
a Palermo o che tenevano ufficio a Milano o, chi sa, erano stati a Londra o a Parigi”.
Insomma, senza destare allarmi particolari per decenni e decenni erano riusciti ad
estendere la presenza criminale inquinante della mafia in aree ben più ampie del Mezzogiorno,
senza che nessuno se ne accorgesse. Avevano esteso il riciclaggio, cioè l’avvelenamento
sempre più profondo dell’economia, anche in nuovi paesi, ulteriormente ampliando l’area
di influenza della criminalità. E dire che ancora oggi c’è chi si ostina a negare
una verità prima di tutto “logica” come l’insediamento della mafia anche al Nord.
Semplicemente grottesco: un po’ come stupirsi della forza di gravità o che l’acqua
bagna.
IngroiaEcco, se mettiamo assieme le riflessioni di Falcone e il racconto di dalla Chiesa,
uniti anche alle nostre personali esperienze di questi ultimi anni – io rimasto fino
a poco tempo fa a Palermo, tu alla guida prima della Procura generale di Torino poi
della Procura torinese della Repubblica – possiamo dire di poter guardare con sempre
maggiore profondità i fenomeni criminali che restano tra i maggiori avversari d’una
democrazia che pretende di basarsi sulla legalità e sulla trasparenza.
CaselliTutto questo è ben vero. Come procuratore di Torino ho seguito recentemente l’inchiesta
giudiziaria denominata “Minotauro” sulla presenza anche in vaste aree del Nord della
’ndrangheta, la criminalità organizzata calabrese. E ho visto confermato il fatto
che la forza della mafia è basata sulla sua organizzazione ma sta anche fuori, nell’economia
che riesce a controllare, nel condizionamento che riesce a esercitare. Ed è basata
anche sui silenzi che la circondano, le superficialità, le disattenzioni che l’accompagnano,
per non parlare delle connivenze se non addirittura delle complicità. Allora ho capito
come la mala pianta della criminalità organizzata riesca, restando bene insediata
nei territori di nascita e di più diretta influenza, a irrobustirsi dissimulandosi
in sempre nuovi territori che sono stati ben concimati da capitali riciclati. E tutto
questo avviene di solito nell’indifferenza generale.
Anche nell’inchiesta “Minotauro”, come già in tante altre inchieste che mi era capitato
di sviluppare a Palermo, ho trovato numerosi rapporti tra i tanti accusati di far
parte della criminalità e politici di vario livello e delle più diverse estrazioni.
C’è una costante in questi casi: il politico ignora sempre (così almeno dichiara)
la natura criminale del suo interlocutore. E c’è un’altra costante nelle inchieste
al Sud o al Nord sui rapporti tra politica e criminalità organizzata: che la legalità
è sempre usata come un vecchio paio di ciabatte che vengono calzate quando fanno comodo,
ma che vengono subito abbandonate quando risultano impicciare chi le indossa.
Ultima costante: l’attacco diretto ai magistrati da parte di quei politici, e delle
loro cordate, che vengono individuati in rapporto con delinquenti. Se si indaga su
politici accusati di reati penali, il magistrato deve mettere in conto che sarà accusato
di “politicizzazione”. Se poi si tratta di fatti che non raggiungono la soglia della
responsabilità penale, partono pretese esplicite di omissis (nella mia esperienza
torinese elaborate a sinistra...), intrecciate con polemiche e attacchi contro i magistrati
che non avrebbero dovuto rendere pubblici i rapporti della politica con gente accusata
di far parte del mondo del crimine. Ma come? Tutto questo viene invocato contro chi
si impegna a contrastare la mafia, dimenticando che se si indaga su un sistema criminale,
che si nutre anche di rapporti esterni, non si possono non evidenziare gli incontri
con insospettabili fino ad autocensurarsi o autoconvincersi dell’opportunità di tacere.
Si sostiene: perché mai parlarne se il contatto non è penalmente rilevante? Semplicemente
perché è la prova che non si tratta di delinquenti qualunque ma appunto di mafiosi,
che le “relazioni esterne” le hanno nel loro Dna. Come può permettersi, rispondo,
un inquirente di non evidenziare certe vicende, certe manovre che possono rivelare
disegni, progetti dell’organizzazione mafiosa finalizzati a creare una rete di rapporti,
un intreccio di interessi che finisce per costituire la spina dorsale del suo potere?
No, non è così che si fa il magistrato. Lo credo fermamente. E chi pretende magistrati
conniventi con la malapolitica sbaglia.
IngroiaÈ bene ricordare che dagli anni delle stragi, anche l’immagine della mafia è cambiata.
La sconfitta dei corleonesi ha significato la sconfitta, l’uscita di scena dei capi
mafiosi più sanguinari, dei teorici dello scontro frontale con lo Stato, degli stragisti.
Levato di mezzo il sangue, la criminalità ha dato molte meno preoccupazioni: davanti
alla criminalità degli affari e dei grandi capitali, qualcuno può anche aver pensato
che poteva risultare più opportuno e conveniente chiudere un occhio o, ancor meglio,
non dotare lo Stato di adeguati strumenti di contrasto. Ecco, detto in estrema sintesi,
quel che in realtà è successo.
CaselliMa come si può accettare che l’espansione della criminalità in tante aree del paese
e in tanti settori sia avvenuta senza che nessuno se ne accorgesse? Ma se ci sono
ormai settori economici nei quali le mafie operativamente fanno il bello e il cattivo
tempo! Per esempio nel settore movimento terra, in tanti subappalti. E questo sarebbe
avvenuto senza che nessuno ci facesse caso? Ma davvero non scherziamo. Lo stesso è
avvenuto nel comparto della ristorazione, in quello della distribuzione commerciale.
In questi anni, credo di aver capito che la massima latina secondo la quale pecunia non olet non è proprio una frase fatta. Purtroppo, soprattutto in stagioni di crisi economica,
purché l’economia riprenda a girare, poco importa per qualcuno che vi siano momenti,
angoli di opacità. E questo nonostante i momenti di opacità dilaghino in tante parti
d’Italia, l’invasione di capitali che hanno radici in traffici criminali si manifesti
in sempre nuove zone del paese. E tutto ciò contrasta con una indubbia crescita culturale
e operativa di gran parte della magistratura e delle forze di polizia, che alle mafie
guardano ormai anche come a protagoniste del mondo economico e finanziario. Ricordo
bene che quando arrivai a Palermo, a guidare la Procura, subito dopo le stragi del
’92, c’era ancora poca sensibilità per dedicarsi specificamente alle cosiddette misure
di prevenzione patrimoniale, che invece negli ultimi tempi si sono rivelate uno degli
strumenti di più efficace contrasto contro le mafie, con varie confische di immobili,
di denaro e di beni accumulati con le attività illecite della criminalità organizzata.
Voglio solo accennare, forse per far capire ancor meglio quel che è accaduto negli
ultimi venti anni partendo praticamente da zero per arrivare a livelli impensabili,
ad un colloquio che ho avuto poco tempo fa a Torino con un imprenditore che opera
sia in Piemonte sia in Sicilia. Ci si chiedeva chi fosse il soggetto economicamente
più potente a Torino e chi lo fosse a Palermo: per Torino ha indicato ovviamente Marchionne,
cioè l’amministratore delegato della Fiat, mentre per Palermo ha tirato fuori il magistrato
che presiede l’ufficio che si occupa delle misure di prevenzione. Mi ha fatto piacere
ascoltarlo: vuol dire che anche all’esterno del nostro mondo si captano i cambiamenti
maggiori del nostro modo di muoverci. Restano invece insondati e sotto silenzio i
rapporti fra politica e mafie, tanto che quando affiorano, in Piemonte come in Lombardia,
per effetto di qualche inchiesta giudiziaria, ecco che tutti cadono (o fingono di
cadere) dal pero. Ma che conoscenza mai hanno i politici della società? Perché mai
non vigilano? Non controllano? Pecunia non olet, dicevamo prima. E questo vale non solo in Italia. Prendiamo la strage di Duisburg
in Germania ad opera della ’ndrangheta: anche lì sorpresa e sconcerto, una caduta
dopo l’altra da un pero all’altro per presenze inquietanti che si sarebbero dovute
avvertire ben prima. Dopodiché passano un paio di settimane e nessuno ne parla più.
Questo sottovalutare, questo frettoloso dimenticare, questo distrarsi ha, in Italia,
una sua interfaccia, ahimé, nella timidezza dell’opposizione. Sui temi dell’antimafia
è capitato che l’opposizione talvolta sia stata decisamente all’avanguardia, altre
volte ha però balbettato. Prendiamo l’atteggiamento di un leader storico della sinistra
d’opposizione come Emanuele Macaluso che ha messo sotto accusa la Procura di Palermo
perché, a parer suo, procedendo penalmente contro Giulio Andreotti, non avrebbe permesso
che si arrivasse a una resa dei conti sulle responsabilità politiche e morali dell’esponente
di governo. Un tale atteggiamento mi pare emblematico di una distorsione logica: ma
se tu non hai mai parlato di responsabilità politiche e morali, mentre io cerco di
dimostrare (e ci riesco!) una responsabilità di carattere penale, come è mio dovere
fare, perché non pensi di inserirti chiedendo finalmente il conto anche delle responsabilità
politiche e morali? E invece niente: pensi sia più giusto fare la polemica con me.
È incredibile, francamente.
IngroiaSulla strage di Duisburg ho anch’io qualche osservazione da fare. Sono stato in Germania
qualche tempo fa e mi è parso di capire che sull’allarme espansione della mafia, sulla
consapevolezza dell’analisi su cosa siano e come operino e si estendano le criminalità
organizzate non si sono fatti molti passi avanti. Anzi. Non fa piacere constatarlo,
ma è doveroso farlo. Certamente la consapevolezza della magistratura in questa ottica
si è assai ampliata. Lo stesso non può dirsi per la politica. E il discorso è simile
anche se andiamo al di là dei confini nazionali.
Eppure alcuni presupposti perché la realtà così non fosse si sono manifestati. A cominciare
dall’intensificarsi di rapporti, scambi, aggiornamenti, approfondimenti delle analisi
e delle conoscenze tra esperti, come tra i magistrati. E poi sono aumentati gli strumenti
normativi, come la convenzione Onu di Palermo. Ci sono nuovi organismi di scambio
di informazioni e di collegamento tra magistrature di vari paesi, come Eurojust, dove
sei stato anche tu, Gian Carlo, in qualità di rappresentante italiano. E poi purtroppo
ci sono stati episodi eclatanti di cronaca che in varie nazioni hanno suscitato emozioni,
mostrando visibilmente l’avvenuta espansione della criminalità, dei suoi affari, dei
suoi delitti. Ma così non è stato.
Personalmente ho avuto un paio di occasioni per confrontarmi con colleghi tedeschi
assai prima e dopo la strage di Duisburg. La prima volta sarà stato nel 2000 o giù
di lì e mi detti da fare per segnalare i rischi di una sempre maggiore espansione
delle attività criminali o comunque di copertura: fui trattato, duole dirlo, con sufficienza.
Mi venne fatto capire che ci potevano essere certamente casi di singole attività mafiose,
di tentativi di espansione di fronte ai quali però l’impianto normativo e organizzativo
in Germania era assolutamente adeguato per fronteggiarli e quindi per sconfiggerli.
Insomma, mi fu fatto capire che il sistema tedesco era così ben radicato che non sarebbe
stato possibile ai mafiosi insediarsi in quella società. Poi c’è stata la strage di
Duisburg, cioè la prova dell’insediamento e della attività omicida della criminalità
calabrese. Nonostante questo, mi sentii trattare ancora una volta con sufficienza:
fu quando sottolineai l’allarme e suggerii di attrezzarsi adeguatamente anche sul
piano normativo.
Mi è successo ancor più di recente, quando mi sono sentito dire che la mafia per svilupparsi
e crescere, insomma per dar vita a quello che io chiamo autentico colonialismo, ha
bisogno di un’acqua particolare e che quest’acqua, ha sottolineato un magistrato tedesco,
in Germania non c’è. A me tutto ciò pare miopia, assai pericolosa. Ho cercato di replicare
dicendo che se si ritiene che l’acqua che nutre la criminalità la si può trovare solo
nel Sud del nostro paese, si commette un grave errore. Del resto, proprio in Italia
abbiamo la prova della capacità di adeguamento e di radicamento delle mafie in territori
diversi dal Sud di origine: lo dimostrano le più recenti inchieste giudiziarie in
Piemonte o in Lombardia sulla criminalità organizzata, in particolare calabrese. Anni
fa, Liggio latitante non venne forse catturato a Milano? Non dimentichiamocelo.
Da tempo si può dire, fotografando la realtà, che la mafia si sviluppa nelle zone
più ricche d’Italia e d’Europa: è lì che trova l’acqua per nutrirsi di affari e di
manovre. Proprio l’errore di vedere le mafie circoscritte al Sud ha portato molti,
finora, a sottovalutarne i rischi di un’espansione che, seppure non percepita, andava
di fatto sviluppandosi.
C’è poi un altro errore diffuso che non consente a molti di analizzare acutamente
gli avvenimenti nel mondo criminale. Ed è l’errore di far combaciare quello che è
stato una sorta di segmento di storia della mafia con l’intera storia della mafia.
Mi riferisco al periodo del predominio dei corleonesi. Se uno lo giudica come un periodo,
per quanto lungo, tutto sommato ben definito (devo dire per quanto mi riguarda che
il dominio corleonese corrisponde all’intero periodo della mia attività inquirente),
allora riesce bene a seguire gli sviluppi, i diversi profili nella vita delle organizzazioni
criminali. Se così non fa, rischia di commettere errori macroscopici, per esempio
l’affermare che la mafia è stata sconfitta, che la criminalità è finita.
Era questo un vizio ricorrente dei governi guidati da Silvio Berlusconi. E se qualcuno
dissentiva da questa impostazione e da questa valutazione storica, subito lo si accusava,
se per caso era un magistrato, d’essere vittima di una sorta di ossessione riguardante
le attività criminali utile anche a rafforzare il ruolo interessato degli inquirenti.
In pratica, si è detto, vi è utile presentare la criminalità come forte e pericolosa
perché così ribadite e rafforzate indirettamente il vostro ruolo. Niente di più falso.
No, non è vero che si sia voluto alimentare un mito per giustificare il valore del
nostro ruolo. Così come non si è voluto prendere atto della sconfitta delle organizzazioni
criminali solo per difendere noi stessi. Non lo si è fatto semplicemente perché non
era vero, perché era una mistificazione.
Il predominio dei corleonesi copre solo una parte, un periodo della storia della mafia:
quando i corleonesi braccati, arrestati, resi innocui devono abbandonare i vertici
di Cosa Nostra non per questo Cosa Nostra scompare, finisce. Si limita a cambiare
pelle e strategie. Uccide sempre meno e ricicla sempre di più. Resta comunque pericolosa,
violenta e inquinante. Si espande e cambia, come si è detto, il profilo dei propri
esponenti: non più ruvidi uomini dell’ala militare ma, come aveva osservato Falcone,
più preparati frequentatori di ambienti borsistici. Si può dire che la strategia stragista
dei corleonesi è stata sconfitta, che le ipotesi di attacco allo Stato e di sfida
generalizzata della criminalità anche alla politica hanno dovuto cedere all’azione
di polizia e magistratura: ma guai a pensare che la storia di Cosa Nostra per questo
è finita. Correremmo il rischio di dover subire un drammatico risveglio. Le mafie
sanno muoversi anche senza rumore.
Un’ultima considerazione sulle scelte politiche effettuate nel campo del contrasto
alla criminalità: mi pare che in tutti questi anni anziché scegliere una politica
di annientamento della criminalità, si è preferito fare una politica di contenimento.
Con misure di emergenza nei momenti di maggiore intensità e visibilità dello scontro,
con grande allentamento quando gli attacchi diventano meno percepibili. Anche per
questo talvolta, credo, ha fatto comodo sbandierare la convinzione che la guerra contro
la criminalità organizzata è finita, con la sconfitta dei criminali. Tornando con
la memoria a quella coesione istituzionale che subito dopo le stragi, dopo gli assassinii
di Falcone e Borsellino, noi magistrati sentimmo attorno a noi, quando anche tu, Gian
Carlo, arrivasti a guidare la Procura di Palermo, e fu una coesione che produsse la
formulazione di una legislazione antimafia, ebbene quella coesione di cui forse ci
illudemmo, non fu una risposta della classe dirigente alle due terribili stragi. Mi
sono convinto, in questi anni, che la spinta maggiore a schierarsi, a mettersi al
fianco della magistratura fu determinata soprattutto dalla sempre più diffusa consapevolezza
che Cosa Nostra aveva direttamente sfidato la classe politica dirigente, aveva colpito
i propri nemici insieme agli amici, cioè a quanti l’avevano aiutata. Da qui l’allarme
diffuso, il panico tra gli esponenti del mondo politico. Con la conseguenza, che pure
avvertimmo, di porsi al nostro fianco. Non per l’emozione, per lo slancio che percorreva
il paese. Ma per il fatto, penso, di sentirsi obiettivi di quel sanguinoso attacco
allo Stato. C’era la necessità di ridimensionare la mafia e per questo era necessaria
la magistratura.
CaselliAnche se allarmata, la politica non ha mai smesso di delegare l’antimafia pressoché
esclusivamente alla repressione (forze dell’ordine e magistratura), sottraendosi alle
sue responsabilità. Voglio ancora citare una frase di dalla Chiesa, che credo torni
utile per meglio illustrare le caratteristiche del contrasto fra Stato e criminalità
organizzata in questi anni difficili. Teniamo conto che il generale era uno Sbirro
(con la S maiuscola!), un uomo di manette. Diceva dunque dalla Chiesa: “Ho capito
una cosa molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei
privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari
diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti
i nostri alleati”.
Insomma, quest’uomo di manette aveva ben chiaro che l’antimafia della repressione,
alla quale anche lui apparteneva, da sola non bastava: ci volevano anche l’antimafia
sociale o dei diritti, assieme a quella della cultura. Perché se i diritti fondamentali
dei cittadini non sono soddisfatti, i mafiosi li intercettano e li trasformano in
favori che elargiscono per rafforzare il loro potere. Così la mafia vince sempre.
E i mafiosi ne sono ben consapevoli. Lo dice con schietta brutalità Pietro Aglieri
ad un collega di Palermo che lo stava interrogando: “Quando voi venite nelle nostre
[sic] scuole a parlare di legalità e giustizia, i nostri [sic] ragazzi vi ascoltano
e vi seguono. Ma quando questi ragazzi diventano maggiorenni e cercano un lavoro,
una casa, assistenza economica e sanitaria, a chi trovano? A voi o a noi?”. Ecco,
finché i cittadini, invece dello Stato, troveranno soprattutto i mafiosi, finché saranno
costretti ad essere sostanzialmente loro sudditi, la guerra alla mafia non sarà vinta.
Per fortuna oggi, a più di trent’anni dalle analisi azzeccate di dalla Chiesa, si
può dire che l’antimafia del sociale, l’antimafia dei diritti non è più all’anno zero.
Passi avanti ne sono stati fatti. C’è l’esempio significativo di Libera, la bella
associazione guidata dal generoso Luigi Ciotti e dal suo coraggio. In questi ultimi
anni il numero degli aderenti a Libera è cresciuto esponenzialmente, coinvolgendo
uomini e donne di tutti gli orientamenti politici e religiosi. I percorsi di educazione
alla legalità organizzati da Libera nelle scuole sono sempre di straordinaria efficacia.
Così come preziosissima è risultata l’iniziativa di Libera di raccogliere in tutto
il paese un milione di firme consentendo di ampliare l’efficacia della legge Rognoni-La
Torre, passando dalla “semplice” confisca dei beni mafiosi alla loro destinazione
ad attività socialmente utili, e restituendo così alla società civile parte di ciò
che le avevano rapinato le organizzazioni criminali.
Ribadiamo ancora una volta che nell’esigenza della criminalità organizzata di ripulire
il proprio denaro va ravvisata una delle principali cause della sua grande espansione
al Nord. Questo lo siamo venuti scoprendo anche con le nostre più importanti inchieste
giudiziarie. Ed è un punto che deve essere isolato, fermato e che rappresenta il progresso
di consapevolezza che abbiamo acquisito, come magistrati, e che ci consente di dire
come oggi sia maggiore, anche rispetto ai tempi di Falcone e Borsellino, la conoscenza
del profilo e delle nuove linee di espansione delle organizzazioni criminali. Diciamo,
semplificando, che le mafie sono piene di soldi ma non se li possono godere finché
l’origine criminale può essere scoperta. Se, ad esempio, uno di noi fosse un rapinatore,
subito dopo un colpo non andrebbe certo a fare spese pazze a poca distanza dalla banca
che ha svaligiato, perché altrimenti lo beccherebbero immediatamente. Meglio portare
i soldi lontano e spenderli dopo un po’ di tempo, non certo in un deserto dove puoi
risultare troppo visibile con il tuo malloppo. Cerchi di portarli in qualche zona
ricca del paese, mescolandoli con il denaro che vi circola e aumentando così le probabilità
di farla franca. In tempi di crisi economica come l’attuale, inoltre, la disponibilità
notevole di denaro garantita dalle attività illecite pone i gruppi mafiosi in posizione
privilegiata rispetto ai normali operatori economici: i criminali non dipendono dalle
banche, e la disponibilità di denaro a costo zero consente loro di fare ingiusta concorrenza,
inquinando l’economia legale. Per di più per un primo periodo, se io sono un mafioso
che vuole intraprendere una qualche attività economica, non ho bisogno subito di altri
profitti: già sono ricco, già dispongo di abbondanti capitali, inizialmente almeno
posso permettermi di non guadagnare altro. Anche così posso fare concorrenza sleale
agli operatori normali, perché posso puntare ad impossessarmi di fette di mercato,
praticando condizioni che la concorrenza non è in grado di reggere. E poi (altro vantaggio)
non è pensabile che un mafioso rispetti le regole, né sindacali né antinfortunistiche,
né previdenziali né d’altro tipo. E se ha problemi, sa bene quali “scorciatoie” imboccare
ricorrendo a ricatti, corruzione, violenze assortite. Se si considera tutto questo
e soprattutto se lo Stato non adotta efficaci contromisure, non è particolarmente
faticoso e impegnativo, per la ricca criminalità organizzata, espandersi e ulteriormente
prosperare nelle aree più sviluppate del paese.
Nello stesso tempo, una ricerca di qualche tempo fa del Censis esamina l’influenza
devastante delle mafie sull’economia del Mezzogiorno. Sintetizzando i risultati di
questa ricerca, condotta certo non da un qualunque Caselli o Ingroia, ammalato di
antimafia e giustizialismo, ma da ricercatori che usano metodi e ottiche assolutamente
scientifici, si ricava che le mafie, in campo economico, zavorrano il Mezzogiorno,
ne impediscono il decollo, lo sviluppo. Le conseguenze concrete di questo zavorramento
sono drammatiche: ogni anno, 185 mila posti di lavoro perduti per causa del radicamento
mafioso e un impoverimento diffuso, pari a 7,5 miliardi di ricchezza in meno. Conclusione
del Censis: se non ci fossero le mafie, il divario fra Nord e Sud sarebbe ben diverso.
E ti pare poco! Eppure, al di là della consapevolezza della magistratura e delle forze
dell’ordine, quindi della contrapposizione repressiva contro la diffusione in nuove
aree, principalmente al Nord, degli investimenti mafiosi, poco negli ultimi anni è
stato fatto. La classe dirigente non ha fatto propri gli allarmi profetici che erano
scaturiti addirittura oltre venti anni fa dalle analisi di Falcone. E questo mi appare
particolarmente grave. Per fortuna va delineandosi anche qualche segnale di segno
diverso. Per esempio l’assai meritevole l’iniziativa presa dalla Confindustria siciliana
in accordo con la Confindustria nazionale che ha fissato l’espulsione per quanti accettano
i soprusi ricattatori della mafia. È una misura esemplare e giusta: ma è anche, a
parer mio, una sorta di misura difensiva, per bloccare l’espandersi dell’economia
criminale che è presente in quasi tutti i settori e che inquina e distrugge l’economia
che rispetta le regole.
IngroiaCondivido pienamente la tua analisi, che viene, lo voglio sottolineare, da uno come
te che ricopre l’incarico di procuratore capo a Torino, cioè nell’unica città del
Nord il cui procuratore, Bruno Caccia, è stato anni fa assassinato proprio dalla ’ndrangheta.
Io vorrei ora proseguire nell’approfondimento dell’analisi che poco fa mi ha portato
a dire che il sostegno a favore di noi magistrati registrato anche da parte della
classe politica subito dopo gli assassinii di Falcone e Borsellino in quel momento
noi lo interpretammo come un segno di massima coesione dello Stato radicato nella
acquisita consapevolezza dei doveri dei poteri pubblici contro l’attacco della mafia.
Era un’ottica che portava a rendere oggettiva una conseguenzialità che in realtà apparteneva
invece soprattutto alla lettura della realtà da parte di chi faceva il magistrato.
Molti politici ci avevano affiancato non per solidarietà, ma perché seguivano un ben
diverso percorso: era un cammino che era partito dalla loro diffusa preoccupazione
per l’assassinio di Salvo Lima. Quell’omicidio inaspettato, come già ho detto, suscitò
terrore profondo in una larga schiera di esponenti politici: era saltata, secondo
me, la linea della possibile convivenza. Ora lo sappiamo meglio, dopo anni di indagini,
confessioni, ricostruzioni: come dimenticare che fu Leoluca Bagarella a dire agli
altri capimafia “noi non dobbiamo più avere a che fare con politici come questi, che
possono tradirci in nome dei loro interessi del momento”. Il delitto Lima, lo sappiamo,
era la conseguenza della sentenza della Cassazione che aveva reso definitive le sentenze
del maxiprocesso palermitano. Il ragionamento dei mafiosi era dunque: non più accordi
con i politici; entreremo noi direttamente nel mondo della politica senza più deleghe
né alleanze; in sintesi, comanderemo direttamente noi.
È allora che comincia il lavorìo degli uomini di Cosa Nostra per creare una valida
alternativa alla tradizionale individuazione del solito referente politico, perché
Cosa Nostra abbia i suoi Ciancimino e non più i suoi Lima. Insomma, non più politici
con i quali stringere patti, ma propri uomini che entrano in politica. Da quel momento
vi è chi si dà un gran daffare per verificare la fattibilità del progetto. Si ha notizia
anche di progetti golpisti, di matrice separatista, come quello di Bagarella e Brusca,
e altre ipotesi di impegno diretto da parte di Cosa Nostra con propri uomini in operazioni
politiche. Lo abbiamo visto anche in processi già conclusi anche se non definitivamente
(ora, mentre parliamo, si aspetta la sentenza definitiva della Cassazione): a me è
capitato al processo di primo grado che aveva come principale imputato Marcello Dell’Utri
di dire, nella requisitoria di conclusione, che non si trattava di un alleato di Cosa
Nostra, cioè di un politico che aveva stretto un patto con l’organizzazione criminale,
ma di un vero e proprio ambasciatore di Cosa Nostra dentro il mondo della finanza,
dell’economia e della politica. Dell’Utri è, secondo me, il modello dell’uomo politico
che ripropone il modello Ciancimino, non certo il modello Lima. Ma al di là dei casi
specifici, in una visione più generale, la politica di fatto è scomparsa, occupata
dalla criminalità. Una profonda differenza tra Prima e Seconda Repubblica probabilmente
consiste anche nel fatto che nella Prima Repubblica la politica, pur con tutte le
sue storture, i difetti, le ombre, c’era e svolgeva il ruolo di mediazione tra interessi
privati, talvolta anche illeciti, e la cosa pubblica. Questa mediazione mi pare che
nella Seconda Repubblica sia saltata: sono entrati in scena direttamente, senza mediazione,
nella cosa pubblica gli interessi privati che si sono impadroniti della politica e
di alcune istituzioni ed è diventato naturale anche per Cosa Nostra mischiarsi in
questo flusso di interessi privati, che si realizzano direttamente, senza mediazioni
di sorta. Ecco così che quasi si realizza il sogno di Leoluca Bagarella: non tutto
quel che aveva profetizzato si avvera, ma molto si avvicina. Francamente la non completa
realizzazione del sogno criminale di Bagarella non arriva a concretizzarsi, non perché
vi sia una politica “buona” che gli si contrappone, non credo. Piuttosto vi è stata
una sempre più compatta società civile capace di fare argine di fronte ai progetti
criminali mafiosi.
Ma voglio tornare a quel che dicevo della scomparsa della politica nel favorire la
realizzazione del bene comune nella Seconda Repubblica. Davanti a questa svolta non
poteva non scatenarsi la guerra contro la magistratura, anche perché negli stessi
anni in cui si è assistito all’inserimento degli interessi privati nel tessuto dell’attività
politica, tra i giudici è andato affermandosi l’orientamento costituzionale della
magistratura. C’è stata insomma una divaricazione sempre più profonda fra i due mondi,
fra i punti di riferimento, quasi di origine dei due mondi, da una parte la politica,
dall’altra la magistratura. E sia detto con tutti i rischi di generalizzazioni di
questo tipo di interpretazioni, che il conflitto sui punti da cui traggono origine
i due mondi inevitabilmente era destinato a dare origine a un conflitto profondo e
ingiusto, anzi a un attacco diretto e ingiusto della politica alla nostra attività.
L’adesione sempre maggiore, fin dagli anni Ottanta, ai principi della Costituzione
(uguaglianza, giustizia, eccetera) ha fatto sì, per restare al mio punto di osservazione,
cioè il Palazzo di Giustizia di Palermo, che Falcone e Borsellino si siano sentiti
letteralmente accerchiati dal mondo politico e non solo e che via via sia cresciuto
il numero dei componenti il manipolo che hanno condiviso analisi e atteggiamenti dei
due. Anzi, si può sostenere che le idee di Falcone e Borsellino hanno costantemente
allargato le loro radici fra i giudici. Noi, lo ripeto, dopo le stragi di Capaci e
di via D’Amelio ci illudemmo pensando che il crescente sostegno che sentivamo nei
nostri confronti significasse l’affermazione anche da parte della politica della necessità
condivisa di far prevalere il bene comune, sfidato dalla criminalità. La realtà, lo
ribadisco, adesso mi appare ben diversa: i politici si avvicinarono allora a noi perché
prevalentemente temevano gli attacchi diretti di Cosa Nostra, come era avvenuto con
il delitto Lima. Insomma, la nostra funzione repressiva a difesa delle istituzioni
contro la criminalità in quel momento gli faceva comodo. Non c’era solidarietà civile
o scelta di campo in quel loro schierarsi accanto a noi. Gli assassinii di Falcone
e Borsellino purtroppo c’entravano poco. Il processo di avvicinamento però durò poco.
Dovemmo subire nuovi attacchi, direi trasversali, che è capitato si siano trasformati
non solo in aggressive campagne di stampa, in furenti attacchi, ma addirittura in
talune feroci cacce all’uomo, verso chi in certi momenti veniva individuato come pericoloso
perché col suo atteggiamento metteva in discussione un determinato assetto politico-istituzionale.
È inevitabile che io debba per forza generalizzare e questo può rendere più discutibile
questa mia ricostruzione, della quale sono venuto convincendomi negli ultimi anni.
CaselliSalvatore Lupo, noto storico dell’Università di Palermo, ha scritto (in L’evoluzione di Cosa nostra: famiglia, territorio, mercati, alleanze, in “Questione Giustizia”, n. 3/2002) che c’è una “richiesta di mafia nella società italiana”, in settori della società civile, dell’imprenditoria e della politica, del sistema
finanziario ed economico internazionale e di certi poteri costituiti. Già nella campagna
elettorale del 1994, ricorda Lupo, partì “un attacco, che allora nell’opinione pubblica
nessuno accettava, alla legge sui pentiti” e vi fu un “assalto della magistratura
quando la magistratura era sulla cresta dell’onda”. Se fosse stato soltanto un problema
di consenso – sostiene ancora Lupo – nessun uomo politico avrebbe azzardato queste
operazioni. Furono dunque operazioni “per il futuro, perché c’è bisogno di mafia o
di altre cose analoghe alla mafia”. Perché occorre “che i magistrati non ci siano
più... Perché domani si arrivasse di nuovo a dire ‘non sappiamo se c’è l’organizzazione
mafiosa, comunque sono quattro fessi, non ci interessa’”. Confesso che all’inizio,
quando ho letto queste righe, mi sono parse delle frasi fin troppo forti, forse con
qualche fondamento di vero ma anche con qualche eccesso dialettico. Ora, ripensandoci,
credo che facessero parte di un’analisi precisa, quasi profetica, fondata e condivisibile.
Da premettere ad ogni analisi sui rapporti fra mafia e politica negli ultimi venti
anni.
Ma voglio tornare sull’argomento (oggi fondamentale) che non è certo una novità, l’espansione
al Nord delle mafie. Ancora un passo dell’intervista di trent’anni fa che il generale
Carlo Alberto dalla Chiesa rilasciò a Giorgio Bocca poco prima di essere ucciso: “La
mafia ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi,
o commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa ‘accumulazione
primitiva’ del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste
lire rubate, estorte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in
case moderne o alberghi o ristoranti à la page. Ma ancor più mi interessa la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case,
imprese e commerci magari passati a mani insospettabili e corrette, sta nei punti
chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”. Parole
chiarissime, come si vede. Che essendo state pronunziate trent’anni fa, oggi vanno
moltiplicate per chissà quanto. Perché da allora ad oggi tantissime cose sono cambiate.
In particolare è aumentata la facilità di circolazione di persone, merci e denaro
con conseguente incentivazione di quella espansività che la mafia di per se stessa
ha già nel suo Dna. Va perciò ribadito che non possiamo assolutamente consentirci
il lusso di stupirci davanti alla espansione della mafia soprattutto nel Nord Italia.
Occorre prenderne atto e cercare di contrastarla con gli strumenti di cui in nome
del ripristino della legalità disponiamo. Insomma, l’abbiamo già detto: guai a stupirsi
se l’acqua bagna. Piuttosto bisogna attrezzarsi e aprire l’ombrello. Quell’ombrello
che in trent’anni pochissimi hanno aperto, soprattutto tra i politici e gli amministratori
locali, ma anche nel mondo dell’informazione. Invece, voglio ricordare che addirittura
già nel 1994 la Commissione parlamentare antimafia, in un capitolo della relazione
curato da Carlo Smuraglia, si dedicò proprio alle infiltrazioni di mafia al Nord ed
espose fatti e presenze concrete di cui però nessuno si fece carico: acqua che scorreva
sul marmo. Anni dopo la Commissione, presieduta da Francesco Forgione, tornò sull’argomento
descrivendo con puntiglio e precisione la presenza delle mafie, della ’ndrangheta
in particolare, nel Settentrione, compreso ovviamente il Piemonte. Ebbene, tutto questo
è avvenuto nel sostanziale silenzio delle istituzioni e dei media, senza reazioni
preoccupate. Semmai vi furono, in Piemonte, astiose polemiche contro Forgione accusato
(anche da taluni che pur avevano incarichi istituzionali) di essere semplicemente
un provocatore, se non proprio un calunniatore. Tutto questo significa una scarsissima
sensibilità di gran parte del ceto politico, anche di quello che ha responsabilità
di governo centrale o locale, verso una emergenza che ha talmente attecchito nel territorio
da non poter più essere considerata una emergenza, essendo purtroppo una realtà consolidata.
Dobbiamo affrontare il problema, consapevoli delle sue dimensioni e dei nostri ritardi.
Finora sono mancate decisioni e azioni adeguate: parlo in particolare del Piemonte
dove attualmente mi trovo ad operare. Eppure era stato proprio a Torino che nel 1983
la ’ndrangheta aveva ucciso Bruno Caccia, il procuratore capo della Repubblica (così
una sentenza definitiva della Suprema Corte). Non solo: negli anni precedenti, dal
1970 al 1983, in provincia di Torino, furono registrate 44 uccisioni, con 24 assassinati
di origine calabrese, nel segno della criminalità organizzata. E ancora: è sempre
il Piemonte che si vede sciogliere per ’ndrangheta il primo consiglio comunale, che
è Bardonecchia nel 1995. E poi ci sono le robuste inchieste, rigorose e ben documentate,
coordinate e dirette dalla Procura distrettuale antimafia di Torino negli anni Ottanta
e Novanta. Impossibile non sapere. Perché allora la diffusa mancanza di consapevolezza
da parte della classe politica dirigente in Piemonte? Perché la magistratura è stata
lasciata sola? Perché non c’è stato dibattito per arrivare a una generale presa di
coscienza della gravità della situazione? Per ignoranza, per miopia, per impreparazione,
per sottovalutazione superficiale? O per una sorta di distacco aristocratico della
gente del Nord (con qualche venatura di razzismo), che ha ostacolato l’impegno contro
una criminalità che si pensava “esclusiva” dell’arretrato Sud? Un po’ per tutti questi
motivi, che di fatto hanno favorito l’insediamento al Nord della mafia, peraltro con
il decisivo contributo di un fattore che sempre opera quando la mafia agisce in territori
nuovi, non tradizionali: la sua capacità di ibridarsi, di mimetizzarsi, di sforzarsi
per riuscire a non essere avvertita come pericolo presente. Ha usato molto a tal fine
quella sua componente strutturale che già abbiamo visto e che possiamo definire “forza
relazionale”, cioè la costante ricerca e/o costruzione di rapporti stretti con personaggi
di rilievo in vari settori della pubblica amministrazione e della politica, del mondo
degli affari e della finanza. La mafia, soprattutto nella sua espansione fuori dalle
aree tradizionali, non rinunzia certo alla violenza, ma la usa come ultima risorsa,
per non dare troppo nell’occhio. Prima vengono l’intimidazione, la suggestione, la
pressione, la corruzione, tutte azioni che non si vedono e che consentono appunto
l’espansione sotterranea, quanto più invisibile e perciò indisturbata.
Insomma ormai alle spalle abbiamo oltre trent’anni di mimetizzazione delle mafie al
Nord. E abbiamo lo sviluppo nella società di una zona grigia di fiancheggiatori più
o meno consapevoli (spesso volutamente miopi) del reale profilo criminale dei loro
interlocutori. E mentre le attività criminali si espandono con vari atti di gangsterismo,
come estorsioni, usura, caporalato, traffici di droga armi e rifiuti tossici, appalti
pubblici truccati, corruzioni e via delinquendo, continuo è l’incremento di rapporti
esterni con vari ambienti, dalla politica agli affari, all’economia, alla finanza.
Anche per questo le mafie hanno ora sempre più bisogno di esperti: ragionieri, commercialisti,
immobiliaristi, operatori bancari, notai, avvocati, politici, amministratori, uomini
delle istituzioni, magistrati compresi purtroppo. Così diviene sempre più difficile
marcare la differenza tra legale e illegale nelle attività economiche, finanziarie
e produttive. Anche per questo le inchieste sulla mafia diventano sempre più difficili.
È sempre più impegnativo distinguere il bianco dal nero, perché dilaga il grigio.
Tutto ciò esige una magistratura sempre più attrezzata professionalmente e soprattutto
una magistratura sempre più indipendente (esattamente quello che tanti non vogliono...).
Quel che è emerso dalle ultime inchieste giudiziarie riferite agli insediamenti criminali
al Nord, in Piemonte e in Lombardia particolarmente, è che senza alcun dubbio la mafia,
soprattutto con i suoi intrecci e collegamenti con pezzi del mondo apparentemente
legale, si è consolidata anche nel Settentrione come sistema di potere, fatto di crimine
e di “relazioni esterne”. E qui è doveroso tornare ad insistere su di un punto centrale
nell’analisi delle mafie. Io come magistrato, per affrontare un sistema di potere
così esteso, devo indagare in tutti gli ambienti, su tutti gli intrecci. E se risultano
“relazioni esterne” ho l’obbligo di evidenziarle tutte, anche quando non presentino
profili di rilevanza penale. Proprio la presenza di rapporti, la descrizione delle
ramificazioni, di tutte le ramificazioni della organizzazione criminale nel territorio
sono un elemento essenziale per riconoscere le caratteristiche proprie della mafia
nell’estendersi all’interno di una società. Ecco perché non è accettabile (e va ribadito)
la richiesta che spesso viene rivolta ai magistrati perché a conclusione delle indagini
indichino soltanto con molti omissis la rete di relazioni intrecciate dalla criminalità
nel tessuto politico e sociale della comunità. Sarebbe un grande errore, il silenzio
si trasformerebbe in omertà diffusa e non contribuirebbe sicuramente a bonificare
il tessuto sociale.
C’è un altro aspetto che penso sia giusto evidenziare per meglio capire i cambiamenti
a cui si è sottoposta la criminalità. Riguarda i rapporti con il potere politico.
Fino a qualche tempo fa, la mafia avvicinava se non addirittura sottometteva gli esponenti
politici che potevano risultare preziosi per raggiungere certi obiettivi come appalti,
traffici vari, speculazioni soprattutto immobiliari. Da qualche tempo le mafie hanno
ritenuto più conveniente inserire loro uomini direttamente negli organismi politici
e amministrativi ritenuti rilevanti per le loro attività criminali. È importante,
è decisivo a questo punto ristabilire la legalità, cancellare le storture imposte
al sistema democratico, ridare agli uomini e alle donne di una comunità i loro diritti,
le loro libertà. Per fare questo non bastano i magistrati che perseguono i delitti,
non bastano gli investigatori, dalla polizia ai carabinieri alla guardia di finanza:
c’è bisogno che tutti, anche se non soprattutto la politica e l’intera classe dirigente
del paese, si schierino e operino nella stessa direzione, per tentare di togliere
spazi alla criminalità.
IngroiaDobbiamo dire con chiarezza che tutta la legislazione antimafia italiana è tagliata
sul contrasto alla criminalità armata, sulla lotta alle cosche intese come gruppi
di uomini armati, organizzati per compiere soprattutto delitti di sangue. In realtà
Cosa Nostra e le altre mafie si sono dedicate negli ultimi tempi agli affari e hanno
cercato di espandersi in altre parti del paese creandosi nuove complicità e alleanze.
Non credo che per noi magistrati e per gli investigatori siano stati a disposizione
tutti gli strumenti adeguati per attaccare alle radici quest’ultima versione delle
organizzazioni criminali. Lo sottolineo: siamo in grado ormai di dare fruttuosamente
la caccia ai latitanti, di prevalere davanti agli attacchi della mafia militare, ma
abbiamo notevoli carenze nel dare filo da torcere alla mafia politico-economico-finanziaria,
all’individuare e bloccare tutte le vie del riciclaggio, a poter seguire e inseguire
con precisione e consapevolezza l’espansione dei criminali fuori dai territori tradizionali
dove pur sono le radici della loro storia e del loro sviluppo.
Il nostro procedere sulla via del ripristino di legalità è faticoso, accidentato,
soprattutto non aggiornato. E non voglio tacere le difficoltà che abbiamo incontrato
nell’inchiesta che abbiamo fatto sulla trattativa tra Stato e organizzazioni criminali
dopo le stragi del 1992-1993. È sempre stato un nostro obiettivo quello di ricostruire
il contesto in cui si sono svolti quei terribili e sanguinosi attacchi allo Stato
che noi abbiamo visto svilupparsi con l’assassinio di due grandi colleghi come Falcone
e Borsellino, su cui in seguito ci soffermeremo in maniera approfondita. Sono stati
venti anni di indagini, che a Palermo sono andate avanti assieme alle inchieste sviluppate
a Caltanissetta e a Firenze. Il primo fascicolo aperto presso la Procura di Palermo
risale al 1994: non ero ancora io a occuparmene, ma i colleghi iniziarono cercando
le eventuali implicazioni o complicità che poteva aver avuto la criminalità nella
terribile stagione delle stragi. Il primo fascicolo venne archiviato dopo qualche
tempo per poi essere riaperto sull’ipotesi di individuazione di un autentico sistema
criminale, destinata almeno nelle intenzioni di taluni aderenti che non provenivano
direttamente dal mondo mafioso (massoni deviati, eversori di destra, secessionisti
e così via) a preparare addirittura il terreno per progetti golpisti. Anche questa
indagine non arrivò a individuare precise responsabilità penali e personali e perciò
finì in archivio. È un fascicolo che abbiamo riaperto dopo le deposizioni in particolare
del collaboratore Spatuzza e di Massimo Ciancimino. È stato per ora l’ultimo sforzo
compiuto dalla magistratura palermitana per individuare i retroscena della terribile
stagione delle stragi.
CaselliVoglio tornare a ripercorrere i ricordi. E sottolineare anche a te perché il mio lungo
periodo di lavoro a Palermo si sia rivelato autenticamente eccezionale. Comincio con
una constatazione. Con Falcone e Borsellino ci accomunava il fatto di essere stati
tutti e tre giudici istruttori (una figura professionale scomparsa nel 1989, con la
riforma del codice di procedura penale). Lo era stato Giovanni Falcone, lo era stato
Paolo Borsellino, lo ero stato io. Io lo ero stato a Torino dove mi ero occupato soprattutto
di terrorismo, loro a Palermo a guidare inchieste principalmente contro la mafia.
Avevamo sempre svolto questo ruolo con autentico orgoglio.
Terrorismo e mafia sono due fenomeni stellarmente diversi dal punto di vista criminale,
sociale e politico, ma dal punto di vista tecnico-giuridico per alcuni aspetti sono
assimilabili: non solo perché si tratta in tutti e due i casi di reati associativi,
ma perché sono organizzazioni che si basano sul segreto e, soprattutto, perché pongono
quasi gli stessi problemi di risposta da parte dello Stato. Per essere efficace la
risposta deve essere pianificata, mirata sulla specificità del fenomeno da affrontare
e sorretta da un’estrema chiarezza riguardo alla vera natura del fenomeno stesso:
i brigatisti non erano certo dei Robin Hood come avrebbero voluto far credere, ma
spietati assassini; né Cosa Nostra è formata da uomini davvero d’onore, né le organizzazioni
criminali mafiose sono, nel territorio nel quale si insediano, garanti di pacificazione
come la loro retorica mistificante vorrebbe suggerire. Per questo, per studiare insieme
problemi di comune interesse, mi ritrovai con Falcone e Borsellino in vari convegni
e incontri di studio, per esempio del Consiglio superiore della magistratura, sulle
varie manifestazioni del crimine organizzato. Mi erano sempre piaciuti, fin da allora,
quei due magistrati, perché si vedeva tutta la passione che mettevano nel loro lavoro,
la loro curiosità, la competenza, l’acuta intelligenza.
Ci furono anche incontri di carattere più operativo. I magistrati che indagavano su
fatti di terrorismo in diverse città italiane avevano cominciato a riunirsi su suggerimento
di Emilio Alessandrini, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano che si
occupava con competenza e autentica bravura anche di violenza politica e di eversione,
dopo aver condotto grandi inchieste come quella sulla strage di piazza Fontana e aver
iniziato un’istruttoria sul Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Eravamo magistrati
di tante parti d’Italia, volevamo mettere a fuoco la pericolosità e l’estensione e
articolazione delle organizzazioni armate sul territorio nazionale. Ci scambiavamo,
nel pieno rispetto delle procedure, rapporti, verbali, documenti sequestrati. Era
un modo volontaristico, un po’ artigianale di coordinarci, ma che voleva superare
l’eccessivo frazionamento delle competenze territoriali che finiva talvolta per rendere
incomprensibile al singolo magistrato l’estensione e perfino la natura del fenomeno
criminale che stava affrontando. Sono i princìpi (specializzazione e centralizzazione)
oggi alla base delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale
antimafia. Quelle riunioni si rivelarono presto molto fruttuose, tanto che chiese
di parteciparvi un numero sempre più alto di magistrati, provenienti anche da sedi
giudiziarie poco colpite o non direttamente interessate dal terrorismo. Come Palermo.
Falcone e Borsellino li ho incontrati anche in questo contesto. Mi colpirono per la
lucidità e la voglia di affinare strumenti di conoscenza capaci di rendere sempre
più efficace l’intervento di legalità.
Nella mia memoria ci sono anche le polemiche che accompagnarono questo tipo di incontri:
una certa sinistra, interna anche alla magistratura, insorse rumorosamente pretendendo
di vedere in questo nuovo modo di procedere, finalizzato esclusivamente a ridurre
gli effetti perversi della frammentazione delle conoscenze, addirittura la creazione
di inaccettabili “giudici speciali”. C’era in particolare un amico, che tale è rimasto
nonostante le frequenti divergenze di opinione, che metteva aspramente in discussione
i nostri metodi: era il collega Luigi Saraceni, poi diventato parlamentare. Evidentemente
equivocando le premesse, gli oppositori giungevano a conclusioni errate, scorgendo in moduli di carattere meramente organizzativo pericoli per i princìpi di diritto.
Col risultato che capitava di trovarsi indicati come avversari nella difesa di valori
per i quali ci si stava invece battendo. Equivoci che si sono dolorosamente ripetuti,
ancora di più, durante la mia esperienza a Palermo. E in modo spesso del tutto strumentale.
Ma nel nostro paese è una costante: il magistrato che non interpreta il suo ruolo
in modo burocratico, che si accolla invece la responsabilità del risultato nel rispetto
delle regole, quel magistrato può essere sicuro che se incrocia interessi forti prima
o poi sarà attaccato.
Un giorno Antonino Caponnetto, capo dei giudici istruttori di Palermo, telefona per
sapere come noi a Torino eravamo riusciti ad affidare a più giudici istruttori una
stessa inchiesta. In pratica vuole sapere quale soluzione abbiamo trovato dal punto
di vista procedurale. Il giudice istruttore era infatti per definizione monocratico,
cioè operava da solo. E per questo motivo le primissime inchieste sulle Brigate rosse,
di competenza di Torino, erano state assegnate tutte a un solo giudice istruttore,
che ero io: erano inchieste che avevano al centro i sequestri Labate, Amerio e Sossi
(Pm genovese), operati dal nucleo storico delle Brigate rosse. In termini concreti,
questo significava che fino a quel momento tutti gli atti istruttori erano stati affidati
a un solo magistrato che aveva al fianco un solo pubblico ministero. L’idea di formare
un pool ci venne in mente solo dopo l’assassinio del procuratore generale di Genova,
Francesco Coco, ucciso assieme ai due uomini che lo scortavano, Giovanni Saponara
e Antioco Dejana. La Cassazione aveva designato anche per questa inchiesta noi di
Torino poiché correttamente aveva interpretato quel delitto come una rappresaglia
contro Coco che si era opposto alla liberazione di alcuni detenuti, richiesta dai
brigatisti in cambio del loro “prigioniero” Sossi. Insomma Torino, già incaricata
dell’istruttoria sul sequestro del magistrato genovese Sossi, doveva occuparsi anche
dell’assassinio di Coco, che ne era una conseguenza.
Ricordo che in quella occasione mi chiamò nel suo studio il capo dell’ufficio istruzione
di Torino, Mario Carassi, che mi affidò l’inchiesta Coco, dicendomi che però da quel
momento tutte le inchieste sul terrorismo sarebbero state assegnate non più solo a
me ma anche ad altri colleghi che inizialmente sarebbero stati Mario Griffey e Luciano
Violante. “Ovviamente tu devi continuare”, mi disse esattamente Carassi che è stato
uno dei miei maestri. “Ma ora è bene che tu non sia più solo. L’estensione e pericolosità
del fenomeno terroristico sono sempre maggiori, per cui è necessario che vi siano
in campo più risorse per contrastarlo. E poi, se vi sono più obiettivi possibili,
minore diventa il rischio per ogni singola persona”. Ma soprattutto mi fece capire
che tra le valutazioni che lo avevano spinto a prendere quella decisione vi era anche
quella che, caso mai fosse successo qualcosa a uno di noi, sarebbero restati gli altri
per andare avanti e concludere il processo. Carassi era piemontesissimo e forse non
sapeva l’inglese: non pronunciò mai, a quel che ricordo, la parola pool, che neppure,
credo, gli sarebbe potuta venire in mente.
Sta di fatto che quel giorno nacquero proprio i pool. Io allora gli feci la stessa
domanda che poi ci rivolsero Caponnetto, Falcone e Borsellino: come era possibile
dal punto di vista procedurale realizzare un simile progetto? Come si poteva attribuire
a tre giudici istruttori, a tre magistrati monocratici, la titolarità congiunta di
una stessa inchiesta giudiziaria? La risposta il nostro consigliere istruttore l’aveva
trovata lavorando sull’articolo 17 delle disposizioni di attuazione del vecchio codice
di procedura penale, il cosiddetto codice Rocco. Quell’articolo gli consentiva di
intestare il processo a se stesso come dirigente dell’ufficio, delegando poi per il
compimento dei singoli atti congiuntamente o disgiuntamente singoli giudici istruttori.
Da quel giorno varie volte la Cassazione sarebbe stata investita del problema da ricorsi
presentati da difensori di imputati: e sempre la Cassazione avrebbe sottoscritto e
sostenuto quell’intuizione del geniale consigliere istruttore di Torino.
Questo voleva sapere Caponnetto. Questo gli spiegai. Anche a Palermo decisero di lì
a poco di adottare un’interpretazione sostanzialmente simile a quella torinese. Per
me è stato motivo di grande soddisfazione sapere di avere in qualche modo contribuito
a intraprendere fin da allora (insieme a Palermo) una via procedurale assai efficace
per contrastare la grande criminalità organizzata. Mi faceva piacere ricordare oggi
come gli effetti positivi di una scintilla torinese si fossero presto estesi anche
a Palermo, con grandi, indiscutibili risultati.
IngroiaIo naturalmente il lavoro del pool non l’ho visto nascere, l’ho solo studiato come
metodo d’inchiesta quando frequentavo l’Università di Palermo. Era una mia curiosità
del tutto personale. Il distacco fra facoltà di giurisprudenza e i problemi concreti
che la magistratura, a quel che leggevamo sui giornali, si trovava ad affrontare era
infatti profondo. Non ho allora mai potuto misurare la mia conoscenza giuridica con
Giovanni Falcone e con Paolo Borsellino. Solo alcuni anni dopo questi episodi che
stai raccontando per averli vissuti in prima persona, ho conosciuto direttamente i
due magistrati che sono stati per me autentici punti di riferimento e di insegnamento
per la vita. In parallelo con gli avvenimenti che stai ricostruendo ho solo ricordi
di studio e di civile, grande interesse per i fatti di mafia. Ricordi giovanili. Assieme
a quella che talvolta mi appare come una vera e propria predestinazione: mi sono laureato
infatti nel 1985 con una tesi sul reato associativo di mafia, cioè il 416 bis, che
era stato introdotto nel codice penale da non molto tempo, esattamente dopo l’assassinio
del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente
Domenico Russo nel 1982. Io sono palermitano e mi ritrovo molto in una osservazione
un po’ fatalista (e noi siciliani, credo, siamo tutti un po’ fatalisti) che un giorno
mi fece Borsellino. Mi disse che spesso occuparsi di inchieste di mafia è contemporaneamente
per noi magistrati un effetto del caso e del destino personale. È proprio quel che
mi è successo. Io francamente, una volta laureato, avrei preferito dedicarmi agli
studi di diritto penale. Feci l’esame di magistrato tanto per provare, ma senza tanta
convinzione: non era in quel momento l’obiettivo principale della mia vita. Diventai
invece magistrato e sei mesi dopo, era il 1988, mi trovai a bussare alla porta di
Giovanni Falcone. Come sempre, un po’ il caso e un po’ il destino.
Capitolo II
I nemici di Falcone e Borsellino
Nel 1986 Gian Carlo Caselli aveva già i capelli bianchi. Di solito veniva a Roma da
Torino, dove abitava, una volta a settimana. E si portava dietro una borsa ricolma
di decine di rapporti, fotocopie, relazioni. Voleva, e giustamente, essere ben documentato
prima di prendere decisioni impegnative al Consiglio superiore della magistratura,
in Palazzo dei Marescialli. Ed è all’ingresso del Palazzo che la sua strada si è incrociata
diverse volte con quella di Falcone. Era più sorridente Falcone, quando arrivava per
essere sentito dal Consiglio, anche se appariva preoccupato. Con lui in queste occasioni
non si parlava, a differenza di quel che spesso poteva capitare a Palermo, di cassate
siciliane o di estasiante frutta candita, equilibrando così ritratti di mafiosi, storie
di misteri criminali, oltre a suggestioni e ricordi legati a comuni, allegre rievocazioni
di intelligenti passaggi tratti da libri letti o riferiti a film leggendari visti.
Caselli appariva invece quasi teso, drammaticamente serio. Allora parlava di un mondo,
di un ambiente che conosceva solo per averne letto attraverso molti documenti. Sempre
in quell’ingresso romano, dopo l’austero portone del Palazzo gli capitò anche di incontrare
Borsellino, anch’egli spesso generosamente arrabbiato. Era più severo Caselli dei
due venuti dall’estremo Sud, era più riservato, più preoccupato.
Ingroia, invece, ancora non lo conosceva nessuno, tra i magistrati più impegnati.
Forse faceva ancora lo studente a Palermo, sognando di dedicarsi poi allo studio e
alla riflessione. Non c’erano ancora nella sua vita quotidiana ricostruzioni di delitti,
tracce di sangue e di violenza. Non sapeva di avere tra i nemici uomini dediti alla
corruzione, alla menzogna, gente i cui traffici intralciavano l’onesta attività di
altri. Non doveva fare i conti con gli alibi e le menzogne. Gli bastavano i cineclub
per nutrirsi di fantasia e sogno. Ingroia doveva ancora incontrarsi con Falcone, suo
primo maestro di istruttorie. E doveva ancora imparare l’imparzialità e la rettitudine
da Paolo Borsellino.
Sia Caselli sia Ingroia hanno frugato nella loro memoria, cercando ricordi e segnali
di feroci contrapposizioni contro quei due magistrati che hanno saputo ben coniugare
rettitudine e intransigenza, specchiatezza e determinazione. Lo hanno fatto a lungo,
uno di fronte all’altro, con emozione, con nostalgia, con profonda e dura onestà.
CaselliMentre tu ti laureavi e vincevi il concorso, io dal 1986 al 1990 ho fatto parte del
Consiglio superiore della magistratura. Ero stato eletto, con Pino Borrè ed Elena
Paciotti, nella lista di Magistratura democratica. Sono stati anni contrassegnati
da continui “casi Palermo”. In particolare, io facevo parte del Comitato antimafia
del Consiglio. Frequentissime sono quindi state le occasioni in cui ebbi a che fare
con Falcone e Borsellino (che di quei “casi” erano di fatto le vittime).
Il primo “caso Palermo”, poco dopo la conclusione del maxiprocesso a Cosa Nostra,
riguarda Paolo Borsellino, che fa domanda per essere trasferito dal Tribunale di Palermo
(pool dell’ufficio istruzione) ed essere nominato procuratore capo a Marsala. Il contrasto,
la spaccatura all’interno del Csm riguarda i criteri di nomina dei dirigenti degli
uffici giudiziari in terre di mafia. Concorrente di Borsellino è il dottor Alcamo,
magistrato molto più anziano ma assai meno esperto di mafia. All’interno del Consiglio
si creano due fronti, uno a favore dell’anzianità di servizio, allora principale criterio
di assegnazione degli incarichi “ordinari”, un altro – in forza di una circolare del
Csm del 15 maggio 1986 espressamente dedicata al tema della lotta alla mafia – a favore
della professionalità di Paolo Borsellino.
Io sostengo con decisione il secondo criterio e quindi la candidatura di Paolo Borsellino,
ed è in quel momento che – inevitabilmente – si crea con lui un rapporto molto cordiale.
Sostengo Borsellino a costo di staccarmi dai miei colleghi di Magistratura democratica,
che votano in maniera diversa, non ritenendo possibile scavalcare un’anzianità così
clamorosa. Alla fine, la maggioranza del Csm si esprime in favore di Borsellino. Sembra
tutto finito. Invece, scende in campo il “Corriere della Sera”. Il maggiore quotidiano
italiano pubblica un editoriale di Leonardo Sciascia, I professionisti dell’Antimafia. Uno degli obiettivi è Leoluca Orlando, ma lo sconquasso lo crea nelle ultime righe
citando Paolo Borsellino. L’accusa, sorprendente, era di strumentalizzare l’impegno
contro la criminalità mafiosa per acquisire personali vantaggi di carriera scavalcando
colleghi altrettanto se non più meritevoli.
IngroiaRicordo anch’io molto bene quella polemica con tutti gli strascichi, anche le più
scoperte strumentalizzazioni che si portò dietro. Ricordo che a Borsellino provocò
dispiacere. Dispiacere e rabbia. Borsellino era sicuro, me lo disse più di una volta,
che qualcuno che certamente non l’amava avesse fornito a Sciascia informazioni infondate
e tendenziose. Ma Borsellino, se pur convinto che con quella polemica “era iniziata
la fine” (come diceva lui) della stagione del pool di Palermo, non riusciva ad avercela
con Sciascia, amava troppo i suoi romanzi sulla mafia. Perciò, più che ricordare quanto
quella polemica lo avesse ferito, preferiva raccontare la sua “rappacificazione” con
lo scrittore. Si incontrarono, si parlarono e si chiarirono. Borsellino si rasserenò.
CaselliIn quel Consiglio superiore di cui facevo parte anch’io, ci occupammo più volte di
Giovanni Falcone. Fu Antonino Caponnetto, involontariamente, a mettere in moto il
meccanismo. Quando lasciò Palermo, infatti, dovemmo nominare il suo successore, il
nuovo capo dell’ufficio istruzione. Ci trovammo a discutere di Giovanni Falcone e
di Antonino Meli, suo diretto concorrente, che rappresentava una cultura giudiziaria
molto vecchia, tradizionalmente perdente nei confronti della mafia. Ci fu una nuova
spaccatura, interna ed esterna al Consiglio. Per la seconda volta anche Magistratura
democratica si divise: io votai per Falcone; Paciotti e Borrè per Meli. Questa volta
andai in minoranza. Quasi tutti i consiglieri appartenenti a Magistratura indipendente,
a cominciare dal palermitano Vincenzo Geraci, che pur nell’occasione precedente avevano
votato per Borsellino, si schierarono contro Falcone d’accordo con la stragrande maggioranza
di un altro gruppo, quello di Unicost, che tirava esplicitamente, anche con asprezza
di toni, la volata a Meli.
Ne nacque la battaglia che molti ancora ricordano. Una brutta, impegnativa, difficile
battaglia, di cui voglio rievocare alcuni momenti, che vissi anche con rabbia. Come
quando nel dibattito intervenne il collega Sergio Letizia, in rappresentanza di un
gruppo poi scomparso che mi pare si chiamasse Sindacato dei magistrati o qualcosa
di simile. Letizia, in pieno Consiglio, sostenne che nominare Falcone avrebbe significato
violare la legge e disse che lui non credeva proprio “ai geni e ai superuomini”. Anzi,
sottolineò che se fosse stato nei panni di Falcone, in presenza di candidati molto
più anziani lui non avrebbe neppure osato presentare la domanda. Falcone, si sa, venne
sconfitto. Ascoltando alcuni interventi contro Falcone si capiva bene come una certa
magistratura guardasse con antipatia, perfino con diffidenza, ai colleghi più attivi
e operosi, e per questo più noti, quelli che si spendono, che si espongono e che vengono
ingiustamente accusati di un protagonismo che in realtà non è quasi mai voluto e che
semmai è la conseguenza dello spirito di servizio. Ricordo che un consigliere di Unicost,
Gianfranco Tatozzi, arrivò a dire nella solennità della grande aula del Palazzo dei
Marescialli, dove pubblicamente si riunisce il “plenum” del Consiglio, che “un’eventuale
scelta a favore di Falcone” poteva essere interpretata come “una sorta di dichiarazione
di stato di emergenza negli uffici giudiziari di Palermo decretata da un organo che,
senza essere politicamente responsabile, si arrogherebbe il potere di sospendere l’applicazione
delle regole legali”. Insomma una bocciatura per Falcone. Eppure poco prima lo stesso
Tatozzi, in pubblico, aveva pronunciato una battuta che aveva fatto il giro di tutti
i giornali, sulla riconoscenza che il nostro paese avrebbe dovuto esprimere a Falcone,
nominandolo... senatore a vita. E per concludere, il palermitano Vincenzo Geraci,
pochi giorni dopo la sconfitta di Falcone da lui tenacemente perseguita, nel tentativo
di spiegare a un giornale la sua posizione a favore di Meli, arrivò ad affermare che
“per quanto mi riguarda personalmente, non ho difficoltà ad ammettere che prima di
schierarmi ho valutato quale orientamento era prevalente fra i giudici e all’interno
delle correnti di Palermo. Il riflesso elettorale di questa decisione non poteva essere
trascurato”. Come dire che un pugno di voti a favore della propria corrente associativa
aveva finito col contare di più rispetto alla valutazione della professionalità antimafia
di un magistrato come Giovanni Falcone.
Il risultato di questi attacchi naturalmente fu pessimo: al di là delle intenzioni
di alcuni, in definitiva venne bocciato il modello di magistrato che fa di più e che
perciò rischia di più. Lo dissi in Consiglio con sofferenza, con passione. Attaccai
apertamente chi aveva visto nella eventuale nomina di Falcone un “premio dato al protagonismo”:
quando i magistrati non erano scomodi perché restavano inerti, non facevano, erano
tutti bravi e belli; ma quando hanno cominciato a dare segni di vitalità, a pretendere
di esercitare il controllo di legalità anche verso obiettivi fino ad allora impensabili,
ecco che è cominciata l’accusa di protagonismo. Mentre niente è stato detto contro
quei giudici che si sono tirati indietro: è successo a Torino in occasione del processo
di assise per i capi storici delle Brigate rosse, è successo a Palermo per il maxiprocesso
in assise contro la mafia. E in Consiglio ebbi parole dure anche per chi aveva adombrato
una sorta di privilegio per i magistrati provenienti da determinate esperienze professionali.
Osservai che era scandaloso anche solo ipotizzare una tale situazione: come poteva
essere inteso come privilegio l’operare ad esempio a Palermo, a tu per tu con la criminalità
organizzata? Semmai era una vera e propria penalizzazione. Mi accalorai, motivai,
spinsi. Fu tutto inutile.
Il Consiglio si impegnò solennemente, in occasione della nomina di Meli, a sostenere
anche in futuro il collaudato metodo di lavoro del pool. Falcone, seppure molto amareggiato,
cercò di continuare a Palermo il suo lavoro di giudice istruttore.
Per qualche tempo al Consiglio superiore non si sentì più parlare di Palermo. Seppi
però dei giusti risentimenti, della delusione di Falcone. Mi arrivò l’eco delle difficoltà
del collega rimasto al suo posto. Fu Borsellino, procuratore di Marsala, a lanciare
pubblicamente l’allarme nel luglio 1988. Lo fece con generosità, andando allo scontro,
rischiando come sempre di persona. In un convegno ad Agrigento e in due interviste
denunciò come il nuovo capo dell’ufficio istruzione, Meli, stesse letteralmente smantellando
il pool. Altro che il solenne impegno del Consiglio a sostenerlo. Tutta l’architettura
del contrasto giudiziario contro la criminalità organizzata messa faticosamente in
piedi veniva pezzo per pezzo abbattuta. Non si affrontava più Cosa Nostra per quel
che è, cioè una struttura centralizzata, fermamente controllata dai capi, articolata
nel territorio e che richiede quindi da chi è chiamato a ripristinare la legalità
una struttura organizzativa speculare. Si tornava a fronteggiarla parcellizzando gli
interventi, segmentando le inchieste, sminuzzando le conoscenze, correndo a inseguire
a uno a uno i singoli atti criminali, dall’estorsione alla rapina, al traffico di
droga, alla vessazione, all’assassinio. Senza più centralizzare le informazioni, senza
più affidare a una sola struttura l’analisi e la ricostruzione del sistema mafioso.
Si era fermato tutto lo scambio di notizie, il sostegno reciproco fra magistrati.
Si era tornati là dove si era partiti mezzo secolo prima, quando i mafiosi continuavano
a farla franca e la magistratura appariva largamente impotente.
Capii allora la rabbia di quei due colleghi, la loro delusione. Ebbi la conferma che
erano uomini che, nel rispetto delle regole, volevano liberare quella terra, la loro
terra, dagli assassini, dai fuorilegge e dai tanti complici. Capii e li apprezzai
ancora di più. Noi, al Palazzo dei Marescialli, fummo chiamati a intervenire dopo
la denuncia di Borsellino. Qualcuno forse pensava che quella poteva essere la grande
occasione per mettere a tacere anche altri, non solo Falcone. Furono giorni di veleni,
di scontri, di insidie. Falcone e Borsellino dovevano ostentare sicurezza, ma erano
tesi, preoccupati. Fu una battaglia brutta e lunga: noi di Magistratura democratica
ci ricompattammo per difendere il pool ma, come si sa, fummo sconfitti. La nostra
posizione, pur sommandosi a quella di altri, restò di minoranza. Alla fine il pool
venne letteralmente distrutto, le istruttorie smembrate, il lavoro investigativo sminuzzato
se non interrotto. Palermo in quei giorni mi entrò nell’anima.
Con Falcone e Borsellino, durante queste fasi consiliari, ebbi poche occasioni di
parlare privatamente, a tu per tu: la situazione era assai delicata, ciascuno doveva
rispettare le regole del proprio ruolo e mantenersi assolutamente libero. Ciò nonostante
per noi parlarono i voti espressi, lo schieramento, il sapere d’essere tutti e tre
dalla stessa parte. Sconfitti, naturalmente, tutti e tre: ma consapevoli di esserci
battuti, ciascuno per suo conto, in nome del nostro dovere.
Di quei giorni, che furono tanti, troppi, mi è rimasto ben impresso nella memoria
il clima quasi di ferocia in cui si svolsero alcuni dibattiti interni al Consiglio
superiore. Nell’estate, credo del 1987, il Consiglio fu convocato d’urgenza e in via
straordinaria, per parlare ancora una volta di Palermo. Ricordo che per difendere
il pool e la lotta antimafia dallo smantellamento in atto si presentò anche Pino Borrè,
che pure era appena entrato in convalescenza dopo un infarto. Furono giorni e notti
...