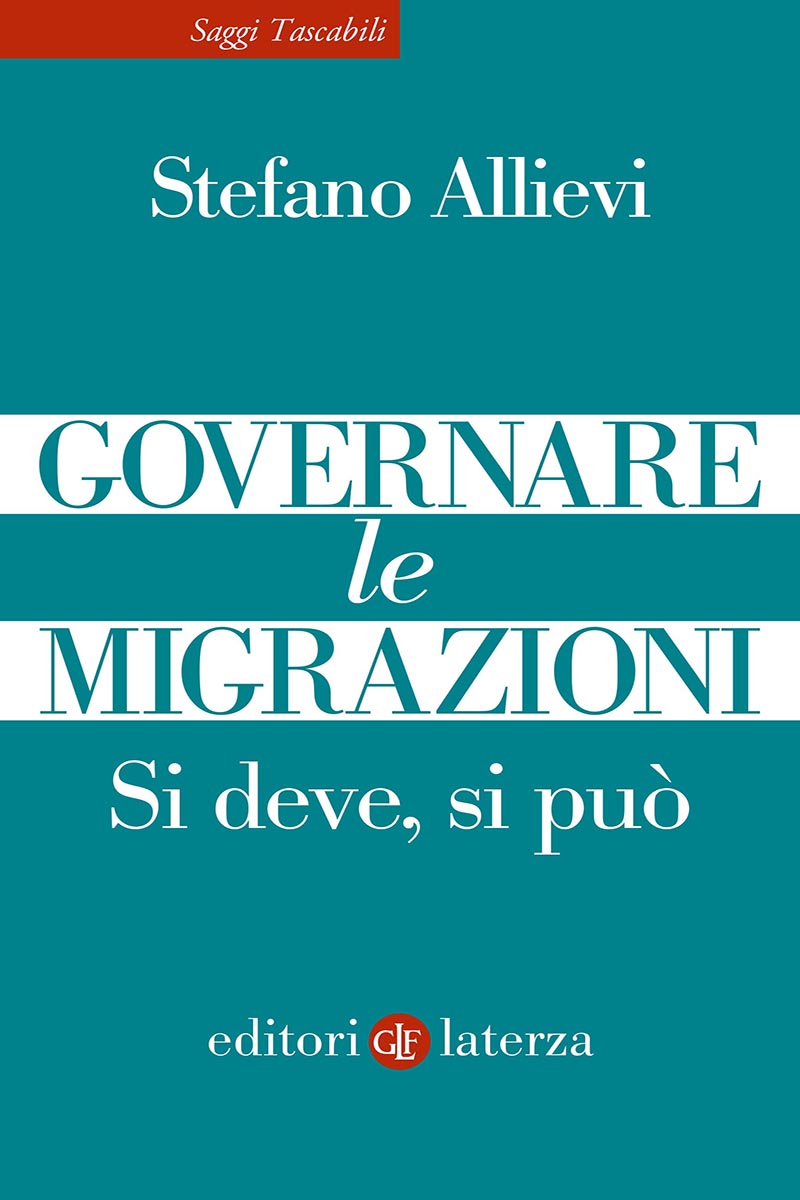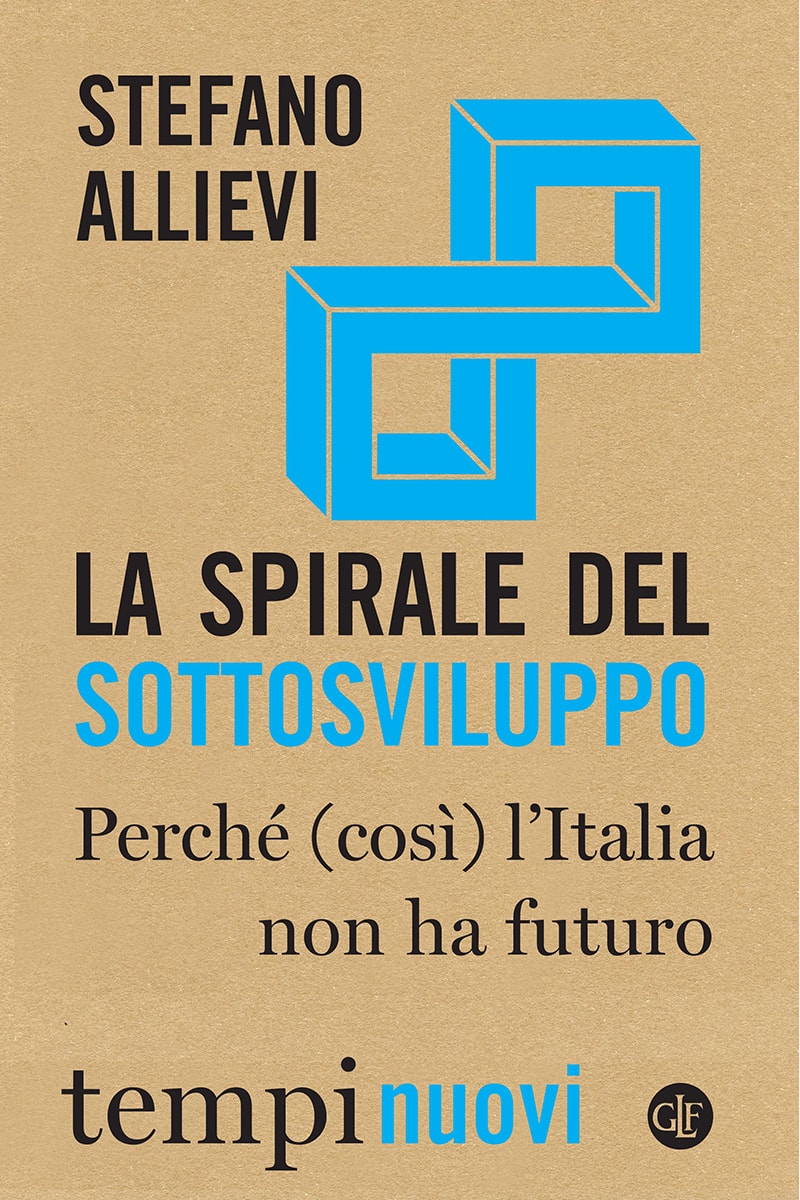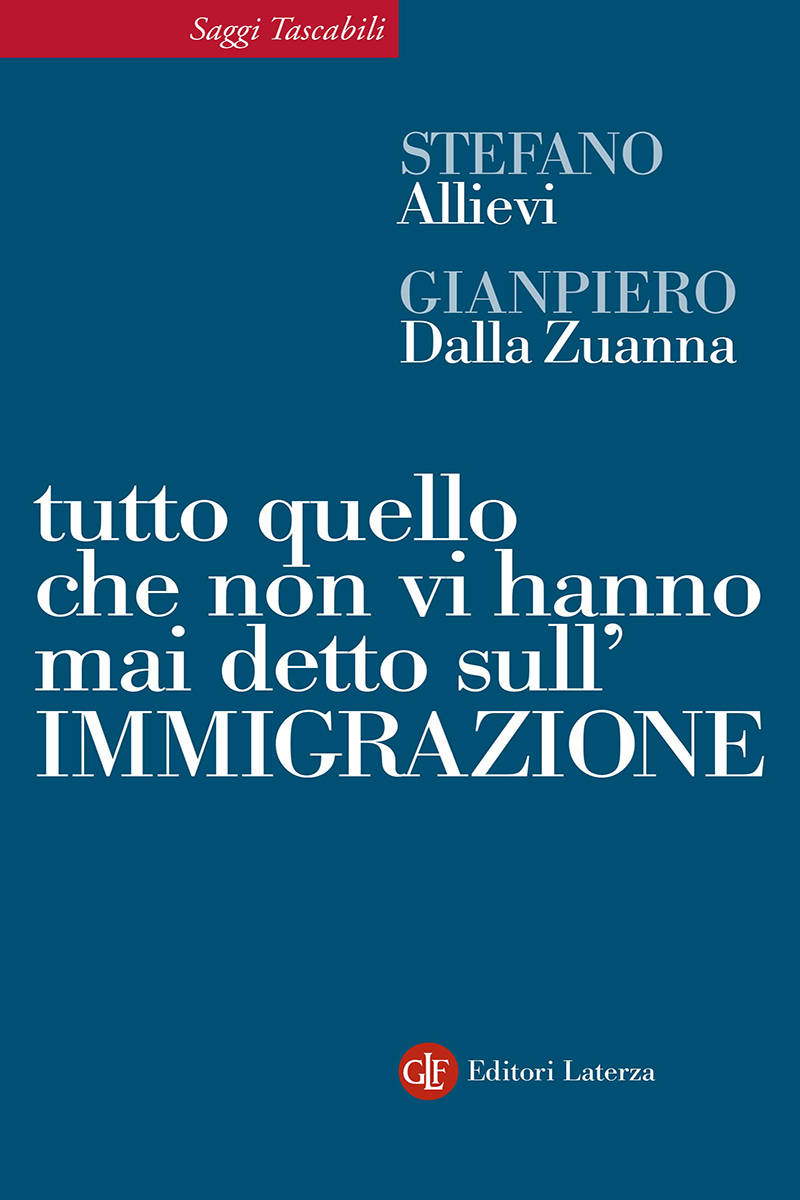Immigrazione
Le migrazioni ci sono. Sono sempre di più e saranno ancora di più in futuro. Non è più il tempo dei problemi senza risposta: è il momento delle soluzioni.
L’immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni. Tuttavia è sempre stato affrontato in termini di emergenza, come fosse un fatto episodico. Ma l’estensione, la qualità e la quantità del processo sono tali da esigere una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza che non sottovaluti il malessere diffuso nell’opinione pubblica. Le recenti polemiche intorno al ruolo delle ong nei salvataggi sono l’ultimo degli esempi. Per non dire della crescente xenofobia che rischia di indebolire la coesione sociale del nostro paese. L’immigrazione irregolare, il trafficking (i suoi costi e i suoi morti), i salvataggi, i respingimenti, la gestione dei richiedenti asilo con le sue inefficienze, le forme dell’accoglienza. E ancora, i problemi legati ai rimpatri, alla cittadinanza, alle implicazioni delle diverse appartenenze religiose: è urgente e necessaria una riflessione critica onesta su tutte le questioni che accompagnano le migrazioni attuali, affrontando quelle più spinose, con il coraggio di proposte radicali.
Rassegna stampa
-
Immigrazione
L'immigrazione e coesione sociale: Allievi spiega perché non è emergenza
-
Immigrazione
Allievi spiega le migrazioni "chiudere i canali regolari avvantaggia solo le mafie"
-
Immigrazione
Superare gli "squilibri" e accogliere: allievi rompe il tabù immigrati