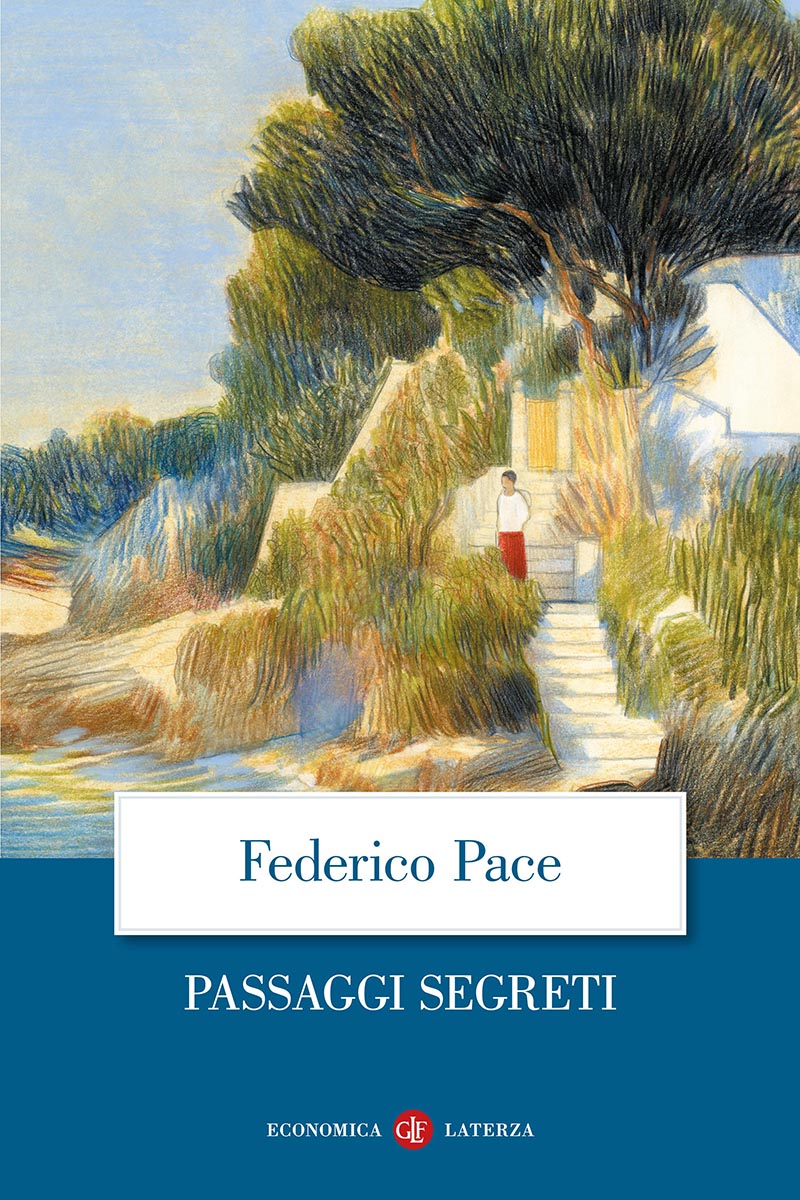Passaggi segreti
«Un pomeriggio d’inverno sono partito per un viaggio così breve che non pensavo potesse condurmi così lontano.»
Tra le valli e i monti, lungo i fiumi e tra gli alberi. A pochi passi dalle città e lontanissimo dalle autostrade. Là dove il rumore delle metropoli retrocede, ci sono vie poco battute, percorsi ferroviari nascosti, passaggi fluviali e varchi che aprono la strada verso un’Italia preziosa e profonda. Dalle enigmatiche vie cave di Pitigliano scavate nel tufo al rocambolesco fascino della statale 92 che attraversa la dorsale della Basilicata. Dal sentiero di punta Manara che conduce lì dove, al confine con il mare, una torretta ancora sembra attendere l’attacco dei Saraceni, fino ai meandri misteriosi delle barene tra le isole abbandonate della laguna della Venezia Nativa. Dai gradoni luminosissimi e irreali della Salita dei Turchi fino al viaggio in traghetto, sulle acque rapide del Lago Maggiore, che conduce all’eremo di Santa Caterina del Sasso. Federico Pace ci accompagna in un suggestivo viaggio tra luoghi che diventano occasione di piccole epifanie, in cui si svela qualcosa di inatteso, un meravigliato contatto che, senza una partenza, non sarebbe stato possibile. Il paesaggio, il movimento, le storie delle persone e i loro legami offrono l’opportunità di uno sguardo diverso e nuovo su noi stessi, sugli altri e su quel che ci accade intorno.