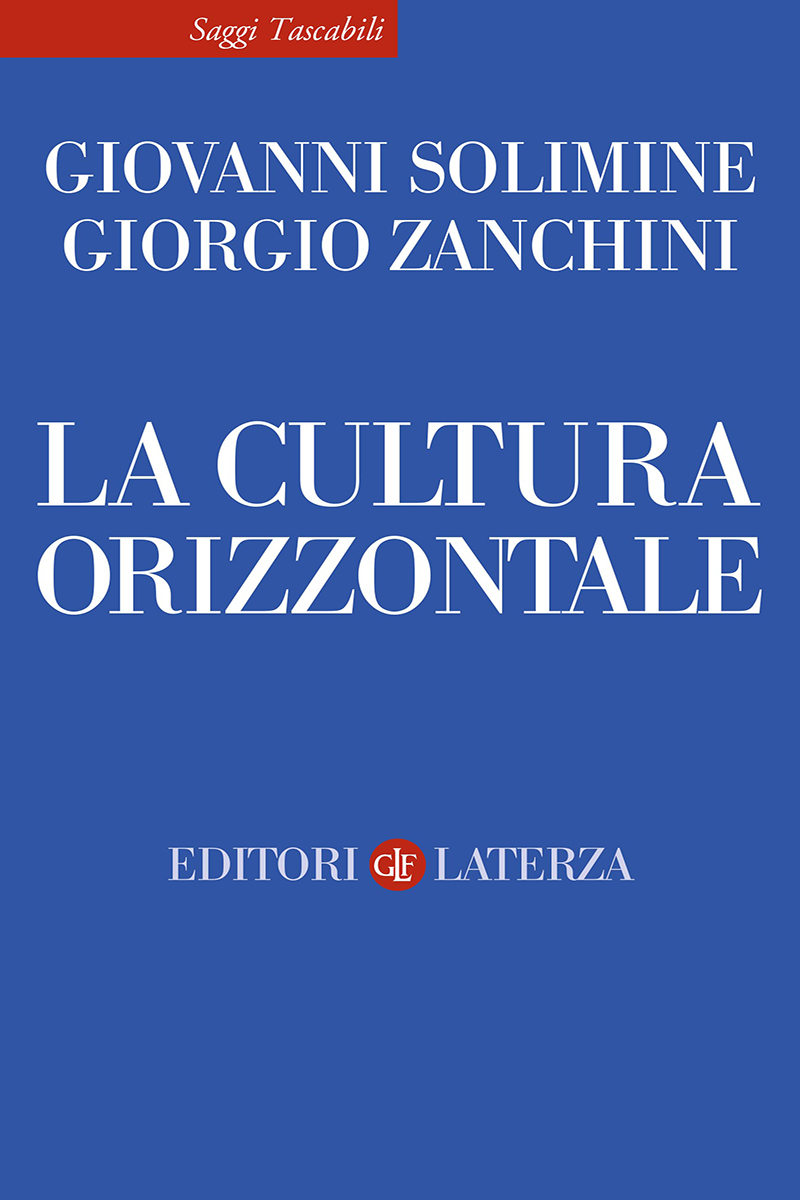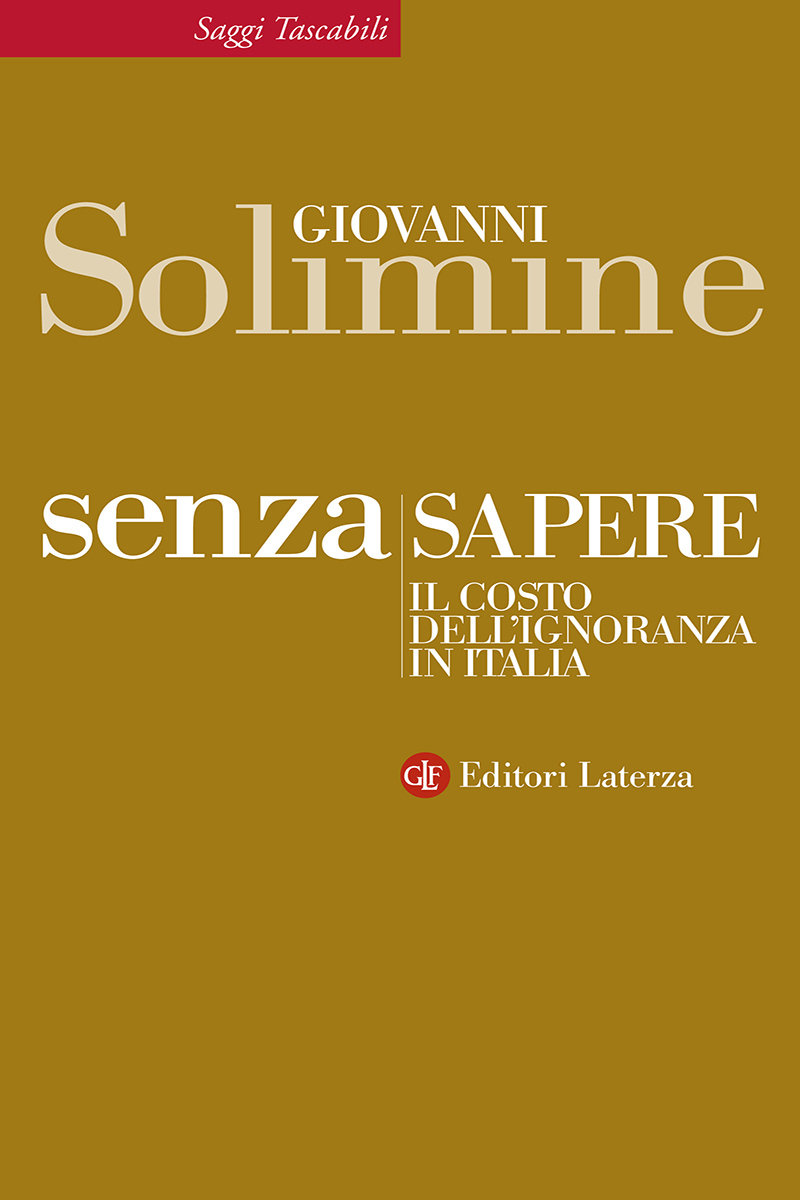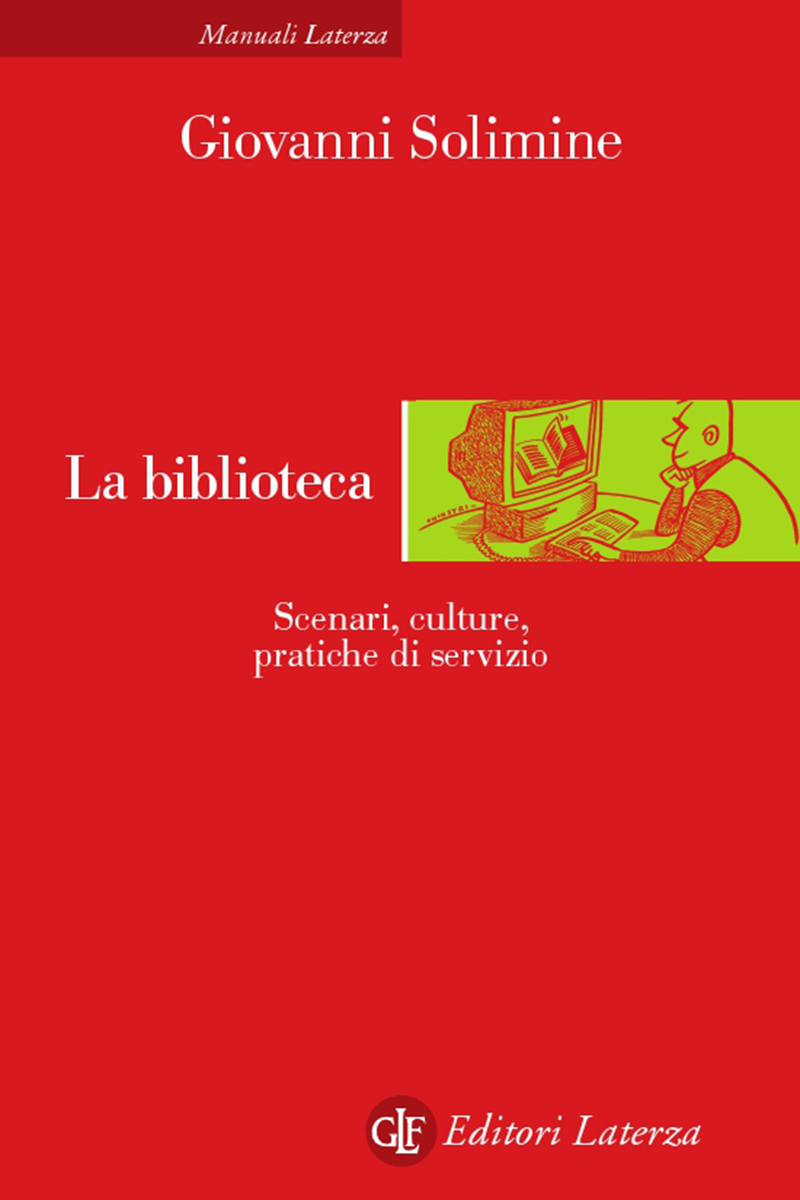Premessa
Da poco sono stati celebrati i cinquant’anni di Internet e, nelle occasioni di discussione
che hanno accompagnato l’anniversario, si è spesso affermato che questa invenzione
ha cambiato profondamente la nostra esistenza.
L’espressione secondo la quale ormai è ‘tutto un altro mondo’ vale anche per la cultura.
Scopo di questo nostro lavoro è descrivere le forme di produzione e di partecipazione
culturale nell’era della rete e, analizzando le attività svolte dal pubblico giovanile,
cercare di comprendere se atteggiamenti e pratiche collettive possano essere utilizzati
per individuare connotati utili per leggere meglio l’identità plurale di un’intera
generazione.
A noi è sembrato di poter individuare nella dimensione orizzontale l’elemento caratterizzante
delle pratiche culturali in rete nei primi due decenni del XXI secolo ed è di questo
che cerchiamo di dar conto nelle pagine che seguono.
I contenuti del volume sono stati discussi e condivisi dai due autori, che sono anche
intervenuti congiuntamente e con successive riscritture nei diversi capitoli. Tuttavia,
le prime stesure possono essere così attribuite: Giovanni Solimine è autore della
parte iniziale del volume, corrispondente grosso modo ai primi dieci capitoli, mentre
Giorgio Zanchini è autore dei restanti capitoli; le considerazioni conclusive sono
frutto delle convinzioni che entrambi hanno maturato a mano a mano che il volume prendeva
forma.
Questo lavoro non sarebbe stato realizzato senza il contributo di Paolo Pugliese,
che ha collaborato alle ricerche e alla messa a fuoco di molte questioni, ed è inoltre
l’autore del capitolo 18. A lui va il nostro sentito ringraziamento.
Gli autori hanno anche contratto debiti di gratitudine nei confronti di tanti amici
e colleghi che non hanno fatto mancare consigli e segnalazioni: un ringraziamento
particolare va ad Anna Gialluca e a Gino Roncaglia.
G.S. G. Z.
1.
In che mondo siamo?
Più di quattro miliardi! Stiamo parlando degli utenti di Internet, quantificati nel 2019 in 4,39 miliardi e con un ritmo di crescita di oltre un milione
di nuovi utenti ogni giorno. In termini percentuali vogliono dire il 57% degli abitanti
del pianeta, di cui l’86% dei cittadini europei (con una punta massima del 95% nei
paesi nordici e una punta minima dell’80% nei paesi dell’Est), il 78% nelle Americhe
(ma il 95% nel Nord America), il 71% in Medio Oriente, il 52% in Asia e nell’area
del Pacifico, il 36% nel continente africano (ma qui l’80% della popolazione dispone
di una connessione alla rete mobile e in molti paesi il numero di utenti si raddoppia
o triplica di anno in anno). Si prevede che entro il 2025 gli utenti diventeranno
sette miliardi, quasi la totalità della popolazione. Mediamente gli esseri umani trascorrono
su Internet 6 ore e 42 minuti al giorno, di cui circa la metà tramite connessione
mobile.
I social media sono usati dal 45% dell’umanità (il numero degli utilizzatori è raddoppiato
nell’ultimo quinquennio) e assorbono mediamente due ore al giorno del nostro tempo;
la punta massima di utenti si registra in Nord America ed Estremo Oriente, col 70%.
La connessione mobile fa registrare percentuali elevatissime: raggiunge ormai i due
terzi della popolazione (oltre 5 miliardi di persone, ma gli account sono circa 9
miliardi) e veicola più della metà del traffico a livello mondiale (dieci anni fa
non raggiungeva l’1%).
Più di un miliardo il numero di siti presenti sul web; i più visitati sono, nell’ordine,
Google, YouTube e Facebook; Facebook e WhatsApp sono i sistemi di messaggeria più
diffusi (quest’ultimo figura al primo posto in 133 paesi e conta un miliardo e mezzo
di utenti). Esteso su oltre il 90% della superficie del pianeta, Facebook ha superato
i due miliardi di utenti mensili, nel 96% dei casi viene usato da mobile ed è maggiormente
diffuso nella fascia d’età 25-34; Instagram è a un miliardo di utenti (in gran parte
di età compresa fra i 18 e i 34 anni) e fa registrare il più elevato ritmo di incremento;
seguono due social cinesi: Qzone e Weibo, un ibrido fra Facebook e Twitter, che si
aggirano entrambi intorno ai 500 milioni di utenti. Infine, fra i 200 e i 350 milioni
di utenti si collocano Twitter (usato per due terzi dai maschi), Google+, Snapchat
e Pinterest. Il più diffuso social network professionale, LinkedIn, ha triplicato
in un anno i suoi utenti, che superano ora i 300 milioni.
Il 75% degli utenti di Internet e il 37% della popolazione di età superiore ai 15
anni effettua acquisti in rete (per un valore di circa 1,8 trilioni di dollari e con
un ritmo di incremento annuo del 14%), e in Indonesia, Cina e Thailandia più del 70%
di queste transazioni avviene via smartphone; più della metà delle ricerche di un
prodotto da acquistare parte dal sito di Amazon, il cui fatturato supera i 230 miliardi
di dollari.
Anche gli ‘oggetti’ e le attività culturali più tradizionali e non commerciali sono
migrate rapidamente e in misura consistente verso la rete. Senza considerare il materiale
digitale nativo e limitandoci solo a ciò che dall’universo analogico si sta trasferendo
verso quello digitale, l’offerta è in progressiva crescita. A partire dal 2005 Google
Books ha approssimativamente digitalizzato e reso disponibili online 30 milioni di
volumi full-text, in 400 lingue diverse e provenienti da oltre 100 paesi (non si dispone
di dati più precisi e aggiornati, perché dal 2015 non vengono più fornite informazioni
sullo stato d’avanzamento del progetto); Internet Archive dichiara la disponibilità
di 15 milioni di ‘books and texts’, con in più 550.000 libri che non sono nel pubblico
dominio, ma che possono essere presi gratuitamente in prestito digitale; Europeana
offre 51 milioni di item, di cui il 43% etichettati come non meglio specificati ‘testi’;
la Digital Public Library of America ha accumulato un patrimonio di 30 milioni di
item; il progetto Gutenberg ha digitalizzato in formato testo 57.000 libri; la nuova
start-up Perlego, destinata agli studenti universitari, ha stipulato accordi con 1.400
case editrici e ha offerto al momento del lancio oltre 200.000 pubblicazioni manualistiche
da leggere in streaming. La didattica universitaria ha incrementato notevolmente la
sua presenza in rete e milioni di studenti di tutti i paesi del mondo seguono i MOOC
(Massive Open Online Courses), tra cui i 2.700 corsi prodotti da oltre 250 università partner della piattaforma
Coursera.
Ovviamente l’elenco potrebbe continuare se considerassimo la grande quantità di progetti
di conversione al digitale avviati in tutto il mondo. Oltre ai libri, attraverso Internet
Archive, ma non solo, la rete mette a disposizione 4 milioni e mezzo di documenti
video, 4,7 milioni di documenti sonori, 3 milioni di immagini. Sul versante musicale,
la sola Spotify offre decine di milioni di brani a oltre 70 milioni di abbonati.
Dunque? In che mondo siamo? I dati che abbiamo appena riferito ci dicono che le pratiche
di rete hanno strutturato un nuovo ecosistema che pervade tutti gli ambiti delle nostre
attività. Detto in altri termini, la rete è diventata l’infrastruttura su cui poggia
tutto ciò che facciamo. Da tempo ha smesso di essere semplicemente uno strumento a nostra disposizione che
possiamo decidere di utilizzare o di ignorare. Da quando la rete è entrata nelle nostre
tasche attraverso gli smartphone e accede a noi anche se non siamo noi ad accedere
deliberatamente a essa, da quando cioè abbiamo la connessione in mobilità, si è rivoluzionato
il rapporto tra noi e il tempo, tra noi e lo spazio. Il wireless è nell’aria che respiriamo e attraverso i social network anche gli aspetti più intimi
della nostra quotidianità si sono trasferiti sulla rete. Internet non è solo un mezzo
di comunicazione che è andato ad aggiungersi o a sostituire ciò che c’era prima: è
un ‘sistema’ nuovo che ha modificato radicalmente le coordinate del contesto in cui
operiamo.
È avvenuto ciò che McLuhan aveva previsto oltre mezzo secolo fa, nel 1967: interpretando gli effetti che le applicazioni tecnologiche nel campo della comunicazione
avrebbero prodotto sulla società e sugli individui, il sociologo canadese aveva intuito
che the next medium avrebbe compreso la televisione come contenuto, ma non come ambiente (stava parlando
di YouTube?), avrebbe reso obsolete le organizzazioni bibliotecarie (si riferiva ai
tag e agli algoritmi di Google?), avrebbe beneficiato del talento enciclopedico di
tutti noi (aveva previsto la nascita di Wikipedia e di tutto il volontariato collaborativo
che la rete riesce a mobilitare?), avrebbe generato una nuova economia. In definitiva,
aveva preconizzato che il nuovo medium sarebbe stato un mezzo globale di comunicazione
e di ricerca, quello che poi è diventato Internet. E proprio in questi ultimi anni
stiamo toccando con mano l’effetto di ‘sconfinamento’ prodotto dalla transmedialità.
Eravamo abituati alla multimedialità: un contesto all’interno del quale operavano
diversi mezzi di comunicazione, integrati tra loro, nel quale erano i media a occupare
il centro della scena rispetto ai contenuti veicolati da ciascuno di essi. Ogni mezzo
conservava, infatti, la propria specificità. Ora al centro della scena ci sono i contenuti,
le diverse piattaforme sono retrocesse a veicoli di diffusione.
Per capire di cosa stiamo parlando, basti pensare a quello che è accaduto al cinema,
assorbito all’interno dei servizi video digitali, di piattaforme come Netflix, Infinity,
Now Tv, TIMvision, per fare solo qualche esempio. Per non dire dell’impatto che avranno
Prime Video di Amazon e soprattutto Facebook Watch, la piattaforma su cui guardare
in streaming video e programmi direttamente attraverso il social network più diffuso
al mondo. Ovviamente le ricadute sono quantitative, in termini di utenza, ma anche
qualitative, per il minore scarto generazionale: nel 2017, nella fascia d’età 14-29
anni, gli utenti dei servizi video digitali erano il 20,6% e quelli della fascia 30-44
anni arrivavano al 15%; l’anno successivo, seppure la fascia 14-29 fosse sempre in
testa (29,1%), gli adulti le erano a ridosso con il 26,6%.
2.
La cultura cambia funzione
Ma cos’è questo nuovo che sta prendendo il posto del vecchio? E che effetti sta producendo sulla trasmissione, sulla produzione e sul concetto
stesso di cultura? Di certo la tripartizione proposta trent’anni fa da Guido Martinotti non funziona più. Non esistono più nell’organizzazione sociale del sapere tre diversi
‘mondi’ nettamente separati: quello del sapere ‘organizzato’ o ‘colto’, collegato
alle strutture scientifiche ufficiali, sistematico, prodotto negli ambienti accademici
da soggetti (studiosi, esperti, praticanti) che hanno il compito istituzionale di
produrlo, conservarlo, tramandarlo; quello del sapere ‘organizzativo’ o ‘burocratico’,
che comprende le conoscenze accumulate nel corso della propria attività dalle grandi
organizzazioni formali, come le amministrazioni pubbliche e le imprese, le cui finalità
non accademiche ma eminentemente pratiche lo facevano identificare con i saperi e
le pratiche professionali; infine il mondo del sapere ‘diffuso’, legato alla vita
delle comunità e dei gruppi sociali, destinato a variare rapidamente e a essere altamente
deperibile.
Non esistono più, almeno in questa forma, poiché sembra non esserci più tra le diverse
‘forme’ di cultura una distinzione chiara a seconda dei circuiti, di chi le produce
e delle finalità che le ispirano. È sempre più diffusa la sensazione di partecipare
attivamente a un processo corale, in cui tutti possiamo essere al tempo stesso produttori
e utilizzatori di cultura. Non è un caso se alcuni anni fa è stato coniato il termine
prosumer per indicare una nuova figura, al tempo stesso un po’ producer e un po’ consumer. Sembra diventato realtà quel mondo culturale senza gerarchie in cui si sarebbero
potute esprimere le potenzialità creative di ciascuno, ipotizzato agli inizi degli
anni Novanta da Pierre Lévy, che aveva parlato di «un’intelligenza distribuita ovunque,
continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione
effettiva delle competenze». Nell’era del fai-da-te si è indebolita, talvolta fino quasi a sparire, qualsiasi
forma di mediazione culturale – quella esercitata dagli insegnanti, dagli editori,
dai giornalisti, dagli opinion makers. Ciò ha avviato un processo di secolarizzazione della cultura che affranca da ogni
tutela e imposizione autoritativa.
Una costruzione e trasmissione orizzontale della cultura, dunque. Ma in che modo,
con quali effetti e con quali funzioni questa modalità orizzontale opera rispetto
alla precedente modalità verticale? Cercare di capirlo impone prima di tutto lo sforzo
di non cadere nella trappola che ci spingerebbe a schierarci necessariamente con gli
‘apocalittici’ o con gli ‘integrati’, con i tecnoentusiasti o i tardo-umanisti.
Non si scambi perciò per compiacimento, o nostalgia per il buon tempo andato, il rilevare
che – dal punto di vista della funzione – in passato la cultura era intesa, in primo
luogo, come agente di cambiamento e la crescita culturale consisteva in una progressiva
conquista degli strumenti critici attraverso cui impadronirsi di contenuti articolati
e complessi. Lo ha descritto molto chiaramente Zygmunt Bauman qualche anno fa in una
sorta di breve storia sociale della cultura e degli usi che ne sono stati fatti:
Il nome ‘cultura’ venne assegnato a una missione di proselitismo progettata e intrapresa
nella forma di tentativi di educare le masse e di raffinarne i costumi, facendo così
progredire la società e facendo avanzare ‘il popolo’ (ossia, coloro che stavano negli
‘strati bassi della società’) verso chi stava in cima.
[...]
La ‘cultura’ comportava un accordo programmato e atteso tra coloro che possedevano
la conoscenza (o quanto meno presumevano di possederla) e gli ignorantoni (o quelli
così descritti da quanti erano convinti di avere i titoli per educarli); un accordo,
sia detto per inciso, che recava una sola firma, stabilito unilateralmente, e realizzato
sotto la direzione esclusiva dell’appena formata ‘classe colta’, che accampava il
diritto di plasmare il ‘nuovo e più avanzato’ ordine che stava nascendo dalle ceneri
dell’antico regime.
Ma nel mondo liquido moderno la cultura ha cambiato funzione, è iniziata tutta un’altra
storia:
Nella modernità liquida la cultura non ha un ‘volgo’ da illuminare ed elevare; ha,
invece, clienti da sedurre. [...] La funzione della cultura non è soddisfare bisogni
esistenti, ma di crearne di nuovi, pur mantenendo allo stesso tempo bisogni già radicati
o permanentemente insoddisfatti. La sua principale preoccupazione è di impedire che
prenda piede un senso di soddisfazione tra quelli che erano i suoi soggetti e operatori,
trasformati ora in clienti, e soprattutto di contrastare una loro gratificazione perfetta,
completa e definitiva, che non lascerebbe spazio ad ulteriori bisogni e capricci,
nuovi e ancora non soddisfatti.
Ecco svelato il capovolgimento: «la ‘cultura’ è stata trasformata da stimolante in
tranquillante». Ha smesso con ciò anche di essere un agente di cambiamento politico. Una funzione
che nel passato esercitava combinando insieme la conoscenza e l’esercizio del potere
di governo. Bauman ha dato per tramontato il progetto illuministico, che
dava alla cultura (intesa come attività paragonabile alla coltivazione della terra)
lo status di strumento basilare per la costruzione della nazione, dello Stato e dello
Stato-nazione, e insieme affidava questo strumento nelle mani della classe colta.
Oggi sono le tecnologie della comunicazione il veicolo della mondializzazione e interconnessione
della (e delle)società. La disponibilità delle tecnologie e la capacità di usarle sono infatti l’elemento
fondante dei nuovi diritti di cittadinanza nella società globale dell’informazione,
e attraverso la rete passa la linea di demarcazione dello sviluppo, la frattura digitale,
o digital divide. Non a caso, le organizzazioni internazionali calcolano gli ‘indici di modernizzazione’
ponendo in relazione i dati sui tassi di alfabetizzazione, di industrializzazione,
di urbanizzazione e di esposizione ai media. E c’è chi ha visto in questo atteggiamento
una versione aggiornata della ‘occidentalizzazione’ del mondo.
L’accelerazione dei processi di disintermediazione figura tra gli effetti più evidenti
e importanti di questa rivoluzione. La rete ha indebolito la funzione dei corpi intermedi
in qualsiasi ambito: da quello politico – pensiamo ad esempio al ruolo sbiadito dei
partiti o dei sindacati – a quello culturale – pensiamo all’indebolimento del ruolo
di insegnanti, critici, giornalisti, editori, bibliotecari, librai. La possibilità
di un accesso immediato e diretto ha messo in discussione il metodo con il quale si
è trasmessa la conoscenza per secoli, e cioè in modo organizzato e mediato dall’autorevolezza
ovvero dalla competenza. Questo significa che la rete ha scardinato il sistema di
accesso alla conoscenza a cui eravamo abituati? Come vedremo la risposta è complessa,
parziale, necessariamente prudente.
3.
Un ecosistema globale
e territorializzato
Per iniziare a rispondere cominciamo dal territorio della rete, che presenta tante
contraddizioni, forse proprio perché include tutto. Non è così globale come a prima
vista potrebbe sembrare. E ciò ha delle conseguenze assai rilevanti. Il sociologo
francese Frédéric Martel mette in chiaro i termini del problema: «Internet non uniforma
le differenze: le consacra. Infatti, non è globale, non annienta le identità: le valorizza.
Le nostre conversazioni sono e rimarranno territorializzate. Il contesto è fondamentale.
La geografia conta».
L’ipotesi di Martel è che il tempo di un’Internet globalizzata sia già alle nostre
spalle, si è ‘territorializzata’, è finita l’egemonia di un World Wide Web dove tutto
è equidistante e in cui le specificità culturali e linguistiche devono combattere
e resistere al mainstream che dilaga oltre ogni confine. Oggi l’uso della rete è tutt’altro che globale e sta
diventando sempre più locale: inviamo messaggi ai nostri amici e parenti, consultiamo
Google Maps alla ricerca di indicazioni sulla strada che ci apprestiamo a percorrere,
utilizziamo l’app di un’azienda di trasporti per conoscere gli orari dell’autobus
che stiamo aspettando e che dovrebbe portarci al lavoro, vogliamo conoscere le previsioni
meteorologiche riguardanti la città in cui viviamo, prenotiamo l’albergo o il ristorante
di cui ci serviremo nel fine settimana, ci rivolgiamo al commercio elettronico per
acquistare libri scritti nella nostra lingua madre. Internet sarà legato sempre più
a questo genere di usi quotidiani, piuttosto che essere utilizzato per discutere con
chi vive dalla parte opposta del pianeta: il suo impiego, anche quando è funzionale
alla collaborazione di una équipeinternazionale di scienziati che operano in università di continenti diversi, è legato
alla ‘nostra’ sfera e non a una sfera globale.
Internet è una galassia di comunità tenute insieme da interessi specifici. Ed è questo
un altro modo per evidenziare la sua dimensione orizzontale. Riecheggiano qui le riflessioni
della Scuola di Birmingham dei cultural studies, e i nomi di Stuart Hall, Richard Hoggart, Raymond Williams, e le loro illuminanti
pagine sulla capacità di riappropriazione, rielaborazione, ricodificazione, trasformazione
e quindi diremmo anche territorializzazione dei contenuti da parte di chi li fruisce,
chiunque e ovunque egli sia. Qualcosa di simile aveva affermato molti anni prima uno
dei più lucidi studiosi della società dell’informazione, Manuel Castells, parlando
di virtual community scientifiche, professionali, civiche, e di nuovi assetti d’interazione organizzativa
online, che preferiva chiamare network, che divengono «forme di ‘comunità specializzata’, vale a dire forme di socialità
costruite intorno a interessi specifici».
Martel non nega che si stia avverando la profezia del ‘villaggio globale’, ma intende sottolineare la dimensione comunitaria e aggregativa del web: «se l’infrastruttura
di Internet è globale e territorializzata, i contenuti e le conversazioni sono per
lo più scollegate, territorializzate e frammentate. Detto in altri termini: Internet
è territorializzata attraverso interazioni globali». La nostra ‘partecipazione’ alla rete si concretizza, nella maggioranza dei casi,
nel far parte di comunità più o meno circoscritte e che raramente hanno elementi di
interconnessione reciproca: ciascuno di noi intesse parallelamente relazioni, per
esempio, con i colleghi di lavoro, con gli ex alunni dello stesso liceo, con i membri
di un’associazione, con i fan di un personaggio dello spettacolo o dello sport, con
chi coltiva lo stesso hobby o con chi soffre della nostra stessa patologia, e così
via. Queste distinte affiliazioni sono altrettante componenti della nostra identità
che contribuiscono a determinare orientamenti e comportamenti individuali e collettivi.
4.
I fili, il tessuto
La rete ha reso il campo informativo-culturale policentrico, mutevole, disordinato,
vitale. La crossmedialità, la convergenza tra media diversi è fortissima, e l’online
dialoga di continuo con l’offline, cosicché disegnare una mappa del campo stesso è
molto difficile. Una cartografia non infedele potrebbe essere quella di una grande
ragnatela, un grande accampamento dove si parla e ci si parla da piattaforme diverse,
con le voci più diverse. E la metafora del ragno, decisamente minaccioso, è proprio
quella usata da un neurobiologo come Lamberto Maffei a proposito della rete delle
comunicazioni:
La rete del ragno delle Comunicazioni ha qualità speciali: la rapidità, la facilità
dell’uso del mezzo, la semplificazione del linguaggio nella continua ricerca della
sintesi necessaria per migliorare il fattore velocità, diventato traguardo essenziale
del messaggio. [...] Il ragno della Comunicazione ha cominciato ad interessare più
l’occhio che l’orecchio e dal punto di vista del sistema nervoso, quindi più il cervello
visivo che quello del linguaggio. Il ragno della Comunicazione possiede, forse inconsciamente,
raffinate conoscenze neurologiche e si rivolge alla parte del cervello più pronta
a intrappolare gli insetti del mondo, dato che le immagini hanno una via preferenziale
nel cervello umano e prediligono l’emisfero destro; inoltre l’immagine è di per sé
già realtà, concetto indiscutibile tale da vincere persino l’incredulità di San Tommaso
e quindi ha una Potenza straordinaria di convinzione del ricevente. [...] Questa tendenza
del ragno a privilegiare operazioni mentali rapide contrasta con ciò che le neuroscienze
ci dicono della macchina cervello, sostanzialmente lenta, soprattutto se paragonata
ai sistemi digitali di analisi dell’informazione, i cui tempi sono dell’ordine dei
nanosecondi.
La rete viene spesso accusata di produrre una mutazione dei processi di apprendimento
della mente umana poiché il suo uso richiede e produce processi di elaborazione differenti
da quelli cui eravamo abituati. È diventata quasi proverbiale la discutibile affermazione
di Nicholas Carr secondo cui Internet ci renderebbe stupidi. L’autore, parlando della
propria esperienza di navigazione (peraltro riferita a un’epoca in cui non utilizzavamo
smartphone e tablet e, quindi, gli effetti pervasivi della rete erano assai meno potenti
di quanto non accada ora), scriveva:
Mi accorsi che la rete esercitava su di me un’influenza molto maggiore rispetto a
quanto non facesse il mio vecchio computer privo di connessioni. Non era soltanto
perché trascorrevo così tanto tempo a fissare lo schermo di un computer. Non era nemmeno
solo perché ormai le mie abitudini e i miei ritmi di lavoro stavano cambiando, a mano
a mano che mi abituavo a usare il Web ed ero sempre più dipendente dai siti e dai
servizi della rete. Sembrava cambiato il modo stesso in cui il mio cervello funzionava.
È stato allora che ho cominciato a preoccuparmi della mia incapacità di prestare attenzione
a un’unica cosa per più di due minuti. All’inizio pensavo si trattasse del tipico
rimbambimento di mezza età. Ma mi accorsi che il mio cervello non stava semplicemente
andando alla deriva. Era affamato. Chiedeva di essere alimentato nel modo in cui la
rete lo alimentava, e più veniva alimentato più aveva fame. Anche quando ero lontano
dal computer, bramavo di controllare le e-mail, di cliccare sui link, di usare Google.
Volevo essere connesso.
I neuroscienziati studiano da tempo gli effetti collaterali che le pratiche di rete
stanno producendo sui meccanismi di funzionamento del nostro cervello e sottolineano
che se da una parte stiamo acquisendo nuove abilità, dall’altra rischiamo di perderne
delle altre. Ad esempio, abbiamo imparato la lettura frammentata, quella che prevede
l’esposizione a un massiccio flusso di informazioni e immagini, ma stiamo perdendo
la ‘lettura profonda’, cioè quella che ha bisogno di ‘pazienza cognitiva’, per rubare
un’espressione a Maryanne Wolf, una lettura che implica una gamma di processi sofisticati
che includono il ragionamento inferenziale e deduttivo, le abilità analogiche, l’analisi
critica, la riflessione e il discernimento. Con questo non stiamo dicendo che il primo tipo di lettura sia meno ricco. Al contrario:
il flusso può essere così denso da produrre un sovraccarico cognitivo. È però una
lettura esposta al rischio di desensibilizzazione nei confronti del messaggio trasmesso,
che induce a una ricezione passiva.
Affronteremo di nuovo più avanti la questione delle competenze. Intanto sottolineiamo
che le circostanze ambientali in cui oggi si svolgono le pratiche culturali non paiono
assecondare la ricerca della complessità. Pur senza essere tecnofobi e senza disconoscere
la valenza positiva di questa orizzontalizzazione della conoscenza, dell’accorciamento
delle distanze tra chi produce cultura e chi la fruisce, in una parola di questa metamorfosi
democratica della cultura, qualche motivo di allarme è legittimo. Ciò non è dovuto
alle caratteristiche intrinseche della rete e dei documenti in essa residenti, ma
al modo in cui la usiamo. Rischiamo, per esempio, di perdere di vista la distinzione
tra gli atomi informativi decontestualizzati e il sapere elaborato criticamente, tra
principi e teorie e la loro applicazione specifica, tra i singoli fili e il risultato
di un processo finalizzato alla costruzione di un tessuto, costituito dalle relazioni
tra questi elementi, orientati alla comprensione profonda di una questione o alla
ricerca della soluzione di un particolare problema.
La grande quantità di contenuti culturali disponibili e la facilità con cui possiamo
accedervi con uno sguardo a volo d’uccello e qualche download, induce inevitabilmente
un senso di sazietà che in realtà occulta una deprivazione: l’abbondanza di risorse
e contenuti non può coprire le lacune dovute alla debolezza derivante da una alfabetizzazione
incompiuta. Incombe su di noi la minaccia di una nuova forma di nozionismo: provando
ad esprimerci attraverso uno slogan, possiamo dire che il rischio è di ‘sapere tutto,
senza capire niente’. Ci illudiamo che gli ingredienti equivalgano a una pietanza,
senza dover fare la fatica per amalgamarli e cuocerli. Il fatto è che l’uso di qualsiasi
strumento ha bisogno di tempo per evolversi e maturare, come osserva Gino Roncaglia
nel suo libro dal titolo significativo L’età della frammentazione:
Può certo lasciare perplessi considerare ancora pre-industriale un mondo come quello
della rete, attorno al quale ruotano interessi miliardari e alcune fra le aziende
più ricche e tecnologicamente sviluppate al mondo. Ma che la rete sia ancora ben lontana
dall’aver sviluppato tutte le sue potenzialità è dimostrato proprio dalla necessità
di superare granularità e frammentazione, non solo attraverso l’uso di aggregatori
ma attraverso l’uso di strumenti capaci di favorire la produzione di informazione
digitale realmente e nativamente strutturata e complessa.
Certo, se l’età della rete si riducesse a essere l’età della frammentazione e se la
dimensione orizzontale della circolazione culturale divenisse antitetica a qualsiasi
forma di approfondimento di tipo verticale, avremmo fatto un bel passo indietro. Con
ragionato ottimismo possiamo però sperare in un processo di crescita delle nostre
capacità di elaborare e utilizzare le enormi potenzialità di Internet. Ma c’è ancora
tanto lavoro da fare, specie da parte delle istituzioni formative.
A questo proposito, qualcosa va detto del rapporto che gli intellettuali hanno avuto
con la rete. Pur concedendo il beneficio della frattura generazionale – che significa
che chi appartiene ad un’era in cui la cultura si produceva e diffondeva tramite i
luoghi e i canali tradizionali (i libri e i giornali, i teatri, i musei, le sale cinematografiche
e da concerto, i dischi ecc.) è portato quasi per istinto a ritenere che quelle forme
di cultura siano qualitativamente superiori rispetto a quelle ‘partecipate’ che oggi
vanno per la maggiore – una qualche responsabilità va individuata anche nel mondo
accademico e negli esperti qualificati che hanno spesso abdicato al loro dovere di
farsi ‘classe dirigente’. Spesso arroccati sulle certezze del sapere, non hanno contribuito
alla formazione dell’opinione pubblica, non hanno svolto la cosiddetta ‘terza missione’
dell’università, ovvero l’estensione e la diffusione delle conoscenze attraverso un
accorto lavoro di divulgazione, il solo che consente ai cittadini di maturare un’opinione
informata e di partecipare responsabilmente alle scelte ‘eticamente sensibili’ e al
dibattito su tutte le questioni da cui dipende il loro effettivo benessere. Gli intellettuali
‘ufficiali’ sono spesso restati prigionieri del loro gergo e dei ristretti circoli
di quello che Martinotti chiamava ‘sapere organizzato’, condannandosi con ciò stesso
all’irrilevanza e alla frustrazione e aumentando la frattura fra cultura ‘di regime’
e cultura ‘dal basso’.
Di certo in rete si percepisce un atteggiamento ostile, se non di disprezzo, nei confronti
del mondo della cultura. «Temo che stiamo assistendo alla fine dell’idea stessa di competenza, un crollo – alimentato da Google, basato su Wikipedia e impregnato di blog – di
qualsiasi divisione tra professionisti e profani, studenti e insegnanti, conoscitori
informati e fantasiosi speculatori». È quanto sostiene lo studioso americano Tom Nichols che, pur consapevole della diffidenza,
se non addirittura dell’avversione, che gli americani con il loro pragmatismo hanno
sempre avuto nei confronti di intellettuali e ‘cervelloni’, sottolinea un sempre più
diffuso e radicale sentimento di delegittimazione e rabbioso rifiuto verso le opinioni
degli ‘esperti’ e verso il sapere specialistico. A partire da poche e banali notizie
recuperate sul web, gli americani si ritengono esperti di qualsiasi cosa. Si convincono,
ad esempio, di saperne quanto basta per pretendere che i medici prescrivano loro un
farmaco piuttosto che un altro, di avere fondate opinioni sulla politica estera, sull’inquinamento
ambientale o sul riscaldamento globale, su ciò che la scuola dovrebbe insegnare ai
loro figli, sulla bontà del cibo senza glutine senza sapere cos’è il glutine.
Mai ci sono state tante persone scolarizzate sul nostro pianeta, eppure mai come in
questo momento l’ignoranza esercita un fascino irresistibile.
E se i sentimenti di cui parla Nichols fossero una reazione a un abuso delle ‘competenze’,
a una dittatura degli ‘esperti’ che hanno nascosto interessi di parte dietro argomentazioni
astruse e incomprensibili ai più? Pierre Bourdieu, decenni fa, ha spiegato in modo
più che persuasivo come la cultura sia stata spesso usata consapevolmente per creare,
marcare e salvaguardare le gerarchie sociali e le divisioni di classe. Vero, ma da qui a ritenere che la verità possa essere decisa a maggioranza attraverso
i plebisciti cui la rete ci sta abituando, ce ne corre.
Anche in Italia abbiamo assistito in più occasioni a clamorosi episodi di contrapposizione
popolarità/competenze. A volte il terreno di scontro è stato la salute e il rifiuto
delle posizioni della medicina ufficiale. Il ‘caso Stamina’ – vale a dire la polemica
innescata dalla sperimentazione, rifiutata dalla comunità scientifica e bloccata poi
dal ministero della Salute, di un metodo di medicina rigenerativa basato sul trapianto
di cellule staminali mesenchimali che, a detta del suo promotore Davide Vannoni, sarebbe
stato capace di curare svariate malattie – e più recentemente l’opposizione alle norme
sulla obbligatorietà delle vaccinazioni – in cui al timore sui rischi dei vaccini
si sono mescolate componenti ideologiche, alimentate anche da alcune forze politiche
e dietrologie sugli interessi economici delle case farmaceutiche – sono stati probabilmente
i più clamorosi.
Ma sono tanti i campi in cui ‘dal basso’ si sono rifiutate le opinioni degli ‘esperti’.
Non è stata risparmiata neppure l’edizione 2019 del Festival di Sanremo, dove il giudizio
dei critici musicali accreditati in sala stampa (pari al 30% dei voti complessivi)
e quello di una ‘giuria d’onore’ formata da personaggi del mondo dello spettacolo
(20%) hanno ribaltato l’esito che si stava determinando in base al televoto da casa
(50%), producendo un risultato che ha tenuto conto non solo della popolarità dei cantanti
in gara, ma anche della qualità dei testi e della musica. All’insegna di affermazioni
come «la musica la sceglie il popolo», l’interprete sconfitto si è scagliato con animosità
e rancore verso i giornalisti «che si sentono importanti», lamentando l’ingiustizia
subita. Al di là della vicenda specifica, un dato interessante dal punto di vista comunicativo
è che la replica dell’artista che si è sentito danneggiato è stata affidata a Instagram,
ovvero a una piattaforma che favorisce la monodirezionalità del flusso informativo
e non certo un confronto mediato. Con un messaggio veicolato dai social puoi sostenere
i tuoi argomenti con una scarsa possibilità di contraddittorio, andando a generare
quella ‘camera dell’eco’ di cui tanto si parla. Ambienti digitali dove si ritrovano
contatti omogenei per orientamento o per opinioni, nei quali circolano quasi soltanto
informazioni coerenti con le proprie convinzioni e preferenze, dove non fa che accentuarsi
il cosiddetto pregiudizio della conferma.
L’atteggiamento anti-establishment a volte va a saldarsi con un altro orientamento, altrettanto diffuso in rete, e che
trae origine però da motivazioni del tutto diverse e di segno tendenzialmente positivo
(anche se a volte è poi degenerato in non condivisibili forme di illegalità). Ci riferiamo
a quella cultura stravagante, libertaria e ‘irregolare’ impersonata dagli hacker che
si propone di sfidare tutte le barriere costituite dalle tecnologie e, per traslato,
dall’economia e dalle leggi. Mettendo assieme tutto questo, l’approdo sembrerebbe
essere, più che una ‘rivoluzione digitale’, una ‘insurrezione digitale’.
Del resto, la rete è stata fin dalla sua origine il terreno privilegiato per chi voleva
opporsi al ‘potere costituito’ e immaginare un ‘ambiente’ senza regole. Tuttavia,
anche le biografie di figure portatrici di una forte carica di utopia e innovazione,
come Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e tanti altri, che per anni ci hanno
parlato di un mondo nuovo in cui il sapere sarebbe stato liberamente alla portata
di tutti, hanno avuto una parabola controversa. Una volta divenuti i padroni della
rete, il mondo senza regole che avevano contribuito a costruire ha consentito loro
di svolgere in modo indisturbato le loro attività di monopolisti miliardari. Non a caso l’assetto creatosi anche grazie a loro, pur solido, è sottoposto a critiche
crescenti e ad azioni che mirano a modificarlo o indebolirlo: dalle direttive europee sulla
protezione della privacy alle pronunce o alle indagini dell’antitrust.
5 .
Il paradigma
della cultura orizzontale
Non c’è nulla che possiamo fare per ricomporre la frattura tra cultura ufficiale e
cultura di rete?
Alessandro Baricco, in un recente libro, ci invita ad abbandonare l’idea di poter
opporre resistenza al web e a costruire un nuovo umanesimo digitale.
Entrare nel Game, senza paura, affinché ogni nostra inclinazione, anche la più personale
o fragile, vada a comporre la rotta che sarà del mondo intero. Usarlo, il Game, come
una grande chance di cambiamento invece che come un alibi per ritirarci nelle nostre
biblioteche o generare diseguaglianze economiche ancora più grandi. [...] Lasciare
che i più veloci vadano avanti, a creare il futuro, riportandoli però tutte le sere
a cenare al tavolo dei più lenti, per ricordarsi del presente.
Le argomentazioni proposte possono aiutarci – non fosse altro per i toni autocritici
che l’analisi contiene e da cui muove – a comprendere l’origine di quella rabbia contro
le éliteculturali – quelli che ‘hanno più di 500 libri in casa’ – di cui parla Nichols. Persone
educate, ragionevoli, che credono nella meritocrazia e nelle competenze, che lavorano
per un mondo migliore. Questa minoranza illuminata – prosegue lo scrittore torinese
– ha gradualmente perso ogni contatto con la maggioranza dei cittadini, che frattanto
venivano duramente colpiti dalla crisi economica che ha cominciato a manifestarsi
a partire dal 2007-2009. Più o meno contemporaneamente, questa maggioranza ‘impoverita
e ignorante’ partecipava però a una redistribuzione del potere, il cui simbolo era
lo smartphone che trasformava i consumers in prosumers: si abbattevano le barriere psicologiche secolari su cui si reggeva il patto implicito
fra le élitee ‘la gente’. La rivoluzione digitale ha evidenziato e amplificato questa spaccatura,
anche perché i processi di redistribuzione, più percepiti che reali, toccavano al
massimo la sfera delle potenzialità e del sapere, ma non quella della ricchezza o
della giustizia sociale, e la gente si è incattivita, ha cominciato a voler fare di
testa sua, a rifiutare ragionamenti complessi: preso atto della propria sostanziale
impotenza, ha cominciato a fare il contrario di ciò che le élite, sapienti ma lontane,suggerivano: nei comportamenti elettorali, tanto per cominciare, proprio per liberarsi
delle élite. Scrive Baricco:
C’è qualcosa che possiamo fare, per cambiare l’inerzia di questa disfatta? Che io
sappia, ammettere che la gente ha ragione. Riprendere contatto con la realtà e accorgersi
del casino che abbiamo combinato. Mettersi immediatamente al lavoro per ridistribuire
la ricchezza. Tornare a occuparci di giustizia sociale. Staccare la spina alle vecchie
élites novecentesche e affidarsi alle intelligenze figlie del Game: farlo con la dovuta
eleganza ma con ferocia. Dare un significato nuovo a parole come progresso e sviluppo,
quello che hanno è ormai avvelenato. Liberare le intelligenze capaci di portarci fuori
dal pensiero unico del There Is No Alternative. Smetterla di dare alla politica tutta l’importanza che le diamo: non passa da lì
la nostra felicità. Tornare a fidarci di coloro che sanno, appena vedremo che non
sono più gli stessi. Buttare via i numeri con cui misuriamo il mondo (primo fra tutti
l’assurdo PIL) e coniare nuovi metri e misure che siano all’altezza delle nostre vite.
Riacquistare immediatamente fiducia nella cultura, tutti, e investire sull’educazione,
sempre. Non smettere di leggere libri, tutti, fino a quando l’immagine di una nave
piena di profughi e senza un porto sarà un’immagine che ci fa vomitare.
Il tempo ci dirà se questa ricomposizione è possibile. Non è la prima volta che il
sapere consolidato è sotto attacco, ma oggi l’attacco viene portato all’interno di
un quadro che è profondamente mutato: nella società dell’informazione forse sono meno
sopportabili che in passato l’idea della disuguaglianza culturale e il privilegio
di cui godono pochi depositari del sapere.
Da un sacco di tempo abbiamo imparato che è meglio sapere molto delle cose prima di
cambiarle, che è meglio conoscere molti uomini per capire se stessi, che è meglio
condividere i sentimenti degli altri per gestire i nostri, che è meglio avere molte
parole piuttosto che poche perché vince chi ne sa di più.
Per comprendere la portata della rivoluzione che ci sta attraversando, la domanda
da porsi è: le pratiche culturali online sono da considerarsi complementari a quelle
cui partecipiamo nell’universo analogico, oppure diventeranno un modo alternativo
di fare cultura? Molto dipenderà anche dal modo in cui le istituzioni culturali saranno
capaci di orientare e governare i processi. Prendiamo come esempio l’attività formativa
a distanza, che a volte diventa auto-formazione in modalità self-service: bisogna
capire se l’utilizzo individuale dei materiali didattici disponibili in rete potrà
mai generare un percorso formativo capace di sostituirsi a un sistematico e organico
corso di studi o se non servirà, comunque, una integrazione di tipo ‘analogico’, come
un servizio di coaching pedagogico. Senza disconoscere la necessità di un radicale rinnovamento delle istituzioni
formative, non pensiamo sia opportuno assecondare la deriva che tende a delegittimarle,
contribuendo a scavare un solco sempre più profondo tra i luoghi e le modalità dell’apprendimento
canonico e le pratiche auto-formative delle giovani generazioni.
Più in generale, dobbiamo chiederci se riusciamo autonomamente a dotarci degli strumenti
critici per valutare, organizzare, gerarchizzare ciò che la rete ci mette a disposizione,
dal momento che costruiamo da soli l’offerta che risponde alle nostre domande: la
collezione libraria di riferimento per i nostri studi è quella che costruiamo sul
desktop del nostro computer, non più quella corrispondente al materiale posseduto
da una o più biblioteche, e non diversamente accade per l’intrattenimento. Un obiettivo
potenzialmente alla portata di tutti, purché si abbia una ‘competenza mediale’ (media literacy). E tuttavia le abilità tecniche da sole non bastano. Gli effetti della disintermediazione
e il venir meno del principio di autorità vanno valutati con grande attenzione, soffermandosi
sugli aspetti di contesto che influenzano la produzione, la circolazione e il trasferimento
delle conoscenze.
Dunque, il paradigma della cultura orizzontale presenta varie facce e non tutte di
segno positivo. Se si desidera massimizzarne le ricadute positive, è necessario comprendere
anzitutto il fenomeno nella sua interezza per poi disaggregarlo nelle sue diverse
componenti. La questione non è di natura ideologica, né si tratta di accettare o rifiutare
quella che è incontestabilmente una situazione di fatto: la ‘cultura’ non è più un
patrimonio precostituito da tramandare o del quale impadronirsi attraverso una ricezione
individuale e passiva, ma è un insieme di «pratiche e conoscenze collettive» rese possibili quando una comunità è dinamicamente e unitariamente coinvolta nei
processi che le determinano.
Sposando la tesi enunciata quasi mezzo secolo fa dal cibernetico e psicologo inglese
Gordon Pask, possiamo dire che la capacità di comprendere e interpretare la realtà
e di creare nuova conoscenza è affidata alla capacità di interagire e di ‘conversare’. Detta così sembra essere un avanzamento di se
...