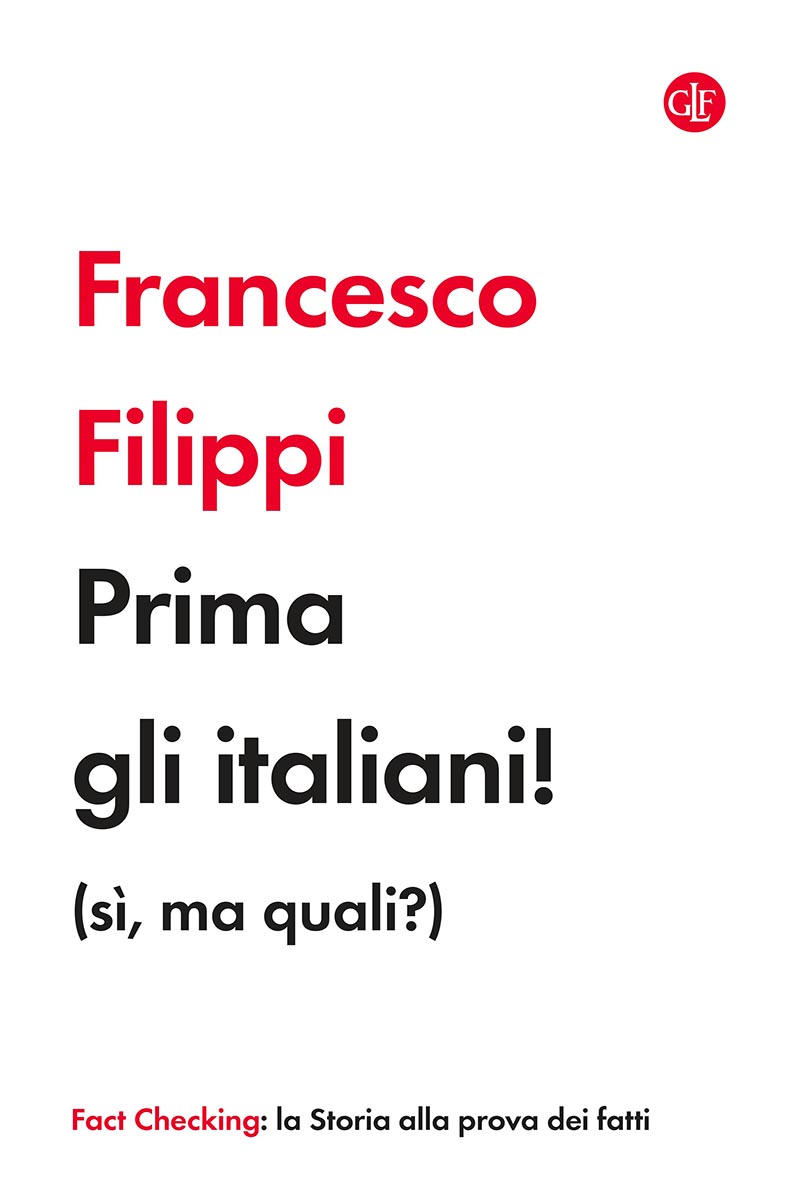Introduzione.
Gli italiani non esistono
C’è chi ha la mente chiusa
ed è rimasto indietro, come al Medioevo
Il giornale ne abusa,
parla dello straniero come fosse un alieno
Senza passaporto, in cerca di dinero
Io mi sento fortunato
Alla fine del giorno
Quando sono fortunato
È la fine del mondo
[...]
Oh eh oh, quando mi dicon “Va’ a casa”
[...]
Oh eh oh, rispondo “Sono già qua”
Oh eh oh, io T.V.B. cara Italia
Oh eh oh, sei la mia dolce metà
Ghali, Cara Italia, Sto, 2018
Chi è italiano?
– “Chi abita in Italia!”.
In Italia il primo gennaio 2020 risiedono legalmente cinque milioni e quattrocentomila
persone che hanno cittadinanza estera, l’8,9% della popolazione.
– “È italiano chi ha la cittadinanza italiana!”.
Oltre cinque milioni e quattrocentomila possessori di cittadinanza italiana vivono
stabilmente fuori dai confini del paese.
– “È italiano chi parla l’italiano!”.
L’italiano è lingua ufficiale in Svizzera, dove oltre seicentomila persone di madrelingua
italiana sono cittadini svizzeri, è lingua ufficiale pure in Croazia, Slovenia, a
città del Vaticano e a San Marino; in quest’ultimo stato la percentuale di parlanti
italiano sulla popolazione è del 100%, superiore quindi alla stessa Italia, dove gli
italofoni madrelingua sono “solo” il 95%, cinquantasette milioni. Secondo le ultime
rilevazioni in Argentina c’è oltre un milione e mezzo di abitanti che parla italiano,
negli Stati Uniti e in Canada oltre mezzo milione. A questi andrebbero aggiunti i
milioni di persone che parlano l’italiano come seconda lingua: più di un milione e
mezzo solo in Albania, più della metà della popolazione.
– “È italiano chi ha origini italiane!”.
Secondo le ultime statistiche i discendenti di italiani sparsi nel mondo, i cosiddetti
“oriundi”, sono tra i sessanta e gli ottanta milioni. Più di chi risiede in Italia.
– “È italiano chi nasce sul suolo italiano!”.
Questa definizione, che peraltro sembra tra le più lineari e semplici da applicarsi,
al momento (2021) non è prevista dall’ordinamento giuridico italiano. Essere nato
in Italia non basta per essere italiano, secondo la nostra legge, la legge italiana.
Basterebbe questo veloce tentativo di definire un tratto che la maggior parte di chi
sta leggendo ora questo libro dà per scontato per capire che in realtà una delle caratteristiche
fondamentali dell’approccio al tema dell’identità è tutto fuorché chiara e, se analizzata,
del tutto artificiale: termini come “origine”, “territorio” o definizioni legali come
“cittadinanza” appaiono solo tentativi, peraltro molto approssimati, di inquadrare un insieme reale assai più vasto e complesso.
Si tratta, secondo la definizione del sociologo Benedict Anderson, di una “comunità
immaginata”, vale a dire di un insieme di persone che, pur non conoscendosi e non
essendosi mai incontrato, sente di appartenere, tutto, a un gruppo definito che le
distingue da altre persone.
Eppure, per quanto fittizio, frammentato e disomogeneo possa essere il racconto che
tiene unito questo insieme di persone, esso è tutt’altro che irrilevante: perché nel
corso del tempo, rimanendo solo al caso italiano, è riuscito a convincerle che lo
hanno fatto proprio a prendere scelte economiche controproducenti, imbarcarsi in avventure
dannose per i più, combattere, uccidere e infine morire. È il racconto di una madrepatria
in pericolo che ha prodotto le centinaia di migliaia di morti nelle trincee della
prima guerra mondiale; è la volontà di dare gambe al racconto della rinascita del
paese ad aver prodotto un miracolo economico sostenuto da salari bassissimi e scarsa
sindacalizzazione negli anni Cinquanta e Sessanta; è il racconto della necessità per
un “grande paese” di avere una propria compagnia aerea di bandiera ad aver permesso
di buttare miliardi di euro per tenere aperto un vettore senza prospettive economiche.
Questo racconto viene definito “pubblico” non solo perché indirizzato a tutto l’insieme
degli individui che compongono la possibile comunità, ma perché costruito, approvato
e propagato da chi questa comunità la governa, dandone la visione ufficiale.
È la forza evocativa di un racconto di iperbole storica che spinge Donald Trump a
dichiarare, durante la campagna elettorale delle presidenziali 2020, di voler difendere
l’immagine di Cristoforo Colombo per guadagnarsi le simpatie della comunità italoamericana. Dando per scontato che Colombo sia parte integrante del racconto storico italiano.
Un racconto utile, almeno per chi lo ha saputo gestire, manovrare e, alla bisogna,
reinventare: l’Italia unita ha favorito quella parte di classe imprenditoriale che
riesce da subito a sfruttare la fine delle frontiere interne alla Penisola. L’alfabetizzazione
e “l’italianizzazione” delle masse ha fornito e fornisce a generazioni di capitalisti
milioni di operai che comprendono una singola lingua – quindi comprendono gli stessi
ordini e possono svolgere i medesimi compiti – e hanno basi culturali comuni, cioè
possono credere agli stessi racconti. Una comunità nazionale che ha i medesimi desideri
è anche, se ben manovrata, un enorme mercato uniforme pronto ad accogliere i medesimi
prodotti. Questa spinta di natura economica all’omologazione e all’abbattimento dei
confini è comune non solo al caso italico, ma anche a compagini nazionali dallo sviluppo
storico simile, come la Germania ottocentesca, o anche realtà sovranazionali: basti pensare all’incentivo di carattere economico
perseguito con le grandi riforme europee che hanno portato all’istituzione dell’euro
come moneta comune o con gli accordi sulla libera circolazione delle merci, approvata
dagli stati della Comunità europea già nel 1957 (la libera circolazione delle persone
verrà normata solo molto più tardi, in seguito al Trattato di Maastricht nel 1992).
Ci sono molti motivi per cui l’idea nazionale ha preso piede e continua a sopravvivere.
Ma che cosa significa, davvero, essere italiani?
Una domanda che fa esplodere un’enormità di risposte, tra loro differenti e complementari:
geografia, storia, archeologia, linguistica, antropologia, sociologia... praticamente
tutte le scienze umane hanno tentato di dare seguito a una questione che sembra di
primaria importanza per una sessantina di milioni di esseri umani. E anche l’economia,
il diritto, perfino la biologia sono stati tirati in ballo per tentare di sciogliere
un nodo che pare fondamentale per dare una cornice di senso alla vita di milioni di
noi: quello dell’identità.
Un processo antico e nuovo allo stesso tempo, perché continuamente sottoposto al giudizio
impietoso degli osservatori esterni. L’identità collettiva è precisamente questo:
osserva l’identità di ognuno e la giudica ritenendola, o meno, un rapporto, spesso
faticoso, tra chi propone un proprio modo di rappresentarsi e chi da fuori questo
modello lo deve accettare. Un compromesso faticoso tra l’immagine che si propone agli
altri e la quantità di questa immagine che gli altri sono disposti ad assumere come
“reale” e “giusta”.
Questo è drammaticamente vero innanzitutto per le identità individuali: chiunque abbia
frequentato una classe di scuola sa quanto sia difficile questa contrattazione e quanto
sia pericoloso e doloroso, a volte, il fatto di vedersi imposta un’identità pubblica
in cui non ci si riconosce. Il secchione, il bullo, il bello, il pagliaccio: gabbie
interpretative che condizionano ogni rapporto del singolo col gruppo e del gruppo
col singolo. Un meccanismo ancor più pesante per le identità collettive più ampie
e mature, quelle cioè che vorrebbero abbracciare e riunire in insiemi omogenei più
individui, dando loro la possibilità di – o più spesso costringendoli a – adeguarsi
a modelli comuni.
Il caso dell’identità nazionale in questo senso è tra i più significativi: è un insieme
anche molto vasto di apparati culturali, sociali, emozionali che concorrono a formare
una sorta di manuale non scritto del “chi siamo”. Il caso italiano in questo è tra
i più interessanti. Non solo per la mole incredibilmente ampia di fattori che si ritengono
necessari per aderire al milieu del perfetto italiano, ma anche perché, nel tempo, questi fattori sono cambiati,
si sono evoluti e spesso si sono trovati tra loro in conflitto.
Il processo di sedimentazione della cosiddetta “identità nazionale” è un fenomeno
storico relativamente recente: nella sua forma moderna la si può far risalire all’Illuminismo
settecentesco e in particolare, come ricorda il sociologo Antony B. Smith, al pensiero
di filosofi come Rousseau, che collegò l’ideale di appartenenza nazionale a un “fervore
emotivo e religioso”, vedendo nella nazione una nuova “fede” civile a cui attribuire i valori non più
efficacemente rappresentati dalla religione propriamente detta. Benché si tenda a
presentarla come lo sviluppo uniforme e infallibile di un pensiero invincibile, l’idea
di nazione italiana, come vedremo, ha avuto nei secoli un percorso accidentato, costellato
di vicoli ciechi e false partenze. Ed è ancora lungi dall’essere concluso ora, nel
momento in cui, per dirla col sociologo Jürgen Habermas, l’intero continente è entrato
in un’epoca post-nazionale, nel momento in cui, cioè, pare evidente che il racconto “sangue e suolo” della nazione
così come l’hanno inventata gli europei nell’Ottocento sia del tutto inadeguato per
rispondere alle sfide del mondo globale.
Oggi l’insieme degli atteggiamenti sociali e culturali che vengono accettati come
costitutivi dell’identità, diremmo addirittura dell’essenza dell’essere italiani,
è in realtà un collage di pezzi di racconti pubblici interrotti che si sono succeduti
nel corso del tempo, accavallandosi in una cacofonia di significati spesso non riducibili
tra loro.
Le periodizzazioni di questo faticoso moto ordinativo – molto disordinato – dello
spirito italiano pretendono di avere radici lontane: il mito di Roma in salsa italica,
la “serva Italia” dantesca, l’Italia “espressione geografica” di Metternich; gli “italiani
da fare” una volta unita la penisola; e poi la “grande proletaria” pascoliana, i “santi,
poeti e navigatori”, gli “italiani nuovi” fascisti; passando dal sempreverde “brava
gente” che ha consolato i ricordi dell’ultima guerra mondiale provocata e persa, fino
ad arrivare agli italiani che vogliono essere “padroni a casa propria” senza aver
ancora ben circoscritto che cosa significhi questo essere padroni né tanto meno il
perimetro di questa metaforica casa.
Tutti questi aspetti del preteso “essere italiani” concorrono anche oggi, in tempi
di sovranismo à la carte, a mettere insieme un quadro poco omogeneo di un’idea che vorrebbe formare la base
di una rediviva ideologia nazionale, ma che giornalmente rimane inapplicata alla realtà.
Le contraddizioni del “non modello” italiano si mostrano in tutta la loro difficoltà
una volta applicata la teoria alla pratica: un paese dai confini geografici incerti
e contestati, con specificità regionali che producono fratture sulle direttrici nord-sud,
est-ovest, montagna-mare-pianura, città-campagna, ma anche uomini-donne e ultimamente,
drammaticamente, vecchi-giovani; un paese popolato di italiani che non hanno l’italiano
come madrelingua, che raccontano a sé stessi una storia frammentata in micromemorie
di parte; un paese in cui i momenti più divisivi della vita pubblica sono proprio
le feste nazionali, quelle pensate, cioè, per riunire attorno a simboli specifici
un intero popolo. Un paese in cui, peraltro, il giorno dell’unificazione non è nemmeno
festa nazionale.
Ora il modello di questa identità frammentata è messo ulteriormente sotto stress dalle
generazioni di ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori provenienti da altri paesi,
impossibilitati a rientrare nell’evanescente schema che fa appartenere alla “patria”
intesa come terra dei padri – più raramente delle madri – o, peggio, nello stereotipo
razzista dell’appartenenza etnica. “Non ci sono negri italiani”, si grida negli stadi,
con la realtà attorno a smentire questo ennesimo precario schema identitario.
L’intera architettura del definirsi italiani poggia sulle macerie non spianate di
una serie di tentativi di dare significato a identità locali polarizzate e spesso
tra loro confliggenti. La ricostruzione di questi esperimenti, i motivi per cui hanno
inizio e anche gli effetti che ebbero e hanno sul significato, vero o mancato, dell’essere
italiani saranno i fili conduttori di questo libro.
1.
Siamo italiani!
Sì, ma che vuol dire?
Con tutta la sua boria
Questa volta il Bey perde la testa.
Ci ho gusto. Tanta smania
Avea d’una Italiana... Ci vuol altro
Con le donne allevate in quel paese
Ma va ben ch’egli impari a proprie spese.
Le femmine d’Italia
Son disinvolte e scaltre.
E sanno più dell’altre
L’arte di farsi amar.
Nella galanteria
L’ingegno han raffinato:
E suol restar gabbato
Chi le vorrà gabbar.
Gioachino Rossini, L’Italiana in Algeri, 1813
1.1. L’Italia è da sempre “Lo Stivale”?
Partiamo dalla forma.
A differenza di molte altre nazioni l’Italia odierna sembra avere dei confini piuttosto
ovvi. Molti paesi dell’Europa – il continente che ha inventato il moderno concetto
di nazione – hanno una storia di confini tormentati e contesi, mentre quelli italiani
sembrano delineati con chiarezza dalla natura stessa. Delimitata da un’ininterrotta
catena montuosa, che la chiude rispetto ad altri territori, e dal mare, che ne definisce
le coste, l’Italia “fisica” sembra fatta apposta per divenire un contenitore identitario,
riconoscibile nella sua caratteristica forma, tanto da dare luogo a un’antonomasia.
“Lo Stivale” è diventato un sinonimo dell’italianità, tanto che la NASA ha intitolato
alcune delle più famose immagini del paese dallo spazio “The Italian Boot” e da essere rappresentata in un quadro appeso alle pareti del ristorante di Luigi
Risotto, il cuoco italoamericano della serie TV I Simpson.
Eppure, questa solida figura, retorica e immaginifica, per i cui confini sono morte
nel tempo milioni di persone, ha assunto dei contorni riconoscibili in periodi relativamente
recenti: basti pensare che gli ultimi, certo minimi, “aggiustamenti” delle frange
estreme di questo contenitore datano 2017, con la ratifica degli accordi confinari
tra Italia e Slovenia.
Si potrebbe obiettare che, per quanto “pezzetti” di questo stivale possano in effetti
essere stati acquisiti o persi in epoche recenti, è evidente che la penisola circondata
dalle Alpi è sempre stata riconosciuta come un’unità territoriale stabile e continua,
almeno dai propri abitanti, e che “Italia” sia il nome che ha sempre definito, su
per giù, la terra incastrata tra le Alpi e il Mediterraneo.
Ma non è affatto così.
I processi storici che oggi vengono studiati sotto il nome di “storia d’Italia”, e
che sono tuttora parte integrante dei programmi scolastici italiani, hanno la caratteristica
di raggruppare in un unico filone insieme delle vicende di un territorio che, dei
tremilacinquecento anni che intercorrono tra la nascita del nome Italia e quella che
oggi noi intendiamo come tale, ne ha passati più di tremila spezzettato in entità
locali con sovrani, amministrazioni, culture, società ed economie distinte le une
dalle altre e spessissimo in conflitto tra loro. L’85% del tempo è occupato da queste
vicende storiche.
Specialmente dopo la nascita del regno unitario nel 1861, in molti hanno cercato di
dare forma e dimensione al concetto di “Italia” attraverso la geografia e sostentando
questa convinzione con ricerche archeologiche e linguistiche che hanno come primo
importante risultato il fatto di dimostrare un dato piuttosto curioso: se c’è necessità
di cercare le origini del paradigma geografico italico è perché evidentemente queste
sono, ad oggi, sconosciute o dubbie.
Le diverse interpretazioni che scaturiscono dalle indagini dimostrano soprattutto
che moltissimi, tra quelli che hanno preceduto l’attuale popolazione italiana, abitavano
il territorio che oggi si chiama “Italia” senza ritenersi parte di qualcosa di continuo
dalle Alpi al Mediterraneo e senza nemmeno chiamare “Italia” il luogo in cui vivevano.
La maggior parte di quelli che oggi noi chiamiamo “italiani” non sapeva di esserlo.
Le ricerche più avanzate raccontano che l’origine del termine Italói sembri derivare dal nome con cui gli antichi greci chiamano una popolazione abitante
a sud dell’odierna Catanzaro, pare aventi come animale totemico un vitello (italós). In sostanza, una tribù di adoratori di bovini che divinizza l’animale da cui probabilmente
trae il proprio sostentamento. Gruppi di allevatori, abbastanza arretrati da rimanere
impressi ai compatrioti di Pericle come “quelli che adorano i vitelli”, alla punta
sud di un territorio sconosciuto, ostile, barbaro.
Come questo possa aver poi dato vita e gambe a questo etnònimo tanto da farne un brand
che identifica interi pezzi di territorio in più continenti (le tante Little Italy sparse nelle maggiori città mondiali) è storia complessa e non lineare.
Nel corso del tempo, probabilmente in tono spregiativo, il termine italói diviene per i greci il nome collettivo di quelle popolazioni, sconosciute per lo
più, che attorniano i loro insediamenti nella zona che corrisponde grosso modo all’attuale
regione della Calabria. Confini complicati da stabilire, tutt’altro che corrispondenti
a quelli che riconosciamo noi come tali. La Sicilia è in questo senso esclusa, per
i greci, dal nome “Italia”, essendo terra molto più affine alla loro realtà delle
aspre montagne appenniniche in cui si allevavano i vitelli.
Italói e Italia sono dunque nomi imposti dall’esterno. Così come molti gruppi umani del continente
africano tra Otto e Novecento “scoprono” di essere popoli in base alle definizioni
interessate dei loro occupanti, allo stesso modo la piccola popolazione di allevatori
calabresi accetta questo nome, cominciando ad assumere come naturale un dato di fatto:
quelli che vengono chiamati italói sono, in effetti, diversi dai greci. Hanno cioè una diversa identità, in quanto i greci provengono dal mare, pilotano navi, commerciano e hanno una tecnologia
militare superiore e anche un apparato ideologico più solido e pronto alla colonizzazione.
Nascono col tempo riferimenti mitologici per spiegare le origini di questa gente divenuta
popolo, come quello di re Italo, che avrebbe regnato sugli Enòtri, popolo dimorante
tra le odierne Basilicata e Calabria, che con le sue gesta avrebbe dato il suo nome
a tutte le genti di quelle contrade. Ma si tratta anche in questo caso di leggende costruite sul modello greco, anzi,
omerico, dei mitici re fondatori di civiltà. Per quasi un millennio il termine “Italia”
è un nome geografico che serve a designare solo la punta estrema del famoso Stivale:
un nome che si espande insieme ai dominatori greci, che continuano a battezzare “Itali”
o “Italioti” i barbari in cui man mano si imbattono risalendo le coste della penisola.
1.2. Italiani eredi dei Romani?
Roma all’inizio della sua storia è una tra le molte città-stato al centro della penisola.
Quando la sua espansione prende l’abbrivio, attorno al VI secolo a.C., sono decine
i popoli “italici” che vengono presi e assoggettati a Roma. L’assimilazione e la crescita
della città egemone passano proprio dal riconoscere la cittadinanza romana a questi
popoli: un’estensione del diritto che non si limita a sancire il semplice abitare
un territorio specifico, ma ha a che fare con l’amalgamarsi culturale e sociale delle
popolazioni italiche al modello romano. Nel tempo il concetto di Italia si estende,
venendo ad essere una sorta di “giardino di casa” dei romani che ricomprende i territori
che accettano o subiscono con più efficacia la romanizzazione.
Nella costruzione del dominio romano si fa strada nel tempo la necessità di suddividere
in unità gestibili i territori conquistati e l’Italia, così come la immaginavano i
politici della Roma tardo-repubblicana, comincia ad essere un concetto amministrativo
oltre che geografico: la suddivisione delle regioni dominate porta comunque il nome
Italia ad estendersi fino alle propaggini della Pianura Padana. La Sicilia, come da
tradizione greca, è però esclusa da questa definizione. Un salto in avanti, certo,
rispetto alla sola provincia di Catanzaro, ma è interessante notare che l’Italia così
come la immagina un romano della fine della Repubblica è un territorio che, sovrapposto
a quello odierno, priverebbe del titolo di italiani trentatré (su sessanta) milioni
di attuali cittadini.
Quando passa il fiume Rubicone, nell’odierna Emilia Romagna, Cesare sa che quello
è il confine tra l’Italia e il resto del mondo ed è quel gesto che lo pone fuori dalla
legge romana.
L’espansione di Roma oltre le Alpi e la conquista dell’immensa Gallia transalpina
ridisegnano ancora una volta il concetto di Italia, ricomprendendo le regioni padane,
l’antica Gallia Cisalpina, nel novero delle terre della homeland romana. Diventano “italici”, grazie a questa espansione, gli abitanti delle regioni
alpine che fino a quel momento – e ancora per un po’ i romani “de Roma” – continuano
a definire con disprezzo “galli”.
È con un celeberrimo discorso riportato da Tacito che l’imperatore Claudio, nel I
secolo d.C., racconta la scelta pragmatica di questo allargamento e anche, in sostanza,
la concezione stessa dell’idea di romanità; una lettura molto lontana, quasi antitetica
rispetto a quella che oggi si potrebbe definire “nazionale”:
I miei antenati, il più antico dei quali, Clauso, di origine Sabina, fu contemporaneamente
accolto nella cittadinanza romana e nel numero dei patrizi, mi esortano ad adottare
i criteri da loro seguiti nel governo dello Stato, trasferendo qui quando si può avere
di meglio, dovunque si trovi. Non ignoro infatti che i Giulii furono fatti venire
da Alba, i Coruncani da Camerio, i Porci da Tuscolo, e per lasciare da parte gli esempi
antichi, furono chiamati a far parte del senato uomini provenienti dall’Etruria, dalla
Lucania e da tutta l’Italia e, da ultimo, i confini dell’Italia stessa furono estesi
sino alle Alpi, perché non solo i singoli individui, ma interi territori di popoli
si congiungessero in un solo corpo sotto il nostro nome.
Basterebbe questo discorso per comprendere quanto poco corretto sia oggi, come alcuni
fanno, inserire la tradizione culturale romana, o addirittura i fasti dell’impero
di Roma, nel pantheon storico ereditario delle glorie italiane, comprimere, cioè,
l’idea di romanità nel vicolo stretto di un’eredità nazionale. Ma proseguiamo.
Con l’evoluzione imperiale l’aggettivo “italico” tracima dai confini in cui ai nostri
giorni lo si circoscrive. Con la riforma dell’Impero voluta da Diocleziano (244-305)
nasce la “diocesi italiana”, che ricomprende in sé molte regioni a nord delle Alpi,
cioé tutta l’attuale Svizzera e una parte dei territori che oggi formano l’Austria,
Francia meridionale e Baviera, oltre a Sicilia, Sardegna e Corsica. Un’Italia che
trova i propri confini sul Danubio e sulle coste maltesi.
La solidità dell’idea di Italia viene meno nei secoli delle migrazioni dei popoli,
quando la presa di Roma sul territorio si allenta. Il termine Italia, che ha valore
soprattutto amministrativo, viene travolto dagli spostamenti di genti nei secoli del
tardo impero. L’ultima “Italia” riconoscibile in questo contesto è la prefettura del
pretorio d’Italia, costituita dall’imperatore Giustiniano alla fine della guerra gotica, che comprende ancora una buona fetta di territori a nord delle Alpi ma perde Sicilia
e Sardegna. Un esperimento che vede ancora una volta il territorio definito da un
potere esterno, in questo caso da Costantinopoli, e comunque di breve durata, visto
che viene cancellato dall’arrivo dei Longobardi di Alboino nel 568.
1.3. Italia, una parola “messa in pausa” per più di mille anni
La realtà della penisola dopo la fine dell’impero romano è fatta di popolazioni che
si avvicendano e mescolano, tanto che la parola “Italia” scompare dalle definizioni
ufficiali dei suoi abitanti, soppiantata da nomi etnici come ad esempio “Romània”
o “Longobardìa”, a seconda delle origini rivendicate.
Gli odierni manuali di storia raccontano di come Carlo Magno intervenga con le sue
armate “in Italia”, ma quando prende possesso delle terre conquistate al di qua delle
Alpi dopo la sconfitta del re dei Longobardi Desiderio si fregia del titolo di re
dei Franchi e dei Longobardi e poi, a Roma, di quello di imperatore dei romani. Un
sovrano di popoli, non di terre.
Quando suo nipote Lotario, mezzo secolo dopo, decide di sostituire sistematicamente
nei propri documenti il titolo di re dei Longobardi con quello di “re d’Italia”, lo
fa per cercare di collegarsi all’antica tradizione delle cancellerie imperiali romane
e ripulire dalla barbarie il suo impero nuovo di zecca. È da notare che all’Italia
che intendono Lotario e la sua corte manca tutta la parte centro-meridionale della
penisola, in quanto dominio diretto o rivendicato degli imperatori romani che si trovano
a Costantinopoli. Per questi ultimi “Italia” rimarrà per secoli solo il territorio
costiero che riescono a mantenere nel Meridione del paese. Definizione, questa, che viene spazzata via poco prima del 1100, insieme ai bizantini
stessi, dai Normanni, che da Palermo governano il Sud chiamandolo, tutto intero da
Trapani a Bari, “Regno di Sicilia”.
Per secoli al nome “Italia” si sovrappongono, con maggior efficacia descrittiva, definizioni
che oggi si direbbero locali: mentre il titolo stesso di “re d’Italia” perde senso
nell’Europa della prima età moderna – l’ultimo imperatore a prendersi la briga di
farsi incoronare re d’Italia è Carlo V, nel 1530 –, a Londra la via dei prestatori
di denaro provenienti dalla penisola, originari per lo più del Nord, prende il nome,
tutt’oggi esistente, di Lombard Street. Allo stesso modo, esiste una Rue de Lombards
a Parigi. Le vie dei “lombardi”, non degli “italiani”.
Quelli che oggi i manuali di storia delle nostre scuole spesso definiscono “stati
preunitari”, con una forzata capacità proiettiva della storia otto-novecentesca sul passato,
sono realtà che hanno una propria vitalità e narrazione pubblica radicata che nulla
ha da invidiare a ciò che verrà dopo il 1861. Il Sud Italia ha, ad esempio, una storia amministrativa piuttosto omogenea dai normanni
fino all’unità e naturalmente sviluppa una specificità che si nutre anche del concetto
di “Italia”, ma lo elabora in una propria identità riconoscibile e distinta, in cui
il Mediterraneo e il mondo iberico giocano, per ragioni geografiche e politiche, un
ruolo molto maggiore rispetto al resto della penisola. Il regno di Napoli è una realtà
solida e riconosciuta, tanto che perfino durante i grandi rivolgimenti avvenuti con
le guerre napoleoniche la compagine napoletana rimane indipendente, accanto all’istituzione
di una repubblica italiana (1802-1805), poi divenuta regno (1805-1814) nel Nord Italia, senza che si senta la parzialità o l’inadeguatezza di questo aggettivo, “italiana”,
applicato a una porzione piuttosto piccola dello Stivale.
Allo stesso modo la repubblica di Venezia è proiettata nei secoli alla costruzione
di una talassocrazia che arriva fino a Cipro; i domini dei Savoia sono legati a doppio
filo alle vicende francesi fino all’Ottocento. Lo Stato della Chiesa è poi un caso
ancor più particolare: la sua esistenza basata sul potere temporale del vicario di
Cristo in terra ne fa, per così dire, un’entità dagli interessi globali. Tutti stati
geograficamente inseriti nel contesto della penisola, ma non per questo legati tra
loro da rapporti più saldi di quelli che ci possano essere tra (non sempre buoni)
vicini. Questi stati hanno momentanee comunanze di interessi politici, come quando
francesi, spagnoli o imperiali invadono la penisola, ma sono più spesso diretti concorrenti
che hanno rapporti commerciali e, in misura minore, culturali. Il fatto di giacere
in un unico “stivale” geografico non fa di loro i predestinati antenati della nazione
italiana.
1.4. Lo Stivale torna utile, perché è “naturale”
L’Italia, dunque, dando ragione al principe di Metternich, sembra per secoli in effetti
solo una mera espressione geografica, come “Scandinavia” o “Balcani”, fino a quando
il bisogno di un nuovo racconto unificante rende necessaria una piattaforma fisica
chiara su cui appoggiare rivendicazioni e valori della nuova entità che si va formando
per conquista. Fino a quando, cioè, la geografia non viene arruolata dalla politica.
Con le guerre che portano il regno di Sardegna ad annettere i territori della penisola
in nome dell’unità del paese lo Stivale torna ad essere una forma desiderabile, in
quanto, ad esempio, giustifica l’espansione dai confini stretti dell’Italia di Carlo
Magno e di Napoleone da parte di garibaldini e piemontesi, aggiungendo tutto il settore
meridionale, con Napoli e la Sicilia.
Che la scelta sia dettata dall’opportunità del momento è dimostrato dall’abbandono
di territori già acquisiti, come la regione di Nizza e la Savoia, o delle velleità
su territori fisicamente vicini ma geopoliticamente inarrivabili come la Corsica,
francese, e Malta, possedimento inglese.
È in concomitanza con le guerre che alimentano le speranze di unificazione, a metà
dell’Ottocento, che ritroviamo i geografi al lavoro per incastrare la volontà di identità
delle avanguardie del sentimento nazionale della penisola – intellettuali, politici,
combattenti idealisti – con le prove geografiche e storiche di questa spinta.
La conformazione del territorio aiuta: le Alpi sono una barriera fisica riconoscibile. Il fatto che siano da millenni un confine tutt’altro che omogeneo e che, anzi, abbiano
come caratteristica il fatto di essere un luogo di scambio poroso e scarsamente definito
tra mondi culturali adiacenti non sembra impensierire i tecnici della costruzione
del confine identitario.
La scienza positivista cerca di venire incontro a queste necessità elaborando la teoria
dello “spartiacque”. La linea dello spartiacque è una linea convenzionale che segna
il confine tra due differenti bacini idrografici. Nel caso italico, vengono scelti
i bacini di Po, Adige e dei loro affluenti che dalle Alpi scorrono verso il Mediterraneo.
Una linea arbitraria e convenzionale, come tutti i confini, che ha però un vantaggio:
aderisce in maniera soddisfacente a quelle che sono le mire di espansione geopolitica
dell’allora stato italiano. Non in maniera perfetta, perché da questi confini rimangono
esclusi consistenti pezzi di Liguria o tutte le realtà reclamate come italiane sulla
costa est dell’Adriatico, mentre sono inclusi territori come il Tirolo meridionale,
il Canton Ticino e l’Istria.
Un confine quanto mai approssimativo che però ha un vantaggio sugli altri che si sono
susseguiti nel tempo: un criterio scientifico, basato sulla geografia. Potrebbe sembrare
secondario, visto che i confini sono per lo più tracciati, nella storia europea, a
colpi di guerre più che di discussioni tecniche. Ma alle soglie del XX secolo queste
teorie risultano fondamentali per costruire il “diritto naturale” di un popolo alla
propria terra. E proprio “naturale” è la parola centrale di questo processo, che acquista
in breve una doppia accezione: quella propria, cioè “derivante dalla natura del luogo”,
e quella più emotiva, naturale nel senso di “normale, ovvio, giusto, dovuto”.
Ciò che è compreso nei confini “naturali” può essere perciò raccontato come giusto,
dovuto, e la terra diventa un’entità sacra i cui confini devono essere raggiunti e
difesi col sangue di chi aspira a questa eredità: gli italiani.
Ora si tratta semplicemente di capire chi debba morire, cioè chi siano questi italiani.
1.5. Gli italiani sono quelli che parlano italiano?
Sembra ovvio oggi che la lingua sia un fattore determinante e imprescindibile basare
la propria identità nazionale. Insomma, sono italiani quelli che parlano in italiano.
Certificare la propria appartenenza attraverso la lingua è in realtà una scelta arbitraria,
valida quanto altre. La lingua non gioca un ruolo fondamentale nella costruzione identitaria
di molti movimenti nazionali nell’Ottocento: polacchi, belgi e irlandesi hanno al
proprio interno gruppi linguistici differenti, che non per questo sentono meno l’appartenenza
al proprio gruppo nazionale. Costruire un’identità collettiva significa soprattutto scovare elementi comuni che
possano riunire sotto lo stesso nome più individui e, nel caso italiano, si può affermare
che la lingua sia praticamente l’unico elemento unificante a disposizione, vista la
mancanza non solo di uno stato o istituzione comune, ma anche la confusione secolare
sui reali confini dell’entità che si vuol chiamare Italia.
Quella che chiamiamo oggi “storia della lingua italiana” viene spesso presentata come
un fenomeno lineare di sviluppo. Dalla definizione delle più antiche frasi in volgare
italiano fino all’elezione dei padri della lingua italiana, quella che si presenta oggi all’italiano
medio è una storia che viene scritta principalmente tra Otto e Novecento per dare
al paese una lingua che possa giustificare, quasi da sola, un’identità.
La lingua italiana studiata oggi nei manuali non è una creazione spontanea delle genti
italiche, ma il risultato della forza propulsiva di generazioni di intellettuali che
affidano la costruzione di questo grande mezzo comunicativo al successo di uno dei
più grandi bestseller della storia della letteratura: la Commedia di Dante. Un libro che con il suo eccezionale successo e la sua diffusione si trova
ad essere la base per la lingua comune dei letterati italiani. Come ricorda Benedict
Anderson, le lingue volgari che riescono ad avere diffusione letteraria costruiscono
in tre distinti modi il processo di identificazione comunitaria. In primo luogo, in
quanto esse delimitano un gruppo di persone che comprende la stessa lingua al di sotto
del latino, ancora lingua internazionale dell’Europa tardomedievale, e al di sopra
dei volgari locali facendone, appunto, una comunità. In secondo luogo, con lo sviluppo
della stampa, le lingue letterarie ben presto rallentano la propria evoluzione e acquistano
una loro stabilità data dalla riproducibilità meccanica dei testi: la lingua letteraria
non cambia più attraverso le corruzioni di chi la parla o dei pochi copisti che risproducono
i testi a mano, ma viene riprodotta in copie che la diffondono sempre uguale a sé
stessa, dandole un’idea di fissità, antichità e purezza che ne facilita la mitizzazione.
In terzo luogo, la diffusione di una lingua comune letteraria permette in determinati
casi di assumere la stessa come lingua d’uso amministrativo, “statalizzandola”. Tutte queste caratteristiche si ritrovano e sviluppano nel fiorentino dantesco,
che ben presto vince la gara con gli altri volgari e diventa l’italiano per antonomasia,
tanto che già nel primo Cinquecento è sulla matrice fiorentina che si costruiscono
le prime grammatiche “panitaliane”.
Si tratta, comunque, di una lingua diffusa tra chi sa leggere e legge per diletto,
cioè una parte ampiamente minoritaria della popolazione; persone che non hanno l’italiano
letterario come “lingua madre”, ma spesso si trovano ad utilizzare almeno tre lingue:
il latino, in chiesa o nelle amministrazioni locali; l’italiano per le poesie o i
romanzi; la lingua locale della propria comunità con la famiglia e i vicini.
L’unificazione porta sotto uno stesso governo una parte consistente della penisola
in nome della costruzione dello stato degli italiani, ma se il nuovo regno deve essere il paese di chi parla italiano, una volta proclamato questo paese rischia di rimanere drammaticamente sottopopolato.
L’italiano è una lingua prettamente letteraria, è pertanto possibile analizzarne la
diffusione attraverso l’alfabetizzazione popolare. Chi legge conosce l’italiano, anche
se non è detto che lo parli. Secondo il censimento del 1861 il tasso di analfabetismo
nel regno è del 68%, con una media del 54% al Nord e dell’87% al Sud. Sempre per via del fatto che l’italiano della prima metà dell’Ottocento è lingua
letteraria e amministrativa, verosimilmente nessuno degli alfabetizzati può definire
l’italiano come propria “lingua madre”, essendo nato e cresciuto in contesti in cui
le lingue d’uso sono i dialetti locali.
Che l’appartenenza alla nuova comunità italiana passi da una conoscenza della lingua
e della cultura e che, idealmente, vi sia una differenza sostanziale tra i pochi “italiani”
e tra chi semplicemente in Italia ci vive è dato dalla legge elettorale del regno
di Sardegna, poi estesa nel 1861 a tutta Italia, che prevede tra gli altri l’obbligo,
per i votanti, di essere in possesso del requisito di “alfabetismo”, cioè di sapere
leggere e scrivere.
Solo quando l’unificazione territoriale dà la possibilità di costruire una base operativa
alla lingua nazionale in tutto il paese si dà il via al corso forzoso dell’italiano,
attraverso la diffusione di un insegnamento scolastico comune della lingua italiana
ufficiale, affinata in un processo tutt’altro che spontaneo. Un’operazione di omogeneizzazione che avviene dopo che lo stato che doveva riunire
tutti gli “italiani di lingua” è già nato. Un lavoro, come tanti nella storia dei
nazionalismi, di legittimazione ex post.
La diffusione dell’italiano nel neonato regno d’Italia è più simile a un’operazione
di penetrazione commerciale che non a uno spontaneo allargamento di un tratto culturale
nel paese. Non mancano i correttivi a tavolino: il detto che definisce l’italiano
“lingua toscana in bocca romana” getta luce sul lavoro di mediazione locale messo
in atto per rendere più accettabile e accessibile un processo di colonizzazione culturale
calato dall’alto. Quando Alessandro Manzoni va a “sciacquare i panni in Arno”, quando
cioè cerca di ripulire dai dialettismi lombardi il proprio modo di scrivere per portarlo
a una maggiore aderenza nei confronti del modello toscano, è conscio di compiere un’operazione
artificiale, tentando di piegare consapevolmente la lingua italiana che conosce e
usa a Milano alla “lingua di Dante”.
Viene da chiedersi che frutti abbiano portato questi centosessant’anni di ingegneria
sociale applicata alla diffusione della lingua comune. Come già accennato, le cifre
non sono esaltanti: l’ISTAT in un rapporto del 2015 ricorda come l’italiano standard
sia la forma espressiva “prevalente” solo del 45,9% degli italiani. I restanti italiani si esprimono con diversi gradi di diffusione anche, o addirittura,
prevalentemente nel proprio dialetto e quasi il 10% della popolazione italiana (poco
meno di 6 milioni di persone) non riconosce, a oggi, l’italiano come la propria lingua
madre. Pare proprio che la lingua non riesca, dopo decenni di scuola pubblica e di TV commerciale,
a definire, se non molto parzialmente, i caratteri identitari degli abitanti del paese.
Eppure, su questi caratteri sono state avviate narrazioni pubbliche, legislazioni
escludenti, guerre mondiali.
1.6. Italia da costruire tra desiderio e realtà
Quando nel 1786 Johann Wolfgang Goethe si spinge a sud delle Alpi afferma:
Eccomi a Rovereto, punto divisorio della lingua; più a nord si oscilla ancora fra
il tedesco e l’italiano. Qui per la prima volta ho trovato un postiglione italiano
autentico; il locandiere non parla tedesco, e io devo porre alla prova le mie capacità
linguistiche.
L’Italia che ha sotto gli occhi Goethe inizia circa 150 km più a sud rispetto a quella
odierna. La gente porta con sé più facilmente la propria lingua che non la propria
casa e i confini tracciati e tracciabili a livello politico difficilmente combaciano
esattamente con quelli culturali e linguistici. In più, i confini politici, ovviamente,
possono cambiare, costringendo i fautori della creazione delle identità a faticosi
salti concettuali.
Pochi anni prima, ad esempio, esce dalla rappresentazione dell’Italia geografica la
Corsica, ceduta nel 1768 da Genova allo stato francese. Ciò non impedisce alla piccola
nobiltà isolana di continuare a crescere i propri figli nella lingua d’uso delle élites peninsulari, come fanno i Buonaparte con Napoleone, nato francese appena l’anno dopo
la cessione dell’isola, nel 1769. Il francese non fluentissimo dell’imperatore rimane
a memoria delle difficoltà di costruire dei racconti identitari “puri” di lingua e
suolo; la confusione è tale che ancora un secolo dopo viene inserito nel pantheon
degli italiani che hanno dato gloria al paese prima che il paese esistesse.
Ma qual è, allora, lo stato che si desidera costruire?
Dopo aver pensato e messo in atto modelli che possano includere il maggior numero
di individui all’interno di recinti governabili e riconoscibili e aver chiuso questi
utlimi attorno alle persone attraverso la proclamazione dello stato degli italiani,
le autorità della nuova struttura di governo si affannano per fare in modo che questa
chiusura arbitraria sia realistica. Si comincia cercando di assimilare o escludere
dal racconto nazionale e poi dalla nazione stessa chiunque non si riesca a uniformare
al presunto modello di riferimento.
La teoria non analizza, ma insegue e si rimodella sulla pratica, per poi dichiararsi,
immancabilmente, solida e inamovibile.
In concomitanza con l’accelerazione del fenomeno di identificazione tra stato e nazione
proprio lo stato, come ricorda Eric Hobsbawm, “diventò paladino del diritto politico
della nazione e della bandiera”. Le compagini statuali proiettano sé stesse sulla scena internazionale – altra parola dal peso etimologico forte, perché pone come soggetti proprio le nazioni,
che sembrano confrontarsi tra loro come organismi individuali pensanti – come agglomerati
omogenei diversi gli uni dagli altri, aventi cioè una propria identità. Specifica.
Per rendere efficiente questo assemblaggio standardizzano il proprio modo di governarsi
e di dirigersi: un’unica legge applicata da un’unica amministrazione che, per comodità,
è meglio che parli un’unica lingua. Tutti, appunto, sotto un’unica bandiera.
Accanto a questa spinta “dall’alto” al fenomeno di identificazione nazionale arriva
poi una formidabile spinta “dal basso”. In particolare, agli inizi dell’Ottocento,
dopo i grandi rivolgimenti politici susseguitisi alla rivoluzione francese e alle
guerre napoleoniche, in tutto il continente europeo si comincia a diffondere l’idea
che sia lecito, anzi, sia un diritto, da parte degli abitanti di un determinato luogo,
esprimere le proprie idee sulle strutture che li governano.
...