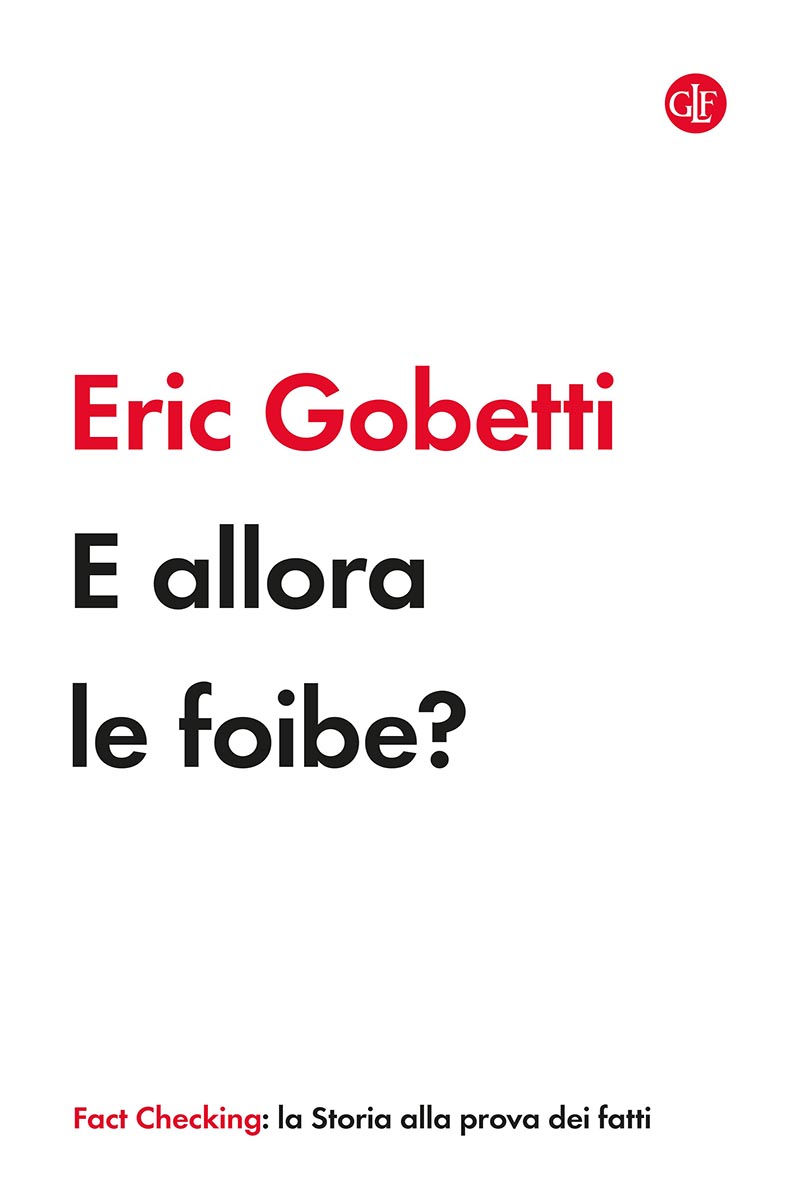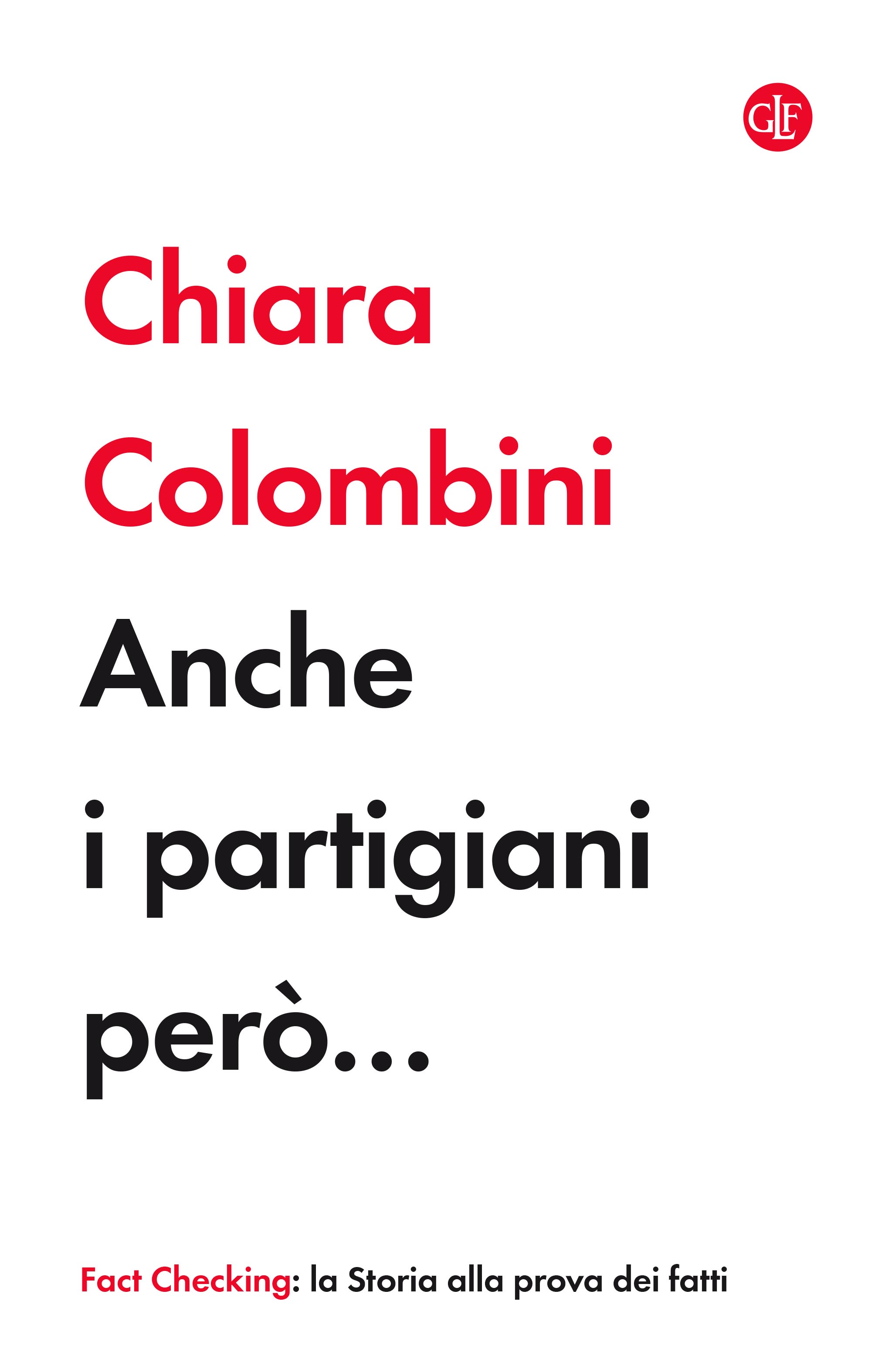Introduzione
Non si parla mai dei crimini del comunismo! Sul serio?
Chi lo dice, in genere, vuole esprimere due cose, entrambe vanno oltre il senso proprio
della frase, come un sottotesto.
La prima è che si ritiene esagerata l’attenzione che si dedica alla Shoah. Diluita
nell’ecatombe di morti ammazzati da feroci utopie, fondamentalismi e tirannie del
cosiddetto “secolo degli estremi”, lo sterminio degli ebrei d’Europa perderebbe la
sua abominevole singolarità. Di conseguenza, non vi sarebbe motivo di ritenere i fascismi
un “male assoluto”. L’intenzione, insomma, è poco onorevole.
In secondo luogo: si lamenta un’amnesia, l’esistenza di un muro di omertà o addirittura
– in sintonia coi tempi – una congiura del silenzio, perché del nazismo e dei suoi
Lager sapremmo oramai tutto o quasi, mentre si tacerebbe delle morti per fame nell’Ucraina
degli anni trenta o delle deportazioni nell’“arcipelago” Gulag, parlare e scrivere
del quale sarebbe ancora scomodo e imbarazzante.
Dietro questa affermazione, mi pare evidente, non c’è alcun desiderio di conoscerli
meglio, questi e altri crimini del comunismo (mi rendo conto del carattere sommario
e impreciso del termine, chiariremo presto!) né la premura di rendere più note pagine
terribili della storia del Novecento e nemmeno un sincero bisogno di commemorare le
vittime, delle quali poco si sa e ancora meno interessano, perché appaiono a molti
anonime e distanti, nello spazio come nel tempo.
Il vero destinatario di questa contestazione, almeno in Italia, è “la sinistra”, accusata
di subdola reticenza, di non aver fatto i conti col passato, in un contesto nel quale
la cultura comunista è stata eccezionalmente pervasiva.
Non si parla mai dei crimini del comunismo! non vuol essere, dunque, una constatazione oggettiva né un’esortazione costruttiva:
è uno statement politico, di parte naturalmente, manifestazione di un interesse puramente
strumentale alla storia. Anche perché, nei fatti, è difficile parlare seriamente di
congiura del silenzio quando della lunga storia di violenze e crimini contro l’umanità
commessi da regimi comunisti se ne parla e scrive diffusamente in tutto il mondo,
la memoria delle vittime è tutt’altro che trascurata, la ricerca storiografica, la
riflessione critica e il dibattito su quanto accadde nell’Urss di Lenin e Stalin,
nella Cina di Mao o nella Cambogia dei khmer rossi sono quanto mai vivaci.
La questione, piuttosto, è un’altra, ben più seria e complessa di un’evocata congiura
del silenzio: a dispetto delle approfondite conoscenze oggi disponibili grazie a una
vasta letteratura, permangono alcune serie divergenze nella valutazione del significato
da attribuire a quei crimini e nelle dinamiche di ricezione di quei fatti nella memoria
collettiva dei popoli. In Europa, per esempio, dalla fine dell’era sovietica e per
effetto dell’integrazione comunitaria è in pieno corso un processo di revisione, ridiscussione
e ricalibratura della memoria storica sul doppio livello nazionale e continentale.
Un processo inevitabile e irreversibile, innescato dalle profonde trasformazioni politiche
che hanno investito i paesi dell’Europa centro-orientale dopo la caduta del Muro di
Berlino e che, semplificando, riguarda lo spazio da assegnare ai crimini staliniani
e ai danni morali e strutturali del cosiddetto socialismo reale nella memoria storica
collettiva dell’Europa riunificata.
Almeno in una parte dell’Europa occidentale, sicuramente in Italia, si reagisce con
forte scetticismo e disagio alla rivendicazione avanzata dai paesi post-comunisti
dell’Unione europea di vedere integrate le proprie esperienze e la propria specifica
sensibilità in una consapevolezza storica collettiva europea, paventando il rischio
che questo possa contribuire, tramite l’equiparazione dei totalitarismi di destra
e sinistra, a offuscare i crimini immensi del nazismo, a sdoganare il fascismo e tutto
quanto ne consegue. A prescindere dalle motivazioni di ordine politico (quindi strumentali
della storia e della memoria pubblica) che sicuramente non sono estranee all’azione
dei paesi di Visegrád1, l’impressione è che queste inquietudini e reazioni sdegnate coprano in verità un
problema più grande e profondo: la difficoltà a sgombrare il campo definitivamente
dai fumi della mitologia ideologica comunista, il cui carattere mistificante è ampiamente
documentato da un’ormai vastissima storiografia internazionale, nonché a congedarsi
da una concezione benevola del leninismo, che ci si ostina a collocare in una storia
di lotte per la libertà, la pace e la giustizia sociale, ascrivendo al solo stalinismo
errori, orrori e qualità totalitaria del fenomeno.
Abbandonando le trincee ideologiche della Guerra fredda, che ci hanno reso piuttosto
infantili nell’approccio analitico e nelle argomentazioni (e allora il capitalismo?
e i crimini delle “democrazie”? e la Cia?), si possono riconoscere senza difficoltà
le comprensibili ragioni di questa benevolenza in paesi come l’Italia e la Francia,
dove i partiti comunisti ostacolarono la maturazione di una piena consapevolezza del
fatto che atrocità, repressioni e violenze di massa commesse in nome della “società
senza classi” non erano incidenti di percorso, screditandone la denuncia come professione
ideologica di anticomunismo. Se poi a ciò sommiamo che da questa parte dell’Europa
non si fece esperienza dei metodi di governo delle dittature comuniste, ma anzi, i
comunisti contribuirono in misura decisiva alla lotta di resistenza antifascista e
svolsero (nel caso italiano grazie a una dirigenza di qualità intellettuale e morale
indubbiamente superiore alla media) un ruolo di primissimo piano nella vita democratica
nazionale e anche oltre, non possono sorprendere l’irritazione e lo sconcerto che
suscitano gli accostamenti e l’associazione dei totalitarismi novecenteschi.
Dei crimini del comunismo, dunque, se ne parla eccome. Anzi, direi che non si è mai
smesso di parlarne e mai come oggi ricevono grandissima attenzione. Se apriamo gli
orizzonti di analisi oltre la dimensione europea, scopriamo che il lavoro, il dibattito
e la riflessione sulla traumatica eredità di regimi dittatoriali ed esperienze di
violenza di massa dello Stato non occupano affatto solo le società europee. Dall’America
Latina alla Corea, dalla Mongolia all’Etiopia, si elaborano i traumi e le conseguenze
di guerre e tirannie, si dibatte sulla persecuzione dei responsabili di atrocità commesse
e su come ricordarne le vittime. E ovunque si discuta dell’eredità di dispotismi e
repressioni di massa, sorgono monumenti, musei e istituzioni commemorative, che non
si limitano solo a celebrare le vittime, ma si confrontano con determinati eventi
storici di portata nazionale e internazionale ricorrendo alle più moderne forme di
documentazione, elaborazione e divulgazione mediatica.
È evidente che, con il venir meno delle vecchie contrapposizioni ideologiche del mondo
diviso della Guerra fredda e con lo sviluppo delle comunicazioni e della globalizzazione,
si sia venuta a creare una congiuntura molto positiva dell’interesse per la storia
che pervade società e Stati in tutti i continenti. In molti paesi questo boom della
memoria, che ha visto crimini a lungo tenuti nascosti venire finalmente tematizzati,
vittime dimenticate pubblicamente onorate e, in qualche caso, anche taluni carnefici
portati a processo e confrontati con le loro responsabilità a decenni di distanza
dai fatti, ha prodotto un mutamento fondamentale nelle culture del ricordo, valorizzando
la funzione dei memoriali. Ma con la rimozione dei tabù si sono anche aperte aspre
lotte per l’interpretazione dei traumi della storia, col ritorno a vecchie ostilità
fra gruppi sociali, etnie e Stati, concorrenze fra le vittime e un uso palesemente
strumentale della storia da parte di forze politiche e governi2.
Tutti questi “conflitti di memoria”, ci ricorda Günter Morsch, hanno in comune la
ricerca di chiavi interpretative per spiegare guerre, eccidi e altri crimini di massa
di cui è tragicamente costellata la storia del Novecento3. In moltissimi casi si tratta di crimini commessi da regimi comunisti in paesi che
hanno affrontato o sono alle prese con la difficile transizione postcomunista. Il
collasso del mondo sovietico ci ha fatto velocemente dimenticare che ancora all’inizio
degli anni ottanta oltre un terzo dell’umanità viveva in Stati comunisti, sotto regimi
politici ispirati ai principi della dottrina marxista-leninista.
Personalmente, mi trovo a seguire il dibattito sull’interpretazione della storia del
comunismo novecentesco e dei relativi crimini da un osservatorio particolare, quello
tedesco, col suo doppio passato, prima il nazismo, poi l’esperienza del socialismo
di Stato di stampo sovietico nella Germania orientale. Per certi aspetti è un osservatorio
privilegiato, e non mi riferisco tanto alla proverbiale esemplarità che si usa attribuire
al modello tedesco di approccio all’elaborazione dei traumi storici, quanto piuttosto
al fatto che in Germania si trovano riprodotte in scala minore la divisione della
memoria europea e le tensioni che l’accompagnano. In Germania, infatti, s’incontrano
e collidono non solo le due memorie storiche tedesche dell’Est e dell’Ovest, ma anche
“per procura” i discorsi della cultura della memoria europea occidentale, incardinata
attorno al primato della Holocaust Education, e quelli dell’Europa orientale, che
hanno esigenza di abbracciare anche l’esperienza del Gulag e delle persecuzioni comuniste.
Negli ultimi dieci anni della mia attività di studioso e formatore al Memoriale di
Berlino-Hohenschönhausen (le prigioni della Stasi, la polizia segreta della Germania
orientale, sono oggi una delle istituzioni commemorative della capitale tedesca più
visitate in assoluto) ho potuto fare quotidiana esperienza del profondo divario di
conoscenze e nel sentire comune esistente fra la memoria dei crimini nazisti e quelli
comunisti.
Più volte, per portare un esempio concreto, mi è capitato di assistere a scene come
questa: un ragazzo di una delle tante scolaresche che ogni giorno affollano il piazzale
d’ingresso del memoriale si presenta alla visita sfoggiando un colbacco nero con la
stella rossa e l’emblema della falce e martello. La guida che accoglie la comitiva
subito se ne avvede e, garbatamente ma con decisione, lo esorta a togliersi il copricapo
per rispetto di chi ha sofferto imprigionato in quel carcere. Il giovanotto reagisce
meravigliato e in suo soccorso interviene l’insegnante, il quale invece di scusarsi
polemizza. A un certo punto dell’alterco che ne scaturisce, la guida sbotta, sinceramente
esasperata: «Ma, scusi, lei permetterebbe a un suo alunno di entrare a Dachau con
una svastica sul berretto?». Il paragone fa saltare i nervi all’insegnante, che esige
di parlare col direttore: «Senza Stalin», reclama, «Hitler non sarebbe stato sconfitto!».
Poi, insistendo nel fatto che il suo allievo non voleva offendere nessuno, fa presente
che portare il copricapo invernale dell’Armata rossa non è affatto illegale, lo si
può acquistare nei negozi di souvenir al Checkpoint Charlie o intorno alla Porta di
Brandeburgo, è una delle reliquie della Guerra fredda più vendute ai turisti!
Ricordo che mi colpì molto la freddezza di quell’insegnante, una carenza di empatia
che poteva avere mille ragioni, comprese le più banali, ma che rimase inalterata anche
quando gli fu gentilmente spiegato che l’anziana guida con la quale si era messo a
litigare, in quella prigione che stava per visitare, c’era finito quando aveva solo
15 anni (gli stessi del ragazzo col colbacco) e precisamente nel braccio delle celle
in cantina, il cosiddetto U-Boot (sottomarino) utilizzato nel periodo 1946-51 dalla brutale polizia segreta sovietica
per estorcere confessioni (la Stasi continuò a usarlo fino al 1960).
Condannato da un tribunale militare sovietico per atti di “resistenza contro le autorità
di occupazione” (che non aveva commesso), Horst trascorse otto anni della sua gioventù
nelle carceri della Germania comunista. Se n’è andato alla vigilia di Natale 2020,
all’età di 89 anni, lasciandoci una testimonianza di grande ricchezza umana e una
lezione, che cerco di fare mia nel lavoro con i ragazzi: l’elaborazione critica della
storia del comunismo ha in sé elementi molto utili alla promozione della cultura democratica,
è preziosa quanto quella del nazismo e del fascismo, sia per la formazione storica
in generale, sia per l’educazione a una cittadinanza democratica consapevole e capace
di acquisire la lezione di ciò che è accaduto nella storia quando si è abbandonato
il terreno della democrazia e del pluralismo per realizzare l’utopia di una società
(più) giusta, ma al contempo senza frustrare l’impulso umano a sviluppare visioni,
anche radicali, per correggere e migliorare il presente.
In luoghi come Hohenschönhausen ho imparato a conoscere, insieme a tutti i delicati
problemi che pone l’impiego dei cosiddetti testimoni dell’epoca nel lavoro con la
storia del secolo scorso, il sincero e profondo desiderio che alberga nell’animo delle
vittime delle persecuzioni politiche nella Germania orientale di vedere riconosciute
e onorate le proprie sofferenze e che alla loro esperienza venga dedicata, dalle istituzioni
come nella memoria pubblica, un’attenzione equivalente a quella che si presta alle
vittime del nazismo. Non è difficile immaginare come in un paese che ha fatto del
riconoscimento dell’assoluta singolarità della Shoah la pietra angolare della propria
coscienza civile democratica, questo desiderio e le pretese che ne discendono pongano
alcuni seri problemi, come ampiamente dimostrato dalle accese polemiche e fortissime
tensioni che hanno accompagnato negli ultimi trent’anni l’istituzione di tutti i musei
e memoriali dedicati alle repressioni operate dagli organi di sicurezza sovietici
e della Repubblica democratica tedesca (Ddr).
Particolarmente critica si presentava la situazione, negli anni novanta e duemila,
in quelle strutture di concentramento e istituzioni detentive cosiddette a doppio
o triplo passato, come i campi di Buchenwald e Sachsenhausen, Lager nazisti fino al
1945, poi campi di internamento sovietici (Spezlagerja) fino al 1950, ma anche le prigioni di Torgau e il penitenziario di Bautzen in Sassonia,
utilizzati sia dai nazisti che dai sovietici e infine dalle autorità della Germania
orientale. A infiammare la controversia (con picchi al limite dello scontro fisico
fra storici e rappresentanti delle associazioni delle vittime) fu il problema di come
interpretare crimini e sofferenze del periodo 1945-89 e in che relazione questi dovessero
stare rispetto alle precedenti violenze perpetrate dal nazismo.
Queste turbolenze sono state una dura scuola, dalla quale è dovuta passare l’elaborazione
del comunismo in Germania nei suoi primi tre decenni di evoluzione dalla fine della
Guerra fredda. Il risultato è un consenso antitotalitario, che ha consentito al ricco
e articolato panorama di realtà che fanno ricerca, formazione e informazione sull’esperienza
del comunismo nella Germania Est di emanciparsi dai problemi di gerarchizzazione della
memoria storica, facendo propri orizzonti d’analisi comparativi e transnazionali.
Un fatto molto positivo è che la ricerca e il dibattito su nazismo e comunismo hanno
oggi smesso di viaggiare su binari paralleli senza toccarsi, ma s’intrecciano e si
stimolano a vicenda.
I conflitti che hanno caratterizzato il dibattito tedesco li ritroviamo attualmente
a livello europeo, dove la contesa sul disequilibrio della memoria del nazismo e del
comunismo in Europa ha assunto un’infelice dimensione politica (infelice perché non
è mai buono quando la politica mette le mani sulla storia, che ha invece bisogno urgente
di lucidità di analisi e indipendenza di giudizio) da quando è stato trasferito nell’arena
di Strasburgo, cioè da quando le istituzioni comunitarie hanno cominciato a intervenire
a colpi di risoluzioni sul sensibile terreno della politica della storia, con l’ambizione
di trovare nella coscienza storica la cifra di un’identità europea in una fase di
crisi dell’Ue (stranamente, si è partiti proprio da ciò che più divide gli europei:
la storia del Novecento). L’esperienza tedesca ci dice che il conflitto di memorie
e sensibilità storiche cui assistiamo costituisce una preziosa opportunità: quella
di sviluppare una specifica modalità con la quale le società europee affrontano le
loro storie intrecciate, un modello di memorie plurali, complesse e dialoganti, insofferente
ad astrazioni affrettate, omogeneizzazioni e costruzioni politiche di “memoria condivisa”,
e che ha a cuore la centralità della ricerca storica indipendente.
La freddezza, dicevamo. Nel 1980 lo scrittore franco-spagnolo Jorge Semprún auspicava
nel suo romanzo Quel beau dimanche! l’abbattimento di ogni riserva verso la storia dell’altro grande totalitarismo del
Novecento e la maturazione di una consapevolezza del carattere sterminatore proprio
anche del Gulag sovietico. Semprún, sopravvissuto al Lager nazista di Buchenwald,
immaginava una riunificazione della memoria europea sdoppiata (mémoire dédoublée) o una memoria “raddoppiata”, nella quale sarebbero confluite, incontrandosi e interloquendo
fra loro, la sua personale esperienza e quella dei sopravvissuti al Gulag come il
russo Varlam Šalamov, autore dei famosi Racconti di Kolyma (1973)4.
A oramai quarant’anni di distanza dall’auspicio di Semprún, la “doppia memoria” è
ancora una faccenda controversa, caratterizzata da asimmetrie che saltano all’occhio
anche agli osservatori più superficiali: se quasi tutti conoscono Heinrich Himmler,
Reinhard Heydrich e Rudolf Höß, i più ignorano chi siano stati Feliks Dzer�inskij,
Nikolaj E�ov e Naftali Frenkel, oppure il cinese Kang Sheng o il cambogiano Kaing
Kek Iew. Nella stessa Germania, dove si è molto sviluppato il campo della cosiddetta
Täterforschung (l’analisi dei processi di “disumanizzazione” ossia dei meccanismi psicologici, sociologici
e culturali che trasformano uomini in efferati aguzzini esecutori di crimini di massa),
gli studi dedicati ai “volenterosi carnefici” di Lenin, Stalin, Mao e altri tiranni
comunisti sono ancora una rarità.
Si tratta allora di capire se vi sia soltanto un problema di ricezione, di interpretazioni
concorrenziali dei fatti, oppure se il nodo non riguardi invece proprio alcune proprietà
peculiari dei crimini stessi e delle vittime, in altre parole che nelle violenze di
massa commesse da regimi comunisti vi siano tratti e componenti che impediscono di
svilupparne una memoria equivalente rispetto a quelle perpetrate dal nazismo. Interrogandosi
sui motivi per cui, a dispetto delle diffuse e approfondite conoscenze storiografiche,
molti continuino ad avvertire come “più gravi” e carichi di significato per la memoria
collettiva i crimini nazisti, perché insomma Auschwitz sia divenuto così centrale
nella memoria del Novecento, mentre il Gulag non abbia ancora lo stesso impatto emotivo,
Charles Maier propone un’analisi originale, nella quale, mutuando dalla fisica nucleare
il concetto di emivita ovvero il tempo di decadimento radioattivo degli elementi, ci offre i concetti di
hot e cold memory: la Shoah e i Lager di sterminio nazisti sarebbero «come un plutonio della storia
che contamina il paesaggio per secoli con le sue radiazioni», mentre le atrocità del
regime stalinista avrebbero «la ricaduta radioattiva molto meno duratura dell’isotopo
trizio, che si dissipa in tempi relativamente brevi»5.
Secondo Maier, due fattori giustificano lo scarto di intensità esistente fra la memoria
(“calda”) del nazismo e quella (“fredda”) del comunismo. Il primo è che la Germania
nazista uscì sconfitta e annientata da un devastante conflitto da lei stessa provocato
allo scopo di soggiogare l’Europa; il comunismo, dal canto suo, può apparire oggi
passé, ma sul campo non ha perso una battaglia. Comunque, nessun regime comunista scatenò
mai un conflitto mondiale, anzi, dopo la morte di Stalin, il regime sovietico e quelli
“satelliti” in Europa orientale mitigarono la propria violenza, mettendo fine al terrore
stalinista e assumendo il carattere di sistemi autoritari a rigida disciplina sociale,
definiti dal dissidente ceco Václav Havel post-totalitari, che sono infine collassati, abbandonando mestamente il palcoscenico della storia:
«Qualunque dittatura entri in una fase di post-totalitarismo lascia un’eredità storica
molto più ambigua di un’altra che crolla tra le fiamme»6.
In secondo luogo, il terrore nazista assassinava in virtù dell’appartenenza etnica
(“razziale”) o politica in quanto tale, si trattò pertanto di un targeted terror. Quello stalinista era invece stochastic terror, un terrore imprevedibile, perché nessuno poteva presagire chi sarebbe stato il prossimo
a venire prelevato dalla polizia segreta e incriminato di sabotaggio o cospirazione
ai danni del Partito o dello Stato. Era un terrore di cui chiunque poteva restare
vittima e laddove si uccise per soddisfare quote stabilite, le vittime non apprendevano
nemmeno il motivo per cui venivano assassinate. Vi è insomma, come segnala Jörg Baberowski,
un problema di categorizzazione delle vittime, con conseguenze sul modo che abbiamo
di ricordarle: «la cultura della memoria relativa ai crimini dello stalinismo necessita
di forme e schemi propri, diversi da quelli sviluppati per affrontare e valutare i
crimini del nazismo, perché i nazisti categorizzarono molto precisamente le loro vittime
e questo rende oggi più semplice identificarle, commemorarle, risarcirle e chiederle
loro perdono, nello stalinismo invece le categorie di vittime erano molto più fluide
e moltissimi carnefici finirono a loro volta vittime della violenza che loro stessi
avevano usato ad altri»7.
Non dobbiamo dimenticare che gli Stati comunisti dell’Europa orientale esistettero
quarant’anni, il regime sovietico addirittura settanta, a differenza dei dodici del
nazismo, la metà dei quali in guerra. Inoltre, i regimi comunisti non ci hanno lasciato
rovine fumanti e montagne di cadaveri, ma sono implosi e collassati praticamente imbelli.
Dobbiamo comprendere, insomma, che il comunismo non fu solo le purghe di Stalin e
i massacri di massa di Mao, Menghistu o Pol Pot, ma anche società relativamente pacifiche
e pacificate, dove per decenni si condusse una vita quotidiana e si formarono generazioni
di uomini e donne. Solo tenendo presente questo fatto possiamo intuire perché, per
fare i conti col comunismo, senza banalizzare riducendolo alla sola dimensione criminale,
abbiamo bisogno di ragionamenti e riflessioni diversi e indipendenti da quelli che
siamo abituati a fare per il nazismo.
Come ci ricorda Baberowski, allo stalinismo, in Europa orientale, seguì l’esperienza
di un dominio autoritario che seppe rinunciare sua sponte (cioè per propri interessi e non costretto con la forza dall’esterno) al terrore
di massa, preferendogli altri dispositivi di controllo e condizionamento repressivo
di più basso profilo e a ridotta intensità, un’evoluzione per descrivere la quale
la storiografia tedesca ha forgiato il termine, molto controverso anche questo, di
Konsensdiktatur: una forma di governo, secondo la definizione proposta da Martin Sabrow, il cui strumento
principale non è più la repressione, bensì «un consenso ostentato, inscenato, sia
forzato che volontario [...] la finzione di un’unità fra popolo e regime»8. Questa «transizione da una modalità di egemonia con aggressione frontale ad una
pervasiva» approfittò di un processo che Sabrow chiama «interiorizzazione de-drammatizzata
dei vincoli di estorsione del consenso»9 e il sociologo Karl-Siegbert Rehberg, più semplicemente, «quotidianizzazione del
totalitario»10.
In altre parole, il terrore di massa del periodo precedente, cioè quello dell’imposizione
violenta della formazione sociale sotto Lenin e Stalin, si era radicato nelle anime,
era rimasto impresso nella memoria del corpo delle generazioni che non lo avevano
subìto più direttamente, come violenza sempre possibile, continuando a condizionarne
i comportamenti: «Morto Stalin, la dittatura non cessò. Per decenni le vittime del
terrore non poterono parlare delle loro esperienze traumatiche, mentre i carnefici
moderarono la loro violenza. Si diffuse una cultura del sospetto e il regime siglò
una tregua con i cittadini attraverso il mito della Grande guerra patriottica, che
distese un velo di silenzio sopra quanto era accaduto prima e trasformò tutti, vittime
e carnefici, in vincitori della Seconda guerra mondiale, al prezzo però dell’oblio
del sanguinoso passato»11.
Questa pax sovietica permise una forma di convivenza civile e radicò nelle masse dell’Impero sovietico
fino alla sua estrema periferia occidentale la concezione di un ordine sociale autoritario
e conservatore che non è affatto scomparsa dopo il 1989. La ritroviamo oggi nel rigetto
del liberalismo che esprimono le società dell’Est europeo post-sovietico, nella loro
ansia di ordine entro orizzonti e orientamenti nazionali nel caos del mondo globalizzato.
Anche questo fa parte della complessa eredità che ci ha lasciato il comunismo12.
Chi si interroga sulla più debole risonanza e considerazione che trovano le testimonianze
dei crimini comunisti nella memoria pubblica, rispetto a quelle che riguardano fascismo
e nazismo, deve ragionare anche sul prolungato esercizio di razionalizzazione della
violenza, della quale a lungo si è predicata l’imprescindibilità per fare la rivoluzione,
per rifare il mondo da capo. Nel celeberrimo Le origini del totalitarismo, Hannah Arendt individuava nella sua inutilità economica («aperta anti-utilità»)
la qualità nuova e singolare, la cosiddetta unicità della Shoah. Tenendo ferma quest’ultima,
dobbiamo domandarci, come ci invita a fare Gerd Koenen, se non siamo di fronte a un’odiosa
forma di relativismo morale quando proviamo a cercare ragioni di ordine utilitaristico
per l’eliminazione dei kulaki o di altre categorie di “nemici del popolo”. Mi riferisco
al relativismo morale di chi ha provato o prova ancora oggi «a frapporre fra sé e
la realtà storica il carattere “utopico”, “universalista” e “sostanzialmente umanistico”
del comunismo come una pellicola protettiva»13, evocando un carattere razionale degli eccidi perpetrati da Stalin, Mao e Lenin,
rappresentando per esempio quelli dei primi due come l’alto costo umano di una modernizzazione
industriale a passo forzato, quelli del terzo invece come atti di legittima protezione
della sua rivoluzione, che rischiava di essere soffocata sul nascere. Così argomentando,
si precipita in un abisso di cinismo. Cosa si vuole affermare? Forse che quanto più
nobili sono gli intenti, più elevati gli orizzonti ideali, tanto più accettabili e
quindi perdonabili i misfatti? Non è vero piuttosto il contrario?
«[C’è] un tremendo paradosso», scrive Koenen, «che quasi si sottrae alla nostra odierna
comprensione: tutti gli umanismi, gli utopismi e gli universalismi solennemente evocati
servivano in verità a un mostruoso capovolgimento della realtà, un ribaltamento di tutti i valori senza precedenti, gli operai ridotti in schiavitù in nome della classe operaia; il
tradimento e la delazione elevati a virtù rivoluzionarie, la menzogna trasformata
in scienza in nome della “verità” [...]; si cancellò la memoria delle persone reinventandone
la storia [...]; milioni furono privati della libertà e della dignità personale in
nome della libertà [...]; infine, con un’imperturbabile buona coscienza, [...] si
assassinarono centinaia di migliaia di persone [...] in nome dell’umanità e del suo
progresso. Ma perché questa realtà, che anche i contemporanei potevano riconoscere
e descrivere ad occhio nudo, valeva così poco dinanzi alle proiezioni della propaganda?»14.
A parte qualche clamorosa eccezione, come il massacro di Katy, non furono i carnefici a insabbiare la verità sui loro atti criminosi. Nel suo memorabile
Il passato di un’illusione, François Furet puntò il dito sull’«incantesimo», l’incrollabile e accecante convinzione
di avere compreso il senso della storia e di stare compiendo qualcosa di immenso e
grandioso, niente di meno che scardinare la civiltà per edificarne una del tutto nuova15. In questa lotta del nuovo contro il vecchio, qui ancora Koenen, «il terrore continuò
a essere considerato qualcosa di eccezionale anche quando da tempo era divenuto la
regola», anzi, proprio questo «terrore apertamente riconosciuto contro i nemici del
nuovo ordine sociale aveva per molti qualcosa di irresistibilmente allettante, di
seducente, perché testimoniava di una volontà animata da motivazioni molto forti»16. In altre parole: non era soltanto il fine a giustificare i mezzi, come si suole
dire e pensare, anche i mezzi stessi – il terrore – rendevano grande il fine, quel
terrore che non era un eccesso, bensì una logica conseguenza del Progetto, di un’impresa
che non aveva precedenti. «Gli occhi azzurri della Rivoluzione brillano di crudeltà
necessaria», recitava un famoso aforisma del poeta francese Aragon17.
Dovremmo avere l’onestà di riconoscere che è stato più facile, sul piano morale e
intellettuale, stigmatizzare l’odio primitivo del fascismo, la follia delle razze
e la feroce volontà di prevaricazione del nazismo. Consegnare alla storia un fenomeno
che si richiama a grandi idealità umane di emancipazione, proiezioni sociali profondamente
ancorate nell’immaginario e nella storia dell’uomo da secoli, che può vantare (ma
vedremo come) il titolo dell’antifascismo, l’aver sconfitto in campo aperto il “male
assoluto” del nazismo, è una faccenda ben più complessa. Bisogna fare i conti con
l’ambivalente e a tratti enigmatica eredità di una grande ideologia, che ancora oggi,
in molti, suscita più impressione che sdegno. Le disillusioni sono sempre dolorose,
quella del comunismo lo è ancora di più, per le energie umane immense che ha calamitato,
per il raccapricciante sacrificio di sangue, e perché, come preconizzava Furet nel
1995, ci ha «condannati a vivere nel mondo in cui viviamo», nel quale «l’idea di un’altra
società è diventata quasi impossibile da pensare»18.
1.
Cento milioni di morti!
Cento milioni è un numero che rimane impresso.
L’edizione originale francese lo portava stampato sulla fascetta che avvolgeva la
copertina, quelle fascette di colori sgargianti che aiutano a catturare l’attenzione
dei lettori nelle librerie, ricorrendo a superlativi, paragoni strabilianti, numeri
di vendita d’eccezione.
Ma cento milioni non erano le copie vendute.
Erano i morti.
Cento milioni di morti!
Baam! Una cannonata. Un botto che doveva scuotere le coscienze, liberarle da un potentissimo
maleficio che continuava a tenerle prigioniere. «Non è nostra intenzione istituire
in questa sede chissà quale macabra aritmetica comparativa né tenere una contabilità
rigorosa dell’orrore o stabilire una gerarchia della crudeltà», avvertiva la prefazione,
«ma i fatti parlano chiaro e mostrano che i crimini commessi dai regimi comunisti
riguardano circa 100 milioni di persone, contro i circa 25 milioni di vittime del
nazismo. Questa semplice constatazione deve quantomeno indurre a riflettere sulla
somiglianza fra il regime che a partire dal 1945 venne considerato il più criminale
del secolo e un sistema comunista che ha conservato fino al 1991 piena legittimità
internazionale, e che tutt’oggi è al potere in alcuni paesi e continua ad avere sostenitori
in tutto il mondo»1.
Era il novembre 1997. Nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Rivoluzione
d’Ottobre l’editore parigino Laffont pubblicava Il libro nero del comunismo: 841 pagine di massacri, esecuzioni, deportazioni e carestie provocate da politiche
scellerate, dalla Russia all’Afghanistan, passando per la Cina, il Vietnam, la Cambogia,
l’Europa fra le due guerre mondiali e quella divisa della Guerra fredda, i regimi
afrocomunisti degli anni settanta, Angola, Etiopia, Mozambico, giù fino a Cuba e al
Nicaragua. Una carrellata secolare di crimini immensi, abusi sistematici e atrocità
di ogni genere compiute da regimi comunisti o sedicenti tali in quasi ogni angolo
della Terra. A raccontarli e documentarli un collettivo di undici autori, ricercatori
del prestigioso Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese. Alcuni di loro erano
importanti collaboratori di François Furet, il quale avrebbe dovuto impreziosire il
Libro nero con una sua autorevole introduzione, ma la morte improvvisa glielo aveva impedito.
Di aprire e chiudere il volume, dandogli una cornice, s’era incaricato allora il curatore
e coordinatore del progetto, Stéphane Courtois.
Il libro nero del comunismo ebbe un impatto editoriale fenomenale: tradotto in oltre venti lingue, un milione
di copie vendute nel mondo, i numeri di un bestseller. Appena uscito, si scatenò subito
un dibattito internazionale vasto e profondo, molto acceso, perché la fine dell’era
sovietica era ancora vicina e il libro non mancò di essere impugnato nella contesa
fra forze politiche in vari paesi. Le destre esultarono, le sinistre lo contestarono,
ricevendolo come un attacco prevenuto alla loro storia. L’accademia si divise, non
risparmiò critiche severe all’impostazione e alla metodologia dell’opera, ma sottolineando
il valore e lo spessore di alcune sue parti. Nel complesso, il volume aveva il pregio
di tentare una narrazione d’insieme della storia del comunismo, offrendo un panorama
completo del fenomeno in tutta la sua estensione geografica e cronologica, con un
respiro internazionale sicuramente consono alle ambizioni di un’ideologia universalista
che voleva riscattare l’umanità intera dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Tuttavia,
l’appiattimento sulla dimensione criminale trasformava il libro in una specie di tribunale
pubblicistico, un lungo e corposo atto d’incriminazione per un’immaginaria Norimberga
post festum del comunismo.
Lo sforzo di invocare una concentrazione internazionale su fatti estremamente significativi
della storia umana del Novecento, anche tematizzando l’esistenza di un problematico
squilibrio nella percezione pubblica dei crimini commessi da regimi comunisti rispetto
a quelli del nazismo, era di per sé apprezzabile, ma perdeva gran parte della sua
incisività per la manifesta intenzione di Courtois di vedere sancita una perfetta
equivalenza criminale di nazismo e comunismo, affiancando al «genocidio di razza»
del primo il «genocidio di classe» del secondo: «la morte per stenti del bambino di
un kulak ucraino deliberatamente ridotto alla fame dal regime stalinista “vale” la
morte per stenti di un bambino ebreo del ghetto di Varsavia ridotto alla fame dal
regime nazista»2. Insomma, il comunismo ridotto a una forma di nazismo rosso, al quale sarebbe spettata
anche la paternità di metodi repressivi e di sterminio che «non soltanto ricordano
quelli nazisti, ma molto spesso ne sono il precorrimento»3. Courtois riproponeva insomma l’idea del “nesso causale” fra comunismo sovietico
e nazionalsocialismo tedesco, già stata respinta dieci anni prima dagli storici coinvolti
nella famosa Historikerstreit (“disputa degli storici”), scatenata dalle provocazioni di Ernst Nolte, secondo il
quale: «Se nella testa di Adolf Hitler non si fosse formata l’idea che gli ebrei erano
responsabili dei gulag e del cosiddetto Terrore rossodel 1919 e 1920, non ci sarebbe potuta essere Auschwitz»4.
Una causalità di questo genere, forse è superfluo ricordarlo, non ha alcun fondamento
storico. Non l’aveva allora, nel 1997, e non ce l’ha oggi, allo stato delle conoscenze
più approfondite e precise che abbiamo. Al di là di certe affinità elettive sul piano
culturale, politico e strutturale fra bolscevichi e nazionalsocialisti o fra i regimi
di Stalin e Hitler (parallelismi che meritano di essere sottoposti a un’attenta analisi,
ma solo dopo aver chiarito esattamente cosa paragonare, come farlo e soprattutto a
che fine operare il raffronto, evitando sciocche equiparazioni), la formula “genocidio
di classe” adoperata da Courtois, al sol scopo di equipararlo alla Shoah, rappresentava
una più che discutibile forzatura di un concetto, quello di genocidio, la cui applicabilità
ai crimini staliniani continua ancora oggi ad essere molto controversa. Problematico
era anche l’uso disinvolto che lo storico francese faceva dei concetti di “classe”
e di “razza”, come se non si trattasse di categorie estremamente imprecise e arbitrarie
perché politiche, rispondenti a criteri adottati dai regimi per operare i loro interventi
epurativi5.
A infiammare il confronto scaturito dalla pubblicazione del Libro nero non fu però solo l’infelice approccio equiparativo adottato da Courtois, peraltro
apertamente contestato persino dagli stessi autori del collettivo6. Quel numero – cento milioni – appariva più funzionale a una strategia sensazionalistica
che il risultato di un serio e ponderato tentativo di quantificazione scientifica.
Lo stesso Courtois, argomentando, menzionava talvolta la cifra di 80 milioni, talaltra
85, altrove ancora 100, come se, dato l’ordine di grandezza, la differenza di 15-20
milioni di morti si potesse semplicemente arrotondare! Courtois, sbagliando, giudicò
superfluo informare i lettori che si trattava di una sommatoria di stime da decenni
oggetto di controversia nella comunità scientifica per almeno due ragioni: la limitata
disponibilità di documenti ufficiali e dati demografici affidabili e il disaccordo
sui criteri in base ai quali stabilire quali vittime di quali atti criminosi contare,
sommare, eventualmente confrontare. Ma non era questo il problema più serio. La cifra
tonda serviva a impressionare e, direttamente contrapposta ai “soli” 25 milioni di
morti causati dal nazismo, a dimostrare che il comunismo fu infine peggiore del nazismo,
perché uccise quattro volte tanto. In altre parole, Courtois andava oltre l’equiparazione
di nazismo e comunismo, affermando la maggiore letalità di quest’ultimo in virtù di
un unico criterio: la conta dei cadaveri.
Sia chiaro: non era in dubbio la verità dei fatti riportati nel Libro nero, sostanzialmente coerenti con le ricostruzioni di altri studi e pubblicazioni, precedenti
e seguenti, e corredato di abbondanti riferimenti bibliografici e archivistici, in
larga parte nemmeno inediti. Oltremodo critica, per non dire irricevibile, era l’enfasi
sul resoconto dei crimini in termini numerici, puramente quantitativi. Il mero numero,
a prescindere da come ci si arriva, è sul piano etico un criterio abbastanza equivoco,
a meno che non si sia disposti a giudicare migliore, meno brutale o addirittura più
umano un regime che ammazza 25 milioni di persone rispetto a un altro che ne ammazza
50 o 100. In termini di qualità, invece, vale a dire sul piano dello sforzo conoscitivo
delle caratteristiche specifiche dell’esperienza storica del comunismo, la storiografia
con la calcolatrice di Courtois ha fatto parecchi danni.
Innanzitutto, non ha risvegliato, come si proponeva, le coscienze sorde ai crimini
del comunismo, generando piuttosto nuova insensibilità. Il Libro nero ha fornito munizioni (cento milioni di morti!) alla più squalificata propaganda dei
detrattori del comunismo ma anche, sul versante opposto, un’opportunità a chi non
vuole prendere atto della storia di rifugiarsi comodamente in una povera polemica
sulla serietà scientifica e l’imparzialità dell’opera. Inoltre, la focalizzazione
quasi esclusiva sui morti ha oscurato l’evoluzione del sistema sovietico e dei regimi
realsocialisti europei dopo la morte di Stalin, mancando di cogliere le caratteristiche
particolari e i problemi del post-stalinismo, che riguardano per esempio il raffinamento
e lo sviluppo di nuove metodologie repressive, e ignorando danni ingenti di altra
natura, che pure meritano di essere conosciuti e ricordati, le devastazioni sul piano
umano, morale, economico, ecologico, che costituiscono oggi la pesante ipoteca del
comunismo in Europa orientale e in tutta l’area post-sovietica.
Su questo, mi concedo una piccola digressione. È notizia molto recente l’approvazione
da parte del governo federale tedesco di un provvedimento che dispone il versamento
di un assegno di risarcimento ai cittadini dell’ex Germania orientale vittime delle
cosiddette “misure di disintegrazione” (Zersetzungsmaßnahmen), una sottile e terribile tecnica di guerra psicologica adoperata dalla Stasi per
intimidire o destabilizzare psicologicamente dissidenti e altre persone giudicate
di attitudini ostili al regime7. Ne gioveranno alcune migliaia di persone, fra queste per esempio Rita8, che da giovane madre aveva preso a frequentare un gruppo antimilitarista. Per indurla
a tenersi lontana da quegli ambienti, la Stasi fece tutto il possibile per distruggere
la sua reputazione, mettendo in circolazione voci che si prostituisse, e quando si
resero conto che non bastava, fecero in modo che i suoi bambini non venissero più
invitati alle feste di compleanno dei compagni di scuola e non fossero ammessi alle
gite scolastiche. La progressiva emarginazione in classe doveva servire a generare
frustrazione nella famiglia e a minare il rapporto di fiducia che legava i figli alla
madre. La polizia segreta devastò silenziosamente la sua vita per anni, come fece
anche con Nadia9, rea di essersi innamorata di un tedesco-occidentale durante una vacanza in Bulgaria.
Per costringerla a interrompere la relazione e a ritirare la domanda di espatrio arrivarono
a toglierle il figlio. Per lei l’assegno è arrivato troppo tardi. È morta in totale
solitudine qualche anno fa in una clinica psichiatrica, dov’era ricoverata da tempo
per i gravi disturbi depressivi causati dalla lunga persecuzione.
Anche se la cifra del risarcimento è simbolica, priva di qualsiasi relazione con l’immenso
danno personale arrecato, si tratta del primo riconoscimento ufficiale delle istituzioni
di questa particolare forma di violenza invisibile, di “terrore discreto”, che non
era sconosciuto anche agli altri paesi comunisti dell’Europa orientale, ma che nel
caso della Germania orientale è stato applicato con un’intensità e un grado di sofisticazione
e metodicità scientifica nettamente superiori. Le vittime del terrorismo psicologico
della Stasi vanno a sommarsi alle altre categorie che ricevono risarcimenti, per esempio
ai condannati per reati “politici”, a chi fu allontanato per motivi di non conformità
ideologica dalla scuola e dalle università o non poté esercitare il proprio mestiere,
a chi fu strappato ai genitori, giudicati indegni di educare i figli all’etica socialista,
e rinchiuso negli istituti di rieducazione per minori, e, naturalmente, alle numerose
persone di altri Stati comunisti che ancora oggi patiscono le conseguenze di lungo
periodo delle più diverse misure persecutorie e discriminatorie subite. I documenti,
conservati negli archivi della Stasi, relativi ai “piani di disintegrazione” ovvero
allo sviluppo e all’esecuzione degli interventi destabilizzanti sulla base dei principi
della psicologia operativa, attestano la medesima miscela di inesorabile spietatezza
e freddo disprezzo nei confronti della persona stigmatizzata come nemica che caratterizzava
la violenza sterminatrice dei crimini di massa. Nell’era post-stalinista, la forma
della violenza era mutata, si era smesso di assassinare selvaggiamente i “nemici del
popolo”, ma la disposizione ad annientare le anime giudicate scomode e indesiderate
era rimasta inalterata.
Tornando al Libro nero, nessuno dei suoi autori ha mai spiegato che senso avesse fare un conto unico, sommare
le vittime del Terrore rosso bolscevico del 1918-20 a quelle della Rivoluzione culturale
cinese, che avvenne mezzo secolo più avanti, o a quelle delle repressioni anti-islamiche
del regime comunista afghano alla fine degli anni settanta. 40, 80, 100 o 140 milioni
di morti fanno una contabilità sconvolgente, spaventosa, ma sono anche numeri che
non dicono nulla. Perché non ci aiutano a capire, a conoscere meglio le ragioni e
i motivi delle violenze che li causarono, il loro significato e il funzionamento dei
sistemi di potere cui imputarne la responsabilità. Per quanto mi riguarda, anche il
criterio della stretta definizione giuridica, ossia la qualifica dei crimini comunisti
secondo il diritto internazionale (crimini contro la pace, contro l’umanità, genocidio)
o ricorrendo a concetti nuovi elaborati in sede di riflessione filosofica e scientifica
(democidio, politicidio, classicidio), non risulta dei più utili sul piano dell’indagine
qualitativa del repertorio di violenze cui ricorsero i governi comunisti dai bolscevichi
in avanti. D’altronde, crimini di massa perpetrati dallo Stato contro civili non sono
peculiari dei regimi comunisti novecenteschi e costituiscono solo un aspetto dei sistemi
repressivi che instaurarono. Peculiare è semmai la loro relazione con l’ideologia
che ispirò gli atti criminosi o con la quale certi regimi ne giustificarono il compimento:
«Tutta questa discussione», commentava nel 1998 Rossana Rossanda a margine della querelle
aperta dal Libro nero all’interno della sinistra italiana, «sarebbe assai utile se da una parte si smettesse
di appiattire il movimento comunista sui socialismi reali, e questi sulla repressione
pura e semplice, ma dall’altra, la nostra, si ammettesse che non è possibile una separazione
drastica. In altri termini, alla domanda: ma siete certi che da quell’idea non derivi
necessariamente un totalitarismo, risponderei sicuramente di no. Ma alla luce della
storia non posso dichiararla irricevibile»10.
Un altro serio problema che poneva il Libro nero e che in fondo continua a porsi ogni volta che, con ordinaria approssimazione, parliamo
di crimini comunisti o del comunismo, è che questa dicitura presuppone – anzi la dà
per scontata – l’esistenza di un unico soggetto criminale, il comunismo, che si vorrebbe
vedere condannato senza appello dalla Corte suprema della Storia, magari insieme all’idea
stessa di rivoluzione sociale. Ora, questo soggetto viene postulato prescindendo dalle
differenze spaziali e temporali, le quali, è evidente, sono state tutt’altro che trascurabili:
il movimento comunista, a dispetto dei connotati di un movimento internazionale tendente
all’unità, non è stato né monolitico né unitario e nelle sue singole espressioni storico-politiche
sono confluite tensioni e tradizioni culturali molto diverse. Ha un senso, allora,
parlare di crimini del comunismo, come parliamo dei crimini del nazismo o del fascismo?
Cosa vuol dire crimini del comunismo? Di quale comunismo? Quello di Berlinguer o quello di Ceauescu? Le sanguinose tirannidi di Stalin e Mao erano della stessa qualità di quelle
di Honecker, Gomuka e Fidel Castro? E Togliatti o Thorez la pensavano allo stesso
modo, quanto a violenza e repressione, di un Todor �ivkov o un Kim Il-sung? Siamo
seri. Evidentemente no.
Cosa è stato questo comunismo se si è manifestato in forme così diverse? Individuare,
come fece Courtois, nel carattere messianico del Progetto rivoluzionario marxista
una sorta di “codice genetico” comune a tutte le variazioni e metamorfosi del comunismo
nello spazio e nel tempo, non basta a spiegare perché le stesse idee produssero effetti
così diversi e divergenti in contesti, epoche e sistemi culturali differenti. La difficoltà
a definire che cosa tenga insieme gli anziani e grigi signori che governavano al Cremlino
negli anni settanta, i militanti dei movimenti studenteschi del Sessantotto a Parigi
o Francoforte e i khmer rossi che sterminarono oltre un milione di cambogiani, rende
piuttosto complicato scrivere una storia complessiva del comunismo che abbracci le
diverse esperienze, trattando il tutto come un fenomeno unitario nella sua multiformità.
Negli ultimi trent’anni ci hanno provato in tanti, partendo chi da Lenin (Silvio Pons
e Stephen A. Smith), chi da Marx (Furet), chi invece dalla Rivoluzione francese (David
Priestland)11. Gerd Koenen, nel suo monumentale Die Farbe Rot [Il colore rosso], comincia addirittura dal neolitico, per dimostrare che lo sviluppo
di utopie comunistiche, egalitarie e palingenetiche ha radici molto profonde nella
storia dell’umanità12.
Considerate le linee di sviluppo così diverse, il quadro di grande disomogeneità che
si presenta, possiamo parlare di comunismo al singolare? Non dovremmo quantomeno declinarlo
sempre al plurale? O comunque riferirci alle singole esperienze, parlando di stalinismo,
maoismo, socialismo reale, come fossero fenomeni separati e per sé stanti? E dove
collocare le correnti comuniste in opposizione alla dottrina marxista-leninista, il
comunismo di sinistra (bordighismo, luxemburghismo, consiliarismo, trozkismo), il
marxismo libertario e l’anarco-comunismo?
Al netto di tutti i distinguo e le precisazioni che si possono e si devono fare, vi
sono buone ragioni sul piano storico, come suggerisce Koenen, per parlare di comunismo
al singolare.
L’idea del comunismo non nacque con la rivoluzione bolscevica del 1917 e nemmeno con
la pubblicazione del Manifesto del Partito comunista nel 1848, ma fu solo nella seconda metà dell’Ottocento che le correnti della riflessione
utopistica di una società umana redenta dall’ingiustizia e dalla diseguaglianza di
classe confluirono in un sistema dottrinario armato della pretesa di essere scientificamente
fondato. Successivamente, a cavallo fra Ottocento e Novecento, maturò nello sviluppo
pluralista delle varie anime del marxismo l’orientamento ad abbandonare la strada
gradualista del riformismo civilizzatore della socialdemocrazia, cioè del maggiore
movimento organizzato dei lavoratori che l’Europa avesse mai conosciuto, la Seconda
Internazionale, per abbracciare una concezione radicale della dittatura di uno Stato
onnipotente quale strumento per imporre con la violenza e la negazione di ogni autonomia
sociale la trasformazione delle strutture della società. È qui che troviamo l’origine
della parabola secolare del comunismo marxista novecentesco, un movimento politico
globale, nella quale non si esauriscono tutte le moderne correnti politiche e di pensiero
di una nuova società anticapitalista, sebbene fra i filoni culturali che l’alimentarono
il sistema ideologico del marxismo-leninismo fu senz’altro quello che infuse le energie
essenziali.
È la storia, come la descrive Agosti, di «un movimento collettivo che ha inciso in
profondità nella storia delle relazioni internazionali e in quella dei singoli paesi,
intrecciandosi in vari modi alla specificità della loro tradizione nazionale e della
loro conformazione sociale; che ha plasmato in forma diretta o indiretta l’organizzazione
economica, i sistemi politici, le coordinate culturali del mondo contemporaneo»13. Con i bolscevichi al potere in Russia, l’idea e il programma del comunismo trovarono
una prima incarnazione storica nell’Urss quale modello di riferimento per i partiti
comunisti di tutto il mondo, sino al suo disfacimento all’inizio degli anni novanta.
Nella primavera del 1918, Lenin fece assumere al suo partito la qualifica di “comunista”
per rimarcare la netta separazione dal resto del movimento socialista europeo. Un
anno dopo si costituì a Mosca l’Internazionale comunista, attraverso la quale il modello
leninista del “partito di tipo nuovo”, un’organizzazione di “rivoluzionari di professione”
disciplinata secondo il principio del centralismo democratico, venne imposto come
matrice alle compagini politiche nazionali che andavano formandosi nei diversi paesi
e associandosi in posizione subordinata alla centrale sovietica14. La storia del comunismo è legata a questa precisa concatenazione di passaggi storici:
senza i bolscevichi al potere e il mito dell’Urss “patria e paradiso di tutti i lavoratori”
non ci sarebbe stato il Comintern a dettare la linea alle sezioni nazionali, ma verosimilmente
solo una molteplicità di partiti e gruppi radicalsocialisti di varia osservanza. E
senza Internazionale comunista a guida sovietica è difficile immaginare che si sarebbe
giunti, nel corso del Novecento, all’instaurazione di altri regimi comunisti nel mondo,
i cui massimi dirigenti, da Ho Chi Minh a Tito e Ulbricht, passarono più o meno tutti
dalla scuola del Comintern15.
Sorvolando la storia del Novecento, si riconoscono tre fasi di espansione del comunismo
nel mondo: all’Ottobre 1917 seguì il sorgere di partiti comunisti in molti paesi europei,
in Asia e America Latina; dopo il 1945 partiti comunisti presero il potere, con la
propria forza oppure installati manu militari da Mosca, in Jugoslavia, Albania, Vietnam, Cina, Corea del Nord e nei paesi dell’Europa
centro-orientale; negli anni sessanta e settanta, entro il processo di decolonizzazione
di quello che all’epoca si chiamava il “Terzo mondo”, si costituirono in vari paesi
africani, del Sudest asiatico e del Centroamerica cosiddette repubbliche popolari
orientate al modello sovietico di organizzazione politico-istituzionale e di sviluppo
industriale. Questa sequenza forma l’ossatura della storia del comunismo novecentesco,
un asse lungo il quale troviamo agganciate anche altre storie ed esperienze come l’azione
dei comunisti nella resistenza antifascista in vari paesi europei, le guerriglie nell’America
Latina degli anni sessanta e il progetto della Rivoluzione tricontinentale di Castro
e Guevara, i movimenti del Sessantotto16.
Anche il comunismo di partiti e movimenti dell’Europa occidentale rappresenta un capitolo
molto importante, trattandosi di formazioni politiche che non arrivarono a prendere
il potere nel senso leninista dell’espressione, ma che in alcuni paesi come l’Italia
parteciparono alla gestione politica e incisero profondamente nella vita sociale e
culturale. Il legame con Mosca, a prescindere dagli aiuti finanziari elargiti, aumentava
il peso specifico di quelle formazioni, talvolta anche oltre il loro reale prestigio
e seguito17.
Aperto e chiuso da eventi storici senza precedenti, a un capo la nascita dello Stato
sovietico, all’altro il suo dissolvimento circa settanta anni dopo, il “secolo breve”
del comunismo ci appare come un segmento ben definito della storia del Novecento.
Lo snodo principale, al termine della Seconda guerra mondiale, fu l’aggregazione attorno
all’Urss di un blocco di Stati contrapposto all’Occidente capitalista e liberaldemocratico,
un “mondo comunista” che già nel 1949, con la costituzione della Ddr e la proclamazione
della Repubblica popolare cinese, si estendeva dall’Elba al Fiume Azzurro. Nel 1980
questa aggregazione raggiunse il suo punto di massima estensione geografica con ventidue
cosiddette democrazie popolari, dallo Yemen a Cuba all’Angola. In quasi ogni paese
del mondo ci sono stati partiti comunisti attivi nell’alveo di più larghi movimenti
sociali o di liberazione nazionale.
A prescindere da scismi, scomuniche e “vie nazionali”, il movimento comunista internazionale
creato a Mosca nel 1919, nonostante il carattere sempre più differenziato e meno unitario
che assunse negli anni, è stato senza dubbio la più vasta formazione politica del
XX secolo, un fenomeno che ha riguardato la vita di milioni e milioni di persone,
e se anche l’immagine di un blocco eurasiatico comunista o almeno di un compatto movimento
mondiale si rivela ingannevole, il suo afflato internazionalista e la tensione verso
una rivoluzione mondiale non hanno precedenti nella storia.
Stati comunisti nel 1983
Venendo ora ai crimini, anche l’uso di questo termine merita qualche osservazione. Cosa intendiamo, quando
parliamo di crimini, è abbastanza chiaro: crimini di massa, stragi, massacri, stermini
e altri atti violenti rubricabili sotto la categoria dei crimini contro l’umanità.
Quest’ultimo è un concetto che ha una storia lunga, fu evocato per la prima volta
...