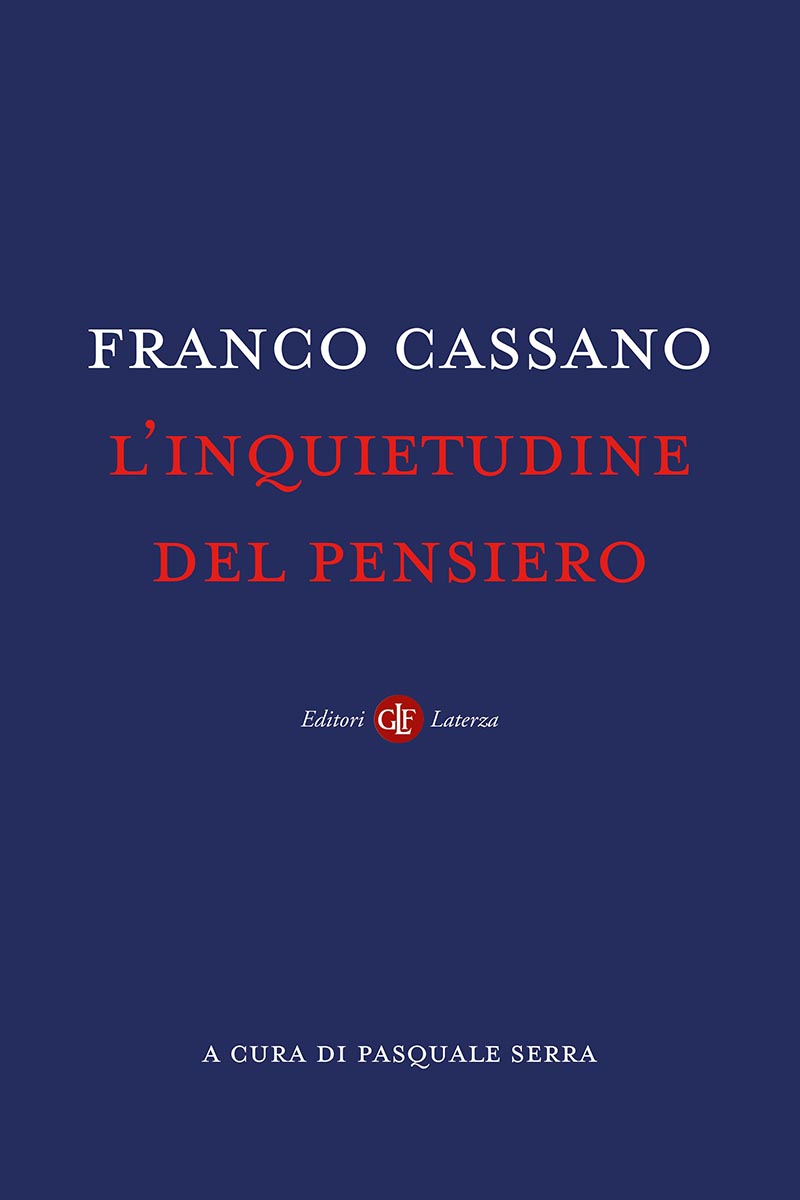Il pensiero lungo di Franco Cassano
Questo libro è un grande regalo. È l’ultimo scritto di Franco, Franco Cassano, scomparso
nel febbraio 2021, che Luciana De Fazio, sua moglie e compagna di vita, ci ha generosamente
offerto per la pubblicazione ben sapendo quanto ciò sarebbe stato accolto con entusiasmo
in casa editrice. Perché con Franco oltre a un intenso e rilevante rapporto professionale
c’era anche una relazione affettiva e intellettuale: che prevedeva sia le sue chiassose
irruzioni nella redazione di Bari o le cene in cui si dichiarava eternamente a dieta
e cercava invano di evitare gli schizzi di salsa sulla sua maglia; sia un intenso
scambio di idee e riflessioni sul suo lavoro, sugli scenari politici e sociali, sul
nodo di pensieri che stava affrontando. Con una sensibilità e una capacità di ascolto
che erano parte del suo carattere e, insieme, del suo stile di ricerca.
Questo libro non è un “testamento spirituale”, né una “ultima lezione”. È molto di
più: è il desiderio di Cassano, che sente vicina la fine, di esprimere un’interpretazione
“autentica” del proprio percorso, mantenendo vivo il senso di quanto sia impossibile
l’autocertificazione della storia intellettuale di un autore e di quanto sia ovvio
che i suoi lettori lo interpretino e lo fraintendano. Con una consapevolezza nuova,
alle soglie del buio, della auspicabilità di questo fraintendimento che tradisce una
verità comunque fragile e contraddittoria, ma ne sottrae i tratti all’oblio:
L’interpretazione, quando è seria e impegnata, è un modo di rivivere quello che l’altro
ha detto, una “fedeltà infedele” che permette agli uomini di comunicare pur rimanendo
diversi.
L’incontro di Cassano con la casa editrice, al di là dei mille pregressi punti di
contatto con la redazione barese di Vito Laterza, ha una data e perfino un’ora precisa:
avviene nella nostra Libreria il 7 dicembre 1993, alle 18.30. Occasione: la presentazione,
con Arcangelo Leone de Castris e Giuseppe Cotturri, del suo libro Partita doppia. Appunti per una felicità terrestre, edito quell’anno dal Mulino. Forse più che una presentazione fu un pacifico agguato.
In particolare mia madre Giovanna, allora alla guida della Libreria, colpita dallo
straordinario successo di pubblico nella presentazione di Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro (il Mulino, 1989), mi aveva ripetutamente invitato ad avvicinare questo autore cinquantenne,
brillante, fuori dai ranghi e dalle convenzioni, che sembrava poter dire e dare molto
in quello che era un tempo complicato. Per l’epocale caduta del Muro di Berlino nel
1989 e per la dissoluzione dell’URSS nel 1991 che a molti sembrava promettere una
prospettiva di mondializzazione e progresso felice ma di fatto aveva rotto un equilibrio,
politico ed economico, in assenza di un’alternativa solida. Ma anche per i venti di
guerra che per un decennio avrebbero scosso i territori della ex Iugoslavia, riportando
alla luce antichi odi etnici e religiosi, che si sarebbero rivelati assai più che
un residuale retaggio del passato. E poi per quello che era sotto i nostri occhi:
il drammatico approdo della nave Vlora nel porto di Bari con il carico di dolore e speranza di ventimila albanesi nell’agosto
1991; il terribile e inaspettato rogo del Teatro Petruzzelli nell’ottobre dello stesso
anno. E infine per quello che accadde tra il 1992 e il 1993 su scala nazionale ed
europea: l’esplosione di Tangentopoli al Pio Albergo Trivulzio di Milano; la soppressione
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e la successiva crisi del sistema bancario
meridionale; l’offensiva mafiosa in Sicilia con i mortali attentati a Falcone e Borsellino;
la sottoscrizione del trattato di Maastricht che rilanciava il progetto europeo ma
comportava l’adozione dei famigerati parametri di convergenza per l’accesso alla Unione
economica e monetaria.
Da quell’incontro e in quel contesto è nato, ai primi del 1996, Il pensiero meridiano. Un’opera che ha avuto un successo straordinario ed esercitato una forte influenza,
divenendo l’emblema della voglia di riscatto non solo del Sud d’Italia, ma di tutti
i Sud.
Il padre del pensiero meridiano ha amato e odiato questo figlio.
Lo ha amato perché, tra mille travisamenti, ha acceso un dibattito nel Mezzogiorno
in un clima politico che vedeva incrociarsi i tentativi di costruire una sinistra
dopo lo scioglimento del Partito comunista italiano, la discesa in campo di Silvio
Berlusconi, l’impennata della Lega Nord e della “questione settentrionale”. Ne è stato
fatto – per lo più in buona fede – il manifesto di un rivendicazionismo meridionale,
un appello alla “decrescita felice”, l’onirica immagine di un grande abbraccio dei
popoli del Mediterraneo o della sconfinata bellezza dei Sud: tutte letture distorsive,
espressione, però, del desiderio di rompere la cappa di silenzio che sul Mezzogiorno
e sui (e tra i) meridionali era calata. In realtà, il nucleo forte dell’opera era
nell’invito a ripensare un autonomo progetto di sviluppo per i Sud senza piegarsi
al solo confronto con il modello dei Nord.
Il primo passaggio essenziale del libro – scrive Cassano nella prefazione alla edizione
2005 – sta nella netta e radicale rivendicazione di autonomia del Sud. Come recitava
la quarta di copertina della prima edizione, il cuore del progetto è quello di “restituire
al Sud l’antica dignità di soggetto del pensiero, interrompere una lunga sequenza
in cui esso è stato pensato solo da altri”. Il Sud non è un non-ancora, non esiste
solo nella prospettiva di diventare altro, di fuggire inorridito da sé per imitare
il Nord venti o cento anni dopo, e quindi probabilmente mai. Il primo passo dell’autonomia
sta proprio qui, nella comprensione che il futuro può non essere un inseguimento eternamente
incompiuto ed eternamente fallimentare.
Era anche una visione ottimistica del mondo dopo la fine del bipolarismo: un mondo
in cui sembrava che le istituzioni sovrannazionali – e non solo il capitalismo senza
patria della globalizzazione – potessero prendere slancio e in cui pareva possibile
aprire un dialogo di pace e comune progresso tra le sponde del Mediterraneo. Un tentativo
di aprire una linea di ricerca – come ha scritto Franco Chiarello su “La critica sociologica”
– per “modernizzare la modernità”.
Lo ha odiato perché gli è rimasto abbarbicato addosso anche quando la sua riflessione
era andata avanti e oltre e, pur restando vitale il messaggio di fondo, troppe cose
erano cambiate per ripeterlo ritualmente e senza distinzioni. Sì, perché Cassano aveva
ben chiaro che il trauma delle Torri Gemelle, dell’11 settembre 2001, aveva avviato
una spirale ritorsiva di cui era – e resta difficile ancora oggi – vedere gli esiti;
che la crisi finanziaria esplosa nel 2007 aveva mostrato il volto cattivo della globalizzazione
come motore di disuguaglianze, impoverimento e paura anche nei paesi ricchi; che la
deludente esperienza delle “primavere arabe” aveva mostrato i limiti dell’idea di
una meccanica esportazione della democrazia senza contraccolpi e contraddizioni. Tutti
temi, questi, che – insieme alla riflessione sullo scenario politico italiano – hanno
ispirato altri due libri Laterza: L’umiltà del male (2011) e Senza il vento della storia. La sinistra nell’era del cambiamento (2014), nei quali si è interrogato sui fenomeni dei populismi insorgenti, sui nuovi
rancori razziali e territoriali, sulla disarticolazione del mondo del lavoro, sul
declino della classe operaia come soggetto politico, sulla crisi della prospettiva
internazionalista delle sinistre europee. Questioni che ricorrono anche nelle pagine
della Contraddizione dentro.
Dall’intreccio di riflessioni che sono alla base del Pensiero meridiano è nato anche dell’altro. Negli anni immediatamente successivi si è coagulato, intorno
a Cassano, un informale pensatoio barese del quale, oltre me, hanno fatto parte molte
persone. Franco aveva alle spalle una lunga esperienza di militanza politica nel Partito
comunista italiano e nutriva il desiderio profondo di cercare strade nuove per superare
l’asfitticità del dibattito pubblico e il silenzio dei partiti ridotti a macchine
di riproduzione del consenso, senza visione e senza partecipazione. Io e alcuni altri
assidui frequentatori di quegli incontri informali in casa editrice, tra i primi Oscar
Iarussi e Gianfranco Viesti, sentivamo forte una differenza – una delle contraddizioni
descritte in questo libro: non avevamo trascorsi di partito e soprattutto, per ragioni
anagrafiche, non avevamo vissuto le illusioni e le delusioni del Sessantotto. Ma condividevamo
l’esigenza di ridare voce al Sud e di riattivare il circuito del confronto politico.
Con noi molti altri e altre. Il frutto di questo percorso è stato, alla fine del 2000,
l’associazione Città plurale, nella quale il terreno di elezione prescelto fu quello
della cittadinanza attiva nella nostra città, Bari. Così la descrive lo stesso Cassano
nel manifesto fondativo:
Un’associazione che si propone di ricostruire uno spazio pubblico nella città non
mira a diventare un partito o a sostituirsi ai partiti, ma pretende di farli uscire
da uno stato comatoso, di costringerli a misurarsi sulle grandi questioni, di modificare
i criteri di reclutamento e selezione della classe dirigente: non più il censo o la
fedeltà al capo o all’apparato, ma la discussione civica, la capacità di formulare
risposte trasparenti ed efficaci ai problemi. Solo dei partiti aperti, e non arroccati
attorno a piccole oligarchie, potranno dare un impulso decisivo alla vita democratica
della città.
Un progetto ambizioso, che assunse alcune battaglie (come quella sull’ecomostro di
Punta Perotti) e divenne uno degli emblemi della cosiddetta “primavera pugliese” che,
tra il 2004 e il 2005, vide l’ascesa della sinistra alla guida del Comune di Bari
e della Regione Puglia. Un progetto in vista del quale le Edizioni della Libreria
Laterza lanciarono la collana “Tracce”, prevalentemente dedicata a temi di cultura,
economia, attualità di Bari, e inaugurata da Mal di Levante di Cassano. È discusso, e probabilmente discutibile, che Città plurale sia stata
la causa prima della “primavera pugliese”, ma non c’è dubbio che essa sia stata un
sintomo rilevante di un moto che ha poi prodotto il cambiamento e dato il via a una
nuova narrazione della Puglia e del Sud. Né a Città plurale può essere addebitata
la parabola della “primavera pugliese”, che pure ha coinciso con una singolare rinascita
culturale nel cinema, nella musica, nella letteratura. I cicli e i processi politici
non hanno un andamento lineare. E, checché se ne dica, non risponde esattamente al
vero il paradossale motto andreottiano per cui “il potere logora chi non ce l’ha”.
Anche Città plurale, esaurito il suo compito, è andata in dissolvenza e Franco Cassano,
giunto al pensionamento accademico, accettò l’invito del Partito democratico a candidarsi
alla Camera in occasione delle elezioni politiche del 2013. Siederà a Montecitorio
fino alla primavera del 2018. Non so se feci bene a incoraggiarne l’adesione alla
richiesta del Pd. Nessuno poteva prevedere le vicissitudini della segreteria del partito
e della guida del governo che avrebbero visto protagonista la parabola di Matteo Renzi.
E soprattutto era difficile indovinare che, inquadrato nella schiera dei parlamentari
Pd, Franco non sarebbe stato necessariamente valorizzato pur occupandosi di materie
a lui congeniali (Ambiente, Affari esteri, Diritti umani). Soprattutto gli è pesato
il carico di aspettative che era maturato in ragione del suo mandato parlamentare
e il sospetto da parte di alcuni che lui avesse ceduto alle lusinghe del renzismo
più spavaldo e manovriero. Ricordo con amarezza l’atteggiamento vagamente ostile e
distante del pubblico che affollò la Libreria Laterza in occasione della presentazione
di Senza il vento della storia.
La sinistra – scrive Cassano nel libro – deve prendere atto della limitatezza del
proprio insediamento sociale nei paesi sviluppati, dove cresce non solo l’area delle
figure sociali escluse dalle garanzie conquistate nei “trenta gloriosi”, ma anche
la pressione che su quelle conquiste viene esercitata dall’ingresso nel regno d
...