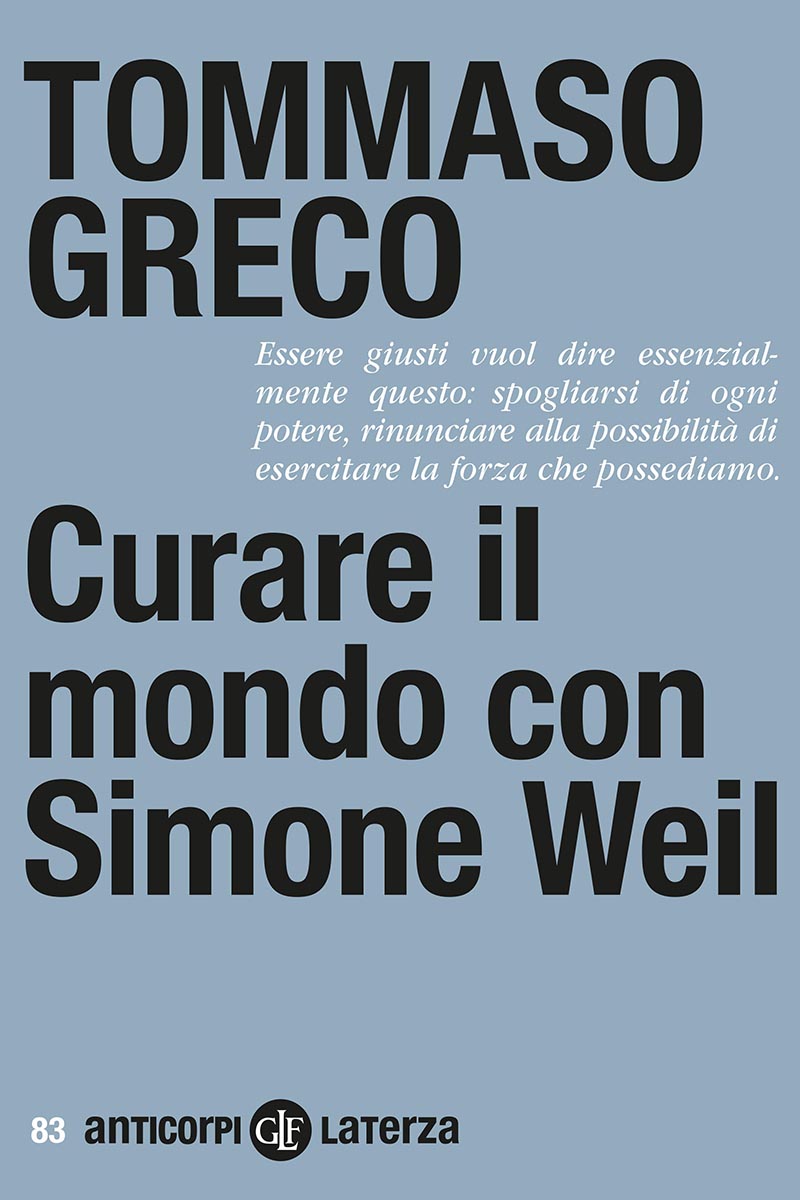Alla memoria di mia madre Nina, incarnazione dell’‘infinitamente piccolo’, tessitrice,
donna giusta
Il solo fatto che esistiamo, che concepiamo e vogliamo una cosa diversa da ciò che
esiste, è per noi motivo di speranza.
Perspectives (1933)
Nessuno sforzo di autentica attenzione va mai perduto, anche quando non porti mai
direttamente o indirettamente qualche risultato visibile.
Lettera a Joë Bousquet (1942)
Introduzione.
La giustizia di tutti
1. Siamo convinti che la giustizia riguardi principalmente, se non esclusivamente,
il nostro rapporto con le istituzioni, con la politica, con le leggi, dimenticando
che la gran parte di quel che avviene di ‘giusto’ o ‘ingiusto’ nelle nostre vite ha
a che fare innanzi tutto con le scelte, le azioni, i comportamenti che mettiamo in
atto nelle nostre relazioni quotidiane, talvolta in esecuzione ma spesso anche indipendentemente
dalle leggi e dall’ordinamento giuridico.
La giustizia non è soltanto ‘battere un pugno sul tavolo’ per ottenere dalle istituzioni
qualcosa che pretendiamo di avere nella convinzione che ne abbiamo il diritto, ma
è fare in modo che a ciascuno venga riconosciuto ciò che gli spetta nelle situazioni
più normali e più diverse: in famiglia, a scuola, sul lavoro, nelle relazioni stabili
e occasionali di cui è fatta la vita di ognuno. Ecco perché essa ha a che fare prima
di tutto con noi stessi e mette in gioco il nostro atteggiamento nei confronti del
mondo e di chi lo abita. Possiamo mettere davanti il nostro io, e pensare che ciò
che ci circonda debba esistere in funzione del nostro esclusivo benessere; oppure
possiamo mettere il nostro io a servizio del mondo, affinché questo possa migliorare
e prosperare. La giustizia, in altre parole, ci chiama spesso a scegliere se imporci
agli altri oppure lasciare a essi lo spazio per esistere, facendo arretrare la nostra
persona, nella convinzione che soltanto abbandonando la logica che ci porta a sovrastare
chi ci sta di fronte sia possibile una relazione – e di conseguenza, una convivenza
– che possiamo definire come ‘giusta’.
È un’idea antica – spesso ripresa e ripetuta, ma altrettanto spesso lasciata a sonnecchiare
in un angolo buio delle nostre coscienze – quella secondo cui la giustizia della società
dipenda innanzi tutto dalla giustizia degli uomini e delle donne che la abitano. Si
ripropone dunque la vecchia questione analizzata da Platone, il quale iniziava il
suo dialogo sulla Politéia a partire dalla questione su chi sia l’uomo giusto e concludeva che solo una città
formata da uomini giusti può essere a sua volta definita come giusta. Ma quando, davvero,
possiamo dire che un uomo o una donna sono giusti?
2. Quel che vorrei mostrare nelle pagine che seguono è che c’è un’idea della giustizia
che sfida tutte le altre e si colloca là dove queste segnano il passo. Le categorie
del nostro pensiero ci hanno abituato a cercare la giustizia nella ‘conformità alla
legge’ oppure nel ‘trattare gli altri in modo uguale’, ma non sempre legalità e uguaglianza
(formali o sostanziali che siano) producono automaticamente quella giustizia di cui
gli uomini, tutti, hanno sete. Anche tralasciando il campo della giustizia penale,
sottoposto più di altri al rischio di errori drammatici, è nella quotidianità delle
vite ‘normali’ che l’applicazione di una regola, seguendo un meccanismo in base al
quale si finisce per guardare alla regola più che alla vita, produce spesso decisioni
che percepiamo come ingiuste.
La giustizia che vaoltre vuole invece guardare alla vita prima che alla regola; e non in spregio al senso
delle regole, ma perché nella vita c’è spesso qualcosa che alle regole sfugge o di
cui le regole non si occupano. C’è qualcosa che le regole – e la giustizia a esse
legata – non vedono.
Se volessimo disegnare un’immagine diversa della giustizia – diversa, voglio dire,
da quelle alle quali siamo abituati e di cui sono pieni i tribunali e i palazzi del
potere civile – dovremmo rinunciare completamente ai caratteri consueti. Dovremmo
rinunciare innanzi tutto alla benda: quel simbolo cui si legano l’imparzialità e l’incorruttibilità di colui che decide,
rischia di diventare un ostacolo in quanto impedisce di vedere proprio quelle situazioni che richiedono un intervento riparatore e salvifico: per
riparare un’ingiustizia, per farsi carico di una sofferenza, per lenire un dolore.
Abbiamo bisogno di una giustizia che sappia vedere ciò che per sua natura si nasconde,
perché spesso non è possibile che gli ultimi facciano sentire la loro voce mediante
la rivendicazione di diritti: gli ultimi sono quelli di cui le regole non si occupano;
e anzi, talora sono ultimi proprio perché sono le regole a produrne l’esclusione.
Potremmo dire che mentre la giustizia con la benda è tipica di chi muove da una definizione
di ciò che è giusto, che ritiene di per sé valida e applicabile a prescindere dalle
situazioni concrete, la giustizia che rinuncia alla benda appartiene a un ragionamento
differente, che muove dalla consapevolezza che la prima ed essenziale forma della
giustizia è proprio quella di riparare alle ingiustizie.
Una ‘giustizia che guarda’, in secondo luogo, non misura matematicamente e certosinamente
meriti e demeriti: per questo motivo, rifiuta anche la figura della bilancia. Essa interviene per rispondere a un bisogno e non per contraccambiare una prestazione
o per distribuire premi e punizioni. La bilancia presuppone, infatti, che ci sia qualcosa
da pesare e misurare; rinunciare al suo uso significa motivare diversamente l’atto
di giustizia. Non si fa qualcosa in risposta a ciò che l’altro ha omesso o compiuto;
si fa qualcosa per l’altro, per soddisfare la sua domanda di giustizia, investendo fiduciariamente sulla sua
capacità di proiettarsi nel futuro. «Sognando gli altri come ora non sono» perché
«ciascuno cresce solo se sognato», per dirla con un celebre verso di Danilo Dolci.
Naturale appare allora l’abbandono dell’ultimo, e più ingombrante, simbolo della giustizia
tradizionale: quello della spada. Un simbolo che per molti rappresenta il fondamento stesso del patto sociale ancor
prima che della giustizia (si ricordi Hobbes: i patti senza spada «non sono che parole
vuote» e non hanno alcuna possibilità di dare sicurezza agli uomini). L’idea che la spada possa simboleggiare un atto di giustizia viene meno allorché
si pone in primo piano la relazione tra noi e l’altro, che talvolta può essere persino relazione tra chi ha subìto un’ingiustizia e chi
l’ha invece compiuta, tra la vittima e il reo. Si capisce dunque perché, tra tutte,
è questa la sfida che incontra maggiori resistenze. Diffusa è infatti l’opinione espressa
da Spinoza nel Trattato teologico-politico: «L’insegnamento del Cristo e di Geremia circa la sopportazione delle offese e il
perdono incondizionato degli empi vale soltanto per i luoghi nei quali si trascura
la giustizia e per i tempi di oppressione, ma non per uno Stato ben ordinato, dove,
tutelandosi la giustizia, ciascuno è tenuto, se vuole condursi rettamente, a denunziare
al giudice l’offesa patita, non per vendetta, ma nell’intento di difendere la giustizia
e le leggi della patria e per non lasciare ai cattivi la convenienza di essere tali». Come si può, in effetti, affermare il principio che si debba avere attenzione persino
nei confronti di chi ha compiuto il male e si è macchiato di gravi delitti, invocando,
più che la punizione, il perdono? Non ha ragione Javert che nei Miserabili chiama «bontà cattiva» quella che vuole dare ragione «a chi è in basso contro quello
che è in alto» perché «con questa bontà la società si disorganizza»? Se è «molto facile
esser buoni, il difficile è esser giusti».
3. Una giustizia siffatta può assai difficilmente farsi istituzione e non può non
incontrare resistenza «il tentativo di introdurla come regola dell’etica pubblica». Anche se non mancano testimonianze storiche importanti e talora fondative – commissioni
di riconciliazione, percorsi di riparazione sperimentati all’interno dei sistemi penitenziari
–, si tratta certamente di una giustizia che parla a tutti in prima persona, in quanto
è mediante il comportamento quotidiano di ciascuno che essa può sperare di incarnarsi.
Ci parla nelle situazioni concrete nelle quali siamo chiamati, anche inaspettatamente,
ad agire come attori di una relazione nella quale è in gioco la possibilità di produrre
giustizia o ingiustizia. Come ha spiegato, direi ineccepibilmente, Jacques Derrida,
in questa prospettiva l’atto di giustizia si presenta a noi quasi sempre come «ciò
che non può attendere»: la decisione giusta è richiesta «immediatamente, subito, il più presto possibile», dato che le situazioni nelle quali ci troviamo
spesso non ammettono «l’informazione infinita e il sapere senza limiti delle condizioni».
Qualcuno potrebbe pensare allora che un discorso del genere poco abbia a che fare
con la giustizia; che non è col nome di giustizia che si può chiamare un tale approccio
alle cose del mondo. Ma ci viene in soccorso addirittura il massimo giurista e teorico
del diritto del Novecento, Hans Kelsen – proprio colui che aveva nettamente tenuto
distinti diritto e giustizia –, per il quale «il precetto dell’amore del prossimo
nel senso della prescrizione di aiutare chiunque sia soggettivamente in preda al dolore
o alla necessità, con o senza sua colpa», può ben essere considerato come una norma
di giustizia, purché non ci si limiti a legare «il concetto di giustizia alle sole
esigenze avanzate nei riguardi dell’autorità legislativa» e vi si includa invece quella
«norma che prescriva come un uomo deve trattare un altro».
E difatti, non è mancato chi ha identificato puramente e semplicemente la giustizia
con la carità. Per Simone Weil – la filosofa francese morta all’età di 34 anni dopo
una vita di impegno e sacrificio, di cui quest’anno ricorrono gli ottant’anni dalla
morte e al cui pensiero fanno riferimento le pagine contenute in questo volume – non è possibile fare alcuna distinzione tra giustizia e carità, dato che non è
la sfera del diritto, che ella considerava inestricabilmente connessa con la forza,
che può portarci nel mondo della giustizia. Aver voluto distinguere la giustizia dalla
carità, dice Weil, è stato un modo per spogliarsi della responsabilità di prendersi
cura del mondo e degli altri; perché, se nella giustizia ‘giuridica’ ci si sente obbligati
soltanto in presenza dei diritti degli altri, e perciò dove non ci sono diritti non
ci sono obblighi, nella giustizia-carità il nostro obbligo non è determinato dal diritto
bensì dal bisogno dell’altro. È una giustizia che non fa dormire sonni tranquilli,
quella della carità: essa ci interroga incessantemente, perché incessantemente ci
interroga la vita.
4. È umana una giustizia come questa? Sembrerebbe di no. La provocazione con cui Glaucone interroga
Socrate nel II libro della Repubblica di Platone parte proprio dal presupposto che una giustizia ricercata per amore della
sola giustizia, e che perciò eviti di strumentalizzare l’altro riconducendolo ai propri
fini, sia del tutto impossibile per l’uomo. Non si deve voler essere giusti, dice Glaucone, ma soltanto sembrarlo. Altrimenti, bisognerebbe sostenere che la condizione del giusto perfetto, che nonostante
il suo essere giusto consegue il disonore e la morte, è preferibile a quella dell’ingiusto
perfetto, che nonostante il suo essere ingiusto consegue invece onori e ricchezze.
E tuttavia, quella che per Glaucone era una provocazione estrema per mettere alle
corde il suo interlocutore viene presa estremamente sul serio da Simone Weil, che
la assume a modello nelle sue meditazioni sul tema della giustizia. Il ‘giusto perfetto’,
di cui Glaucone diceva che «verrà flagellato, torturato, gettato in ceppi, avrà bruciati
gli occhi, e infine, dopo avere sofferto ogni sorta di mali, verrà impalato», e che
per Platone non era altri che Socrate, per la filosofa francese è incarnato dal Cristo
crocifisso. La sua figura nuda e martoriata ci dice che per essere giusti occorre
spogliarsi di se stessi; addirittura «fino alla morte», quando questo sia necessario.
Spogliarsi di se stessi vuol dire mettere da parte la forza, non inseguire il prestigio,
non cercare la sopraffazione.
Ci sarà sempre bisogno di una giustizia come questa, sembra dirci Simone Weil, perché
la legalità e l’uguaglianza – che pure devono stare a fondamento del consorzio civile
– non potranno mai colmare tutti i bisogni di giustizia che assetano l’animo umano.
Per quanti sforzi si facciano – ed è bene che si facciano – per far sì che la carità
venga sostituita dalla giustizia giuridica (incarnata proprio da ciò che Simone Weil
criticava, e cioè dai diritti: civili, politici e soprattutto sociali), rimane il
fatto che nessun ordinamento statale può mai sostituire l’azione e gli effetti della
cura. Allo stesso modo, non c’è applicazione giusta di leggi giuste (non parliamo di quelle
ingiuste) che possa rendere superfluo lo sguardo dell’attenzione nei confronti di chi si trovi a essere giudicato, o che semplicemente debba subire
una decisione presa da altri.
Non si tratta però di riproporre l’opposizione tra cura e giustizia che ha occupato uno dei luoghi centrali nei dibattiti filosofico-politici degli ultimi
decenni. Occorre piuttosto mostrare che esse si sostengono a vicenda, e che anzi si
compenetrano: perché di fatto, per un’autrice come Simone Weil, la cura costituisce
l’essenza della giustizia, ben oltre ogni separazione, ma anche oltre quelle conciliazioni che mantengono comunque
divisi i rispettivi ambiti d’azione. Questa convinzione è ben espressa da un’immagine
che campeggia nell’aula di giustizia del Tribunale di Milano, raffigurante una madre
con in braccio il proprio bambino e uno sventurato che gli chiede soccorso. L’immagine
è collocata proprio sopra la scritta ‘La legge è uguale per tutti’. Può essere un
modo per dire che la legalità è un valore fondante e fondamentale, ma che non può
arrivare dappertutto, e che quindi l’attenzione e la cura possono arrivare dove essa
ha deciso di arrestarsi, o comunque dove è costretta a farlo per i suoi limiti intrinseci.
Ma può essere anche un modo per dire che nell’applicazione delle leggi e delle regole
si può individuare la via per cercare lo sguardo dell’altro invece di utilizzarle
per schivarlo. In entrambi i casi occorre mettere all’opera quella capacità di attenzione
da cui le regole spesso ci distolgono e su cui invece Simone Weil ha centrato la sua
perorazione in favore della giustizia.
Nel presente lavoro sono ripresi, arricchiti e in gran parte riscritti alcuni contributi
pubblicati precedentemente. I paragrafi centrali dell’introduzione sono ripresi da
La giustizia del crocifisso, pubblicato in «Endoxa/Prospettive sul presente», n. 4 del 2016. Una prima versione
del cap. 1 era stata presentata come relazione al convegno per il centenario della
nascita di Simone Weil organizzato da Emilia Bea Pérez a Valencia (Spagna) nel mese
di ottobre del 2008; il testo fu poi pubblicato nel volume Simone Weil. La conciencia del dolor y de la belleza, edición de E. Bea Pérez, Editorial Trotta, Madrid 2010. Il testo originario del
cap. 2 fu anch’esso presentato in un convegno per il centenario weiliano, organizzato
da Stefania Tarantino a Napoli nel maggio del 2009; fu poi pubblicato in Pensiero e giustizia in Simone Weil, a cura di S. Tarantino, Aracne, Roma 2009. Il cap. 3 è frutto di una relazione presentata
nel 2018 in un convegno organizzato da Rita Fulco presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa e dedicato a Simone Weil: Filosofia e nuove istituzioni per l’Europa; il testo è stato poi pubblicato in L’Europa di Simone Weil. Filosofia e nuove istituzioni, a cura di R. Fulco e T. Greco, Quodlibet, Macerata 2019. La traccia del cap. 4,
infine, è stata presentata nell’ambito del Cenacolo di cittadini ‘La nobiltà d’animo’,
un ciclo di incontri sulla cittadinanza rivolto agli studenti delle scuole superiori
della regione Marche, organizzato da Ebe Francioni a Carpegna nel maggio 2011, ed
è stata poi pubblicata come paper nel Bollettino dell’«Italian Society for Law and
Literature» (2012), curato da Carla Faralli e Maria Paola Mittica. Ringrazio dunque
tutte e tutti coloro che hanno concesso l’autorizzazione a riprendere questi testi
e in particolare le curatrici dei convegni che mi hanno invitato a riflettere insieme
nelle occasioni che ho appena menzionato. Vorrei cogliere questa occasione anche per
esprimere un ringraziamento a Eugenio Ripepe, che ormai molti anni fa mi suggerì di
accostarmi al pensiero di Simone Weil, certo che lo avrei trovato estremamente stimolante.
Come spero testimoni questo lavoro – che ha trovato in Giovanni Carletti della casa
editrice Laterza, che pure vorrei qui ringraziare, il suo lettore ideale –, quello
stimolo non ha più cessato di accompagnarmi.
1.
Forza del diritto, debolezza della giustizia
Che ruolo possono avere il diritto, le regole, le istituzioni nella cura del mondo?
Possono svolgere una funzione benefica in funzione della giustizia o rappresentano
piuttosto un ostacolo che impedisce di raggiungerla? E soprattutto, quale compito
può assumersi ciascuno di noi per far sì che si vada in una direzione o nell’altra?
Se abbiamo prove continue ed evidenti delle varie confliggenti possibilità che si
possono concretizzare nella realtà, anche le risposte che troviamo in Simone Weil
sono nette e allo stesso tempo (apparentemente) contrastanti. Esse hanno a che fare
non solo con l’evoluzione del suo pensiero e con le mutevoli vicende della drammatica
storia del mondo alla quale ha assistito e preso parte nella sua breve esistenza,
ma pure con l’accentuazione di aspetti di volta in volta diversi, sebbene sempre connessi
alla preoccupazione per la condizione degli ultimi, di coloro che si trovano nella
sventura. Non c’è dubbio infatti che «in Simone Weil, nella sua vita e nelle cose
che ha scritto, risplend[a] una straordinaria testimonianza umana dalla quale sgorgano
motivi sconfinati di comprensione e di conoscenza di ogni vita straziata dal dolore». Confrontarsi con quanto la filosofa francese ha scritto sul tema della giustizia
è dunque certamente opportuno, e direi necessario, proprio perché il suo pensiero
appare particolarmente appropriato a fondare una riflessione profonda e allo stesso
tempo densa di indicazioni pratiche, rivolta a coloro che mostrano preoccupazione
per le sorti del mondo e per quanti in esso sono collocati dal destino in fondo alla
scala sociale.
Diciamo subito che abbiamo una sorta di conto in sospeso con Simone Weil: se la sua
acuta capacità di indagine ha ricevuto molta attenzione sul piano teorico e filosofico,
nulla di fatto ella ha provocato sul piano pratico e politico. E tuttavia, proprio
la sostanziale mancanza di ricaduta pubblica delle riflessioni weiliane spinge a riprenderle: a maggior ragione quando questo tentativo dovesse sembrare «un’operazione disperata». Per la sua capacità di offrire uno sguardo inconsueto sulle cose, Simone Weil appartiene
a quella ristretta cerchia di autori e autrici ai quali occorre sempre rivolgersi
quando si sente il bisogno di uscire dai sentieri conosciuti per battere strade sempre
rinnovate. Dobbiamo quindi tornare a una pensatrice che «aveva il dono di pronunciare
parole con significato umano illimitato»: soprattutto quando di strade nuove si sente estremo bisogno.
Il diritto come limite della forza
Lo si vede immediatamente se si rilegge il primo scritto – l’unico, peraltro – che
Simone Weil ha dedicato al diritto proprio all’inizio del suo itinerario intellettuale.
Si tratta di una composizione risalente al 1930, D’une antinomie du droit, nella quale viene discussa l’affermazione spinoziana sulla corrispondenza tra diritto
e potenza. In questo breve scritto, Simone tocca uno dei nodi fondamentali del pensiero
giuridico: cosa rimane del diritto se esso viene confuso con la potenza? Che senso
ha dire che io devo fare qualcosa se questo dovere si basa esclusivamente sul fatto che io posso (ho la potenza di) farlo?
Dire che il diritto si misura con la potenza è esprimere male la negazione pura e
semplice del diritto, perché è come dire che niente di ciò che si fa è contrario al
diritto. Ora, le opposizioni tra il diritto e la forza, tra il diritto e il fatto,
appartengono al linguaggio comune e la parola stessa diritto indica che il diritto
non è di fatto, ma una regola con la quale si può giudicare il fatto.
Weil, in sostanza, si rifiuta di confondere il diritto con la forza, anche se non
può non prendere atto che il diritto si presenta a sua volta come forza (di qui l’antinomia
che è insita nella sua natura). Convergendo inconsapevolmente con una delle principali
teorie giuridiche del Novecento, quella kelseniana, Weil affronta dunque nientemeno
che il punto basilare dell’esperienza giuridica: il diritto appartiene alla sfera
dell’essere o alla sfera del dover essere? Non è qui in gioco una mera questione filosofica, una questione di ‘essenze’. Si
tratta di sapere se il diritto svolge una funzione pratica sulla quale gli uomini
possono contare. Se le cose devono andare come in effetti già vanno; se tutto dipende
dalla forza che ciascuno può esercitare, a cosa serve infatti il diritto? Da questo
punto di vista, se la parola diritto deve avere un significato, non si può non fare
riferimento alla capacità normativa delle regole giuridiche, alla loro capacità di
determinare un obbligo, che permetta di superare i disequilibri generati dai rapporti di forza. Così, ad
esempio, avviene nei rapporti di scambio, nell’ambito dei quali la funzione del diritto
è proprio quella di stabilire una misura che eviti la legge del più forte, o il puro
arbitrio derivante dalla fantasia individuale.
Qui, ovviamente, l’immagine più appropriata del diritto è fornita dalla bilancia.
Là dove le forze sono in equilibrio naturale, il diritto non ha molte ragioni di esistere,
perché nessuno può prevaricare sugli altri; è dove invece questo equilibrio non esiste
che il diritto deve intervenire, esplicando la sua funzione equilibratrice. Ci troviamo
davanti una delle grandi alternative presenti nella storia del pensiero politico e
giuridico. Se siamo convinti, come Hobbes, che l’uguaglianza sia naturale ma che sia
fonte di conflitti distruttivi, invocheremo l’idea di un diritto ‘verticale’, cioè
strettamente legato a un potere capace di imporlo, come soluzione per quel conflitto.
L’ordine e la sicurezza vengono così a sostituire l’uguaglianza come prodotto dell’ordinamento
giuridico. Se pensiamo invece, come Montesquieu, che l’uguaglianza produca non conflitto
ma concordia, potremo invocare il diritto proprio come strumento necessario per portare
l’uguaglianza dove essa non si produca spontaneamente. È questa l’opzione alla quale
aderisce Simone Weil, sulla scia del suo maestro Alain, il quale aveva affermato che
è proprio per far fronte all’ineguaglianza «che il diritto è stato inventato». Che poi era ciò che aveva sottolineato Rousseau per rispondere a coloro che criticano
l’uguaglianza dicendo che il mondo è pieno di disuguaglianze: «È precisamente perché
la forza delle cose tende sempre a distruggere l’uguaglianza, che la forza della legislazione
deve tendere sempre a mantenerla».
Questa idea di equilibrio è particolarmente importante perché appare come il luogo teorico e ideale nel quale
ricercare l’essenza del diritto (prima) e della giustizia (poi). Nei Cahiers è costante il riferimento al diritto e alla legge come strumenti che permettono un
riequilibrio delle forze: è grazie alla legge, infatti, se «i deboli sono più forti
dei forti».
Troviamo espressa, in questo modo, l’idea di un diritto che è limite della forza, un diritto che argina la forza dei forti, la contiene, affinché possa stare in equilibrio
con quella dei deboli. Ed è talmente radicata, questa convinzione, che sembra valere
indipendentemente dal contenuto della regola giuridica: se si tratta di regolare ad
esempio il diritto dei padroni di licenziare i propri operai, secondo Weil, pur di
evitare il mero arbitrio, «la regola più assurda, purché stabile, sarebbe un progresso».
C’è una fase del pensiero weiliano, perciò, nella quale emerge l’idea della forza della legge da contrapporre alla legge del più forte. È la fase nella quale Simone, tra le altre cose, facendosi assumere in fabbrica,
sperimenta la condizione degli operai, che ella assimila a quella degli schiavi. Ispirandosi a Montesquieu, nei primi Cahiers viene celebrata la «grandezza delle leggi», considerate come la «sola fonte della libertà». Una libertà intesa non come ‘non-impedimento’ (secondo la versione ‘negativa’ della
tradizione liberale: si è liberi in quanto non si incontrano ostacoli per la propria
azione), bensì come ‘non-dominio’, in una accezione che è vicina a quella della tradizione
repubblicana (anche se gli studiosi del neorepubblicanesimo non hanno mai preso in
considerazione il nome di Weil). C’è una differenza abissale tra l’essere sottoposto a un padrone, per quanto egli
possa essere mite, e l’essere sottoposto alle leggi, per quanto esse possano essere
dure: «Tutto sta nella distanza tra il capriccio e la regola».
È già una Weil realista quella che avanza queste idee; una Weil che si riallaccia
a Erodoto, a Machiavelli, a Montesquieu: sa che bisogna guardarsi dal potere perché
chiunque si trovi a esercitarne tenderà ad accrescerlo e anche ad abusarne.
Questa immagine del diritto e della legge come limite rimarrà costante negli anni;
riemergerà in più punti nei Cahiers e verrà ripresa negli ultimi scritti. In un passo rilevante de L’enracinement, Simone fissa alcune condizioni per la libertà dei soggetti proprio facendo riferimento
alle regole e ai caratteri che esse devono avere:
La libertà, nel senso concreto della parola, consiste nella possibilità di scelta.
Si tratta, beninteso, di una possibilità reale. Ovunque c’è vita comune, è inevitabile
che regole imposte dall’utilità comune limitino la scelta. Ma la libertà non è più
o meno grande a seconda che i limiti siano più o meno larghi. Giunge alla sua pienezza
in condizioni meno facili da misurare. Occorre che le regole siano abbastanza ragionevoli
e semplici perché chiunque lo desideri e disponga di una media facoltà di attenzione
possa capire sia l’utilità cui corrispondono sia le necessità di fatto che le hanno
imposte. Occorre che provengano da un’autorità che non sia considerata straniera o
nemica, ma che venga amata come appartenente a coloro che dirige. Occorre, perché
il pensiero le possa assimilare una volta per sempre e non urti contro di loro ogni
volta che c’è una decisione da prendere, che le regole siano abbastanza stabili, in
numero piuttosto ridotto e sufficientemente generali.
Un vero e proprio vademecum per il legislatore, da cui risulta un quadro chiaro dei
rapporti tra governanti e cittadini, tra chi esercita il potere (anche attraverso
il diritto) e coloro che sono chiamati a ubbidire. Il diritto e le leggi non sono un mezzo di dominio dei primi sui secondi, ma piuttosto
ciò che permette a una società di avere una ‘misura’ che impedisca a una parte di
dominare sull’altra. Quando le leggi attribuiscono a qualcuno una potenza superiore
alla funzione che esso svolge (definita dal lavoro di ciascuno), allora esse sono
«contrarie al diritto», come avviene nel caso della schiavitù e del dispotismo.
Il diritto come maschera della forza
La considerazione positiva del diritto subisce tuttavia una sorta di oscuramento (ma
non un abbandono definitivo) nel pensiero weiliano più maturo. Instaurando una corrispondenza
rigorosa – anzi, una «singolare analogia» – tra lo spirito e la storia di Roma, da un lato, e il diritto nel suo essere espressione
di forza, dall’altro lato, Simone Weil porta in primo piano gli elementi negativi
presenti sul terreno giuridico. In un passo notissimo di uno dei suoi scritti più
importanti afferma che:
la nozione di diritto ci viene da Roma, e come tutto ciò che viene dall’antica Roma,
la donna gravida dei nomi della bestemmia di cui parla l’Apocalisse, è pagana e non battezzabile. I Romani che avevano capito, come Hitler, che la forza
ha la pienezza dell’efficacia solo quando è rivestita di alcune idee, impiegavano
la nozione di diritto a questo scopo. Vi si presta benissimo.
Si tratta evidentemente di un ripensamento radicale di quanto affermato in precedenza.
Il diritto appare fin dall’origine contaminato dalla forza, e dunque non redimibile,
non recuperabile a una funzione positiva. È certamente il periodo storico drammatico
– col ritorno dello spirito di conquista dei Romani, che Weil vede reincarnato sotto
le spoglie dell’hitlerismo (ma che si era espresso anche nei modi del colonialismo) – a spingere la filosofa francese ad assumere una posizione così forte. Più in generale,
però, è la riflessione sullo Stato e sulla natura del potere statale – che per Weil
è centralizzatore, sradicante e tendenzialmente totalitario – a orientare le nuove
convinzioni.
Si comprende meglio questa riflessione se la si mette in relazione con la condizione
della scienza giuridica europea tra le due guerre. È come se anche la nostra autrice
si sia resa conto che il connubio tra diritto e Stato, tipico della modernità, era
giunto a un punto estremo, del quale si poteva dare una lettura solo attraverso lo
strumento concettuale dello ‘stato di eccezione’; una figura giuridica che serviva
paradossalmente solo per descrivere (e affermare) la negazione del diritto e il suo
totale assorbimento nella sfera del potere, come avviene chiaramente nelle teorie
di Carl Schmitt, il massimo rappresentante di questa dottrina. Il tendenziale annullamento del diritto all’interno del potere, caratteristico del
totalitarismo giuridico, sembra in tal modo trovare eco anche nella riflessione weiliana.
Non siamo di fronte, comunque, a una pura e semplice confusione del diritto con la
forza: se è vero che la corrispondenza tra diritto, forza e spirito romano può apparire
schematica, o addirittura caricaturale, il diritto rientra tuttavia nell’‘arte di salvare le apparenze’ e dimostra di avere
un ruolo suo proprio che permette di tenerlo separato dalla figura della forza brutale.
Ponendosi anche stavolta sulla scia di Rousseau, Simone considera il diritto come fondamentale nella strategia di chi impone il suo
dominio. Non più limite per la forza, esso diventa ora piuttosto una ‘maschera’ della
forza stessa: assolve cioè a una funzione ideologica. Ciò non significa naturalmente che esso possa essere assolto; anzi, mostra tutta
la sua negatività nel momento in cui permette di rendere ‘obbligatorio’ – cioè dovuto
giuridicamente – ciò che in sua assenza sarebbe dovuto solamente sulla base di una
costrizione. Grazie al diritto, oppure per colpa del diritto, non siamo semplicemente costretti a compiere un’azione, come ad esempio siamo costretti a dare la borsa al bandito
che ci punta una pistola; siamo invece obbligati a compiere un’azione da un’autorità che si pretende legittima e che si serve proprio
del diritto per rivestire la sua minaccia rinforzata dalla sanzione. Si tratta di
una visione, tuttavia, che discende dal fatto che il diritto viene ora collocato da
Weil lungo una linea esclusivamente verticale, avendo smarrito del tutto la capacità
di rappresentare quel fattore riequilibratore di rapporti orizzontali che sembrava
caratterizzarlo negli anni precedenti. Come a dire che quando il diritto si confonde
tout court con la forza e il dominio, esso smette semplicemente di essere diritto.
Dalla forza alla giustizia
La contaminazione con la forza conduce dunque il diritto ad assumerne fatalmente i
caratteri negativi. Anche se non è possibile ripercorrere qui i momenti della intensa
fenomenologia della forza presentata da Weil nelle sue riflessioni, non si possono non richiamare alcuni punti fermi senza i quali sarebbe impossibile
comprendere l’approccio al tema della giustizia. Prima, però, leggiamo almeno il brano
iniziale dello scritto sull’Iliade, che ci restituisce tutta la bellezza e la profondità dello sguardo weiliano, oltre
che la sua straordinaria capacità di penetrazione dei testi:
Il vero eroe, il vero soggetto, il centro dell’Iliade è la forza. La forza adoperata dagli uomini, la forza che sottomette gli uomini,
la forza davanti alla quale la carne degli uomini si ritrae. L’anima umana vi appare
continuamente modificata dai suoi rapporti con la forza, trascinata, accecata dalla
forza di cui crede di disporre, piegata sotto la costrizione della forza che subisce.
Coloro che avevano sognato che la forza, grazie al progresso, appartenesse oramai
al passato hanno visto in questo poema un documento; coloro che, oggi come un tempo,
sanno discernere la forza al centro di ogni vicenda umana vi trovano il più bello,
il più puro degli specchi. La forza è ciò che fa di chiunque le è sottomesso una cosa.
Quando è esercitata fino in fondo fa dell’uomo una cosa nel senso più letterale, perché
ne fa un cadavere. C’era qualcuno, e un attimo dopo non c’è nessuno.
Primo punto. Qui, come in molti altri brani, emerge la convinzione che gli eventi
di questo mondo siano governati dal principio della potenza, dallo scontro perenne
e inarrestabile di forze in continuo movimento. «Su questa terra – dice Simone in
un altro passo celebre, stavolta preso da L’enracinement – non c’è altra forza che la forza». Entrare nella logica della forza significa perciò esserne catturati, sia che ci
si trovi a subirla, sia che ci si trovi a esercitarla sugli altri. Questa lucida consapevolezza
è appartenuta solo ad alcune civiltà superiori, come quella greca e quella occitana,
ed è solo la presenza di un influsso soprannaturale che porta a non confondere la
forza con la giustizia (errore tipico, secondo Weil, delle civiltà che hanno avuto
il culto della forza e del collettivo, come quella dei Romani o quella ebraica vetero-testamentaria).
Secondo punto: è la natura stessa di questo dominio a definirne anche i limiti. Aderendo
alle tesi esposte da Spinoza nell’Etica, Weil ripete che «non c’è alcuna cosa singola della quale non ve ne sia un’altra
più potente e più forte». Questo comporta lo stabilirsi di un equilibrio che non raggiunge mai una condizione
di stasi ma è invece sempre instabile: il che significa che non si dà mai un ordine
duraturo se si pretende di fondarlo soltanto sulla forza. «Non si trova un solo uomo»,
fosse anche il più potente, dice Simone, che a un certo punto «non sia costretto a
piegare sotto la forza».
Terzo punto: solo in virtù di un atto individuale è possibile abbandonare il piano
della forza per attingerne uno più alto: «Conoscere la forza significa riconoscerla
come pressocché assolutamente sovrana in questo mondo, e rifiutarla con disgusto e
disprezzo. Questo disprezzo è l’altra faccia della compassione per tutto ciò che è
esposto ai colpi della forza». Se è vero che nel mondo non c’è altra forza che la forza, allora essa può essere
superata da una forza di natura completamente diversa, una forza «che non è di questa
terra» e con la quale si può entrare in contatto «a prezzo di un transito attraverso
qualcosa che somiglia alla morte».
Qui si colloca il punto di svolta di tutto il discorso weiliano. Se, come Nietzsche
aveva sottolineato, non si può «pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza»; e se da questa logica derivano, come conseguenze naturali,
la sopraffazione, il «voler abbattere», una incessante sete di nemici, di opposizioni
e trionfi, Simone Weil invita a passare per quel luogo che, nell’ottica di Nietzsche, non poteva
che essere ‘assurdo’: la debolezza. Se la forza è imparentata con il male, l’unico modo di uscire dal suo dominio è
di acquisire appunto la condizione del debole. È a partire dalla debolezza che si
può ritrovare il bene, ed è da qui che bisogna muovere per mettersi sulla via della
giustizia.
È un preciso rovesciamento dell’Anticristo nietzscheano quel che viene additato al nostro sguardo. Se Nietzsche aveva sentenziato
che buono è «tutto ciò che eleva il senso della potenza, la volontà di potenza, la
potenza stessa dell’uomo», e cattivo è «tutto ciò che ha origine dalla debolezza»,
possiam
...