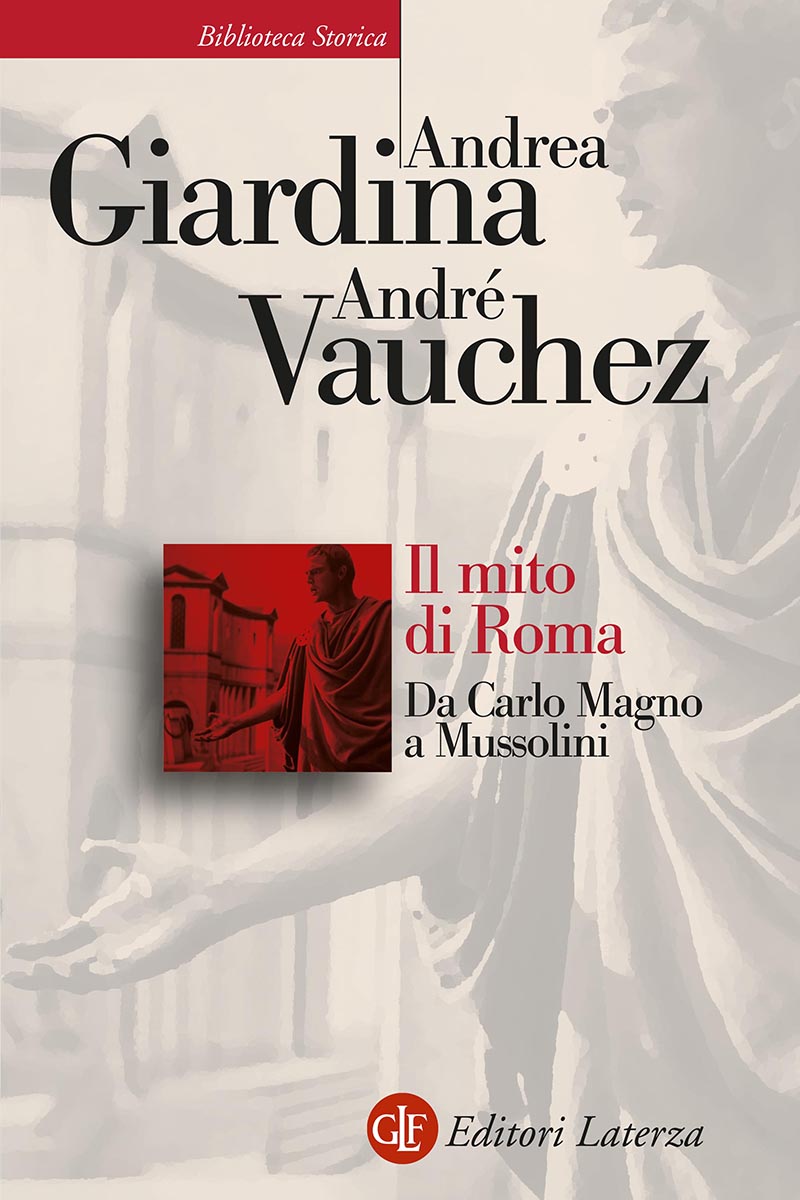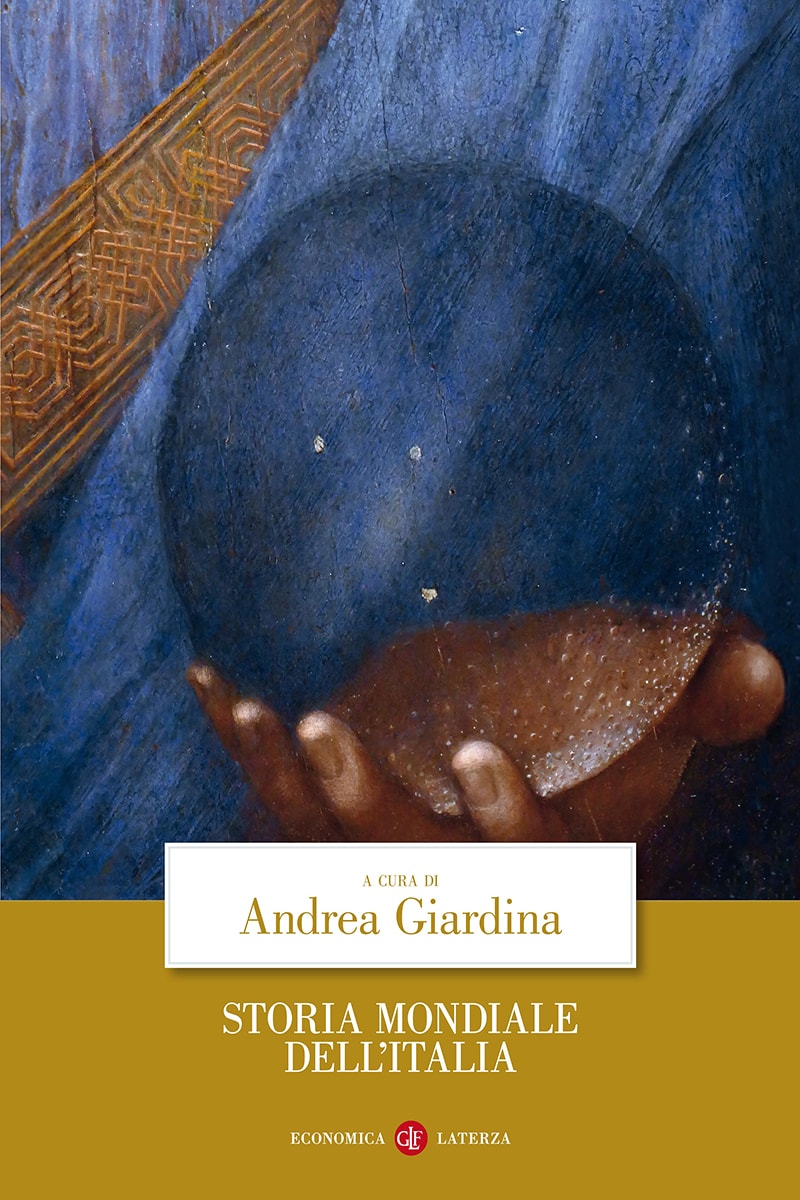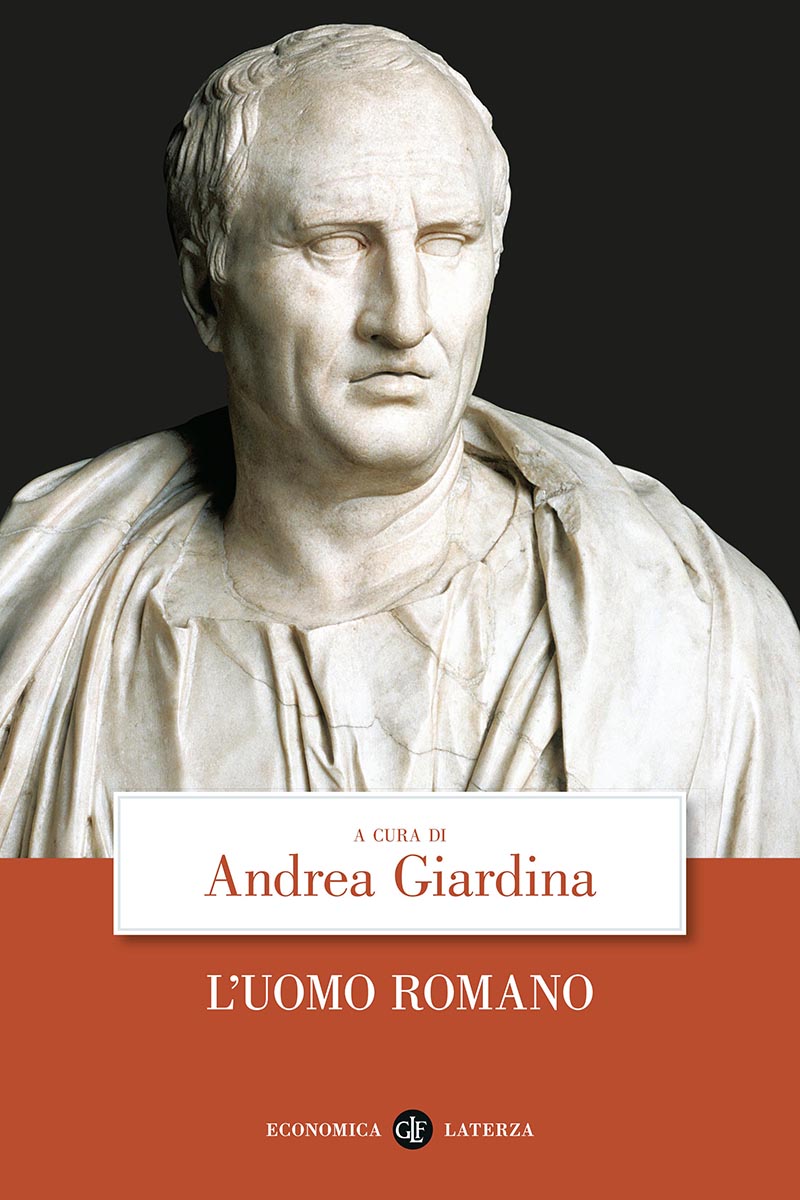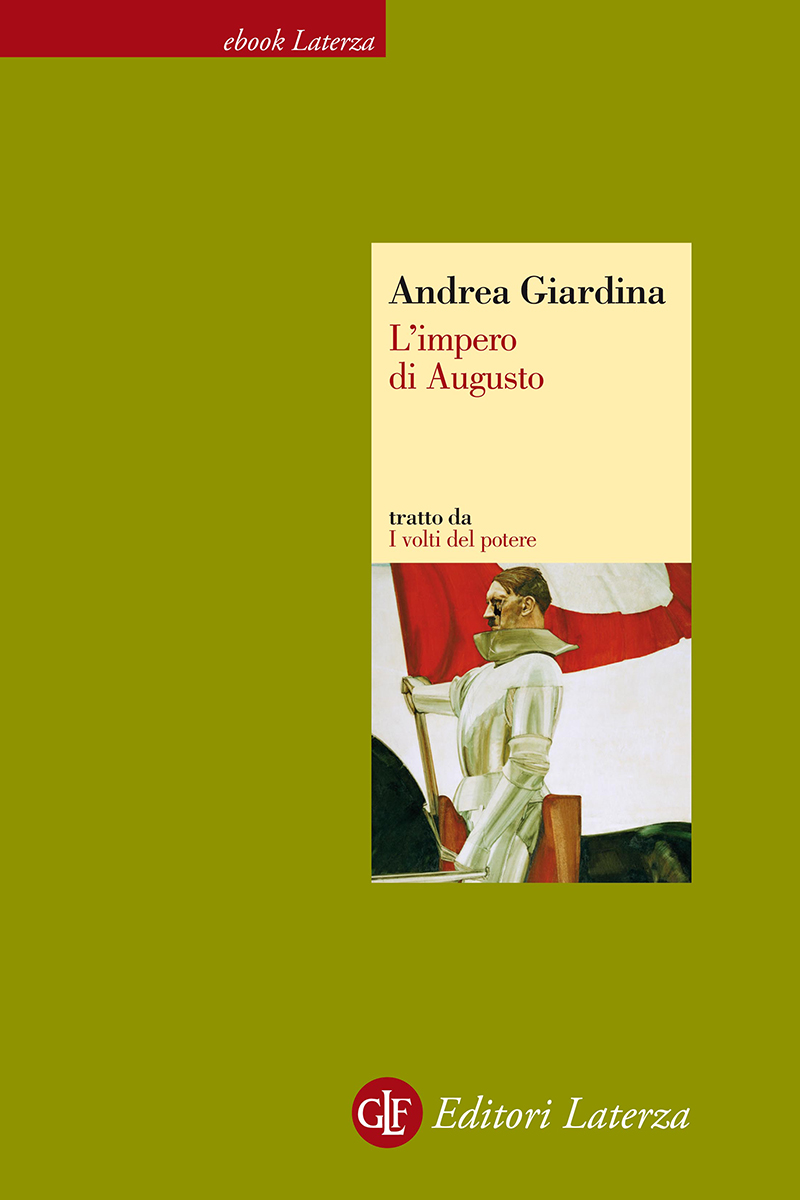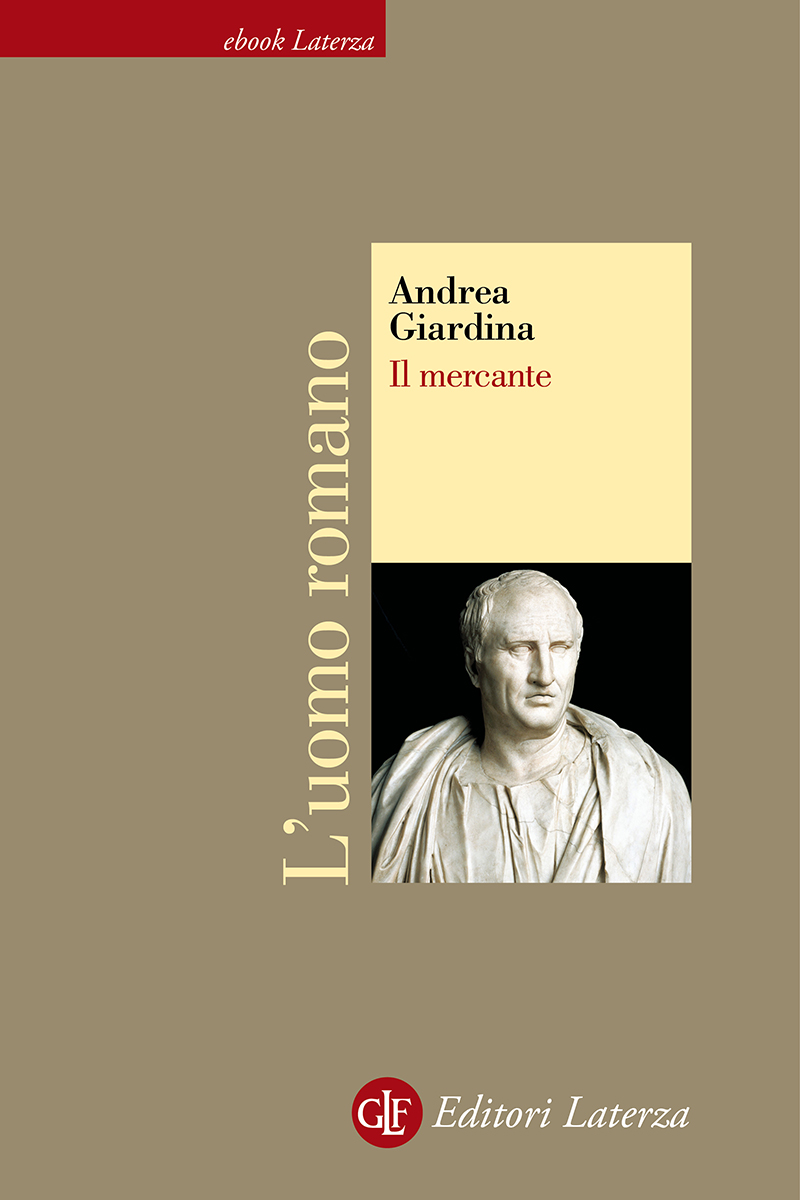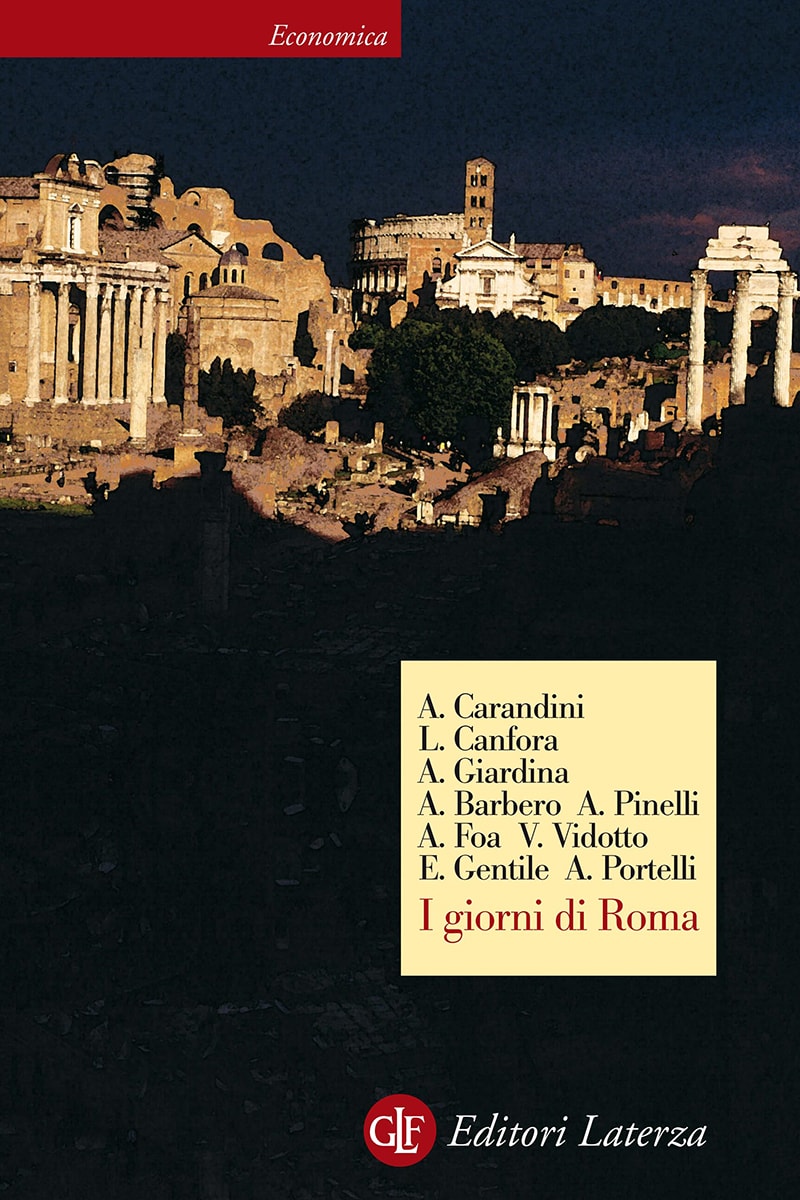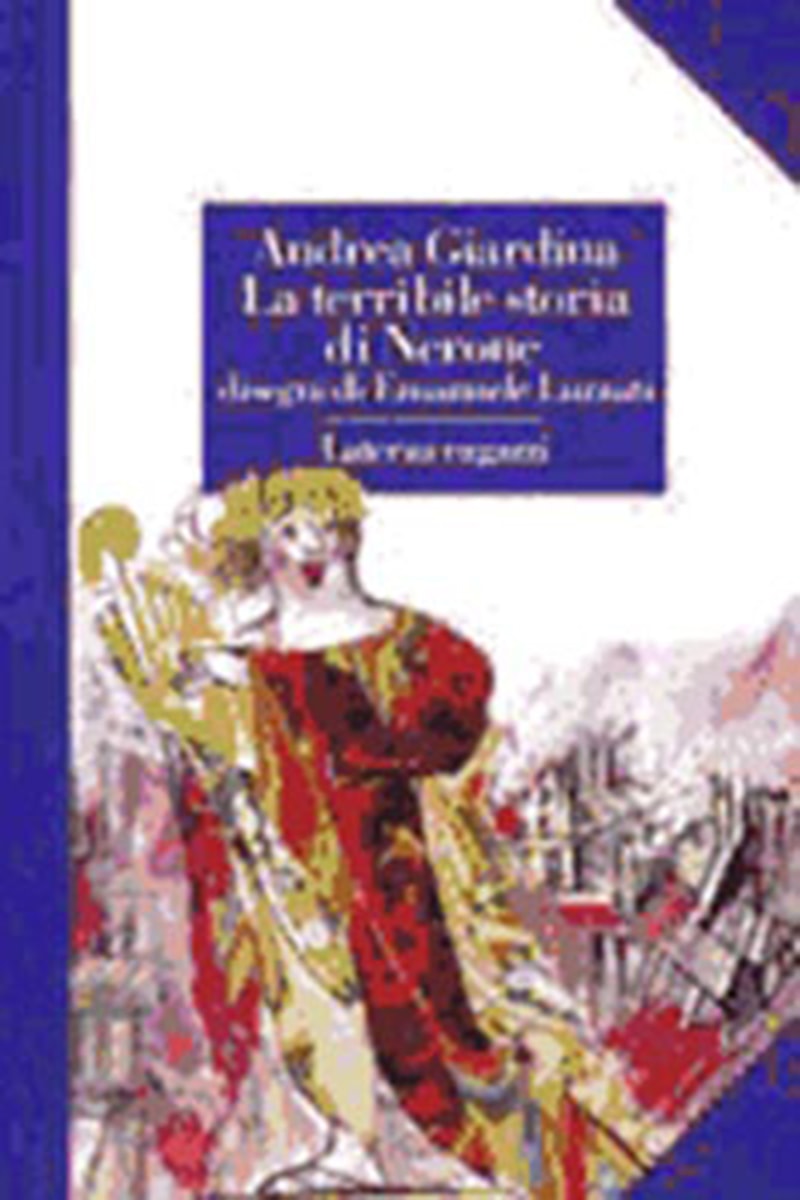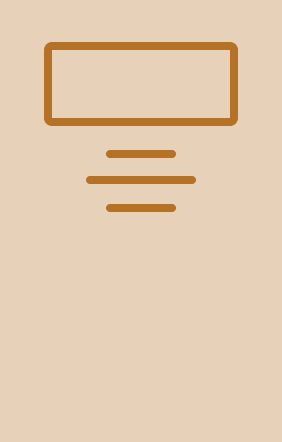Introduzione
Oggetto di questo volume è la memoria di Roma dopo la sua scomparsa come potenza politica
e centro di una delle più brillanti civiltà che il mondo mediterraneo abbia conosciuto.
Roma dopo Roma, dunque; e cioè un insieme di rappresentazioni mentali, di modelli
estetici e di riferimenti ideologici che si sono trasmessi attraverso i secoli e che
hanno permesso alla memoria della città non soltanto di sopravvivere, ma di costituire
fino ai nostri giorni un riferimento vivo e operante negli spiriti e nei cuori. Nessun’altra
città ha avuto un ruolo paragonabile nella storia della civiltà occidentale. L’Atene
di Fidia e di Pericle ha lasciato la testimonianza di un successo politico e culturale
eccezionale e la Sparta di Licurgo è rimasta a lungo un riferimento obbligato in materia
di legislazione e di organizzazione militare; ma, dopo l’apogeo dell’epoca classica,
di esse è sopravvissuto un ricordo rivitalizzato di tanto in tanto da letterati, artisti
o pensatori politici poco interessati al loro divenire e al loro presente. Roma, al
contrario, benché ridotta a poca cosa dopo le invasioni barbariche e le guerre gotiche
del VI secolo, è rimasta una città-faro che non ha cessato di affascinare gli uomini
e di proporre un messaggio, costituito da un insieme di idee e di miti che hanno nutrito
per quindici secoli la coscienza dei popoli un tempo sottomessi al suo impero e anche
di quelli che non gli erano mai appartenuti, dall’Irlanda alla Scandinavia e ai paesi
slavi.
Questa misteriosa attrazione, e la sua straordinaria continuità attraverso le vicissitudini
della storia, sono legate prima di tutto alla perennità di Roma come centro urbano
di una certa importanza. A differenza di Troia o di Cartagine – altre città famose
il cui destino ha ugualmente segnato l’immaginario occidentale –, essa, in effetti,
non ha cessato mai di esistere e di conservare almeno le apparenze di una grande città,
circondata com’era – e com’è ancora oggi su una parte del loro tracciato – dall’immensa
cinta delle mura di Aureliano. L’estensione e lo splendore delle rovine che la ricoprivano,
se mettevano in evidenza il suo declino, costituivano nondimeno i segni della sua
grandezza passata e un elemento essenziale del suo irraggiamento. Ma la città si è
nutrita a sua volta dei miti che si erano sviluppati intorno ad essa e che essa seppe
far giocare a suo vantaggio: a partire dal martirio dei santi Pietro e Paolo – avvenimento
fondatore del suo prestigio nel mondo cristiano – fino all’incoronazione di Carlo
Magno e dei sovrani germanici, una serie di fatti e di credenze ha contribuito a mantenere
viva l’idea che Roma continuava a essere il centro del mondo e la città eterna per
eccellenza, anche quando niente nella sua realtà concreta e nel rapporto di forze
esistente sembrava legittimare questa rivendicazione.
Sotto questo aspetto, Roma non può essere paragonata che a Gerusalemme, altra città
il cui potere di fascinazione è sempre stato indipendente dalla sua importanza sul
piano demografico e politico. Ma, nell’Occidente medievale e moderno, l’irraggiamento
della prima ha sempre sopravanzato quello della seconda, in quanto il mito di Roma
non rimandava soltanto a una città o a una storia santa ma anche all’impero di cui
era stata il centro e alla civiltà che vi si era sviluppata a partire dall’epoca etrusca
fino al V secolo della nostra era. Questo lascito dell’antichità ha potuto in seguito
ridursi o impoverirsi, ma non ha mai cessato di apparire, agli occhi dei popoli e
delle civiltà eredi dell’impero romano, come una forma di vita superiore a livello
materiale e morale. Dietro la diversità delle tradizioni e delle leggende attraverso
le quali si è trasmesso il ricordo di Roma si riscontrano alcuni temi ricorrenti che
ne costituiscono il nocciolo duro: un certo senso della grandezza, l’idea di uno spazio
amministrativo unificato e regolato dal diritto, un’efficacia tecnica associata alla
bellezza della forma nelle arti e nelle costruzioni, come pure un insieme di virtù
morali in cui si era tentati di vedere il segreto di un simile successo. Ma, per quanto
pregnante possa essere stata in certe epoche, l’eredità dell’antichità non sarebbe
bastata ad assicurare una fonte costante di ispirazione se il cristianesimo non l’avesse
ripresa su di sé, almeno in una certa misura. Bisogna sottolineare subito il ruolo
decisivo svolto in questo processo dal papato, che fece di Roma, dal IV secolo d.C.,
un punto di riferimento fondamentale per tutti i cristiani e il centro di un potere
convinto di essere investito del compito di dirigere la Chiesa, e più tardi la cristianità,
sulla base del prestigio degli apostoli Pietro e Paolo e del culto dei martiri romani.
Queste due sorgenti – per esprimersi alla maniera di Bergson – si sono mescolate nel
corso dei secoli in proporzioni variabili, e il carattere composito del fascio delle
tradizioni radicate nel suo passato ha permesso alla città di mantenere il suo prestigio
in contesti storici molto diversi: Roma pagana e cristiana, repubblicana e imperiale,
universale e comunale ecc. Passato l’anno Mille, l’Occidente non ha tardato a riscoprire
la complessità di questo lascito, al quale non hanno mancato di richiamarsi le imprese
più diverse come la Riforma e la centralizzazione della Chiesa intorno al papato,
la promozione della scrittura umanista nel Rinascimento o la politica estera dell’Italia
fascista. Sul piano politico, il ricorso a Roma è servito tanto a legittimare esperienze
o aspirazioni democratiche e riformiste che si appellavano all’esempio di Bruto e
dei Gracchi, quanto regimi autoritari o persino totalitari che sognavano di restaurare
il potere di Cesare, di Augusto o di Costantino. Nel corso dei secoli, si è attinto
più o meno generosamente a questa riserva di riferimenti storici e simbolici privilegiando
questo o quell’aspetto e, anche all’interno di una stessa epoca, si sono visti a volte
gruppi o correnti di pensiero differenti mobilitare il ricordo di Roma al servizio
di interessi divergenti, quando non antagonisti, come la ricerca di una unificazione
del mondo cristiano sotto l’autorità dell’imperatore o sotto quella del papa fra l’XI
e il XIII secolo. Roma, allora, non sarebbe stata altro che una specie di «albergo
spagnolo» in cui ognuno trovava solo quello che vi portava, o una maschera di cera
il cui naso poteva essere torto in tutte le direzioni? Niente di più inesatto, poiché,
dietro queste rivendicazioni contraddittorie o questi ricorsi spesso anacronistici
o abusivi all’idea o ai miti di Roma, si ritrovano idee-forza identiche come l’universalità
e la maestà del potere, il regno della legge e la massima dell’ordine.
Tutti questi elementi dell’eredità non sono stati presenti in maniera permanente e
simultanea nella coscienza collettiva degli occidentali nel corso degli ultimi quindici
secoli. Ma basta una schiarita o un concorso di circostanze politiche e religiose
favorevoli perché alcuni di loro, a lungo dimenticati o trascurati, risalgano in superficie,
a volte raggrinziti o deformati ma sempre presenti e suscettibili di ridiventare fermenti
attivi di rinnovamento. Questo libro non pretende di raccontare in dettaglio le vicissitudini
dell’idea di Roma in Europa e nel mondo, dal sacco della città ad opera del barbaro
Alarico, nel 410, fino ai nostri giorni. Abbiamo preferito considerare nella lunga
durata e con un certo distacco il processo di periodici flussi e riflussi della romanità
in seno alla società e alla cultura occidentali, in virtù del quale a «secoli senza
Roma» sono succeduti tentativi di renovatio del modello politico romano e accessi di marcato fervore per la sua cultura o i suoi
aspetti di sacralità. E nessuno certo si meraviglierà se all’interno di queste fasi
alterne e di ineguale durata abbiamo privilegiato quelle in cui le élite dirigenti
– che davano il tono al loro tempo – hanno ritenuto, con un miscuglio sorprendente
di umiltà e di ferma convinzione, che la possibilità di dominare il presente passava
necessariamente per un ritorno a Roma e per il recupero dei ricordi e dei valori della
sua civiltà.
A.G. A.V.
Aprile 2000
Gli autori ringraziano vivamente Louis Audibert, che è stato all’origine di questo
libro ed Elisabetta Bonasera-Hubert che ha tradotto in italiano i primi due capitoli.
Andrea Giardina esprime la sua gratitudine a Innocenzo Cervelli, Adolfo La Rocca,
Luisa Mangoni, Ignazio Tantillo, Giusto Traina, Vittorio Vidotto.
I.
Il Medioevo:
tra continuità e sogni di rinnovamento
Il 21 maggio 996 un principe tedesco di quindici anni, il futuro imperatore Ottone
III (980-1002), entra solennemente nella basilica di San Pietro a Roma. Il giovane
sovrano, rivestito del mantello imperiale ricamato con scene dell’Apocalisse e decorato di perle, pietre preziose e 365 campanelli d’oro, come i sommi sacerdoti
del tempio di Gerusalemme, riceve la corona dalle mani di papa Gregorio V, alla presenza
di una folla di romani e della grande aristocrazia imperiale. Il nuovo imperatore
è nipote di Ottone I, il duca di Sassonia che dopo aver sottomesso la Germania alla
sua autorità, nel 962 aveva ristabilito l’impero in Occidente. È figlio di Ottone
II († 983), l’unico imperatore del Medioevo a essere sepolto in Vaticano, dove la
sua tomba è ancora visibile, e della principessa bizantina Teofano. Con i suoi consiglieri
laici e soprattutto ecclesiastici, fra tutti Gerberto di Aurillac, già suo precettore,
che nel 999 fece papa con il nome di Silvestro II, Ottone III gettò le basi di un
vasto programma di restaurazione dell’impero romano (renovatio Romani imperii). Secondo un cronista tedesco del tempo, l’imperatore aveva espresso l’intenzione
di «rinnovare nel suo tempo l’antico costume dei romani già in gran parte scomparso»
e, come indica uno dei suoi diplomi, di fare in modo che «conservando la Chiesa di
Dio la libertà e la sicurezza, l’Impero possa conoscere la prosperità, possano i suoi
eserciti trionfare, la potenza del popolo romano accrescersi e lo Stato restaurarsi»1. Particolarmente sedotto da Roma, Ottone III fu il primo imperatore dopo Teodorico
(† 526) a insediarsi in un palazzo sul Palatino e a circondarsi di alti dignitari
dai titoli pomposi che evocavano la corte di Costantinopoli. Ma il sogno di un ritorno
a quelli che erano stati i tempi di Giustiniano fu di corta durata: i romani, ostili
a una presenza che intralciava la loro già lunga tradizione di autonomia, non tardarono
a ribellarsi. Nel febbraio del 1001, l’imperatore fu costretto a prendere la fuga
insieme al suo pontefice. Ottone III non avrebbe mai più rivisto Roma: morì il 24
gennaio 1002 in un castello nelle vicinanze della città, nel vano tentativo di riconquistarla.
Il suo corpo fu riportato in Germania e sepolto ad Aquisgrana.
Fino al 1328 questo copione si ripeté più volte nei secoli a venire, con variazioni
più o meno violente o drammatiche che nulla tolgono alla sua coerenza globale: un
sovrano tedesco scende in Italia con il suo esercito, si spinge fino a Roma senza
incontrare molta resistenza, anzi una parte della popolazione lo accoglie con gioia,
è incoronato imperatore, più o meno volentieri, dal papa o dal suo legato nell’antica
basilica di San Pietro, costruita da Costantino sul Vaticano in onore di Cristo e
dell’apostolo Pietro nel luogo presunto del suo martirio. Segue poi un breve soggiorno
del nuovo imperatore a Roma, soggiorno presto segnato da tensioni con l’aristocrazia
e il popolo romano, che possono spingersi fino alla rivolta e assumere le forme di
una guerriglia urbana; infine, più pietoso che trionfale, il ritorno del sovrano e
del suo seguito a nord delle Alpi.
Lo storico non può non chiedersi il senso di questo rituale incentrato su Roma, così
frequentemente ripetuto e con risultati generalmente deludenti. Tutto ciò che l’imperatore
otteneva era un titolo prestigioso – Ottone III si designava «servitore di Gesù Cristo
e imperatore romano augusto» – e una consacrazione religiosa. Di fatto la realtà del
suo potere proveniva dalla forza militare e politica legata alla sua carica di re
di Germania e, dal XII secolo, alla sua elezione al titolo di «re dei romani» da parte
di un certo numero di principi tedeschi, ecclesiastici e laici. Ma solo Roma, cardine
dell’universalismo politico, e il papa, patriarca della Chiesa d’Occidente, potevano
conferire all’eletto una legittimità che faceva di lui il successore di Costantino
e di Carlo Magno, imperatori cristiani venerati come santi e il cui ricordo era diffuso
in tutta la cristianità. Così, tra la seconda metà del X secolo e l’inizio del XIV,
quasi tutti i sovrani germanici si lanciarono in quella affascinante avventura che
era la discesa in Italia, la famosa Romfahrt tanto cara agli storici tedeschi del XIX secolo e che consumò tante forze e ricchezze,
ma che nutrì anche tanti sogni di gloria e di potere.
1. Roma vedova («Roma vidua») tra declino e mediocrità (VI-VIII secolo)
Una città decaduta Perché Roma continua per secoli a esercitare un tale fascino quando, ormai da lungo
tempo, si era ridotta all’ombra di se stessa? In realtà, tutti i viaggiatori che visitarono
allora la città sono unanimi nel presentarla come un centro di modesta importanza,
circondato dalle rovine quasi eccessivamente estese del suo superbo passato. Emile
Mâle ha felicemente evocato questa Roma medievale che rimase all’incirca immutata
fino al Rinascimento:
Palazzi a metà spogliati dei loro rivestimenti di marmo, ville patrizie decorate da
ninfei i cui ultimi resti scomparvero solo nel XIV secolo, vie lastricate di basalto
fiancheggiate da portici diroccati, statue rovesciate ai piedi dei loro basamenti,
quinte di muri dove aderivano ancora affreschi di squisita fattura, terme gigantesche
che riparavano ancora sotto le loro volte le loro piscine prosciugate, le vasche di
porfido e le divinità marine dei mosaici, i volumi imponenti dei circhi, dei teatri,
degli anfiteatri, delle tombe imperiali sui quali cinque secoli non avevano ancora
trionfato e, qua e là sulle colline, i resti dei vecchi boschi sacri dal fogliame
oscuro. La Roma immaginaria di Hubert Robert, questa Roma di sogno dove una sfinge
egizia giace accanto a un portico dalle colonne illividite dall’incendio, dove le
alte volte lasciano intravedere da lontano l’abside decorata a cassoni di un tempio
le cui pietre sono divelte dagli alberi, questa è la Roma di Ottone III2.
In effetti questa città, che alla fine dell’antichità contava ancora mezzo milione
di abitanti, non aveva cessato di restringersi su se stessa e la sua popolazione non
doveva probabilmente superare le 30.000 anime. Intorno all’anno Mille solo alcuni
quartieri tra Castel Sant’Angelo e il Campo Marzio erano ancora abitati in modo continuo.
Al di là di queste isole si incontrava una costellazione di piccoli gruppi di abitazioni,
talvolta costituiti solamente da quattro o cinque case, minuscoli villaggi all’interno
della cinta urbana separati gli uni dagli altri da terreni incolti o abitazioni isolate.
A est e a sud della città sorgevano chiese prestigiose: San Giovanni in Laterano,
cattedrale di Roma e residenza del papa, Santa Maria Maggiore o San Paolo fuori le
mura. Le mura di Aureliano, ricordo imponente dell’estensione dell’Urbs, superata solo nel XX secolo, racchiudevano nel loro circuito più giardini e rovine
che case. Tra i quartieri densamente popolati dell’ansa del Tevere e le basiliche
della periferia, dal Foro a una parte dell’Esquilino, del Celio e delle terme di Caracalla,
si stendeva un’immensa zona pressoché disabitata, che costituirà il tratto caratteristico
del paesaggio e dell’urbanesimo romano fino ai nostri giorni. Come ha giustamente
notato Marc Fumaroli: «Non esiste nessun’altra città al mondo il cui centro storico
si sia svuotato come in seguito alla caduta di un enorme meteorite che ha provocato
una ferita riapertasi più volte e mai cicatrizzata»3. Quindi una Roma vedova del suo imperatore, ma anche svuotata della propria sostanza
dalle difficili contingenze dell’epoca.
Il fenomeno medievale della riduzione delle superfici delle città e della loro perdita
d’influenza nel campo socio-economico non è certamente specifico dell’antica «capitale
del mondo». In questa epoca scomparvero anche in Italia numerose città la cui fondazione
risaliva all’antichità e quelle superstiti si rinchiusero all’interno di cinte fortificate
che delimitavano una superficie spesso non superiore a pochi ettari. Ma la situazione
romana era particolare: dopo le guerre gotiche che nella prima metà del VI secolo
avevano opposto gli eserciti bizantini a quelli del re ostrogoto Teodorico, più volte
presa e riconquistata dalle forze opposte e ben presto privata dell’acqua dei suoi
acquedotti che nessuno era più in grado di restaurare, Roma era ridotta all’ombra
di se stessa; isolandola da Ravenna e dalle città dell’Italia meridionale, le invasioni
longobarde della fine del VI e del VII secolo contribuirono ad accentuarne il ripiegamento
su se stessa, mentre l’interruzione dei rapporti con l’Africa settentrionale e più
tardi con la Sicilia, conquistata dai musulmani tra il VII e il IX secolo, mise fine
alle correnti di scambio tradizionali e rese più difficile il rifornimento in grano.
Fin dal VII secolo tutte le attività della vita politica e amministrativa, escluse
quelle locali, scompaiono dalla città. Roma diventa un centro puramente ecclesiastico
gravitante intorno al patriarchium del Laterano, la cui reputazione era resa deplorevole dalle lotte intestine.
Qui la ripresa dell’espansione si fece attendere più a lungo che altrove, rendendo
ancora più flagrante il contrasto tra la mediocrità quotidiana e le tracce di un passato
grandioso: mentre dalla seconda metà del VII secolo numerose regioni d’Italia conobbero
una ripresa demografica ed economica vigorosa, nonché un certo rinnovamento della
vita urbana, testimoniato dallo sviluppo precoce di città come Amalfi, Venezia o Pisa,
Roma non sembra essere stata toccata da questo movimento. Dopo un periodo di stabilizzazione
in epoca carolingia, illustrato dal restauro di numerose chiese e di quattro acquedotti
e dalla costruzione della cinta leonina che univa San Pietro a Castel Sant’Angelo,
l’antico mausoleo di Adriano trasformato in fortezza per servire da rifugio ai papi,
la sua situazione non cesserà di degradarsi fino agli ultimi anni dell’XI secolo,
particolarmente con l’incendio che nel 1084 devastò l’insieme dei quartieri tra il
Laterano e il Colosseo. La sua popolazione era ridotta allora a circa 20.000 abitanti;
essa subì certamente un incremento nel XII e XIII secolo, ma fino al Rinascimento
Roma rimarrà una città d’importanza modesta, incapace di sottomettere con le proprie
forze le piccole città del Patrimonio di San Pietro, come Tivoli o Tuscolo, che la
mettevano in ombra, e che stentava a costituire un contado, ovvero un retroterra rurale
sottomesso alla sua autorità e sfruttato a suo vantaggio, come facevano alla stessa
epoca i comuni lombardi o toscani.
All’ombra di Bisanzio: splendore e potenza della «seconda Roma» Invece, alla stessa epoca, tra la metà del IV e il XII secolo, sulle rive del Bosforo
un’altra Roma risplendeva di tutte le sue luci e continuava a dirigere un impero imponente.
Costantinopoli, la «nuova Roma», come l’aveva chiamata il suo fondatore, l’imperatore
Costantino, era nata nel 328-330 sul sito occupato dalla città greca di Bisanzio.
In seguito aveva conosciuto uno sviluppo urbano di larghe proporzioni che alla fine
del primo millennio doveva farne una delle più grandi metropoli del mondo orientale,
insieme al Cairo, a Damasco e a Baghdad. Originariamente non era destinata a eclissare
la vecchia Roma, di cui riproduceva la topografia, i sette colli, e la cornice monumentale.
Fondando Costantinopoli, Costantino aveva semplicemente preso atto dello spostamento
del centro di gravità dell’impero romano verso oriente e delle minacce che allora
pesavano su questa parte del bacino del Mediterraneo. Come scrisse Henri-Irénée Marrou,
«non vi è che una sola civiltà, la hellenistisch-römische Kultur, la cui ricca unità si concilia perfettamente con una dualità di facies: Oriente greco, Occidente latino»4. Ma questa tardiva ricerca di equilibrio, che favoriva l’Oriente e l’ellenismo, era
destinata ad avere pesanti conseguenze. Durante il V secolo infatti, con l’intensificarsi
delle invasioni barbariche che finirono col far scomparire l’impero in Occidente,
l’equilibrio tra le due parti del mondo romano si ruppe. Occidente e Oriente tesero
sempre maggiormente a evolvere indipendentemente l’uno dall’altro, soprattutto dopo
la definitiva sconfitta della riconquista dell’Occidente che Giustiniano aveva intrapreso
nella prima metà del VI secolo. Di conseguenza, l’ideologia costantiniana della renovatio Urbis, che in origine voleva semplicemente creare una seconda capitale imperiale in Oriente
senza nulla togliere alla prima, si trasformò rapidamente in un trasferimento di sovranità
(translatio imperii) e di prestigio a favore della nuova Roma sulle rive del Bosforo. Quella, cristiana
dalla nascita, incarnava l’avvenire, in opposizione alla vecchia Roma sul Tevere,
decaduta e ancora macchiata da quanto rimaneva del paganesimo.
Non era certo la prima volta che si affermava che «Roma non è più a Roma»: da Sertorio
a Tito Livio e al poeta Giovenale, numerosi erano i romani dell’antichità che già
avevano opposto una Roma ideale che pretendevano di rappresentare o difendere alla
Roma corrotta e imbastardita, indegna erede del suo glorioso passato, nella quale
vivevano. Queste recriminazioni, che pur rappresentano bene la continuità di una certa
idea di Roma, autonoma rispetto alla realtà concreta della città, non ebbero una grande
importanza dal punto di vista pratico fin tanto che quest’ultima rimaneva la capitale
incontestata dell’impero. La minaccia si fece più pericolosa con l’affermazione di
Costantinopoli che, dalla fine del IV secolo, pretese di incarnare in una forma nuova
e superiore l’ideale della romanità. La «seconda Roma» finisce con il considerarsi
l’erede legittima della «prima Roma» e la sua vera continuatrice, come se il declino
fisico e morale attribuito alla Roma tiberina giustificasse un passaggio di poteri
e il trasferimento del nome e dell’onore dall’una all’altra. Il territorio su cui
esercitava il suo dominio non coincideva certamente con quello dell’impero di Augusto
o di Traiano, soprattutto dopo le conquiste arabe del VII secolo, ma per gli imperatori
questi erano solo rovesci di fortuna che un giorno avrebbero potuto essere sormontati.
In ogni modo, l’impero d’Oriente aveva mantenuto le istituzioni dello Stato romano,
che in Occidente andavano perdendo progressivamente significato, e la forza conservatrice
del suo diritto, e a questo titolo poteva a maggior ragione rivendicare il diritto
all’eredità. Secondo la fortunata formula di August Heisenberg, «Bisanzio è l’impero
romano diventato cristiano, di nazione greca»5. Inoltre occorre precisare che questo impero, che durerà addirittura 1129 anni, fu
dapprima uno Stato (il prolungamento dell’impero romano) e in seguito una nazione,
e fu solamente a partire dal XII e XIII secolo, quando gli scontri con i latini si
moltiplicarono e misero in causa la sopravvivenza stessa di Bisanzio, che si iniziò
a insistere sul suo carattere «ellenico». Ma a Costantinopoli il latino scomparve
dai testi ufficiali dalla metà del VI secolo, e a Roma dopo il 752 non ci furono più
pontefici orientali, mentre in Occidente la conoscenza del greco diventava eccezionale
al di là di alcune regioni di contatto come l’Italia meridionale.
Creata per essere il prolungamento di Roma sul versante asiatico, una Roma sdoppiata,
Costantinopoli non tardò a diventare sua rivale e a cercare di sostituirsi a lei.
Già Giustiniano sosteneva che la sola superiorità che la vecchia Roma potesse vantare
era quella di essere stata la madre della nuova, più bella e promettente. Anche la
comune fede cristiana divenne presto occasione di conflitti e divisioni: con i concili
di Costantinopoli del 381 e di Calcedonia del 451, la Chiesa di Costantinopoli affermò
che in quanto città imperiale aveva diritto a un primato equivalente a quello di Roma
tra le principali Chiese dell’impero e rivendicò per il suo vescovo il titolo di patriarca
«ecumenico», ossia universale, provocando vivaci reazioni da parte dei pontefici dell’epoca.
In realtà, durante l’VIII e il IX secolo i rapporti tra le due Chiese andarono sempre
più deteriorandosi; inoltre, quella di Costantinopoli tendeva a considerarsi la custode
dell’ortodossia cristiana davanti alle deviazioni dottrinali e disciplinari, reali
o supposte tali, dei latini, cioè dei cristiani d’Occidente. Di conflitto in conflitto,
le due cristianità si allontanarono sempre più l’una dall’altra e, senza giungere
alla rottura completa delle loro relazioni, dal 1054 finirono con lo scomunicarsi
reciprocamente.
Bisanzio aveva ereditato da Roma il senso dell’universalità e il rispetto delle differenze.
L’importanza che rivestiva l’idea dell’impero non impedì infatti a Costantinopoli
di riconoscere una pluralità di poteri (particolarmente nei paesi conquistati dagli
slavi, dall’Ucraina alla Serbia) e di sistemi giuridici caratterizzati da norme particolari.
Ma l’imperatore di Costantinopoli considerò sempre il suo un potere «ecumenico», cioè
coestensivo al mondo cristiano e, al di là, all’antico impero romano, anche se nella
realtà i territori che erano sotto il suo controllo tendevano a ridursi sotto i colpi
inferti dall’Islam arabo e poi turco in Oriente, e dai longobardi e in seguito dai
normanni in Italia. Di conseguenza, Bisanzio non vedeva di buon occhio tutto ciò che
poteva assomigliare alla ricostituzione di un impero romano in Occidente, come fu
il caso di Carlo Magno nell’800 e di Ottone I nel 962. Il vescovo di Cremona Liutprando,
nel colorito racconto della sua ambasciata a Costantinopoli per conto di Ottone I
nel 968, evoca molto realisticamente l’ira che colse l’imperatore Niceforo Foca, già
esasperato perché chiamato «imperatore dei Greci» in alcune lettere pontificie, quando
egli vantò dinanzi a lui la potenza militare del suo signore. Questo gli valse in
cambio uno sfogo violento: «Voi non siete Romani, ma Longobardi!»6. L’impero non può non essere universale e indivisibile. Se sussisteva ancora una
patria romana, una Romania, era proprio in Oriente, a Costantinopoli, che questa aveva la sua sede e le sue
assise. E poiché la Chiesa di Roma rivendicava il primo posto nella cristianità, avanzando
il fatto che essa possedeva le reliquie degli apostoli Pietro e Paolo, a Costantinopoli
avevano creato la leggenda secondo la quale era stato l’apostolo Andrea, fratello
di Pietro e «primo chiamato» da Cristo, a consacrare il primo vescovo di Bisanzio...
Fiera delle sue reliquie, soprattutto quella della Vera Croce che sant’Elena, madre
di Costantino, aveva portato da Gerusalemme e delle sue icone acherotipe della vergine,
come quella delle Blacherne che aveva la reputazione di aver salvato più volte la
città assediata, Costantinopoli aveva i titoli per considerare che ormai la nuova
Roma superava la prima, sia nella continuità, e quindi nella legittimità, che nella
prospettiva di un rinnovamento, sempre sperato, di un impero romano chiamato a svolgere
un ruolo provvidenziale nella storia della salvezza.
2. Sulle tracce della Roma cristiana (IX-XI secolo)
Le potenzialità di Roma: ricordi, leggende, ideologie Benché schiacciata dal confronto con la sua brillante rivale, la vecchia Roma aveva
ancora delle potenzialità. Paradossalmente, la prima stava proprio nella sua stessa
miseria, o meglio in quell’immensità di rovine ereditate dalla città antica. Nel corso
dei secoli, infatti, queste ultime avrebbero colpito la sensibilità di numerosissimi
visitatori, ispirando loro una gamma di reazioni emotive che andavano dal semplice
rimpianto all’idea che una potenza occulta, ma che avrebbe potuto ridestarsi un giorno,
ancora sopravvivesse in quei resti polverosi. In un Occidente diventato essenzialmente
rurale, dove le città, ancora rare e poco sviluppate, non si distinguevano bene dalle
campagne circostanti e non avevano altri monumenti che le loro chiese, Roma, per quanto
decaduta, appariva ancora molto vasta e straordinariamente ricca. In nessun altro
luogo si poteva incontrare un insieme di edifici di una tale imponenza. Ma Roma era
più di una città: era la città per eccellenza, insieme Urbs e Civitas, termine che secondo la definizione di sant’Agostino nel De civitate Dei (I, 15) designa «una moltitudine di uomini uniti dai legami della concordia». Le
città che avrebbero potuto rivaleggiare in splendore con Roma erano di difficile accesso:
gli unici occidentali a frequentare Costantinopoli erano mercanti e diplomatici italiani,
Cartagine, Siviglia e Palermo erano in mano musulmana. Lo stesso Carlo Magno non riuscì
mai a fare di Aquisgrana una vera capitale imperiale e solo la cappella palatina,
con la tomba dell’imperatore, rimane ancora a testimoniare questo sogno interrotto.
Di conseguenza, la prestigiosa eredità della romanità si concentrò su Roma, quintessenza
di tutto quello che poteva esistere di grande e di bello in questo mondo, anche se
alcune città come Ravenna e Milano o Reims (che pretendeva di essere stata fondata
da Remo, come nel X secolo ricorda fieramente Flodoardo), Bamberg o Pisa cercarono,
più o meno felicemente, di contenderle questo titolo. Più tardi altre città, per ostentare
una qualche fratellanza con Roma, inventarono o riscoprirono a loro uso leggendarie
origini troiane, come Padova nel XIII secolo con l’invenzione del corpo di Antenore,
presunto compagno di Enea. Ma solo Roma riusciva a sintetizzare un impressionante
quadro monumentale e un insieme di ricordi e di miti sui quali senza posa si innestavano
nuove rivendicazioni ideologiche.
La caratteristica di essere un punto di riferimento obbligato, che sarà peculiare
di Roma fino all’epoca moderna, è particolarmente evidente nel campo culturale. Con
la «rinascita carolingia» dell’VIII e IX secolo si avvia un po’ ovunque in Occidente
un movimento di ritorno al «buon» latino dal quale le lingue romanze si erano progressivamente
allontanate, al latino di Agostino e Lattanzio piuttosto che a quello di Cicerone
e Livio. Era la lingua della Vulgata, la Bibbia tradotta in latino da san Girolamo, che durante l’alto Medioevo si era
imposta a tutto l’Occidente, ma era soprattutto la lingua della liturgia, che doveva
essere celebrata in latino. Senza cadere nell’esagerazione, si può definire l’Occidente
medievale come l’insieme dei popoli che usavano il latino come lingua liturgica e
potremmo anche aggiungere come unica lingua scritta per il periodo che precede il
IX secolo, giacché le lingue vernacolari, tranne rare eccezioni, non lo erano. Questa
«rinascita», di cui non bisogna esagerare né l’ampiezza, né l’originalità, non era
legata direttamente a Roma; procedette piuttosto da iniziative locali di monaci, vescovi
o sovrani di regioni molto lontane tra loro: l’Irlanda e l’Inghilterra settentrionale,
la metà settentrionale della Francia con le abbazie di Corbie e Fleury-sur-Loire,
l’Italia settentrionale con Vercelli e Verona e, più tardi, l’Italia meridionale con
l’abbazia di Montecassino. Roma ne trasse un beneficio indiretto: questo movimento
infatti aveva ravvivato il ricordo della sua cultura pagana e cristiana, particolarmente
attraverso le opere di Gregorio Magno, il papa (590-604) che aveva difeso la città
contro la minaccia dei longobardi e i cui testi furono molto letti e commentati durante
il Medioevo. Così, quando all’inizio del IX secolo i sovrani carolingi intrapresero
la riforma dei monasteri, a tutti i monaci occidentali fu imposta la regola di san
Benedetto, già in precedenza largamente diffusa, ma alla pari di altre regole monastiche.
Questo testo doveva certamente il suo successo alle proprie qualità intrinseche, tra
cui la moderazione e l’equilibrio non erano certo le meno importanti, ma anche alla
figura del suo autore, quel Benedetto fondatore di Montecassino di cui Gregorio Magno
aveva scritto una vita e a cui si attribuiva una regola della quale la Chiesa romana
aveva raccomandato l’uso nei secoli seguenti. Rivolgersi verso Roma, adottare gli
usi romani, significava per il clero del tempo riallacciarsi alla purezza delle origini
senza avere l’impressione di riformare. Lo stesso vale per i testi giuridici: alla
ricerca di libri autentici, esenti da errori o da aggiunte avventizie e tali da essere
adottati in tutto l’impero franco, i sovrani carolingi si rivolsero alla Chiesa romana.
Nel 774 questa rispose pienamente alle loro aspettative indirizzando la collezione
canonica detta dionysio-hadriana. Questa codificazione di testi conciliari e di decretali pontificie, redatta all’inizio
del VI secolo da Dionigi il Piccolo e rivista da papa Adriano I nell’VIII secolo,
era destinata a esercitare una profonda influenza sul diritto ecclesiastico in tutto
l’Occidente e a contribuire alla sua unificazione.
Ma l’irradiamento culturale di Roma non seguiva sempre percorsi tanto chiari e, nel
complesso, logici. Così il fascino che i suoi monumenti esercitarono lungo tutto il
Medioevo nulla doveva alla scienza dei suoi abitanti. Come ancora alla metà del XIV
secolo notava Petrarca, i romani erano forse i meno capaci di comprendere il proprio
passato e i meno sensibili alla sua grandezza. Questo severo giudizio sembra confermato
dalla tranquilla incoscienza con la quale per secoli i marmorai contribuirono a distruggere
gli ornamenti di marmo, di serpentino o di porfido che decoravano le antiche costruzioni
per trasformarli in variopinti pavimenti per le chiese o ridurli a piccole tessere
policrome per decorare i cancelli e l’ornatissimo candelabro del cero pasquale. Ma
l’emozione che le rovine di Roma ispiravano ai pellegrini e ai visitatori stranieri,
più che a ragioni estetiche, era dovuta a un’aura di mistero che ne alimentava il
fascino. Numerose leggende, fiorite soprattutto dall’XI secolo e riprese da alcune
guide o da racconti di viaggio, diffusero l’idea che gli imperatori romani avevano
seppellito le loro enormi ricchezze nel sottosuolo della città, soprattutto sotto
i palazzi in rovina. La «leggenda nera» del già ricordato Gerberto (papa dal 999 al
1003 con il nome di Silvestro II), trasmessa alla metà del XII secolo dal cronista
e monaco inglese Guglielmo di Malmesbury, riferisce che questo ecclesiastico, colto
e curioso di tutto, fece scavare il suolo romano nella direzione che una statua antica
indicava con la sua mano. La trincea arrivò rapidamente su una galleria in cui Gerberto
si introdusse coraggiosamente e che lo condusse a una sala dove lo attendevano alcuni
personaggi antichi, immobili e silenziosi tra immensi tesori e oggetti preziosi: ma
quando Gerberto volle mettere la mano su uno di questi, improvvisamente i fantasmi
si animarono e lo colpirono violentemente costringendolo alla fuga... Si raccontava
anche che la collina del Testaccio fosse composta dai resti dei vasi che avevano contenuto
i tributi portati a Roma dai popoli che le erano sottomessi. Furono racconti di questo
genere che probabilmente diedero origine al titolo Roma aurea che appare spesso nei testi medievali e, dall’XI secolo, sulle «bolle d’oro» degli
imperatori, titolo che si riferisce più all’immagine mitica della città che alla sua
prosperità economica. In ogni modo, questa denominazione non è assolutamente debitrice
di una forma qualsiasi di sensibilità artistica, le cui prime tracce apparvero in
alcuni viaggiatori inglesi. Intorno al 1140 il vescovo di Winchester Enrico di Blois
provocò la sorpresa e lo scherno dei romani acquistando statue antiche, soprattutto
femminili, per portarle nel suo paese; verso il 1220, un altro clerico inglese, Maestro
Gregorio, fu autore di un’interessantissima Narratio de mirabilibus urbis Romae, dove sorprendentemente prevale un interesse quasi esclusivo per i monumenti della
Roma pagana. Gregorio esprime con parole commosse l’ammirazione che provò alla vista
di una statua di Venere che, ammette, tornò a vedere più volte, talmente la trovava
vivente e animata. Ma, a quest’epoca, un simile approccio «antiquario» alla città
è ancora eccezionale e non deve essere apprezzato anacronisticamente: il fascino esercitato
da alcune statue antiche, alle quali l’opinione popolare attribuiva volentieri un’origine
magica o anche demoniaca, non era forse dovuta soprattutto al carattere eccezionale
che rivestiva allora la scultura a tutto tondo, tecnica il cui uso era ormai andato
perso da secoli?
In ogni caso, Roma era per eccellenza il luogo dei mirabilia, prodigi e storie fantastiche a mezza strada tra il miracoloso propriamente detto,
che poteva essere esclusivamente religioso o cristiano, e la realtà storica dell’antichità,
largamente ignorata dai contemporanei di Ottone III o di Gregorio VII. Ma avremmo
torto a disprezzare questa letteratura, che contribuì a trasmettere fino alle regioni
più remote del mondo cristiano, forse ancora più di quanto abbiano fatto le copie
dei manoscritti dei testi di Virgilio o di Ovidio accessibili solo a una minoranza
di letterati, una certa idea di Roma, indubbiamente favolosa e talvolta inesatta.
Così tra il 1151 e il 1154 un abate islandese, Nicola di Munkathvera, redasse per
i suoi compatrioti una guida di Roma a partire dai Mirabilia urbis Romae, raccolta di leggende e racconti sui principali monumenti della città ad uso dei
pellegrini, composta nel 1140-43 da Benedetto, un canonico di San Pietro, e destinata
a conoscere un grandissimo successo fino alla fine del Medioevo, sia nella versione
latina che in quella volgare. Non si trattava in realtà di guide descrittive nel senso
moderno del termine, ma piuttosto di una forma di letteratura celebrativa che non
dava troppo peso alla cronologia e talvolta neanche alla topografia, ma cercava innanzitutto
di associare personaggi esemplari o racconti moralistici ai luoghi in cui il visitatore
non poteva evitare di passare. È difficile sapere in quale maniera questi testi si
diffusero e impregnarono gli spiriti dell’epoca. Ma probabilmente Roma era con Gerusalemme
l’unica città che i cristiani d’Occidente conoscessero almeno di nome, e che già immaginavano,
mille anni prima dell’eroe della Modification, come «una fonte di meraviglie e di oscurità»7.
Rinascite e rinnovamenti dell’idea romana Perché Roma e quale Roma? In questo periodo caratterizzato dalla frantumazione feudale
e dalla territorializzazione del potere e delle leggi, solo le rovine dei palazzi
imperiali perpetuano tangibilmente il ricordo dell’impero romano, vasta organizzazione
statale e centralizzata, che per secoli aveva governato la maggior parte del mondo
allora conosciuto, grazie a un’amministrazione efficace e a leggi eccellenti, di cui
alcuni formulari giuridici ancora in uso in alcune regioni prolungavano l’eco. La
storia romana era a tal punto ignorata che queste poche conoscenze certe non potevano
esprimersi altrimenti che attraverso racconti fantastici. In questa prospettiva, uno
dei più interessanti è la Salvatio Romae, il cui tema è quello del «segreto» che permise all’impero romano di durare così
a lungo. È una tradizione che incontriamo già in un trattato dell’VIII secolo sulle
Sette meraviglie del mondo e nel X secolo, nella cronaca detta di Salerno, opera di un monaco benedettino originario
dell’Italia meridionale, e che passò in seguito nella raccolta romana dei Mirabilia, scritti nel XII secolo, anche se alcuni racconti risalgono probabilmente al Mille8. Secondo queste diverse versioni, più o meno concordanti nei particolari, nell’antichità
si trovava sul Campidoglio un gruppo di settanta statue che rappresentavano i popoli
della terra sottomessi a Roma. Ciascuna di esse era munita di piccoli campanelli d’argento
che si mettevano a suonare non appena nella provincia in questione scoppiava un’insurrezione
contro il potere centrale. I sacerdoti che avevano il compito di sorvegliarle avvertivano
immediatamente le autorità imperiali, che potevano intervenire tempestivamente e reprimere
la sollevazione prima che questa si sviluppasse. Non è certo un caso se in tutte le
versioni di questo racconto la scena si svolge sul Campidoglio, considerato come il
centro del potere politico romano. E siccome piove sempre sul bagnato, si attribuiva
a Virgilio, contemporaneamente poeta e indovino e quindi un po’ mago, la paternità
di questa prodigiosa invenzione... In altre tradizioni letterarie medievali il ricordo
persistente delle istituzioni antiche e il superamento dei particolarismi che poteva
operarsi solo all’interno della loro organizzazione fanno apparire Roma come lo spazio
delle leggi e il luogo privilegiato dove «Plus grande justice ne fut mes» (non ci
fu mai giustizia più grande)9.
Effettivamente, non appena in Occidente si fecero sentire gli effetti della crescita
demografica e si affermò un potere forte, quello dei re franchi, da Carlo Martello
a Pipino, con l’appoggio di un papato che l’allontanamento di Bisanzio aveva privato
di sostegno temporale, si assistette a un ritorno verso Roma. Questa era la prima
di una serie di «rinascite» che gli storici faticano a distinguere le une dalle altre
e a definire esattamente, a tal punto questo movimento di riflusso verso la romanità
è evidente nelle sue grandi linee, ma difficile da cogliere nei particolari. Il termine
latino di renovatio, usato nei testi contemporanei per esprimere questo complesso processo, corrisponde
meglio a quella che fu la realtà: si trattò infatti di fasi di recupero di ricordi
e di valori della cultura romana durante le quali alcuni ceti dirigenti, numericamente
molto ridotti, si sforzarono di fronteggiare i problemi attingendo all’eredità del
passato romano. Davanti all’antichità si sentivano come degli eredi legittimi che
avessero per lungo tempo trascurato di occuparsi del loro bene e che volevano far
valere i loro diritti prima che questi cadessero in prescrizione; ma cercando di fare
del nuovo con del vecchio, in un contesto storico e culturale che non aveva più nulla
a che vedere con l’epoca di Augusto o di Costantino, giunsero spesso a risultati che
si allontanano dal modello ideale cui pretendevano di ispirarsi. Non bisogna quindi
farsi ingannare dalle declamazioni dei pubblicisti ufficiali a proposito di questi
«rinnovamenti» successivi dell’impero romano, la cui stessa ripetizione ne dimostra
il carattere superficiale e, in larga misura, artificiale. Quello che si rivela più
interessante in questo approccio è l’idea, allo stesso tempo improntata a umiltà e
fascino, che il dominio del presente passi attraverso un ritorno a Roma. Quest’ultima
continua a svolgere un ruolo decisivo, non tanto in quanto città ma come ricettacolo
di una forma superiore di civiltà e come modello sempre in grado di rispondere alle
sfide della storia.
Tutte le imprese di questo genere si iscrivevano nel segno della continuità e cercavano
di riallacciarsi a un passato che non potevano credere finito per sempre. Questo è
particolarmente vero a proposito del tentativo di restaurazione dell’impero in Occidente
da parte di Carlo Magno, incoronato imperatore a Roma il 25 dicembre 800 da papa Leone
III. Questo avvenimento, che colpì profondamente i contemporanei e rimase impresso
nella memoria collettiva, era il punto d’arrivo di un processo di avvicinamento tra
il papato e i franchi iniziato nel 753 con il viaggio di papa Stefano II in Francia
per l’incoronazione di Pipino. La sacra unzione conferiva alla sua dinastia una legittimità
incontestabile dopo l’eliminazione dei Merovingi già approvata dal predecessore di
Stefano II, papa Zaccaria. Da allora, i franchi divennero i protettori ufficiali della
Chiesa romana, particolarmente contro i longobardi, che finirono con il sottomettere
alla loro autorità. A partire dal momento in cui un solo sovrano regnava su tutta
la «Francia» e sulla maggior parte del territorio germanico e italiano e che tutta
la cultura dell’epoca aveva come elemento comune il recupero dei valori della civiltà
romana e cristiana, era logico che i maggiori esponenti del clero franco e della Curia
romana abbiano pensato di ristabilire l’impero, il cui corso in Occidente era stato
interrotto nel 476 con la deposizione di Romolo Augustolo. Ma benché Carlo Magno avesse
fatto incidere sui suoi sigilli l’iscrizione renovatio Romani imperii («restaurazione dell’impero romano»), questa non poteva essere un semplice ritorno
al passato. Per quanto grande fosse l’ammirazione che nutriva per Roma, il nuovo imperatore
era un sovrano decisamente poco romano, che in realtà desiderava far passare tutto
l’Occidente sotto l’impero dei franchi e realizzare sulla terra una società cristiana,
riflesso della città di Dio, fondata su una forte intesa tra un rector o un defensor civitatis, che non era altri che lui, il papa e i vescovi. Il suo modello ideale era il re
David, non Augusto o Traiano, e in cambio della sua fedeltà e del suo sostegno si
attendeva dalla Chiesa romana una collaborazione leale e senza riserve. Di fatto,
Roma non lo trattenne a lungo e l’imperatore stabilì la capitale ad Aquisgrana, per
il cui decoro furono fatti giungere colonne e marmi presi dagli antichi monumenti
di Ravenna. La struttura politica che per semplicità chiamiamo impero carolingio era
nella realtà un insieme di regni posti sotto l’autorità di un medesimo sovrano o di
alcuni membri della sua famiglia, che non si dotò mai di una legislazione organica
o di un diritto ispirato al modello romano. I popoli che ne facevano parte rimanevano
sottomessi alle leggi germaniche; solo la Chiesa viveva secondo la legge romana e
il potere imperiale prese delle misure per riportare il clero a questa tradizione
che fuori Roma era andata in gran parte perduta. Tutto ciò non significa che Carlo
Magno abbia elaborato il progetto di ricostruire quello che era stato l’impero di
Costantino, che del resto sarebbe stato impossibile realizzare nelle condizioni dell’epoca.
È qui che si misura tutta l’ambiguità della parola renovatio, che implica al contempo il riferimento a un modello ideale e il desiderio di infondergli
vita sotto una forma nuova (reformatio), giudicata superiore alla precedente. Con i sovrani carolingi l’impero si prefigge
l’obiettivo del rinnovamento congiunto della Chiesa e dello Stato, uniti dal desiderio
di riallacciarsi alla grandezza e alla bellezza della Roma cristiana antica. Ma il
suo quadro geografico si sposta verso ovest e il mondo mediterraneo, riferimento fondamentale
nell’antichità, lascia il posto alle nozioni di Occidente e di Europa, in una prospettiva
contemporaneamente antibizantina e anti-islamica. Non è un caso se l’espressione «gli
europei» apparve per la prima volta in una cronaca della vittoria riportata nel 732
da Carlo Martello nella battaglia di Poitiers contro i musulmani venuti dalla Spagna,
e se Carlo Magno sarà più tardi considerato a torto il primo sovrano ad aver preso
il comando di una crociata. Ma dopo tutto l’errore era scusabile, poiché alla vigilia
della sua incoronazione l’imperatore aveva effettivamente incontrato a Roma il patriarca
di Gerusalemme e nell’812 finì per essere riconosciuto dall’impero bizantino. In realtà,
in un contesto cristiano non si poteva pensare alla nozione di impero al di fuori
di un triplice riferimento a Roma, Costantinopoli e Gerusalemme.
Tuttavia, le basi del potere carolingio erano fragili. I particolarismi regionali
e le rivendicazioni dell’aristocrazia, laica ed ecclesiastica, senza la cui collaborazione
il re non poteva governare, indebolirono rapidamente l’impero. Né l’imperatore Lotario,
né tantomeno Ludovico II, allora re d’Italia, riuscirono a proteggere San Pietro dal
sacco dei saraceni dell’846 e dopo Carlo il Calvo, che nell’875 venne a Roma per ricevere
la corona dalle mani del papa, fino al X secolo nessuno dei suoi successori varcò
le Alpi per essere incoronato nella basilica vaticana. Nel 962, con l’incoronazione
di Ottone I a Roma, il titolo imperiale passò dai franchi ai sassoni, ma questo impero
aveva di romano solo il nome. Il suo centro di gravità era ora in Germania: nonostante
il matrimonio di Ottone II con la principessa bizantina Teofano, l’impero rimarrà
limitato a una parte dell’Occidente che non includeva neanche tutta l’Italia, poiché
il Sud della penisola ne rimaneva tuttora escluso. Stabilendo la sua capitale a Roma,
il successore Ottone III cercò invano di far coincidere il sogno con la realtà. Come
abbiamo visto, il giovane imperatore dovette ben presto disilludersi e nel 1002 l’avventura
fu interrotta dalla sua prematura scomparsa. Non per questo l’idea dell’impero fu
abbandonata, e la dinastia tedesca dei Sali ne riprese il titolo e la funzione. Ma
a Roma il papato cadde di nuovo sotto la sfera di influenza delle grandi famiglie
aristocratiche e nel X secolo la perdita di autorità sembrava destinata a durare nel
tempo. Nell’Occidente dell’anno Mille i focolai di vitalità religiosa e culturale
erano costituiti da alcuni monasteri lontani come Reichenau, sulle rive del lago di
Costanza, Cluny, in Borgogna, Fleury-sur-Loire, Poitiers in Aquitania o Ripoll in
Catalogna. E come era già avvenuto alle origini della rinascita carolingia, è in queste
regioni periferiche rispetto all’Italia che dal X secolo si assiste a una crescita
della romanità, percepibile dapprima nell’architettura e illustrata dallo sviluppo
che conobbe la prima arte romanica, e che ben presto si estese ad altri campi: la
pittura, la scultura, la miniatura e la copiatura di alcuni autori antichi, come Terenzio,
le cui commedie erano recitate dalle consorelle di Hroswitha, badessa di Gandersheim,
nell’estremità più remota della Sassonia. Una romanità ancora povera che, in un primo
tempo, mirava più a resuscitare formule antiche, prese a prestito dall’arte e dalla
letteratura della tarda antichità, che a innovare, ma che doveva progressivamente
arricchirsi di elementi originali e finire per raggiungere Roma.
Roma città santa e capitale del mondo cristiano Eppure, dalla fine del IX secolo la città era di fatto solo un centro ecclesiastico
che esercitava un’influenza limitata. Agli occhi del clero e dei fedeli dell’epoca
appariva innanzitutto come un enorme giacimento di reliquie dove vescovi, abati e
personaggi in vista venivano a comprare, talvolta a rubare, i preziosi frammenti dei
corpi dei martiri per collocarli sugli altari o nei tesori delle loro chiese. In questo
senso, le catacombe erano miniere che offrivano risorse infinite, poiché i corpi che
vi erano seppelliti erano assimilati a quelli delle sante e dei santi e i romani non
mancarono di sfruttare questa credenza e di trarne importanti profitti economici.
Ma dietro questo saccheggio sistematico dei cimiteri romani e attraverso questo anarchico
processo di diffusione dei tesori delle sue chiese fino alle più remote regioni del
mondo cristiano, si esprimeva una fede nel destino soprannaturale della città che
per manifestarsi aspettava solo l’apparire di condizioni più favorevoli.
Dalla fine dell’antichità la Chiesa aveva elaborato un’ideologia di Roma che, come
un fuoco che cova sotto la cenere, sopravvisse a lungo in un ambiente ostile prima
di accendersi di nuovo a più riprese durante l’alto Medioevo e di propagarsi all’insieme
della cristianità occidentale durante l’XI secolo. Già nel IV e V secolo alcuni autorevoli
pontefici avevano sottolineato il carattere sacro di Roma, città santa del cristianesimo,
titolo che nessun’altra città, neanche Costantinopoli, poteva contestarle. Su questo
piano, la sola a poter concorrere con Roma era Gerusalemme, ma dal VI secolo essa
era caduta nelle mani dei persiani e poi dei musulmani, e per i cristiani era solo
un luogo della memoria e una speranza escatologica.
Eppure all’inizio non sembrava evidente che il cristianesimo fosse destinato a penetrare
all’interno della struttura stessa dell’impero romano, dal quale era stato dapprima
perseguitato – persecuzione episodica e discontinua, se si escludono alcuni momenti
di parossismo. Nell’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse attribuita all’apostolo Giovanni, Roma appare sotto una luce estremamente negativa:
per odio del vero Dio la città empia e viziosa cerca inutilmente di far scomparire
i suoi servitori. Nuova Babilonia, grande meretrice, Roma incarna le forze del male
scatenate per ostacolare la diffusione della Parola di Dio e l’annuncio della salvezza.
Altri cristiani faranno proprie queste accuse. Lo stesso sant’Agostino, nel De civitate Dei, scritto all’indomani del profondo trauma provocato dalla presa e dal sacco di Roma
da parte di Alarico nel 410, ricordava ai suoi lettori disorientati dalle critiche
dei pagani – i quali facevano ricadere sulla nuova religione la responsabilità di
questo dramma – che ai tempi di Romolo e Remo la città era stata un asilo aperto ai
briganti e che era nata dal fratricidio di Remo, sotto il segno della discordia, dell’orgoglio
e della violenza. Alcuni decenni dopo, Salviano di Marsiglia non esiterà a invitare
la Chiesa a «passare ai barbari» piuttosto che macchiarsi con i romani corrotti...
Ma si trattava di voci isolate, perché da quando con Costantino e soprattutto con
Teodosio l’impero era diventato cristiano, le prospettive erano mutate. Da persecutore
che era, il potere imperiale divenne di fatto strumento della cristianizzazione e,
ben presto, della difesa dell’ortodossia contro le eresie. Con Eusebio di Cesarea
appare in Oriente un’interpretazione provvidenzialistica del ruolo dell’impero romano,
chiamato da Dio a preparare la strada all’evangelizzazione unificando sotto la sua
autorità la maggior parte del mondo allora noto, interpretazione che conoscerà un
brillante avvenire fino a Bossuet e anche oltre. L’Occidente rimarrà per qualche tempo
più riservato: abbiamo visto come sant’Agostino ricordò ai suoi contemporanei che
il destino del cristianesimo non era indissolubilmente legato a quello di Roma, il
cui impero avrebbe potuto scomparire. Agli occhi del vescovo di Ippona, l’essenziale
era la sopravvivenza e la crescita della Chiesa, che già si estendeva oltre le frontiere
politiche del mondo romano. Tuttavia, nonostante la grande influenza che il suo pensiero
doveva esercitare nei secoli a venire, Agostino su questo punto non trovò un largo
seguito. L’interpretazione storica che prevalse fu quella dello spagnolo Orosio, suo
contemporaneo (ca. 380-dopo il 420), che nella sua Historia adversus paganos commentò il famoso sogno di Nabucodonosor riportato nel libro del profeta Daniele
(2, 1-45)10. Nabucodonosor vide in sogno quattro statue colossali (interpretate come i simboli
dei successivi imperi destinati a dominare il mondo) crollare l’una dopo l’altra,
a cominciare da quella di Babilonia. Seguendo questa interpretazione, la tradizione
cristiana riconoscerà unanimemente nel quarto colosso dalle gambe di ferro e nella
quarta bestia dai denti di ferro che appare in un’altra visione di Daniele (Dan. 7) l’impero romano destinato, secondo Orosio, a durare fino alla fine dei tempi,
poiché l’opera di cristianizzazione del mondo doveva proseguire sotto il suo impulso11.
Il tema della rigenerazione di Roma e dell’impero attraverso il battesimo conobbe
un successo completo poiché subentrava, infondendogli nuova vita, a quello dell’eternità
di Roma evocato da Virgilio in un verso dell’Eneide spesso citato (I, 279): His [...] imperium sine fine dedi («A questi [...] ho concesso un impero senza fine»). Nell’alto Medioevo questo tema
si concretizzerà associando queste promesse al destino di alcuni monumenti della città
che sembravano inalterabili nel tempo, come indica un poema anonimo citato nel VII
secolo da Beda il Venerabile: Quamdiu stat Colisaeus / Stat et Roma / Quando cadet Colisaeus / Cadet Roma / Quando
cadet Roma / Cadet et mundus («Fin quando il Colosseo rimarrà in piedi, lo sarà anche Roma. Quando il Colosseo
crollerà, Roma crollerà. Quando crollerà Roma, crollerà anche il mondo»)12.
Come abbiamo visto, l’immancabile interrogativo era sapere se questa Roma cristiana,
promessa a un così lungo avvenire, era proprio la vecchia Roma convertitasi dal paganesimo
o la «nuova Roma» di Costantinopoli, nata cristiana. Dalla fine del IV secolo la Chiesa
romana risponde ribadendo che essa era la sola chiamata a dirigere il mondo cristiano
perché detentrice delle reliquie dei santi Pietro e Paolo, fondatori della Chiesa
e principali propagatori del Vangelo. Non c’erano dubbi di sorta: Roma era chiaramente
la madre e Costantinopoli la figlia, figlia certo votata a un grande destino politico
in quanto capitale dell’Oriente, ma inferiore in dignità alla «regina delle città»,
la Roma Christiana. Da papa Damaso in poi, si assiste all’affermazione di una sorta di «nazionalismo
romano», secondo la fortunata espressione di Richard Krautheimer, che condurrà papa
Leone I (440-461) ad affermare che «è attraverso il trono di Pietro che Roma è diventata
la capitale del mondo»13. Quindi già alla fine dell’antichità la Chiesa rivendica la capacità di far suo il
destino di Roma e dell’impero. Proprio quando quest’ultimo, inteso come realtà politica
e amministrativa, stava scomparendo in Occidente e l’influenza esercitata dalla «madre
delle città», come già la si chiamava al tempo di Augusto, si avviava a un declino
che doveva condurla a una sorta di letargia, l’ideale della pax Christiana soppianta e supera quello della pax Romana, ormai allo stremo. Andando nello stesso senso, lo storico Orosio non aveva esitato
ad affermare che Cristo si era fatto romano accettando di nascere nell ’impero e di
rendere a Cesare quello che è di Cesare14. Così facendo, egli metteva la res publica Romana e la Chiesa in un rapporto di continuità storica: ormai la cristianizzazione di Roma
doveva avanzare di pari passo con la romanizzazione del cristianesimo (fig. 1). Nell’Occidente
medievale questa convinzione impregnò così profondamente le coscienze che novecento
anni più tardi, alla fine del suo Purgatorio, Dante – evocando, è vero, il cielo e non la terra – non esiterà a far dire a Beatrice:
«e sarai meco sanza fine cive / di quella Roma onde Cristo è romano» (Purg. XXXII, 101-102).

Fig. 1. Dittico di Rambona: la crocefissione di Cristo con Romolo e Remo nutriti dalla lupa, avorio, X sec. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Sacro.
Firenze,
foto Scala.
Ma il passaggio dall’antichità pagana alla Roma cristiana non poteva ridursi a un
semplice passaggio di testimone: preso alla lettera, il tema dell’eternità di Roma
non aveva senso, e in una prospettiva che faceva di Dio il padrone della storia rischiava
di apparire sacrilego, come aveva ben visto sant’Agostino. Più che sulla sua immutabilità,
difficilmente sostenibile proprio quando questa era messa a dura prova, gli autori
cristiani insistettero su una perpetuità che non escludeva né l’invecchiamento – la
vecchiaia può essere sinonimo di saggezza e di serenità – né tantomeno un rinnovamento
sempre possibile, a costo di adattarsi a nuovi contesti politici e culturali. La Roma
pagana si era impadronita del mondo; la Roma cristiana regnerà sulle anime. Invece
di scomparire, sarà ormai la sede di un doppio potere, contemporaneamente temporale
e spirituale, ciò che le permette di rivendicare il titolo di città regia che Costantinopoli
si era arrogata da quando ospitava la persona dell’imperatore, ma che la Roma dei
papi stimava di meritare a maggior titolo per le reliquie e i ricordi di Pietro e
Paolo, queste «due luci del mondo», come nel 382 scriveva sant’Ambrogio di Milano,
e per tutti i martiri che avevano versato il loro sangue all’epoca delle persecuzioni
e i cui nomi erano evocati nel canone della messa. Questo credo doveva imprimersi
profondamente nell’immaginario occidentale e alla metà del XIV secolo santa Brigida
di Svezia, in una delle sue prime visioni, sentirà ancora la voce di Dio dirle: «Va’
a Roma dove le piazze sono rosse del sangue dei martiri», frase che probabilmente
riecheggia il canto intonato dai pellegrini quando, al termine del loro cammino, intravedevano
San Pietro: «O Roma nobilis orbis et domina [...], / roseo martyrum sanguine rubea»15. E anche quando Brigida avrà conosciuto, per avervi abitato a lungo, la deludente
realtà della città, la sua Roma rimarrà sempre quella che aveva sognato e che aveva
rivelato la fede cristiana al suo lontano paese.
Queste profonde convinzioni che animavano la Chiesa romana e tutti coloro che in Occidente
guardavano ad essa non potevano non avere ripercussioni in termini di potere. Come
alla fine dell’XI secolo Benzo d’Alba scriverà all’imperatore tedesco Enrico IV: «Roma
esulta di gioia e volge le sue lodi agli apostoli per i loro santi meriti grazie ai
quali essa detiene oggi l’Impero»16. È a Roma infatti che Pietro, come un nuovo Enea, era venuto a portare la croce sulla
quale doveva morire crocifisso come il suo divino maestro, segno della vittoria del
Cristo e dell’universalità della sua redenzione (fig. 2). La Chiesa romana, di cui
era stato il fondatore, era quindi saldamente stabilita sulla sede episcopale di Pietro
(Petri sedes) e i suoi successori potevano legittimamente parlare con autorità dall’alto di questa
cattedra (cathedra Petri), che sarà ben presto commemorata da una festa liturgica e della quale il trono di
bronzo offerto alla basilica nell’875 dall’imperatore Carlo il Calvo e poi incastonato
nella «gloria» del Bernini sarà considerato più tardi come raffigurazione simbolica.
Fin da allora il papato si definisce dunque come un’istituzione sacra a vocazione
universale, fondata sul rapporto privilegiato e unico che esiste, attraverso Pietro
e Paolo, tra la sede apostolica e la Chiesa intera, rivendicando a questo titolo il
primato sulle altre Chiese cristiane.

Fig. 2.
Crocefissione di san Pietro, affresco, inizio XII sec. Pisa, chiesa di San Pietro in Grado. Firenze, foto Scala.
«Interpretatio Christiana»: una rilettura cristiana della storia di Roma È in questo contesto religioso e psicologico che bisogna ricollocare, per comprenderlo,
quel processo culturale esteso su più secoli che prende il nome di «interpretazione
cristiana». È una rilettura selettiva e deformante, alla luce della fede cristiana,
del passato antico, o di quanto se ne conosceva all’epoca, allo scopo di sottolineare
la continuità esistente tra le due fasi della storia di Roma, la storia profana che
precede la conversione di Costantino e la successiva storia sacra. Durante l’alto
Medioevo si svilupparono su questo tema numerose leggende, ben studiate da Arturo
Graf nel suo libro precursore Roma nella memoria e nell’immaginazione del Medio Evo17. Intorno al 1260 una buona parte di queste leggende finì per essere ripresa nella
Leggenda aurea di Jacopo da Varazze, che ne favorì ancora la diffusione in tutta la cristianità
occidentale18. Leggiamo così che la Sibilla tiburtina (cioè di Tivoli, vicino Roma) annunciò ad
Augusto la nascita di un bambino che sarebbe presto disceso dal cielo; poco tempo
dopo l’imperatore avrebbe avuto la visione di una vergine con un bambino e dell’iscrizione
«Questo è l’altare del cielo» (haec est Ara coeli); Augusto avrebbe subito trasformato in cappella la stanza sul Campidoglio in cui
gli era apparsa l’immagine e dove in seguito sorgerà la chiesa dedicata a Santa Maria
in Aracoeli. Si raccontava anche che a Roma nella notte della natività di Cristo un fiotto d’olio
sarebbe scaturito in un luogo detto taberna meritoria, su cui sarà in seguito eretta la basilica di Santa Maria in Trastevere. Bisogna
collegare questo aneddoto al passo della IV egloga in cui Virgilio annuncia la prossima
nascita di un bambino la cui venuta cambierà il volto del mondo. Questi pochi versi,
interpretati durante tutto il Medioevo come un presagio della nascita di Cristo, conferiranno
al poeta la reputazione di profeta, pagano, certo, ma beneficato da «intuizioni precristiane»,
ciò che spiega perché Dante l’abbia scelto come guida nella sua esplorazione dell’aldilà.
Bisogna inserire nella stessa linea anche il destino particolare dell’imperatore Traiano,
per la cui salvezza papa Gregorio Magno avrebbe intercesso presso Dio. Il pontefice
aveva infatti interpretato come un atto di generosità verso una povera vedova uno
dei bassorilievi del foro di Traiano, oggi scomparso, che aveva in realtà un altro
significato perché rappresentava una provincia sottomessa, inginocchiata davanti all’imperatore
vittorioso, circondato da un gruppo di cavalieri19. Ispirato da questa leggenda, Dante destinò al Purgatorio (Purg. X, 73-96) l’imperatore romano, parzialmente riabilitato dalla bontà dimostrata dal
suo gesto.
Questo recupero selettivo si estende anche all’eredità monumentale dell’antichità.
Nel 609 papa Bonifacio IV (608-613) ottenne dall’imperatore bizantino Foca l’autorizzazione
a trasformare il Pantheon in una basilica dedicata alla vergine Maria e ai martiri,
e un certo numero di edifici e templi pagani sopravvissero proprio perché trasformati
in chiese cristiane o utilizzati a scopo difensivo. Questo fu il caso, in particolare,
del mausoleo di Adriano, che divenne Castel Sant’Angelo dopo la misteriosa apparizione
dell’arcangelo Gabriele a papa Gregorio Magno (590-604) durante la grande pestilenza
che colpì Roma all’inizio del suo pontificato. Ma questa relativa continuità dell’abitato
e di certi aspetti del quadro monumentale tra tarda antichità e alto Medioevo non
è il frutto di una scelta ideologica, ma piuttosto il risultato dell’incapacità della
città di dotarsi di un nuovo decoro urbano: in mancanza di altri mezzi, la nuova Roma
continuava ad abitare la vecchia, pur rinnegandola, ciò che permise ad alcuni aspetti
di quest’ultima di rimanere in vita. Così, tra le numerose statue equestri degli imperatori
l’unica a sopravvivere fu quella di Marco Aurelio, in cui, nel XII secolo, il clero
e i pellegrini credevano di vedere l’immagine di Costantino e il popolo romano quella
di Teodorico. Per il resto, Roma fu e rimase fino al XVII secolo una riserva pressoché
inesauribile di colonne e di statue antiche, dove ognuno si serviva a piacere. Il
Colosseo, che figura su quasi tutte le rappresentazioni medievali di Roma, era usato
come cava e fu sfruttato con grande facilità proprio perché nessun ricordo cristiano
era ad esso legato (per questo bisognerà attendere il XVIII secolo), in quanto veniva
comunemente considerato un antico tempio del Sole. Lo stesso Campidoglio, ritenuto
il centro del potere romano durante l’antichità, nel XII secolo avrebbe offerto riparo
a un pericoloso drago, se si deve dar credito al monaco e cronista normanno Orderico
Vitale.
A questa Roma pagana trascurata o disprezzata gli uomini del Medioevo preferivano
quella cristiana, sorta sulle basi gettate nel IV e V secolo da alcuni pontefici,
secondo un programma di cui Charles Pietri ha eccellentemente studiato l’ispirazione
e la progressiva realizzazione nella sua grande opera sulla Roma Christiana20. La città medievale, di cui popolazione e superficie si erano molto ridotte, si era
ricostituita intorno all’asse maggiore che conduceva dalla basilica di San Pietro
a quella di San Giovanni in Laterano, «cattedrale di Roma e del mondo», dove si trovava,
oltre il palazzo del papa (patriarchium), il grande battistero dove la tradizione voleva vedere il luogo del battesimo di
Costantino. Un asse minore, che da Santa Maria Maggiore andava a San Paolo fuori le
mura, incrociava il precedente. Ma queste linee direttrici non avevano nulla in comune
con le grandi vie trionfali: erano piuttosto dei cammini sinuosi che serpeggiavano
tra rovine e giardini. Nel tempo gli itinerari dei pellegrini si adattarono a queste
nuove realtà e il giro delle quattro principali basiliche appena citate, o quello
delle sette chiese principali che si imporrà in età moderna, diventeranno percorsi
rituali. Una città immaginaria si sovrappose a quella concreta, tangibile, ma agli
occhi dei pellegrini la prima era più reale della seconda. Questa Roma costituiva
anche il quadro in cui si svolgevano le vite dei principali santi cristiani e le passioni
dei martiri che avevano subito il supplizio durante il regno degli imperatori persecutori,
come san Giovanni Evangelista, che la leggenda fa morire in oleo, immerso in una vasca di olio bollente vicino a porta Latina, alla presenza del senato
romano... Anche in province relativamente lontane, come la Gallia, Roma manteneva
un importante prestigio religioso, come testimoniano i testi agiografici composti
durante l’alto Medioevo, in cui i santi evangelizzatori giungono unicamente da Roma
e sono inviati in missione da san Pietro. Ciò permise ad alcune sedi vescovili di
rivendicare un’origine «apostolica» priva, inutile dirlo, di ogni fondamento storico.
Interpretazione religiosa ed epurazione del passato pagano furono quindi le parole
d’ordine della politica per secoli tenacemente perseguita dalla Chiesa romana, allo
scopo di fare di Roma una città santuario ad uso dei cristiani della città e soprattutto
dei pellegrini. Questi erano probabilmente numerosi già nell’VIII secolo, quando un
chierico anonimo redasse una Notitia ecclesiarum et urbis Romae che, oltre a San Pietro, si interessava soprattutto alle chiese fuori le mura e alla
zona delle catacombe lungo le vie consolari, dove si trovavano le tombe dei principali
martiri. Ma già un secolo prima l’Itinerario detto di Malmesbury perché noto in seguito alla sua inserzione nelle Gesta regum Anglorum del cronista e monaco Guglielmo di Malmesbury (XII secolo) enumerava le tombe dei
santi e le chiese che bisognava visitare dentro e fuori la città. Un altro libretto
dello stesso genere, il Liber de locis sanctis martyrum, dava invece una lista commentata delle chiese urbane a partire da San Pietro. Il
genere raggiunse la perfezione con l’Itinerario d’Einsiedeln, che prende il nome dall’abbazia svizzera in cui il manoscritto fu conservato, una
guida molto pratica e precisa dove la descrizione di Roma e dei suoi dintorni si svolge
in undici itinerari con un’appendice sulle cerimonie romane della settimana santa.
Il modo di procedere dei pellegrini è chiaro: per prima cosa andavano a venerare le
reliquie di san Pietro, secondo la tradizione crocifisso per ordine di Nerone a testa
in giù vicino all’obelisco vaticano. Questo monumento era famoso perché si credeva
che nella sfera che lo sormontava fossero conservate le ceneri di Giulio Cesare. I
pellegrini chinandosi passavano sotto i quattro enormi leoni che sostenevano l’obelisco,
nella speranza di espiare i loro peccati attraverso questo gesto improntato al rispetto
e alla sottomissione. Ma a Roma c’erano ancora altre reliquie venerabili: le catene
di san Pietro riportate da Gerusalemme dall’imperatrice Eudossia, moglie di Arcadio,
che fece costruire la chiesa di San Pietro in Vincoli e trasformò i tradizionali festeggiamenti
che commemoravano la vittoria di Augusto ad Azio (1° agosto) in festa della basilica;
c’erano le reliquie di san Paolo, la colonna della flagellazione che, almeno dalla
metà del XIII secolo, si trova a Santa Prassede, e soprattutto la «veronica», la «vera
immagine» (vera icona) del Cristo, un panno con cui nella salita al Calvario sarebbe stato asciugato il
viso tumefatto di Cristo, rimasto impresso sul tessuto. Dal 1208 la veronica sarà
portata ogni anno in processione da San Pietro all’ospedale di Santo Spirito in Sassia,
sulla riva del Tevere. Vi erano poi tante chiese, ricche di reliquie, contate e ricontate
senza mai riuscire a ottenere lo stesso numero: 414 secondo il catalogo di Torino,
315 secondo il Liber pontificalis di Cencio nel XII secolo, 395 secondo Gherardo di Wales all’inizio del XIII secolo...
Numerose erano le chiese dedicate alla vergine Maria, dedica non troppo frequente
in Occidente prima dell’XI secolo: Santa Maria Maggiore, dove, secondo una leggenda
rappresentata in un mosaico nell’attuale loggia, in pieno mese di agosto si sarebbe
prodotto il miracolo della neve, o Santa Maria in Trastevere, nel presunto luogo del
miracolo dell’olio, ricordato sopra. E ancora Santa Maria Antiqua, Santa Maria in Dominica o della Navicella, Santa Maria in via lata e tante altre. I pellegrini che arrivavano da nord dopo aver percorso la via Francigena,
una volta giunti sull’attuale Monte Mario (Mons Gaudii o Monte della gioia nel Medioevo), da cui si poteva abbracciare con lo sguardo tutta
la città stesa ai suoi piedi, non potevano non essere colpiti ed emozionati da questo
spettacolo insolito, il cui ricordo ci è stato trasmesso, per periodi più recenti,
da numerosi racconti di viaggio e immagini (tav. 1). Alcuni di essi si recavano a
Roma per devozione personale, altri per penitenza, per espiare peccati particolarmente
gravi che solo il papa o, dal XII secolo, il suo delegato, il cardinale penitenziere,
aveva il potere di assolvere; tutti questi visitatori non erano dei santi e alcuni
di essi erano decisamente dei cattivi soggetti. Ma il loro afflusso ininterrotto attesta
bene il ruolo rassicurante e discolpevolizzante di Roma, dove il perdono che accordava
l’Apostoile (l’Apostolo), titolo che i testi francesi del XIII secolo attribuiscono al papa,
poteva purificare dalle loro colpe anche i più grandi peccatori.

Tav. 1. Cimabue, Vista di Roma, figura simbolica dell’Italia (particolare dell’affresco dei Quattro Evangelisti), 1280-90. Assisi, San Francesco, Basilica Superiore. Firenze, foto Scala.
Nel XII secolo, le crociate e il successo del pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela
non riducono l’intensità del pellegrinaggio a Roma che, al contrario, non cessa di
trascinare folle di pellegrini giunti talvolta da molto lontano, contribuendo a far
conoscere la città in tutta la cristianità e a conferirle un incomparabile prestigio.
Papa Bonifacio VIII aveva capito molto bene questo fenomeno quando nel 1300 propose
all’insieme dei fedeli della Chiesa cattolica l’indulgenza plenaria riservata fino
ad allora ai crociati, ossia la remissione di tutte le pene dovute per l’espiazione
dei loro peccati, se in occasione del giubileo o anno santo si fossero recati a Roma,
vi avessero soggiornato per almeno quindici giorni e avessero visitato religiosamente
San Pietro e Santa Maria Maggiore. Nel 1291, con la caduta di San Giovanni d’Acri,
le ultime piazzeforti della Terrasanta erano tornate nelle mani dei musulmani e Roma,
la città di Pietro e Paolo e dei martiri dei primi secoli, già cercava di diventare
una nuova Gerusalemme, un luogo sacro dove l’individuo ritrovava la propria identità
risalendo alle origini della sua storia e dove i popoli riscoprivano, anche se per
un solo istante, la fraternità originale che li legava indissolubilmente.
3. La disgregazione della visione unitaria e lo scontro tra le «tre Rome» (XII-metà
XIV secolo)
Alla fine dell’XI secolo Roma sembrava versare in uno stato di prostrazione mai conosciuto
in precedenza. Le guerre tra il papato e gli imperatori tedeschi e soprattutto l’incendio
e il saccheggio con cui i normanni accorsi in aiuto di Gregorio VII devastarono una
parte della città, tra il Colosseo e San Giovanni in Laterano, avevano definitivamente
rotto la continuità che poteva ancora esistere tra la città antica e la sua erede
medievale. Ne ritroviamo una testimonianza nella basilica di San Clemente, ricostruita
all’inizio del XII secolo al di sopra della chiesa più antica e a un livello di molti
metri superiore a quello della chiesa paleocristiana, trasformata in cripta. Inoltre,
ciò che rimaneva del quadro e del decoro monumentale dell’antichità aveva perso ogni
bagliore agli occhi di una società che cominciava a prendere le distanze dal suo passato
antico, con cui intratteneva un rapporto ambivalente. Passato considerato pericoloso,
perché era ormai viva la coscienza della distanza religiosa e culturale che lo separava
dal presente, ma tuttavia utile nella misura in cui poteva fornire formule efficaci
e segreti ormai perduti. Di fatto, nel momento stesso in cui, ancora una volta, la
città affondava nella mediocrità e nel declino, si produsse un nuovo movimento che
ricollocò Roma al centro delle nuove concezioni e rappresentazioni del potere che
stavano sorgendo in Occidente.
L’Occidente in cerca di un centro e di norme comuni Nel XII secolo nasce un nuovo interesse per l’eredità antica, in un clima ben diverso
da quello dell’epoca precedente e innanzitutto più stimolante: in un mondo occidentale
frantumato in piccole cellule autonome dal potenziamento del feudalesimo, ma animato
da un vigoroso sviluppo economico e demografico, comincia effettivamente a farsi sentire
l’aspirazione all’unità e a una certa centralità. Queste non potevano non convergere
verso Roma, capitale del mondo conosciuto e luogo per eccellenza della perfezione
e dell’esemplarità. In questa civiltà più ricca e più ambiziosa il progresso passa
attraverso un ritorno a Roma, come se nulla di bello, di grande e di durevole potesse
essere fatto senza ricollegarsi in qualche modo alla sua eredità. Quasi ovunque in
Occidente rimanevano importanti rovine antiche che mantenevano vivo il ricordo di
Roma e il rispetto per la sua opera. Nelle campagne le vie romane, grazie alle loro
solide fondamenta, continuavano ad attraversare lo spazio senza preoccuparsi della
morfologia del terreno, a differenza delle vie medievali, sempre attente a evitare
gli ostacoli dei rilievi. L’abate Sugerico non sognava forse di trasportare da Roma
su un battello le colonne che dovevano servire a ricostruire l’abbazia di Saint-Denis,
di cui voleva fare uno dei monumenti più splendidi del regno di Francia? Alla stessa
epoca i costruttori delle cattedrali di Modena e Pisa integravano in questi nuovi
edifici frammenti d’architettura antica, alcuni dei quali provenivano da Roma o da
Ostia, non con un intento estetico, ma per conferire al nuovo una qualche forma di
auctoritas legata alla vetustà di queste lastre di marmo e al prestigioso ricordo lasciato dalla
civiltà di cui esse prolungavano la memoria21. Questo esempio preso a prestito dalla storia dell’arte illustra bene il senso di
quel mettersi costantemente in rapporto con Roma che allora si afferma un po’ ovunque
in Europa: solo Roma poteva offrire una garanzia all’innovazione, conferendole l’apparenza
di un ritorno a una tradizione più pura, tradizione che nel corso dei secoli precedenti
si era degenerata o di cui si era smarrita la memoria. Al tempo delle leggende e delle
favole, che trasmettono un riflesso, benché deformato, di una realtà avvertita ancora
come vicina, succede il tempo dei miti, che guardano a Roma per legittimare ambizioni
e imprese molto moderne collocandole sotto il segno di una continuità più postulata
che veramente vissuta.
D’altra parte, il clima intellettuale del XII secolo non era più quello dell’epoca
carolingia o dell’anno Mille, quando un pugno di ecclesiastici affascinati dal sogno
di Costantino riscoprì rapito le bellezze appariscenti di una latinità da pedanti.
Una vera rinascita culturale cominciava ad affermarsi e a portare i suoi frutti, sia
in Italia (Montecassino e Salerno, ma anche Bologna, dove Irnerio e i suoi successori
fanno rinascere la scienza del diritto) che in Francia, in Germania e in Inghilterra
(dove appare una costellazione di spiriti originali, da Abelardo e san Bernardo a
Ottone di Frisinga e Giovanni di Salisbury, imbevuti della migliore latinità che essi
stessi contribuirono ad arricchire con le loro opere). L’eredità antica non si limitava
a quello che la tradizione cristiana aveva fatto suo e trasmesso durante l’alto Medioevo.
Le più brillanti intelligenze del tempo cercarono di arricchire e far fruttificare
questo lascito univoco ma impoverito, suscitando così l’apparizione di visioni diverse
e talvolta opposte di questo passato, destinate a confrontarsi intorno a una doppia
sfida: la guida della cristianità, concepita come il prolungamento dell’impero romano,
e lo statuto della città di Roma.
Un’eredità contesa: l’impero Al centro dell’eredità romana si trova l’idea dell’impero. Questa nozione ha avuto
a lungo una cattiva reputazione nella storiografia francese, che voleva vedervi solo
un’astrazione politica e una costruzione retorica, opera di un pugno di chierici imbevuti
di nostalgie universalistiche, già anacronistiche in un’epoca in cui i re di Francia
e Inghilterra gettavano le basi di potenti monarchie nazionali, promesse a un brillante
avvenire, e le città-Stato italiane affermavano con crescente audacia la loro volontà
di autonomia. È pertanto necessario riabilitare l’idea di impero, o perlomeno restituirle
il posto che fu già suo.
Durante tutto il Medioevo questo concetto rimane profondamente radicato, come testimonia
il prestigio della figura di Carlo Magno e il posto che occupa nell’immaginario collettivo
non solo occidentale. Comunemente si credeva, e non solo in Germania, che Dio aveva
voluto l’impero per favorire la diffusione della fede cristiana e per far regnare
sulla terra il diritto e la giustizia. Ne conseguì l’idea che in virtù della sua missione
divina l’impero fosse sacro e inviolabile e costituisse la fonte del diritto politico
e civile. Invece di essere un’istituzione puramente laica, nel senso che diamo oggi
a questo termine, l’impero medievale, come quello di Teodosio e di Giustiniano, aveva
una finalità religiosa: condurre gli uomini verso la salvezza nel quadro del potere
temporale e dell’esercizio delle leggi, mentre la Chiesa si faceva carico della salute
delle loro anime. I due poteri avevano un’origine comune nella persona di Cristo e,
come papa Gelasio aveva ribadito in una celebre lettera del 494 indirizzata all’imperatore
Anastasio I, essi erano insieme distinti e complementari. Quando le funzioni dell’impero
non erano assolte, il potere imperiale poteva cambiare di mano: è quanto si era verificato
nell’VIII secolo, allorché il papato aveva fatto passare l’impero (translatio imperii) da Bisanzio ai franchi, nella persona di Carlo Magno, poi nel 962 attraverso il
passaggio dai franchi ai sassoni con Ottone I, fondatore di quello che prenderà più
tardi il nome di Sacro romano impero germanico, che durerà fino al 1806, quando sarà
soppresso da Napoleone.
Questa dipendenza della funzione imperiale dal papato conteneva una minaccia per il
potere temporale. Essa rimase tuttavia latente fino alla metà dell’XI secolo, ossia
fin quando prevalse la concezione «gelasiana» del potere, detta così perché definita
da papa Gelasio nella lettera appena citata, in virtù della quale il papa e l’imperatore
collaborano, ciascuno nella propria sfera, affinché gli abitanti del regno terrestre
diventino un giorno cittadini del cielo. Ma quando la Chiesa romana, influenzata da
correnti riformatrici prevalenti al suo interno fin dal 1050, iniziò a considerare
che i laici non dovevano più intervenire nella sfera sacra, ormai riservata solo al
clero, questo bell’edificio unitario cominciò a mostrare i primi segni di debolezza.
Con Gregorio VII (1073-85) tale evoluzione condurrà a un conflitto tra il potere papale
e l’autorità imperiale, chiamato dagli storici lotta per le investiture, che si sarebbe
prolungato in forma radicale fino alla fine del XII secolo e, in modo meno parossistico,
fino all’inizio del XIV. In questo contesto conflittuale, il riferimento a Roma servì
a legittimare visioni contraddittorie e spesso antagonistiche circa il presente e
il destino della cristianità occidentale.
La Chiesa romana padrona di Roma e del mondo Con la riforma detta gregoriana, da papa Gregorio VII che formulò le rivendicazioni
pontificie più aspre e polemiche, la Chiesa romana iniziò a liberarsi della tutela
imperiale e a sottrarre lo spirituale alla dominazione del potere temporale, rappresentato
come oppressivo e corruttore. Per questo la Chiesa fece sue alcune affermazioni già
avanzate nel IX secolo da Niccolò I (858-867) e da Giovanni VIII (872-882), secondo
le quali Roma era una città regale e sacerdotale insieme, «madre e guida del mondo
intero», perché era a Roma che si trovava la cattedra del principe degli apostoli,
e la cristianità, erede dell’impero romano, doveva sottomettersi al successore di
Pietro.
Per Gregorio VII la Chiesa si identificava con la res publica Romana: infatti, «Quibus imperavit Augustus, imperat Christus» («Quelli su cui dominò Augusto,
domina Cristo»). Il suo capo supremo, il papa, era alla testa di un nuovo impero romano,
infinitamente più esteso del precedente, perché fondato sulla pietra d’angolo della
fede cristiana, e indistruttibile, poiché non costruito sulla violenza, come quello
dell’antichità, ma sulla carità e la giustizia che il pontefice doveva, per missione,
far regnare sulla terra. Il papa non rivendicava l’impero e il potere politico per
se stesso, ma affermando nella lettera al vescovo Ermanno di Metz che «la dignità
sacerdotale è superiore alla dignità regale quanto l’oro è superiore al piombo», si
erge ad arbitro e a guida suprema della cristianità.
La rivendicazione del pontefice di un potere contemporaneamente sacerdotale e regale,
a immagine della città di cui era il vescovo, investiva in effetti due diversi aspetti:
da una parte implicava che quest’ultimo era ormai il signore assoluto della Chiesa
d’Occidente, ciò che fino ad allora non era stato, nella misura in cui le pretese
romane all’egemonia si erano scontrate, nel corso dei secoli precedenti, con la resistenza
di sedi ecclesiastiche metropolitane prestigiose, come Ravenna o Milano, in Italia,
e di alcuni episcopati nazionali, soprattutto in Francia e in Germania. Ormai le direttive
pontificie saranno trasmesse fino alle regioni più estreme della cristianità da alcuni
legati a latere che, per il solo fatto di essere inviati dal papa, avevano la preminenza sugli arcivescovi
e sui vescovi nelle loro province e nelle loro diocesi. Questo fu il punto d’avvio
di un rafforzamento delle prerogative della Santa Sede a detrimento della gerarchia
ecclesiastica locale e di una centralizzazione degli affari ecclesiastici a vantaggio
della curia romana che, dalla prima metà del XII secolo, conoscerà uno sviluppo continuo,
scandalizzando san Bernardo, che già verso il 1140 ne denunciava in termini virulenti
gli abusi. Con il tempo questo processo, ininterrotto fino al XIV secolo, avrebbe
fatto del mondo occidentale, per la prima volta dalla caduta dell’impero romano, uno
spazio omogeneo e unificato nei campi, all’epoca molto vasti, che erano di competenza
delle istituzioni ecclesiastiche. I pontefici ne furono certamente gli artefici. Ma
il movimento centripeto che animò allora l’Occidente non avrebbe conosciuto un tale
successo se non si fosse basato, almeno confusamente, sull’idea che Roma era il centro
del mondo e sul bisogno, profondamente avvertito dagli uomini del tempo, di un’istanza
suprema che avesse l’ultima parola e le cui decisioni non avessero ricorso. Il desiderio
nutrito dal papato di mettere in evidenza la ritrovata continuità tra la Roma pontificia
e la Roma antica si tradusse del resto, fin dal 1120, nella ricostruzione di un certo
numero di basiliche (Santa Maria in Trastevere e San Clemente) in uno stile che richiama
quello delle chiese paleocristiane del IV e V secolo (fig. 3). Si manifestò ugualmente
con la diffusione in tutto il Lazio di un’«arte controllata», secondo la felice formula
di Hélène Toubert. Una delle più significative espressioni risalenti al pontificato
di Innocenzo III sarà il portico decorato da mosaici e da un’iscrizione solenne della
cattedrale di Civita Castellana, che accoglieva visitatori e pellegrini provenienti
dal Nord quando entravano nel Patrimonio di San Pietro.

Fig. 3. Ecclesia Romana, mosaico, inizio XIII sec., già nell’abside della basilica di San Pietro in Vaticano,
Roma, Museo di Roma. Firenze,
foto Scala.
Facendo del papa il suo imperatore, la Chiesa rivendicava per il pontefice un predominio
politico basato su motivazioni di ordine morale e spirituale, la cui espressione più
radicale è il Dictatus papae, probabilmente il riassunto di una collezione canonica che riflette il pensiero e
le ambizioni di Gregorio VII. Vi è detto espressamente che solo il papa può detenere
e conferire all’eletto di sua scelta le insegne imperiali, ossia la corona, lo scettro
e la spada, la «Santa Lancia» che aveva attraversato il costato di Cristo morto, la
croce, il globo decorato da una croce d’oro e l’aquila d’oro che si diceva portata
in Italia da Enea. Durante il XII secolo e la prima metà del XIII i successori di
Gregorio VII insisteranno sul fatto che in Occidente l’imperatore deterrà il suo potere
esclusivamente per delega del sovrano pontefice, così come la luna deve la sua luce
al sole. Di fatto, fino al 1327 tutti i candidati all’impero si recheranno, più o
meno volentieri, a Roma, il solo luogo al mondo dove si poteva ottenere validamente
la corona imperiale dalle mani del papa o di uno dei suoi legati.
Alla stessa epoca e nella stessa prospettiva, il papato ricorrere sempre più frequentemente
a due temi fondati su racconti mitici: la translatio imperii e la donazione di Costantino. Abbiamo visto come la prima concernesse il privilegio
di cui godeva il successore di Pietro di privare del potere imperiale coloro che ne
erano diventati indegni, come Leone III aveva fatto nell’800 favorendo Carlo Magno
a danno di Bisanzio. Durante il conflitto che all’inizio del XIII secolo oppose due
principi tedeschi candidati entrambi all’impero, Filippo di Svevia e Ottone di Brunswick,
Innocenzo III (1198-1216) si servì di questo argomento per affermare il suo diritto
esclusivo non solo di investire l’imperatore, ma di sceglierlo in funzione degli interessi
superiori della Chiesa e in ragione della plenitudo potestatis che egli rivendicava sull’insieme della cristianità. La donazione di Costantino,
o constitutum Constantini, era in sé un testo elaborato a Roma, tra il 751 e il 754, nella cerchia di papa
Paolo I. Secondo questo diploma imperiale, la cui inautenticità fu dimostrata solo
verso la metà del XV secolo, poco dopo aver ricevuto il battesimo da papa Silvestro
I, l’imperatore Costantino avrebbe riconosciuto al pontefice il primato sulla Chiesa
universale e la sovranità assoluta su Roma e l’Italia, nonché la proprietà di numerosi
territori disseminati su tutto l’impero. Aveva inoltre annunciato al papa che avrebbe
abbandonato Roma per andare a vivere in Oriente e avrebbe proposto la corona a Silvestro
I (fig. 4). Quest’ultimo l’avrebbe rifiutata per se stesso, ma ne avrebbe conservato
la disponibilità. Questo testo controverso aveva all’origine un valore circostanziale:
doveva servire, come sembra, a legittimare la creazione di uno Stato pontificio indipendente
intorno a Roma e ad affermare la superiorità del papa sui vescovi italiani. L’immagine
del papa che ne scaturiva era quella di un monarca il cui potere eguagliava in dignità
quello del più prestigioso sovrano dell’epoca, il basileus di Costantinopoli. Questo testo fondamentalmente antibizantino fu usato dalla Chiesa
romana al momento della grande lotta che oppose il patriarca Michele Cerulario a papa
Leone IX e che si concluse con lo scisma del 1054.

Fig. 4. Anonimo romano, L’imperatore Costantino introduce il papa san Silvestro nella città di Roma, tenendo
la briglia del suo cavallo, 1246. Roma, chiesa dei Santi Quattro Coronati, cappella di San Silvestro. Firenze,
foto
Scala.
Ma gli imperatori d’Occidente non tardarono ad accorgersi che questa tradizione rappresentava
un grande pericolo per il loro proprio potere. Ottone III, che intorno all’anno Mille
volle fare di Roma la sede dell’impero, le negò qualsiasi valore, nella misura in
cui essa sottolineava l’appartenenza della città al papa e non all’imperatore. Nel
1142 Arnaldo da Brescia ebbe il medesimo atteggiamento quando cominciò a osteggiare
il potere temporale dei papi a Roma e nel Lazio. Dal canto loro, i papi dell’alto
Medioevo usarono la donazione di Costantino con una certa prudenza, perché presentava
l’inconveniente di far dipendere i loro privilegi da una grazia imperiale... Ma Urbano
II, al termine dell’XI secolo, si appoggiò su di essa per rivendicare il possesso
della Corsica e di alcune isole del Mediterraneo, e ancora di più l’usarono i papi
del XIII secolo nel tentativo di far prevalere i princìpi teocratici, ovvero la subordinazione
del potere temporale al potere spirituale. Gregorio IX (1227-41) e Innocenzo IV (1243-54)
vi ricorsero particolarmente durante le grandi controversie ideologiche e i conflitti
che li opposero all’imperatore Federico II (1209-50) per affermare la superiorità
del papa sull’imperatore e su qualsiasi istituzione umana, politica e religiosa. Questa
rivendicazione è particolarmente ben illustrata da un ciclo di affreschi della metà
del XIII secolo tuttora visibili nella cappella di San Silvestro, presso il monastero
romano dei Quattro Santi Coronati. I principali episodi della leggenda di Silvestro
e Costantino sono rappresentati con un grande lusso di dettagli: l’autore ha enfatizzato
le scene dove l’imperatore, per esprimere il suo rispetto verso la persona del pontefice,
gli cammina accanto tenendogli la briglia del cavallo o gli rimette le insegne dell’impero
prima di lasciare Roma per Costantinopoli. Non si trattava solo di una rivendicazione
teorica: in quegli stessi anni, la donazione di Costantino servì a legittimare la
deposizione dell’imperatore Federico II, dichiarata da Innocenzo IV nel 1245 al Concilio
di Lione. Nel 1298 papa Bonifacio VIII ricevette gli inviati del «re dei romani» Alberto
di Asburgo, che aspirava alla corona imperiale, tenendosi «seduto sul trono, incoronato
dal diadema di Costantino, la mano destra sulla guardia della spada di cui era cinto»
e respinse violentemente la richiesta gridando «Non sono forse io il pontefice supremo?
[...] sono io Cesare, sono io l’imperatore» («Ego sum Caesar, ego sum imperator»)22. Certo non sorprende che questo papa sia stato anche il primo della storia a essere
accusato di idolatria per aver fatto eseguire da vivo una statua monumentale di se
stesso e averla collocata all’interno o all’esterno di numerose cattedrali e alle
porte di alcune città, come Federico II aveva fatto a Capua, imitando gli antichi
imperatori23.
La città imperiale e il diritto romano Parallelamente a queste rivendicazioni del papato, che affondano le loro radici nel
passato cristiano della città, si sviluppò una tradizione che vedeva in Roma soprattutto
il centro dell’impero (mater et sedes imperii). L’idea imperiale era rimasta profondamente radicata dall’investitura di Carlo Magno,
anche se le sue incarnazioni politiche furono spesso deludenti o effimere. Ma sarebbe
erroneo valutare il potere dell’imperatore sulla base della superficie di territorio
posta direttamente sotto il suo controllo. Alla metà del XII secolo il vescovo e cronista
Ottone di Frisinga ne dava una definizione più esatta affermando che il «patronato»
(patrocinium) del mondo intero apparteneva all’imperatore. L’espressione è interessante, in quanto
mette bene in evidenza la volontà del suo contemporaneo e amico Federico Barbarossa
di rinvigorire l’idea di impero ricollegandola alle sue origini romane. La sovranità
imperiale, così come egli la concepiva, si estendeva infatti sulle nazioni, i principati
e le città della cristianità occidentale, ma l’imperatore non intendeva sostituirsi
ai loro governanti nell’esercizio quotidiano dell’autorità. Così come la Roma antica
aveva rispettato, almeno formalmente, le autonomie municipali e ammesso la doppia
cittadinanza, tanto decantata da Cicerone, all’imperatore bastava che tutti, papa
compreso, riconoscessero il carattere universale del suo potere, che veniva da Dio
e faceva di lui l’incarnazione della giustizia e della legge.
Ma dopo la riforma gregoriana e il concordato di Worms (1122), che segnò essenzialmente
la vittoria del papato nella lotta per le investiture, all’imperatore germanico rimanevano
solo due possibilità: sottomettersi al papa, come fece Lotario III nel 1133, o trovare
al suo potere basi diverse dalla sacralità cristiana, terreno che era meglio lasciare
al clero. Così si scivolò progressivamente nel campo d’azione del diritto romano,
grazie anche alla rinascita degli studi giuridici determinatasi in Italia alla fine
dell’XI secolo. Dal 1084 infatti il giurista Pietro Crasso aveva sviluppato per Enrico
IV una concezione secolarizzata dell’impero, fondata sull’eredità e il diritto romano.
All’inizio del XII secolo Irnerio, uno dei primi maestri della scuola di Bologna,
si schierò dalla parte di Enrico V. Ma solo con Federico Barbarossa l’imperatore si
svincola chiaramente dalla tutela della Chiesa e giunge a una concezione laica dell’impero,
fondata sulla rivendicazione di una continuità assoluta tra l’impero medievale e l’antico
impero romano. Proclamandosi discendente dei Cesari, l’imperatore affermava l’anteriorità
del suo potere rispetto a quello dei papi e allo stesso tempo sfuggiva alla loro tutela.
Parallelamente, alla dieta di Roncaglia (1150) Barbarossa dichiarò la sua volontà
di ristabilire il diritto romano con l’appoggio dei giuristi di Bologna, scelti come
suoi consiglieri quando aveva voluto ridurre all’obbedienza i comuni lombardi; questi
gli proposero l’immagine del principe come fonte del diritto, tratta dalla legislazione
di Giustiniano. A differenza dei suoi predecessori, l’imperatore volle esercitare
una vera sovranità su Roma e sull’Italia e reclamò la restituzione dei diritti imperiali
(regalia) di cui le città si erano appropriate. Ma, nello stesso tempo, quando nel 1155 venne
a Roma per farsi incoronare, rifiutò sdegnosamente le proposte del comune di Roma,
che pretendeva di offrirgli l’imperium, in virtù della lex regia de imperio che riconosce nel popolo romano l’origine della sovranità imperiale. Grazie all’aiuto
dei giuristi del suo seguito, non gli fu difficile rispondere che la sovranità era
stata da tempo oggetto di un’alienazione irreversibile e che preferiva ricevere la
corona dalle mani del papa piuttosto che doverla alla plebe.
Questo dibattito ritornò d’attualità sotto il regno di Federico II (1209-50), che
guardava al modello imperiale romano ancora più di quanto avesse fatto suo nonno,
e cercò di elaborare con i suoi consiglieri «romanisti» Pier delle Vigne e Andrea
da Isernia una definizione romano-laica dell’impero, distinta allo stesso tempo dalla
forma puramente cristiana dell’alto Medioevo e dalle definizioni riduttrici della
curia romana. Nel 1230 Federico fece inserire nelle Costituzioni di Melfi che «l’imperatore
è la legge vivente sulla terra», insistendo sul fatto che egli era «al di sopra delle
leggi», ciò che lo portò ai limiti dell’assolutismo. Riferendosi così alle più radicali
espressioni del diritto romano, Federico II si metteva subito al di fuori del quadro
tradizionale dell’impero medievale: fondato da Cesare, accresciuto da Augusto, i cui
nomi furono introdotti nella titolatura che figurava sulle sue monete (Fridericus gratia Dei Caesar, imperator semper Augustus), codificato da Giustiniano, il potere imperiale poteva rinascere in tutto il suo
splendore con questo straordinario personaggio, più siciliano che tedesco, che stupì
i suoi contemporanei (stupor mundi). Gli mancava tuttavia l’adesione dei romani, benché li avesse colmati di elogi e
di appelli alla gloria, onorandoli con il dono del «carroccio», il carro simbolo del
comune di Milano di cui si era impadronito nel 1237 nella battaglia di Cortenuova.
Il trofeo fu esposto sul Campidoglio, dove presto l’impresa fu commemorata da una
bella iscrizione di stampo classico, che mirava a esaltare la romanità del potere
imperiale. Ma questa retorica antichizzante non fece presa sui romani, che non avevano
ricordi abbastanza precisi del loro passato per potersi appassionare alle invocazioni
infiammate del nuovo Cesare. Così, durante la lotta senza quartiere che oppose l’imperatore
ai papi Gregorio IX e Innocenzo IV, conclusasi con la sua sconfitta e la sua morte,
i romani preferirono rimanere in disparte in prudente attesa. Nell’insieme, Federico
II sembra essere stato un ammiratore sincero ed entusiasta della grandezza della Roma
antica e tentò di restaurarla: lo dimostra la concezione molto classica, e puramente
profana, del programma iconografico della porta trionfale di Capua, dove si fece rappresentare
tra la Fides, che raffigura la fedeltà all’imperatore, e la Iustitia, che regnava grazie alla sua legge. Ma per Federico II Roma era solo un simbolo e
l’impero romano che evocava nelle sue lettere era costituito dall’insieme dei suoi
sudditi.
Il suo successore alla testa del regno di Sicilia, Manfredi (1258-65), trasse insegnamento
dalla sua sconfitta e inviò ai romani un lungo manifesto in cui dichiarava di accettare
l’interpretazione romana della lex de imperio, che riconosceva in loro l’origine della sovranità liberamente delegata all’imperatore.
Affermava anche di voler fare della città la capitale del suo regno italiano. Ma era
troppo tardi: la spedizione di Carlo d’Angiò in Italia meridionale mise presto fine
alla dominazione e all’esistenza stessa della famiglia degli Staufen. Questo però
non significava la fine del sogno imperiale, come dimostra l’esempio di Dante.
4. Una visione repubblicana di Roma: il comune
Accanto alle concezioni ecclesiastiche e imperiali di Roma, dal XII secolo assistiamo
allo sviluppo di una terza rappresentazione della città che venne a interferire con
le prime due in un rapporto spesso polemico o critico. Se fino ad allora la Roma antica
cui si era fatto riferimento era quella imperiale, adesso i romani cominciano a scoprire
la repubblica. Grazie ai conflitti che opposero pontefici e imperatori fin nel cuore
della città, alcuni elementi della popolazione presero coscienza del ruolo più importante
che potevano svolgere nel gioco politico, ad esempio appoggiandosi sugli imperatori
per far prevalere le rivendicazioni autonomiste rispetto ai pontefici. Cercarono così
di conciliarsi il favore degli imperatori accordando loro la dignità patrizia, che
concedeva direttamente ai sovrani «barbari» la cittadinanza romana e il rango aristocratico,
in virtù dell’adagio hospes eras, civem te feci («Eri straniero, ti ho fatto romano»). Nelle lettere indirizzate ai sovrani germanici
si faceva anche balenare l’idea che Roma dovesse ritornare libera per poter svolgere
il ruolo di capitale della sovranità imperiale che aveva già avuto nel passato. Nel
1128 «i consoli, i patrizi e la plebe romana» osarono addirittura ricordare all’imperatore
Lotario che non poteva fregiarsi del titolo imperiale fin quando non fosse venuto
a Roma a farsi incoronare, ciò che egli fece nel 1133. Infine, tra il 1144 e il 1149
si sviluppò a Roma un movimento di emancipazione che si concluse con l’insediamento
di un regime comunale e l’affermazione di un’élite borghese rapidamente assimilata
all’ordine equestre. Sotto l’influenza del riformatore religioso Arnaldo da Brescia,
il comune di Roma chiese in effetti al papa di rinunciare al potere temporale e alle
sue ricchezze e di lasciare l’incarico di amministrare la città e il suo contado a
un’istituzione comunale, il senato, che si riuniva simbolicamente sul Campidoglio.
Questa rivendicazione si fondava anche su un ritorno al diritto romano: i romani giunsero
a considerare che le acclamazioni con cui accoglievano l’imperatore al suo arrivo
in città e il suo riconoscimento da parte del senato erano atti essenziali, equivalenti
a una sorta di investitura, e di conseguenza pretesero di essere all’origine dell’imperium. In seguito, i romani tentarono a più riprese di far valere la loro pretesa di conferire
ai sovrani tedeschi la dignità imperiale. Ma questa rivendicazione aveva scarse possibilità
di successo a causa della contraddizione esistente tra il principio dell’origine contrattuale
della sovranità, che essi difendevano, e quello dell’inamovibilità del principe, legato
alla successione ereditaria, sostenuto dai giuristi di Bologna. E fu quest’ultimo
a prevalere. Dopo aver occupato Roma nel 1167, Federico Barbarossa ridusse il senato
a un semplice organo di amministrazione imperiale nella città.
Anche il papato rifiutava questa visione delle cose, ma per altri motivi: considerava
infatti che era il vescovo di Roma, lui solo, a delegare ai principi elettori il potere
di eleggere il re dei romani, e che la sua autorità sulla città, centro visibile dell’azione
terrena della Chiesa, non doveva nulla al popolo romano, ma tutto agli apostoli Pietro
e Paolo. Così i pontefici cercarono di indebolire la rinascente istituzione senatoria:
nel 1205 Innocenzo III credette di aver finalmente raggiunto il suo scopo sostituendo
al senato un senatore unico nominato dal papa. Il comune non si arrese facilmente
e nel 1234 i romani si ribellarono contro il papa e l’imperatore chiedendo il ritorno
alla libera elezione dei senatori e la restituzione all’amministrazione capitolina
dei regalia, ossia le entrate della zecca e le tasse sui forni e sui pascoli, di cui la Santa
Sede si era impadronita. Nel 1235 si giunse a una pace di compromesso con Gregorio
IX, ma i romani non rinunciarono all’esistenza di un «sacro senato» che doveva governare
la città in stretta collaborazione con il popolo, che fece risorgere così l’antica
formula senatus populusque Romanus. Nel 1252 il bolognese Brancaleone degli Andalò, primo podestà straniero di Roma,
di tendenza ghibellina, fece battere monete con l’iscrizione Roma caput mundi. Questo movimento popolare, sostenuto soprattutto dalle classi medie e dai nuovi
strati sociali, declinò rapidamente dopo la vittoria del papato sull’ultimo degli
Staufen. Dal 1259 si ritornò al regime del senatore nominato dal papa; poi il papato
decise di ricorrere a personalità non romane e particolarmente al re di Sicilia Carlo
d’Angiò, che nel 1268 ottenne la carica di senatore per dieci anni. Nel 1278 papa
Niccolò III, ostile alla pesantissima tutela che gli angioini esercitavano sulla città,
decise che il senatore di Roma doveva ormai essere romano e si attribuì il titolo,
ciò che continuò a fare anche il suo successore Bonifacio VIII. Una volta riuniti
tutti i poteri nelle mani del sommo pontefice, la «normalità» fu ristabilita, come
notava il cronista ecclesiastico Tolomeo da Lucca, secondo cui il quarto regno del
sogno di Nabucodonosor (nella visione del profeta Daniele) era tornato al Cristo e
attraverso di lui al papa e ai cardinali24. Questi infatti non erano forse per i giuristi contemporanei «una parte del corpo
del papa» (pars corporis papae), così come i senatori romani dell’antichità erano stati «una parte del corpo dell’imperatore»
(pars corporis imperatoris), e non li supplivano forse nelle loro funzioni di guardiani dell’impero?25 Fino alla riforma di Giovanni Paolo II, nel 1983, il codice di diritto canonico della
Chiesa cattolica definirà in ogni caso i cardinali come «il Senato del Pontefice Romano»26.