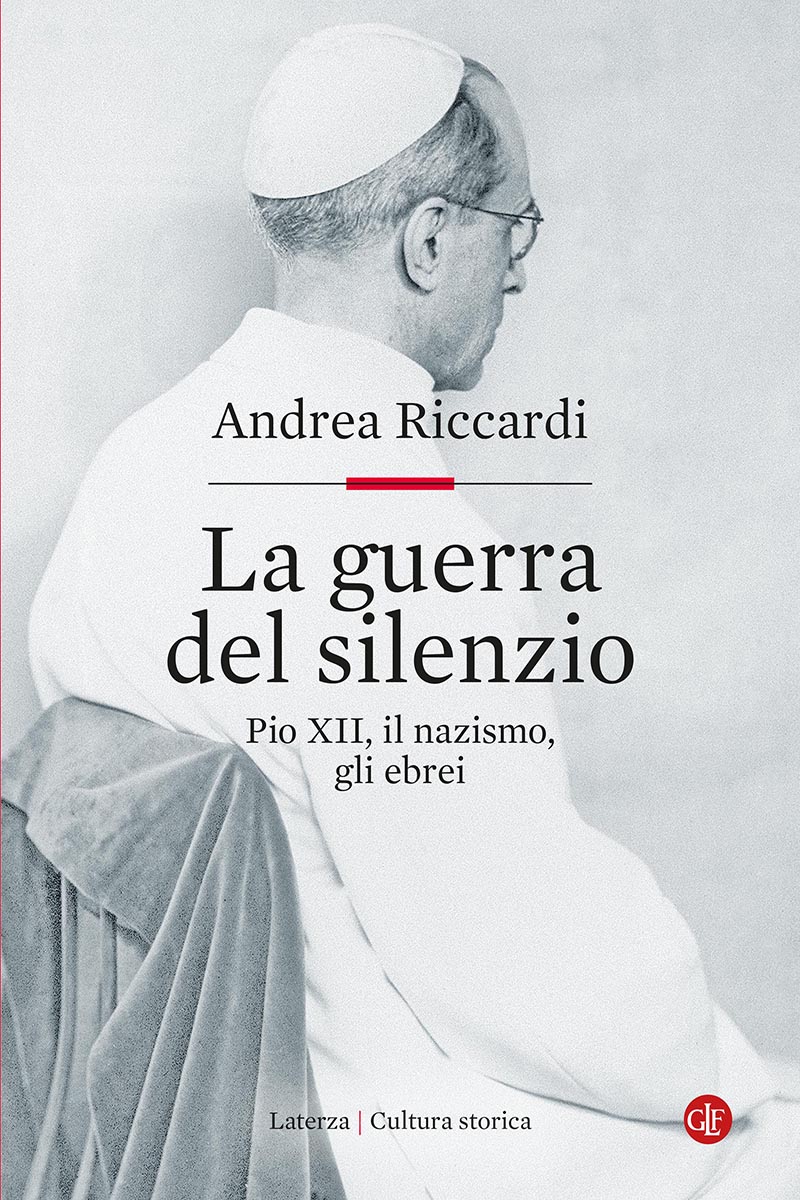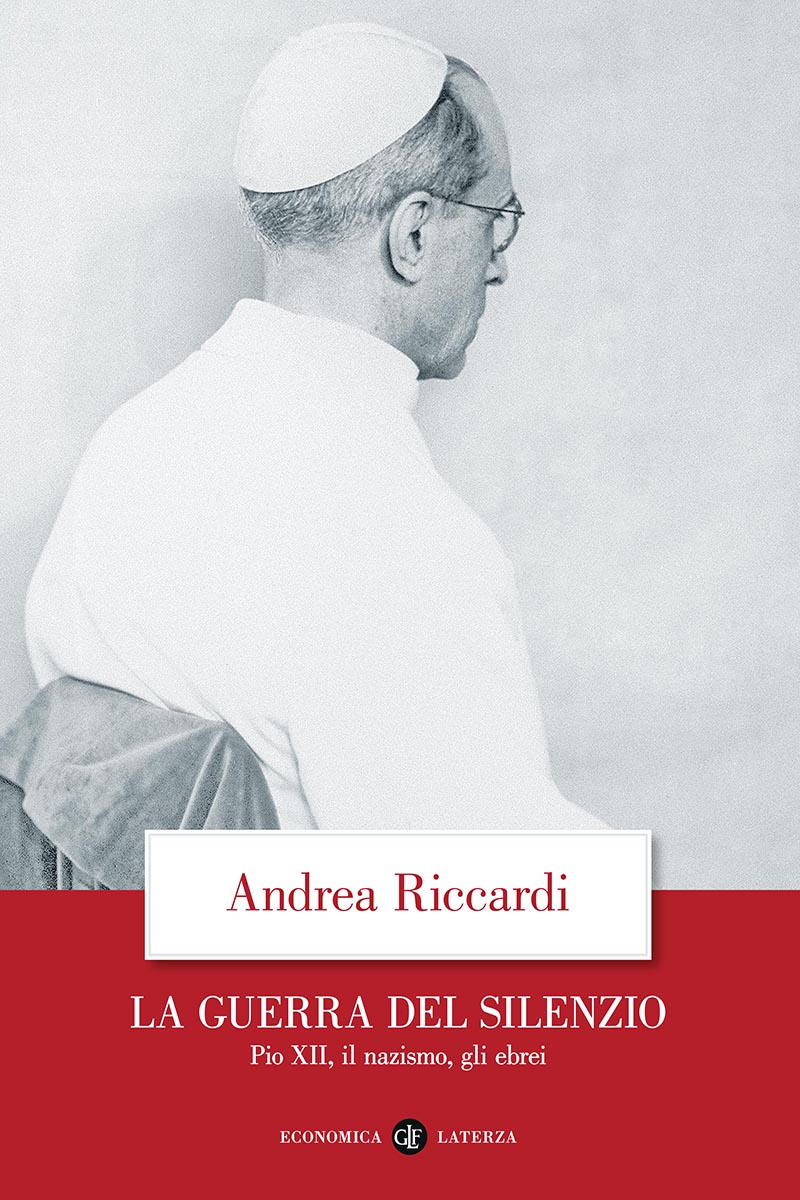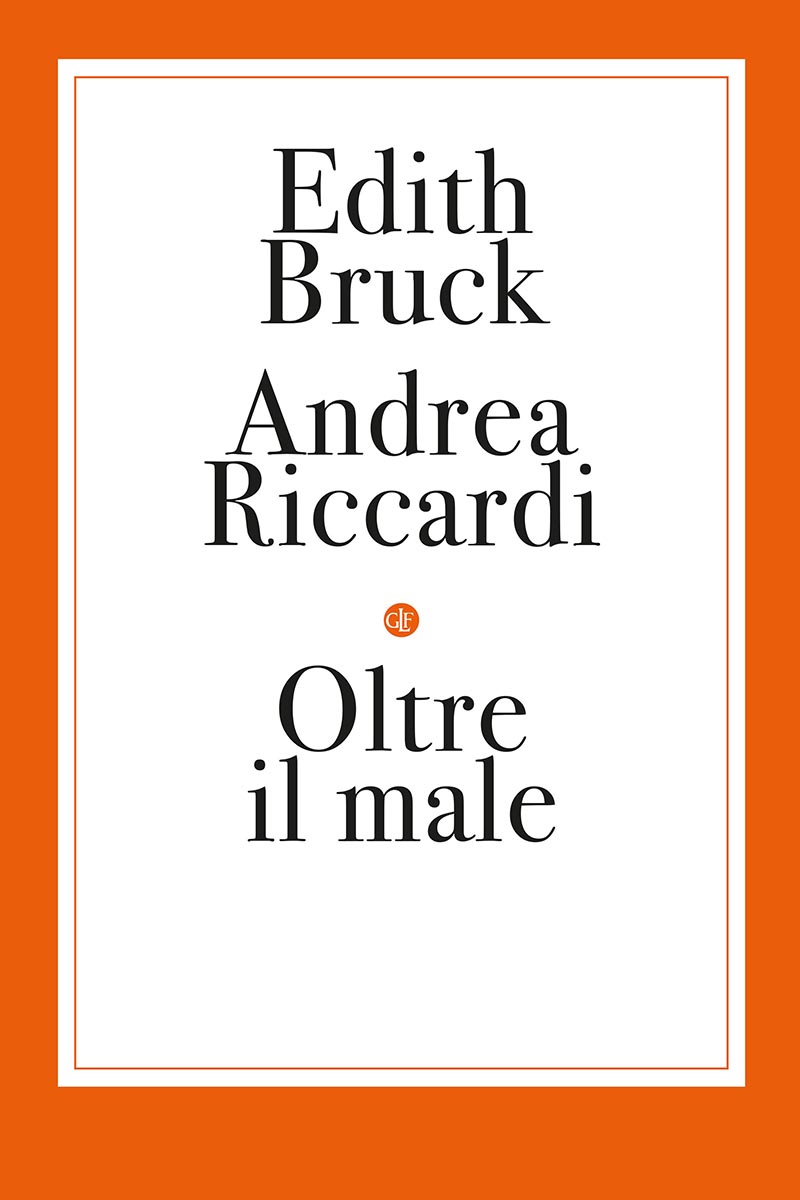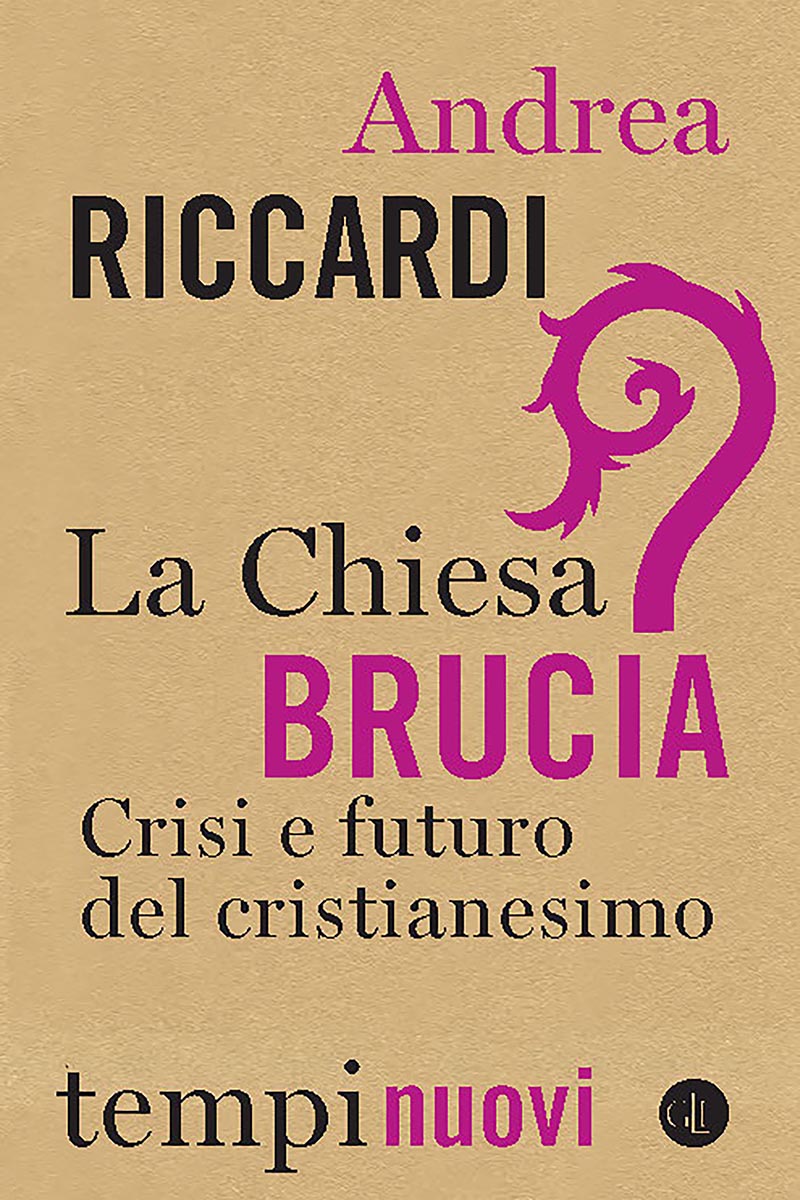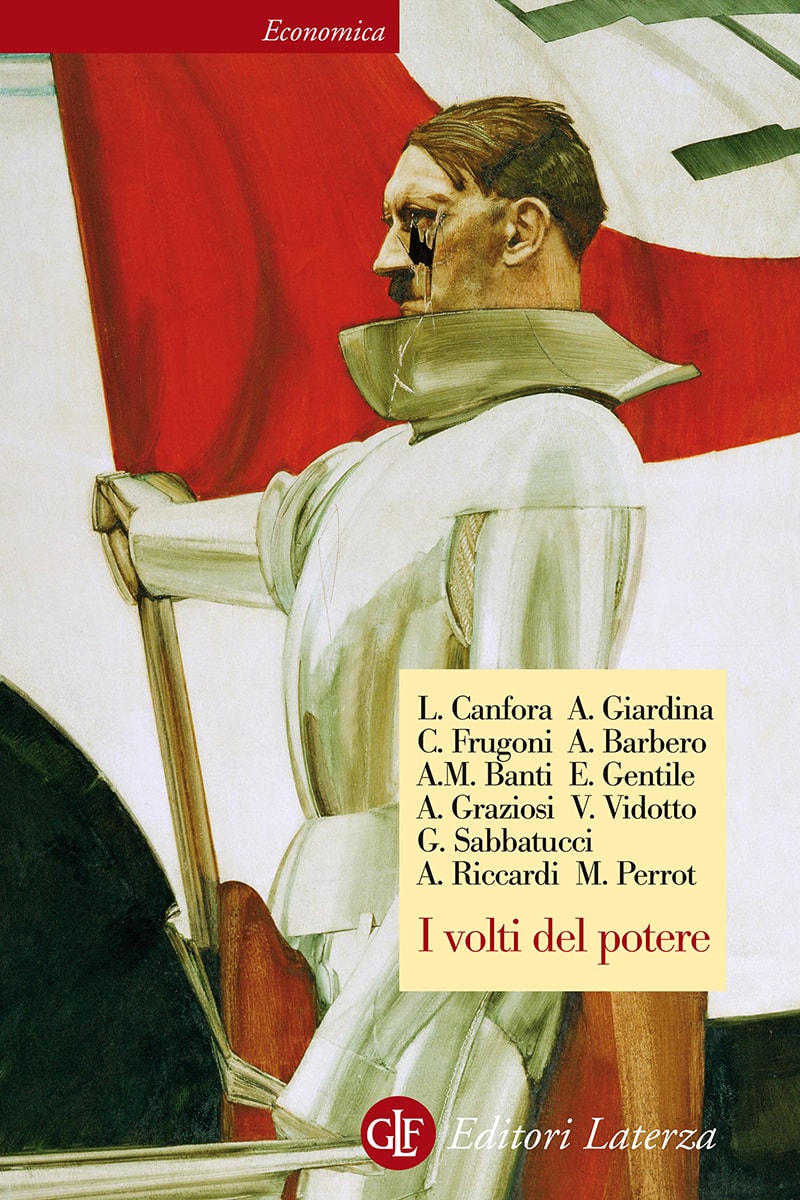“Cosa si pensa dei miei silenzi sui tedeschi?” La domanda di un papa
Mentre in Russia si scatenava l’offensiva tedesca contro l’URSS con la fine del patto
Molotov-Ribbentrop, nel palazzo apostolico si svolgeva un colloquio tra Pio XII e
il delegato apostolico a Istanbul, Angelo Giuseppe Roncalli. Era il 10 ottobre 1941.
Nessuno dei due, ovviamente, aveva consapevolezza che si trattava di un incontro tra
il papa e il suo successore. Allora nessuno avrebbe previsto una folgorante ascesa
per il “buon monsignor Roncalli”, come in Segreteria di Stato veniva definito con
ironia quel diplomatico pontificio di periferia, molto estroverso e non di carriera.
Roncalli era stato inviato prima in un paese di frontiera, la Bulgaria (dove i cattolici
rappresentavano una piccola minoranza), in qualità di visitatore apostolico, e poi
a Istanbul: non più capitale ottomana, ma pur sempre un crocevia internazionale e
la più grande città della Repubblica turca fondata da Atatürk, morto nel 1938, quattro
anni dopo l’arrivo del prelato. Roncalli non era accreditato come diplomatico presso
il governo laico di Ankara (che non aveva relazioni ufficiali con la Santa Sede) e
si occupava dei pochi cattolici del paese. Gli era stata anche affidata la delegazione
apostolica in Grecia, dove a fine aprile 1941 i tedeschi erano entrati ad Atene, innalzando
sull’Acropoli la bandiera con la svastica. Il 1º ottobre 1941, Roncalli era in Vaticano per riferire sulla Grecia occupata
e la Turchia, che aveva scelto la neutralità.
Il prelato aveva l’abitudine di annotare gli eventi di ogni giorno. Registrò quindi
sommariamente i contenuti del colloquio con Pio XII in quell’ottobre 1941. Il papa
mostrò “vivo interessamento” per la Grecia che versava ormai in una situazione umanitaria
drammatica. Lo pregò di ritornare a visitarlo dopo le sue vacanze a Sotto il Monte,
vicino Bergamo. Roncalli annotò una frase del papa: “Mi chiese se il suo silenzio [corsivo mio] circa il contegno del nazismo non è giudicato male”. Evidentemente il prelato fu colpito dalla domanda. Ancora oggi quella richiesta
stupisce. Il papa definisce come “silenzio” il suo atteggiamento verso “il contegno
del nazismo” e si preoccupa di come possa essere giudicato.
Siamo vent’anni prima della messa in scena a Berlino dell’opera di Rolf Hochhuth,
Il Vicario, che innescò nel 1961 il dibattito sui “silenzi” di Pio XII di fronte alle atrocità
naziste. “Silenzi” o “silenzio” divengono termini ricorrenti per indicare l’atteggiamento
del papa sulla Shoah e i tedeschi durante la guerra. In realtà – come si vedrà – non
è Hochhuth a utilizzarli per primo. Si trattava di espressioni con cui si definiva,
non sempre negativamente, l’imparzialità vaticana durante la guerra mondiale, non
solo riguardo agli ebrei. Il termine “silenzio” viene utilizzato talvolta anche da
parte dei rappresentanti dell’Asse, criticando l’atteggiamento del Vaticano sul comunismo.
Nel suo dramma Hochhuth rappresenta papa Pacelli mentre parla con padre Riccardo Fontana,
gesuita, personaggio immaginario, convinto della necessità di intervenire contro Hitler.
Fontana incarna l’anima “profetica” della Chiesa rispetto a quella diplomatica e –
secondo il drammaturgo – invita il papa a parlare:
...A Berlino ha visto
coi suoi occhi come i nazisti
gettavano i bambini ebrei sugli autocarri...
Un veemente Pio XII gli risponde, secondo il drammaturgo:
Chi vuole essere utile
non deve provocare Hitler.
...Abbiamo nascosto centinaia
di ebrei qui a Roma. Concessi
passaporti a migliaia.
Il papa afferma di lasciare ai vescovi locali la valutazione sull’opportunità d’intervenire
contro i nazisti, considerando le possibili conseguenze e rappresaglie. Spiega il
motivo del silenzio. Le sue parole potrebbero scatenare una reazione tedesca contro
la Chiesa e peggiorare la condizione degli ebrei. E conclude:
tacciamo anche
ad mala maiora vitanda.
La figura di Rolf Hochhuth è piuttosto complessa: in una fase della sua vita accusa
pure Churchill di responsabilità verso lo sterminio degli ebrei, mentre più tardi
lo si ritrova ad appoggiare le tesi negazioniste di David Irving. Ma non ci interessa qui indagare sul drammaturgo tedesco, quanto piuttosto sul successo
della sua opera. Il testo esprime interrogativi che aleggiavano da tempo. In fondo
– anche considerando il colloquio con Roncalli – il papa stesso s’interrogava sul
suo atteggiamento. Il processo in prima istanza al criminale nazista Adolf Eichmann
si era svolto a Gerusalemme nel 1961, mettendo in luce di fronte al mondo intero la
realtà della Shoah, attraverso la ricostruzione del ruolo di uno dei protagonisti
principali della macchina dello sterminio di massa. Hannah Arendt, che seguì il processo
a Gerusalemme, pubblicò nel 1963 Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, in sostanza il diario del processo: il libro ha avuto un impatto decisivo sulla
recezione della Shoah. Si diffuse una viva consapevolezza del dramma degli ebrei durante la guerra, ben
più profonda di quanto fosse accaduto dopo il conflitto e nel clima della ricostruzione.
Con l’autorevolezza di affermato scrittore cattolico, Carlo Bo introdusse la traduzione
italiana de Il Vicario nel 1964 (pubblicato in Germania un anno prima). Il dramma uscì in Italia mentre
si celebrava il Concilio Vaticano II. Uno storico laico come Giovanni Spadolini fu
tranchant: era un “libello di diffamazione anticlericale e di autodifesa nazionale”. Giulio
Andreotti, costante difensore di Pio XII, sospettò una manovra sovietica per distrarre
l’opinione mondiale dalle persecuzioni antiebraiche in URSS. Anche in Italia l’opera di Hochhuth fu oggetto di un intenso dibattito.
In quel periodo, nel mondo cattolico si respirava un’aria piena di aspirazioni al
rinnovamento della Chiesa. Giovanni XXIII, succeduto a Pio XII nel 1958, era morto
da un anno, circondato da grande affetto. Aveva cominciato a innovare i rapporti tra
Chiesa e mondo ebraico, anche con i cambiamenti della liturgia del Venerdì Santo,
abolendo la preghiera pro perfidis Judaeis. Dal Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate del 1965 sui rapporti tra Chiesa e religioni non cristiane, sarebbe emersa una prospettiva
innovativa sulle relazioni ebraico-cattoliche. Hans Küng, in un libro di riferimento nel post-Concilio, La Chiesa, edito in Germania nel 1967, osservava come l’antisemitismo nazista sarebbe stato
“impossibile” senza il bimillenario antigiudaismo cristiano. Il suo è un pensiero
influente: sosteneva che i più alti rappresentanti della Chiesa “si circondavano di
prudente silenzio opportunistico e politico o si esprimevano solo con esitazione,
sottovoce, servendosi di oscure clausole e diplomaticamente, senza forza profetica...”.
Dopo il Concilio, nella Chiesa è tempo di rinnovamento e – come si diceva – di “profezia”
(e anche di denuncia del male e dell’ingiustizia). In questo clima, le scelte di Pio
XII durante la guerra appaiono accomodanti, se non imbarazzanti, non solo per la coscienza
nuova della Shoah maturata nel mondo occidentale, ma anche per la “vocazione” profetica
della Chiesa. E pure per i nuovi rapporti di dialogo tra Chiesa e ebraismo. In vari
ambienti postconciliari, Pacelli appare come l’ultimo “sovrano pontefice”, un papa
tradizionale.
Carlo Bo definisce Il Vicario “un dramma cristiano”, non perché il papa avesse più responsabilità nella Shoah rispetto
ai leader alleati, ma perché “la Chiesa che ha paura del peggio e sceglie la strada
del minor male risponde in fondo a uno spirito di adattamento, a una specie di abdicazione...”:
“Un papa – aggiunge – che misura il suo silenzio è un papa che si adatta a una società
che da troppo tempo è stata abituata a non tener conto delle verità del Vangelo e
che ha lasciato crescere l’erba degli interessi immediati sul tronco stesso dell’uomo”.
Anche Pier Paolo Pasolini, che nel 1964 aveva diretto IlVangelo secondo Matteo (girato con l’appoggio degli ambienti cattolici e che aveva suscitato tanto interesse),
negli anni Settanta parla dell’“enigma di Pio XII” in una poesia: “Sono un Papa politico,
e perciò enigmatico” – così il poeta in quei versi fa autodefinire Pacelli. Facendogli
anche dire: “della carità so solo, come dice l’autorità, che c’è”. Un papa politico e diplomatico, espressione di una Chiesa che si è allontanata dalle
radici evangeliche.
Il Vicario incrocia fatti e sentimenti nuovi. Prima di tutto il processo di Gerusalemme ad Eichmann,
punto di svolta nella presa di coscienza della Shoah. Ma anche il “processo” di rinnovamento
della Chiesa cattolica, che mette in discussione l’immagine del passato e mira a una
riforma e a nuovi rapporti con gli “altri”, il mondo, le Chiese e le religioni. Il dramma – come detto – suscitò molte polemiche. La sua rappresentazione a Roma
fu impedita dalla questura, in forza del carattere sacro dell’Urbe, statuito dall’articolo
1 del Concordato (l’unico caso di applicazione di questo dettame concordatario), come
motivò il ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani.
L’atteggiamento di Pio XII sulla Shoah è stato dunque, per decenni, un tema di intense
discussioni. Il film Rappresaglia del regista George Pan Cosmatos (1973), che riprendeva le tesi del libro di Robert
Katz, Morte a Roma, ha dato luogo a un processo per diffamazione intentato dalla sorella di Pio XII,
Elisabetta Rossignani, contro il regista e il produttore Carlo Ponti, che si è concluso
con la loro condanna per diffamazione.
L’inizio dei “silenzi”
Voci critiche sull’atteggiamento di Pio XII non erano mancate fin dall’inizio del
pontificato. Emmanuel Mounier, filosofo cattolico francese e animatore della rivista
“Esprit”, osserva come Pio XII abbia taciuto di fronte all’invasione fascista dell’Albania.
E ne parla come di “silenzio”. Era il Venerdì Santo del 1939, quando l’Italia di Mussolini
invase l’Albania. Mounier scrive: “Due giorni dopo, nella festa di Pasqua, il capo
della cristianità pronuncia un’allocuzione... chiama i popoli alla pace. In termini
più precisi condanna le violazioni alla parola data. Il mondo, dolorosamente sorpreso,
non sente nessuna parola sulla sua bocca su questo Venerdì Santo di sangue”. Crede
che il papa abbia agito riservatamente. Sa “quanto sarebbe ridicolo per un fedele
sostituirsi alla coscienza di un pontefice”. Tuttavia la Chiesa deve parlare alle
coscienze: “...ci sono i popoli, Santo Padre, e non soltanto i Grandi; i popoli ricolmi
di solitudine. Ci sono quelle masse di cristiani che, per metà si abituano alla violenza
a forza di non vederla più scomunicare, e per metà abbassano la testa e ingoiano la
loro umiliazione...”.
Il filosofo pone il problema della coscienza cristiana di fronte alla violenza (che
sarà rilanciato successivamente dal card. Eugène Tisserant). I “silenzi” del maestro
supremo inducono le masse cristiane ad accettare passivamente la violenza indiscriminata,
che viene così legittimata nei fatti. Egli crede invece nel ruolo “educativo” della
Chiesa: “lo scandalo..., con questo silenzio, è penetrato in migliaia di cuori”. Che
aiuto può offrire un cristiano all’“angoscia di un conflitto interiore se [il papa]
debba scegliere tra il negoziato e l’eroismo”? – si chiede. Risponde: “i fedeli dall’interno
e i semi-fedeli dall’esterno possono arrecare un contributo alla decisione dicendogli
quanti lo seguirebbero irresistibilmente nei sentieri dell’eroismo, se egli stabilisse
d’impegnarvisi”.
Bisogna parlare ai fedeli e ai “semifedeli”. La Chiesa ha un’opinione pubblica interna
e non solo. Per Mounier non si tratta di decidere democraticamente la condotta del
papa. È però convinto che una forte parola papale possa sottrarre le masse cristiane
all’attrazione per la violenza dei regimi totalitari. Se il papa avesse imboccato
la via dell’“eroismo”, sarebbe stato sostenuto dai cristiani e da chi vedeva in lui
un simbolo di pace.
Per Mounier, nell’aprile 1939, in un’Europa a rischio di guerra, il conflitto interiore
di Pio XII di fronte alla politica bellicistica si risolve in un’opzione tra eroismo
e negoziato. Egli conclude rivolgendosi al papa: “non vorremmo morire senza aver difeso,
davanti a voi, la causa di tutti gli abbandonati che il vostro silenzio [corsivo mio], involontariamente, ha spinti un po’ più a fondo nel loro affanno...”. Qui – lo ripeto – si tratta dell’invasione fascista dell’Albania, uno Stato sovrano
peraltro già fortemente soggetto all’Italia. Non c’entra la questione degli ebrei,
anche se nel 1935 erano state promulgate le leggi di Norimberga in Germania, e nel
1938 quelle razziste in Italia. Mounier pensa che in un’Europa così conflittuale il
papato sia chiamato a una pubblica posizione. Già parla di “silenzio”.
Il card. Achille Silvestrini, diplomatico vaticano di rilievo al tempo di Giovanni
Paolo II, ricordava l’impressione negativa, quasi blasfema, dell’invasione fascista
dell’Albania il Venerdì Santo del 1939, quand’era seminarista. Era un sentimento diffuso
nel suo ambiente, nonostante la fascistizzazione dell’Italia di quel periodo.
Un tema molto sensibile
Il 2 giugno 1945, con la fine della guerra, Pio XII tenne un discorso ai cardinali
in cui rivendicava che la Chiesa non si era mai illusa sul nazionalsocialismo e che
era stata perseguitata da esso. E concludeva: “Ma se i reggitori della Germania avevano
deliberato di distruggere la Chiesa cattolica anche nell’antico Reich, la Provvidenza
aveva disposto altrimenti”. I dirigenti vaticani erano convinti di aver rischiato
al massimo nell’aiutare i perseguitati, tra cui gli ebrei. Sembrava loro che il papa
avesse espresso con chiarezza i principi della pace, condannando le azioni lesive
dei diritti e dell’umanità dei popoli.
Ma in Vaticano arrivavano anche critiche sul comportamento tenuto durante la guerra.
Non solo verso gli ebrei, ma soprattutto nei confronti della Polonia. Le proteste
polacche (del governo in esilio, degli ecclesiastici, ma anche della gente) erano
state numerose. Negli anni del conflitto, il governo polacco a Londra aveva costantemente
sollecitato la Santa Sede perché intervenisse contro i nazisti e i loro crimini verso
polacchi ed ebrei. Dopo la fine della guerra, gli ambienti polacchi all’estero trovarono
invece un appoggio nella Santa Sede, che non riconosceva il governo filosovietico
di Varsavia nel quadro della spartizione di Jalta. In Vaticano continuava a essere
accreditato l’ambasciatore del governo in esilio, Kazimierz Papée, mentre gli Stati
occidentali riconoscevano il governo “comunista” di Varsavia. Dopo la guerra, la Santa
Sede non riconobbe la Polonia, che aveva nuovi confini rispetto a prima della guerra.
Dal 1958, con l’elezione di Giovanni XXIII, Papée non fu più “gradito” dal Vaticano
(analoga sorte subì il rappresentante del governo lituano in esilio).
Nonostante Pio XII fosse generalmente salutato, nel dopoguerra, come una figura di
pace, difensore dei ricercati e degli ebrei, il tema dei rapporti con il nazismo preoccupava
il Vaticano. Non si tratta di elencare qui, per rispondere alla questione dei “silenzi”,
com’è stato fatto in difesa di Pio XII, i tanti riconoscimenti ebraici verso il papa
per l’aiuto offerto. Tali dichiarazioni hanno espresso una coscienza viva e sincera,
che non va dimenticata. Nel 1958, ad esempio, alla morte del papa, il futuro primo
ministro israeliano Golda Meir, allora responsabile degli Esteri, riconobbe che durante
il “martirio” degli ebrei “la voce del pontefice si è levata in favore delle vittime”.
Il problema dei silenzi è un altro, e non è in contrasto con le dichiarazioni di gratitudine
e stima verso Pio XII. Non è solo una questione del mondo ebraico, ma è divenuta una
problematica che riguarda i cattolici, come si vede dagli interventi di Bo e di altri,
tra cui il famoso scrittore francese François Mauriac, premio Nobel nel 1952. Il processo
di beatificazione di Pio XII ha suscitato opposizioni nel mondo ebraico, ma nemmeno
unanimi consensi nel mondo cattolico. Paolo VI annunciò in pieno Vaticano II la volontà
di procedere alla beatificazione di Pio XII e di Giovanni XXIII. Il processo sulle
virtù di Pio XII è stato aperto nel 1967 e affidato ai gesuiti. Si è proceduto con
molta cautela (Paolo VI seguiva personalmente la documentazione delle sedute del tribunale
presso il Vicariato di Roma). Il processo è stato completato da anni: a conclusione della prima fase, nel 1990,
Pio XII è stato riconosciuto “servo di Dio” e, al termine della seconda fase, nel
2006, “venerabile”, secondo la prassi. D’altra parte non c’è una spinta alla beatificazione
da parte dei fedeli, come invece per Giovanni XXIII (il cui villaggio natale è tanto
visitato dai pellegrini) o per Giovanni Paolo II.
L’eventualità della beatificazione di Pio XII, nonostante sia un fatto interno alla
Chiesa, continua a suscitare seri problemi tra Chiesa ed ebraismo. Durante la visita
di Giovanni Paolo II in Israele, il rabbino capo askenazita Israel Meir Lau chiese
che non fossero beatificate “persone che hanno taciuto mentre il sangue ebraico scorreva”.
Lau ha avuto un intenso rapporto con Wojtya, il quale – durante un incontro in Vaticano
– gli disse di aver conosciuto suo nonno materno, il rabbino Frenkel-Teomim, e di
ricordarlo mentre il sabato, a Cracovia, si recava alla sinagoga, circondato dai bambini. Le autorità vaticane hanno lasciato andare avanti il processo di Pio XII con lentezza
(mentre quello di Wojtya ha impiegato solo sei anni), ma non l’hanno fermato.
Il nodo sta nei “silenzi”. Si ritorna, in qualche modo, al colloquio tra Pacelli e
Roncalli nel 1941, da cui ho preso le mosse. L’alternativa ai silenzi era chiara anche
a un diplomatico di periferia, come Roncalli: prendere o no posizione esplicitamente
sulle crudeltà del conflitto. Roncalli, che trasmise a Roma notizie in proposito,
era conscio del problema. La sua sede di Istanbul, in un paese neutrale, era un crocevia
di contatti e di passaggi. Egli stesso si impegnò (ancora di più dopo il 1941) per
gli ebrei, onde evitarne la deportazione e favorirne il passaggio in Palestina.
L’alternativa ai silenzi viene evocata da Roncalli il 19 ottobre 1942, quando annota
nel diario, dopo aver preso visione di un cifrato vaticano: “Oh! le pene della Santa
Sede! Spesso non c’è che il gemito innanzi alle ingiustizie subite. Si potrebbe gridare
più forte. Ne verrebbero altri guai”. È la tesi, ad mala maiora vitanda, condivisa – sembra – dal prelato. La scelta di non gridare forte, onde evitare guai
maggiori, non riguarda solo la gravissima questione dello sterminio degli ebrei, ma
anche altri popoli che soffrono nel conflitto.
La Segreteria di Stato raccoglie in un documento alcune lettere giunte in Vaticano
dalla Polonia nel 1940, in cui si manifesta il “sentimento di amarezza” nella Polonia
occupata, fino all’“indignazione”. Il Vaticano fa una politica realista, “che condurrà
alla decadenza del prestigio della Santa Sede”: “Ci si domanda in Polonia se veramente
il governo polacco non ha la possibilità di ottenere dal Vaticano l’abbandono di questa
politica di silenzio [corsivo mio]; se non può ottenere una qualche manifestazione della Santa Sede contro
il male che si fa in Polonia?”.
La lettera esprime una delle tante critiche al silenzio sulle atrocità tedesche in
Polonia: si chiede di intervenire. La vicenda polacca viene seguita con grande attenzione
dal Vaticano, che ha numerosi riscontri di come non pochi cattolici polacchi percepiscano
la Santa Sede fredda e distante rispetto al dramma dell’occupazione del loro paese.
Su questo converrà ritornare. È un altro “silenzio”. La Polonia, nella geopolitica
cattolica, è assai rilevante per lo stretto rapporto con il papa di Roma. Polonia semper fidelis: l’antemurale del cattolicesimo di fronte all’Est ortodosso.
Il “silenzio” è un termine e una realtà con cui i diplomatici vaticani fanno i conti
fin dall’inizio della guerra. Prima di tutto, viene usato per la Polonia. Non abbiamo
la certezza che Pio XII, parlando con Roncalli, pensasse agli ebrei; forse, invece,
alludeva alle azioni persecutorie di Hitler contro i polacchi.
In realtà “silenzio” è usato anche per indicare l’atteggiamento vaticano verso i comunisti.
Nel settembre 1941, l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Bernardo Attolico
(che aveva parlato anche con Pio XII) dice a Domenico Tardini, responsabile della
sezione per gli Affari Straordinari della Segreteria di Stato (gli Esteri del Vaticano),
che la situazione è cambiata con la guerra dell’Asse all’URSS. Parla “come cattolico”:
“se si capiva bene il silenzio [corsivo mio] della S. Sede ove quella guerra fosse stata breve, sembra, invece,
opportuno, ora che la guerra è lunga, che ci sia una qualche manifestazione da parte
cattolica contro il comunismo (che è indiscutibilmente ateo)”. Tardini risponde: “quanto
al comunismo, è veramente ateo e condannabile. Ma condannabilissimo è anche il nazismo”.
Il papa non sarebbe contrario a far parlare un cardinale non di Curia sul comunismo,
tuttavia notizie successive sulle atrocità naziste sconsigliano ogni intervento: “non
era più possibile far parlare soltanto contro il bolscevismo”. Pressioni divergenti s’incrociano in Vaticano.
Ma cos’era la Santa Sede tra il 1939 e il 1945? Che cosa rappresentava il papato?
Pur nella continuità più che millenaria, quest’istituzione cambia fortemente rilievo,
presa e consistenza nel tempo. Uno dei rischi in cui si incorre, anche parlando di
Pio XII, è fare riferimento a un’“immagine” del papato contemporaneo e non collocarlo
nel tempo di cui si tratta.
Capitolo I.
L’isola vaticana
Relazioni diplomatiche
L’elezione di Pio XII era stata accolta con un certo favore in Italia (si noti un
significativo e irrituale telegramma di Mussolini). In Francia, era stata salutata
con particolare simpatia. Lì il card. Pacelli aveva compiuto due viaggi. I cardinali
francesi lo avevano appoggiato in conclave. Negli Stati Uniti era viva la memoria
del suo viaggio nel 1936, quando aveva incontrato privatamente il presidente Roosevelt.
Pure nel mondo britannico Pacelli era considerato un papa avverso alle dittature e
aperto ai governi democratici.
Qualche freddezza si registrò invece nel Portogallo di Salazar. Nella Spagna di Franco,
riservatamente, si espressero posizioni critiche verso l’eletto. In Germania, la scelta
del card. Pacelli fu accolta con ostilità, nonostante avesse vissuto a lungo nel paese,
ne parlasse la lingua e fosse un simpatizzante del popolo tedesco. Ma di quale Germania
era amico? In una nota informativa si legge che Pacelli è “amico della vecchia Germania
degli Stresemann, dei von Papen e di altri del vecchio mondo politico tedesco”. Due giorni dopo l’elezione di Pio XII, Hitler mostra il suo disappunto a Goebbels
che annota: “Egli sta pensando se non dovremmo abrogare il concordato con Roma, in
vista dell’elezione di Pacelli al papato. Questo accadrà certamente, quando Pacelli
intraprenderà la sua prima azione ostile”.
L’ambasciata d’Italia a Berlino informa Roma del giudizio su papa Pacelli formulato
negli ambienti della Wilhelmstrasse, il ministero degli Esteri tedesco, e in particolare
dal barone Ernst von Weizsäcker, segretario di Stato e futuro ambasciatore in Vaticano
dal 1943: “il card. Pacelli è dopo tutto un molto fine diplomatico non solo, ma...
né di troppo grande né di troppo forte volontà. Egli non è quindi, per natura, incline
ad azioni politicamente troppo spinte e troppo estreme”. La Wilhelmstrasse non aveva la stessa opinione dei gerarchi nazisti.
Pio XII, dopo il conclave, tentò di migliorare i rapporti con Berlino con una lettera
in cui annunciava a Hitler la sua elezione. David Kertzer ha ricostruito un episodio inedito di un certo significato: gli incontri
segreti tra il papa e il principe Filippo d’Assia, marito di Mafalda di Savoia (figlia
di Vittorio Emanuele III), fiduciario di Hitler, che si protraggono specie nel primo
anno di pontificato nella forma di un negoziato riservato tra Chiesa e Terzo Reich,
anche se alla fine i rapporti tra Berlino e il Vaticano sostanzialmente non migliorano.
Complessivamente, il Vaticano di Pio XII era in una condizione piuttosto marginale
nel quadro internazionale della fine degli anni Trenta. Godeva però del prestigio
storico della Chiesa e dell’attaccamento alla figura del papa (qualunque fosse) da
parte delle masse cattoliche in Europa, in America Latina e del Nord e in quello che
si chiamava il mondo delle missioni (spesso quello delle colonie).
La Santa Sede era un soggetto anomalo nel quadro delle “potenze”, nonostante la fine
della questione romana e la nascita dello Stato della Città del Vaticano nel 1929.
Certo, non aveva quella che è stata successivamente la forza del papato nella seconda
metà del Novecento: la grande attenzione dei media internazionali, che ha permesso
un’ampia diffusione delle posizioni e delle azioni del papa, affermatosi come un leader
spirituale mondiale.
Non si trattava più della condizione della Santa Sede nel 1914-1918, quando non poteva
contare sulla sovranità territoriale, pur intrattenendo alcune relazioni diplomatiche.
Allora i diplomatici dei governi belligeranti con l’Italia, accreditati in Vaticano,
si erano dovuti ritirare fuori dal Regno, interrompendo un contatto diretto, utile
per la Santa Sede, specie in tempo di isolamento dovuto alla guerra. Non erano mancati,
nel 1914-1918, una serie di incidenti che avevano mostrato la precarietà della situazione
giuridica e politica della Santa Sede e fatto auspicare una soluzione del problema
dopo la fine del conflitto.
I Patti del Laterano avevano superato l’impasse. Quando Pio XII viene eletto, lo Stato
vaticano esiste già da dieci anni. Pacelli è il secondo “sovrano” di questa “base”
territoriale della Santa Sede, talmente ridotta e incistata dentro Roma da essere
considerata ironicamente dal marchese Francesco Pacelli, fratello di Eugenio, negoziatore
dei Patti Lateranensi, uno “Stato-mezzo”. È uno Stato funzionale al servizio del papato, più che un mini-Stato sul modello
dei piccoli Stati europei dalle dimensioni più vaste del Vaticano e con una loro popolazione.
Il rapporto con l’Italia era rilevante per evidenti motivi. Da molti anni le relazioni
tra Chiesa e fascismo sono state studiate anche grazie all’emergere di nuova documentazione. Verso la fine degli anni Trenta, tali relazioni attraversavano un periodo di forte
tensione, dopo le leggi razziste e l’avvicinamento del regime alla Germania di Hitler. Ma i contatti tra Vaticano e Italia erano costanti, ufficiali e ufficiosi: il che
non vuole sempre dire buone relazioni.
Del resto il Vaticano è un’enclave nella capitale e il papa è il vescovo di Roma.
L’italianità del personale vaticano, la vicinanza geografica, la frequentazione comune
di taluni ambienti (come il palazzo Colonna, dove s’incontrano Ciano e il Sostituto
Montini) consentono una molteplicità di scambi e di colloqui. In uno di questi incontri,
nel gennaio 1943, propiziato dal principe Marcantonio Colonna su richiesta di Ciano,
quest’ultimo confida al Sostituto la sua contrarietà alla guerra e alla partecipazione
italiana ad essa: “afferma – nota Montini – che la Santa Sede avrà la sua importanza
nell’esito di questa guerra”.
La Chiesa italiana faceva capo immediatamente al papa e alla Santa Sede. L’Italia
mussoliniana era però sempre più distante dal modello di Stato che Pio XI aveva “sognato”
all’epoca della Conciliazione, quando aveva sperato nella conversione del fascismo
in regime cattolico. Il gesuita Pietro Tacchi Venturi era il tramite costante dei
rapporti tra Pio XI e Mussolini, che visitava a palazzo Venezia: per anni aveva trasmesso
in via informale i desiderata di papa Ratti e le risposte del duce.
Giovanni Coco ha ricostruito le relazioni tra il regime e la Chiesa ne Il labirinto romano, mettendo in luce un rapporto complesso, fatto di contatti e vicinanza, ma anche
di notevoli differenze. Il Vaticano, a prevalenza italiana, non è filofascista (anche
se non mancano prelati di questo orientamento) ma molto attento alle questioni italiane.
Ha una visione europea, perché i cattolici vivono in tutti i paesi del Vecchio Continente
e gli equilibri europei condizionano notevolmente la politica mondiale. Del resto
la Santa Sede segue con attenzione vari paesi extraeuropei, che Pio XII ha conosciuto
nei suoi viaggi da segretario di Stato.
Sul finire del pontificato di Pio XI, le relazioni tra le due “sponde” del Tevere
sono difficili. Tuttavia Mussolini, il 26 dicembre 1941, riceve a palazzo Venezia i nipoti di Pio
XII, Carlo, Giulio e Marcantonio, che lo ringraziano per la concessione del titolo
di principe alla memoria del padre Francesco, fratello del papa e negoziatore dei
Patti Lateranensi, e trasmettono al duce gli auguri natalizi di Pio XII. Anche questo
succede a Roma, realtà complessa e trasversale, in cui però non bisogna sopravvalutare
i singoli fatti. Il duce risponde cordialmente ai Pacelli e conclude riguardo al papa:
“il suo, per molti segni, si annuncia già come un grande pontificato”. Sembra un segnale,
ma – come registrano i fratelli Pacelli – l’udienza nella sala del mappamondo dura
dalle 10,58 alle 11,03.
Pio XII, appena eletto, nonostante fosse stato il primo collaboratore di papa Ratti,
“vuole ristabilire e mantenere buone relazioni con tutti e di queste servirsi per
favorire il componimento delle discordie tra gli Stati, assicurando la pace al mondo”. Questa sua strategia fa parte di una politica di allentamento delle tensioni, anche
perché è all’orizzonte il rischio di un conflitto. Pio XII, all’inizio, prova a migliorare
i difficili rapporti con Berlino.
L’elezione di Pacelli – notano i diplomatici – non era stata una vittoria per i paesi
totalitari, perché il nuovo papa aveva condiviso la linea del suo predecessore, con
un ruolo personale decisivo verso la Germania. Pio XII conosceva la realtà del cattolicesimo
tedesco, ma era conscio della scarsa forza della Chiesa nei confronti di Hitler e
del fatto che egli intendesse ridurne progressivamente lo spazio.
L’azione del nunzio a Berlino Cesare Orsenigo, successore di Pacelli nella capitale
tedesca dal 1930, nonostante fosse l’unico tramite per i rapporti con i territori
occupati dalla Germania, era ostacolata o spesso respinta. Nel giugno 1940, la Wilhelmstrasse
informò il Vaticano che le nunziature dell’Aja e di Bruxelles erano soppresse e le
comunicazioni sul Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo dovevano passare per la nunziatura
di Berlino. Negli anni di guerra, il governo nazista rese sempre più difficile l’attività
di Orsenigo riguardo alla Polonia occupata o ai territori annessi alla Germania, e
rifiutò ogni intervento sugli ebrei. Nel 1942, un ordine del Führer precisò che la Germania intratteneva relazioni con
la Santa Sede solo per le questioni riguardanti lo Altreich, il vecchio Reich, cioè i territori del 1933. Se il nunzio non godeva fama di personalità
forte, tuttavia i limiti alla sua azione erano pesanti.
Orsenigo era anche decano del corpo diplomatico a Berlino. In questa veste, nel 1941
aveva ricevuto in nunziatura l’ambasciatore sovietico in una visita formale con cui
il nuovo diplomatico si presentava al decano. Orsenigo non mancò di chiedere all’ambasciatore
notizie dei cattolici nei paesi baltici e sul personale religioso in Russia, ricevendo
risposte rassicuranti.
Il nunzio era un sacerdote milanese ben conosciuto da Pio XI e da lui avviato alla
diplomazia. Il suo atteggiamento durante l’incarico a Berlino è stato giudicato da
Giuseppe Dossetti “assolutamente e manifestamente inadeguato”. Anche il vescovo di Berlino, Konrad von Preysing, riteneva che non fosse all’altezza
di una missione così difficile e osteggiata. Aveva dubbi non solo sull’uomo, ma anche
sulla funzione della nunziatura in una Germania nazistificata: “Mi chiedo – scrive
– se sia giusto che Sua Santità, di questi tempi (vedi la questione degli ebrei, la
persecuzione eccetera), sia ancora rappresentato presso il governo tedesco da un ambasciatore”. Orsenigo non è un personaggio di spicco ma, da parte sua, incarna il limite della
diplomazia nei confronti del nazismo.
Le relazioni internazionali della Santa Sede non erano in genere di grande rilievo.
Con il Regno Unito non erano intense, tanto che a Londra non risiedeva un nunzio,
ma un delegato apostolico senza statuto diplomatico. La diplomazia britannica era
invece rappresentata in Vaticano, dal 1936, dal ministro Francis D’Arcy Godolphin
Osborne, la cui presenza non era molto influente. Il Regno Unito considerava la Santa Sede
poco autonoma rispetto al fascismo, incorrendo in una semplificazione. Con l’aumento
delle tensioni in Europa, però, la rappresentanza britannica si fece più importante
per Londra: il progetto ambizioso era quello di dividere Mussolini da Hitler. Risultò
allora più evidente l’estraneità del papato ai regimi totalitari.
Nel 1943, il delegato apostolico a Londra trasmise un rapporto confidenziale del Foreign
Office in cui si sosteneva che l’atteggiamento vaticano si era fatto cauto dopo l’occupazione
tedesca di Roma, mentre era divenuto facile per i tedeschi controllare o addirittura
bloccare le comunicazioni vaticane con il mondo. I programmi della Radio Vaticana
si erano moderati molto nei contenuti, divenendo prudenti anche nell’esposizione dei
principi umani e cristiani che avrebbero potuto mettere in discussione lo spirito
bellico. Questo il giudizio britannico sulla politica vaticana: “la dottrina vaticana,
di cedere in tutto fuorché nelle cose essenziali, per evitare mali maggiori, è anche
ben nota”. Osborne, scrivendo a Londra nell’ottobre 1942, parlava di “una politica del silenzio”
del Vaticano che nuoceva al ruolo di “guida morale”.
Anche sulla città di Roma gli inglesi non sembravano disposti ad ascoltare le richieste
vaticane durante la guerra. Quando il generale Eisenhower viene spostato dal teatro
bellico mediterraneo nel 1943 e sostituito da un inglese, Pio XII esprime le sue preoccupazioni
ad Harold Tittmann, che rappresentava gli Stati Uniti dentro le mura leonine. Il papa
temeva – nota Tittmann – che “potesse significare minore considerazione per il Vaticano
da parte dell’alto comando alleato”. L’americano credeva “che questa paura riflettesse
la convinzione, diffusa in Vaticano, che nel governo inglese ci fosse una corrente
anticattolica capeggiata da Eden”.
Il card. Pacelli era considerato filodemocratico dai tedeschi, soprattutto filofrancese.
Si faceva notare il forte rapporto con la Francia, visitata due volte come legato
papale, prima recandosi a Lourdes e poi a Lisieux. Nella seconda visita, il cardinale
si era fermato a Parigi dove, oltre al programma religioso, ne aveva svolto uno politico,
recandosi al Quai d’Orsay e all’Eliseo. Il legato fece una buona impressione e apparve
un simpatizzante del paese, di cui parlava correntemente la lingua. In Francia Pacelli,
prima a Lourdes nel 1935 e poi a Notre Dame nel 1937, condannò apertamente “la superstizione
della razza e del sangue”.
L’ambasciatore francese François Charles-Roux, accreditato dal 1932 presso la Santa
Sede, era forse il diplomatico più di peso in Vaticano. Le sue memorie rappresentano
una documentazione significativa anche per gli albori del pontificato di Pio XII. Egli lo descrive come amabile. Osservava come avesse mantenuto un tratto semplice
anche dopo l’elezione a papa, anche se notava che – con il pontificato – era avvenuta
una trasformazione nell’uomo. L’ambasciatore Wladimir d’Ormesson, succeduto a Charles-Roux
nel maggio 1940, esprimeva un giudizio severo sul Vaticano, probabilmente anche per
l’emozione della sconfitta francese: “È la paura che controlla tutto qui... D’altra
parte, il papa si esprime sempre in uno stile contorto e fiorito, che toglie ogni
forza al suo pensiero, lo castra”.
Nel 1940 il governo Pétain, dopo l’armistizio francese con la Germania, cambiò ambasciatore
nominando un politico di lungo corso, Léon Bérard, vicino all’Action Française e a
Pierre Laval. Bérard rassicurò Pétain, con un rapporto del settembre 1941, che il
Vaticano non condannava lo statuto degli ebrei, approvato dal regime collaborazionista
francese il 2 giugno 1941, salvo sul punto che un ebreo battezzato dopo il giugno
1940 venisse considerato dalla legge ancora ebreo. Non c’erano da temere condanne
da Roma.
Pressoché nulli e molto contrastati erano i rapporti tra Santa Sede e Unione Sovietica,
la cui espansione politico-ideologica era molto temuta nei palazzi vaticani. Eppure,
negli anni Venti, la Santa Sede aveva tentato alcuni contatti diplomatici con i “sovieti”,
come si legge nei documenti vaticani. Proprio il nunzio a Berlino, Pacelli, aveva
incontrato il commissario agli Esteri sovietico, Georgij ierin, a casa del ministro degli Esteri tedesco, attorno a una buona tavola, discutendo
con lui un eventuale statuto della Chiesa in Unione Sovietica. L’incontro, franco e cordiale, non aveva condotto a risultati concreti e negli anni
Trenta mondo cattolico e mondo comunista si erano fortemente scontrati anche sul piano
propagandistico. L’enciclica Divini Redemptoris di Pio XI aveva espresso nel 1937 una condanna severa del “comunismo ateo”.
I negoziati di Berlino, tra un nunzio che sarebbe divenuto il papa della cosiddetta
scomunica ai comunisti del 1949 e un ministro sovietico, rivelano un atteggiamento
di fondo della diplomazia vaticana, mai dismesso pure in tempi di forti scontri: cercare
il contatto e il dialogo anche con gli Stati più ideologicamente lontani, pur di assicurare
un modus vivendi alla Chiesa. Nella diplomazia del “negoziato nonostante tutto” si mostra una costante:
provare a garantire la libertà religiosa dei fedeli, almeno quella di culto. In questo
atteggiamento c’è la coscienza della propria fragilità: i cattolici, parte del paese
con cui si negozia, ne divengono in qualche modo ostaggio, se questo è insensibile
alle esigenze della Chiesa.
La filosofia del negoziato si nutre anche di un’altra consapevolezza. La Chiesa non
può non trattare (magari limitatamente) con lo Stato nel cui territorio vivono i suoi
fedeli. L’esperienza di una Chiesa clandestina con ordinazioni segrete di vescovi
e preti in URSS, realizzata a metà degli anni Venti dal gesuita mons. Michel d’Herbigny,
poi caduto in disgrazia presso Pio XI, era stata infelice. Un fallimento, su cui i decisori vaticani potevano meditare. Tuttavia il negoziato
tra Mosca e il Vaticano non era progredito, non solo per lo scontro ideologico e la
persecuzione antireligiosa, ma perché, alla fine degli anni Venti, l’URSS era ormai
disinteressata.
Il rifiuto da parte di Mosca di trattare con la Santa Sede sui cattolici in URSS si
è protratto praticamente fino all’ascesa di Gorbaëv, al contrario dei governi dell’Est che hanno intrapreso da prima negoziati con
il Vaticano. Dal 1929, si era aperto il grande scontro tra Roma e Mosca, di cui già
si erano evidenziate tutte le premesse negli anni precedenti: la “crociata” anticomunista
si contrapponeva alla propaganda comunista anticattolica e antireligiosa. Non esisteva alcuna interlocuzione diretta tra Santa Sede e Mosca. L’attacco tedesco
all’URSS, nel giugno 1941, pur rappresentando un fatto politico-militare di grande
importanza, non spinse però il Vaticano ad assecondare la lotta al comunismo, nonostante
le pressioni tedesche in tal senso. L’affermazione che vuole un Vaticano favorevole
alla guerra nazista contro l’URSS, quasi una sorta di crociata, è priva di fondamento.
Paradossalmente i migliori rapporti del Vaticano, alla vigilia della seconda guerra
mondiale, erano quelli con gli Stati Uniti di Roosevelt. Eppure mancavano relazioni
ufficiali. Il presidente aveva inviato come suo rappresentante all’incoronazione di
Pio XII l’ambasciatore a Londra, il cattolico Joseph Kennedy, padre del futuro presidente
degli Stati Uniti, mentre il 20 marzo 1939 aveva ricevuto alla Casa Bianca il delegato
apostolico Amleto Cicognani, che avrebbe ufficiosamente rappresentato la Santa Sede
a Washington per venticinque anni fino al 1958. Roosevelt, in occasione dell’incontro
con Cicognani, aveva auspicato una graduale soluzione del problema dei rapporti ufficiali
tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, anche per valorizzare il grande contributo del
papa alla causa della pace.
Molti anni fa lo storico Ennio Di Nolfo ha pubblicato le carte del rappresentante
personale del presidente Roosevelt, Myron Taylor, presso il papa. La sua nomina, voluta da Roosevelt (e confermata da Truman), aveva rappresentato
una grande novità tra Roma e Washington. Taylor tenne i rapporti con il Vaticano dal
1939 al 1952. Ebbe influenza anche sulla politica americana nell’Italia del dopoguerra,
fornendo le informazioni ricevute dal Vaticano. Inoltre si occupò dei contatti con
il mondo delle religioni in chiave antisovietica dopo il conflitto, quasi per creare
un fronte religioso opposto al comunismo. In questo quadro influenzò, dopo la guerra,
la scelta del patriarca ortodosso di Costantinopoli promuovendo la figura di Athenagoras,
assai stimato negli Stati Uniti e da Roncalli, in chiave di contenimento dell’influenza
sovietica sul mondo ortodosso.
Le carte di Taylor mostrano l’interesse della Casa Bianca per la Santa Sede, ma pure
la grande attenzione con cui il Vaticano coltivava i rapporti con gli Stati Uniti.
Gli americani, in un primo momento, pensavano che il papa potesse fermare l’ingresso
di Mussolini in guerra. A sua volta Pio XII, sia durante il conflitto che dopo, considerava
gli Stati Uniti il principale interlocutore della Santa Sede. Gli Stati Uniti, durante
la guerra, hanno evitato pressioni troppo forti sul Vaticano – a differenza di altri
governi – perché intervenisse pubblicamente e sostenesse le loro posizioni. La diplomazia
americana aveva una comprensione più larga e strategica del ruolo della Santa Sede
in confronto alle diplomazie alleate, strette dalle necessità della guerra.
A guerra inoltrata, gli americani consultarono i dirigenti vaticani sul possibile
assetto dell’Italia e dell’Europa dopo il conflitto. Venne dalla Santa Sede, in modo
sfumato ma chiaro, il suggerimento di un nome per la guida del futuro governo: l’ex
popolare Alcide De Gasperi, al tempo bibliotecario nella Biblioteca Apostolica Vaticana,
che operava clandestinamente per dare vita alla DC, il partito cattolico il quale
avrebbe avuto sempre più il consenso del papa.
Gli americani non mancarono anche di fare qualche importante “cortesia” assai apprezzata
dal Vaticano, che si trovava in difficoltà in un’Europa dominata dai nazisti. La Santa
Sede aveva necessità di mettere in sicurezza i propri fondi in Europa. Il card. Luigi
Maglione chiese a Taylor un aiuto perché una “notevole quantità” di lingotti d’oro
di proprietà vaticana potesse essere trasferita dalla Gran Bretagna alla custodia
fiduciaria dei banchieri americani. Le autorità britanniche accordarono il permesso,
che fu richiesto da Bernardino Nogara, alla testa dell’Amministrazione Speciale della
Santa Sede. Era anche necessario ottenere l’esenzione dai vincoli statunitensi ai capitali stranieri,
che fu accordata. L’oro, valutato più di sette milioni e mezzo di dollari, costituiva quasi tutta
la riserva vaticana (di cui una parte fu cambiata in dollari). Si tratta di una questione di importanza fondamentale per il piccolo Stato che,
nella crisi della guerra, voleva mettere in sicurezza i capitali e che impiegava molta
liquidità per operazioni umanitarie dalle proporzioni crescenti. L’indipendenza vaticana
è garantita dall’autonomia finanziaria.
Nell’aprile 1940, nel quadro della guerra “economica” all’Asse, il presidente Roosevelt
aveva congelato i beni dei paesi e dei cittadini europei, con l’esclusione del Regno
Unito. Svizzera, Italia e San Marino erano compresi nel divieto, ma non il Vaticano,
che, attraversando le frontiere dell’Europa in guerra, fece degli Stati Uniti il centro
finanziario dei propri investimenti, spesso su buoni del tesoro americani o industrie
(di cui alcune – sembra – anche legate all’impegno militare). I fondi vaticani, depositati
negli Stati Uniti, servivano pure a sostenere le azioni umanitarie e l’aiuto agli
ebrei. Attraverso questi canali finanziari e tramite un sistema di compensazioni giungevano
tra le mura leonine anche finanziamenti di privati o di istituzioni americane o britanniche.
Il governo americano trattava con favore le attività finanziarie vaticane con la concessione
di una licenza rispetto al congelamento dei fondi stranieri. Si vede come, nella gestione
delle risorse finanziarie, la Santa Sede non si attenesse all’imparzialità, ma considerasse
gli Stati Uniti non solo un paese che garantiva i suoi interessi, ma anche su cui
si poteva puntare con sicurezza. Del resto la Santa Sede aveva operato la conversione
in dollari di parte cospicua delle sue risorse all’estero.
In questo quadro l’Istituto Opere di Religione, lo IOR, esercita una funzione di rilievo,
poco notata. È un canale finanziario transnazionale di uno Stato neutrale, che subisce
minori limitazioni e può effettuare transazioni valutarie. Tramite lo IOR, la Santa
Sede riceve importanti risorse (dagli Stati Uniti, dai cattolici e da fonti ebraiche,
specie americane) per finanziare interventi umanitari. Lo IOR è utilizzato dal governo
Badoglio, nel 1943-1944, per far arrivare a Roma finanziamenti ai militari nascosti,
raggiunti clandestinamente nella basilica di San Giovanni in Laterano, e anche al
CLN. Il passaggio di risorse economiche, attraverso le frontiere chiuse di un mondo in
guerra, era decisivo per la Santa Sede.
Complessivamente, comunque, il Vaticano non era un centro di relazioni diplomatiche
di grande rilievo. Lo storico Owen Chadwick, tracciando il quadro dell’ambiente diplomatico
nel 1936, scrive: “I servizi diplomatici hanno bisogno di un certo numero di sinecure
ben retribuite per i loro membri...”. Tale era il Vaticano, dove in sedi prestigiose
vivevano una vita tranquilla diplomatici non troppo impegnati o a fine carriera. Nel
1942, trentasette paesi avevano rappresentanti diplomatici presso la Santa Sede, compreso
il Sovrano Militare Ordine di Malta (che è anche un ordine religioso cattolico, dotato
di sovranità), non tutti residenti a Roma.
Ambasciate ben organizzate in Vaticano erano quelle del Brasile, dell’Argentina, del
Cile, del Portogallo, della Spagna e dell’Ungheria che, per il carattere cattolico
di questi paesi, tenevano ad una rappresentanza adeguata. Anche la Slovacchia, presieduta
da mons. Jozef Tiso, dopo la scomparsa della Cecoslovacchia a seguito dell’accordo
di Monaco, era rappresentata in Vaticano. Il quale, da parte sua, aveva come incaricato
d’affari a Bratislava un giovane e intraprendente sacerdote, mons. Giuseppe Burzio.
La Jugoslavia, nel 1942, aveva un ambasciatore in Vaticano, nonostante il regno fosse
stato smembrato e occupato. Unico paese a maggioranza ortodossa accreditato in Vaticano
era la Romania, dove viveva un’importante minoranza greco-cattolica. Alcuni ambasciatori
soggiornavano temporaneamente a Roma. Infatti, l’Annuario Pontificio pubblica le loro sedi in alcuni alberghi romani. Altri paesi erano rappresentati
da italiani, come il marchese Giulio Pacelli per il Costarica.
La scarsa considerazione del ruolo diplomatico del Vaticano emerge anche da un caso.
Dal 1920 la Germania aveva lo stesso ambasciatore presso la Santa Sede, Diego von
Bergen, figura non omogenea al regime di Hitler, mantenuta in tale posizione anche
dopo l’avvento del nazismo. Era divenuto decano del corpo diplomatico in Vaticano
ma, per le divergenze con il nazismo, manteneva una presenza defilata. Solo nel 1943
von Bergen fu sostituito da Ernst von Weizsäcker, segretario agli Esteri a Berlino,
che aveva chiesto di cambiare incarico. Conservatore, velatamente critico nei confronti
della guerra, attivo nella diplomazia tedesca, non identificato con il regime, Weizsäcker
però non fece nulla per impedire la deportazione degli ebrei di Roma il 16 ottobre
1943, se non evitare reazioni pubbliche da parte vaticana. Nei suoi rapporti a Berlino, descrisse il papa come incerto e non ostile alla Germania,
anche per prevenire un’azione anticattolica da parte dei nazisti e il prelevamento
di Pio XII, cui era contrario. Con questa rappresentazione del papa, mostrava a Berlino
l’opportunità di una politica non aggressiva.
La Santa Sede teneva ad avere relazioni con il maggior numero di Stati, per ribadire
il suo carattere di soggetto internazionale. Un gruppo di sacerdoti, tutti italiani
(con qualche limitata eccezione), sotto la guida di Pio XII, seguiva gli sviluppi
internazionali con passione, attenzione e forte partecipazione, non solo nella prospettiva
degli “interessi cattolici”, ma anche della pace, della politica internazionale e
delle questioni umanitarie aperte dal conflitto. Si trattava di un osservatorio particolare,
unico tra le cancellerie del mondo. Era anche il terminale cui facevano riferimento
gli episcopati del mondo, le congregazioni religiose, personalità cattoliche e sacerdoti
d’ogni paese, oltre che la rete diplomatica vaticana. Gli archivi rivelano le tante
informazioni che pervenivano in Vaticano.
Pio XII
Si è molto insistito sul carattere diplomatico di Pio XII. Del resto aveva svolto
gran parte della sua attività proprio nel lavoro politico-diplomatico. Un nunzio,
Francesco Borgongini Duca, di poco più giovane di Pacelli, così illustrava il valore
“sacerdotale” del servizio diplomatico a un ecclesiastico che esprimeva perplessità:
quando riusciamo a strappare ai governi qualche concessione in favore della libertà
della Chiesa, della nomina dei Vescovi, delle scuole cattoliche, salviamo molte più
anime di quando confessiamo e predichiamo. Del resto, la domenica e tutti i tempi
liberi dall’ufficio, tu seguiterai ad aiutarmi per fare un po’ di bene ai nostri ragazzi...
Questa era la visione degli ambienti diplomatici, di cui Pacelli era partecipe. Già
alla testa degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nunzio a Monaco e Berlino, infine
segretario di Stato, era privo di esperienze pastorali nella guida di una diocesi.
Che tale esperienza fosse necessaria per il papato è un’opinione invalsa successivamente,
anche per la concezione più “pastorale” della Chiesa postconciliare. Tuttavia è un
fatto che, dal 1667, un segretario di Stato non veniva eletto papa. L’ultimo fu Clemente
IX.
Le ombre del conflitto imminente pesarono sul conclave che, il 2 marzo 1939, al terzo
scrutinio, in meno di ventiquattro ore, elesse papa il card. Pacelli con 48 voti su
63. L’alternativa era l’italiano Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, stimato dai
porporati della penisola, allora in gran numero. Una rispettata figura di “pastore”,
veneto d’origine, che aveva trascorso la vita nel ministero pastorale. Un ecclesiastico
forte, non politico, capace di evidenziare pubblicamente il distacco della Chiesa
di Firenze durante la visita di Hitler ma in sintonia con Pio XI. C’era anche la candidatura del card. Maglione, un diplomatico. L’esperienza diocesana
di Dalla Costa apparve però limitata alla maggioranza dei porporati di fronte alla
crisi all’orizzonte. Pacelli era più attrezzato grazie all’esperienza internazionale
e alla vicinanza a Pio XI. Insomma – a quanto è dato di capire – fu scelto soprattutto
perché era il miglior diplomatico della Santa Sede e già al corrente delle grandi
questioni del papato.
Eugenio Pacelli era molto conosciuto nel collegio cardinalizio, non solo per la posizione
centrale che occupava nel governo vaticano: nunzio in Germania, dov’era popolare tra
i cattolici, aveva intrapreso, in qualità di segretario di Stato, viaggi in Francia
(due volte), Ungheria, Stati Uniti e Argentina. Questi viaggi erano stati sollecitati
da Pio XI che voleva promuovere la sua persona. Le visite avevano avuto un carattere
popolare e pastorale a contatto con le masse cattoliche, oltre che con le autorità
politiche. La sua figura, ieratica e religiosa, si scioglieva nel contatto umano con
bonomia romana e simpatia. Uomo di grande cortesia, manifestava condiscendenza nei
rapporti. Come ho già detto, era considerato uno dei migliori diplomatici vaticani,
appartenente alla generazione dei cardinali Marchetti Selvaggiani, Cerretti, Tedeschini
e altri.
Tuttavia c’erano riserve sulla sua persona. Il card. Tisserant non era d’accordo con
i colleghi francesi, tutti per Pacelli, giudicandolo “indeciso, esitante”. Sembra sia stata un’iniziativa dei cardinali francesi, cui si associò Tisserant,
quella di domandare a Pacelli di prendere come segretario di Stato l’ex nunzio a Parigi,
Maglione, con cui del resto il nuovo papa aveva ottimi rapporti e si dava del tu.
“Il cardinal Pacelli è un uomo di pace, e il mondo oggi [ora] ha bisogno di uomini
da battaglia” – avrebbero argomentato alcuni cardinali, secondo lo storico austriaco
Friedrich Engel-Jánosi. Non erano giudizi maliziosi. La personalità di Pacelli era segnata da aspetti di
incertezza ed era molto diversa dal carattere imperioso di Pio XI. Tardini, stretto
collaboratore di Pio XI e di Pio XII, poi segretario di Stato di Giovanni XXIII, così
lo descrive:
Pio XII era, per naturale temperamento, mite e piuttosto timido. Non era nato con
la tempra di lottatore. Diverso in ciò dal suo grande predecessore, Pio XI. Questi,
almeno visibilmente, godeva nella lotta. Pio XII, almeno visibilmente, ne soffriva.
Quella stessa inclinazione, che lo portava a prediligere la solitudine e la quiete,
lo disponeva piuttosto ad evitare di affrontare le battaglie della vita.
E ancora:
La sua grande bontà lo spingeva a contentare tutti e non inasprire nessuno... Certe
volte, nei momenti più difficili, la sua acuta intelligenza, proclive al particolare,
gli prospettava con prontezza e chiarezza tutte le soluzioni possibili. Di ciascuna
scorgeva immediatamente il pro e il contra... Perciò talora rimaneva incerto, oscillante,
quasi non si sentisse sicuro di sé. Bisognava lasciarlo riflettere e pregare. Ma non
tutti facevano così... Presa una decisione si passava ad eseguirla: periodo delicato
anche questo, specialmente se la decisione era tale da spiacere a qualcuno. In tal
caso Pio XII amava... “addolcire la pillola”.
Tardini, incline a soluzioni decise, aggiunge ironicamente che la “pillola” era talmente
addolcita che spesso il “paziente” quasi non avvertiva il messaggio. A causa del carattere
mite, in Pio XII nacque a un certo punto il timore di ricevere “alti dignitari ecclesiastici
e sacerdoti” perché non amava rifiutare loro quanto gli chiedevano, talvolta in modo
insistente. Così sulle nomine, sottoposto a varie pressioni, il papa restava incerto:
“Perciò – dice Tardini – ...non amava fare cambiamenti e preferiva differire”.
Pio XII ebbe un concetto molto alto del suo ministero, tanto da forzare il suo carattere
– insiste Tardini. Il prelato parla di un uomo che durante il pontificato si è trasformato:
“uomo di pace, papa di guerra”. Ricorda una frase di Pio XII, espressiva del senso
alto del suo servizio: “il Papa deve parlare da Papa”. Fu infatti un attento comunicatore,
molto impegnato nella scrittura dei suoi discorsi, e un fervente predicatore, tanto
che Pio XI lo chiamò “oratore pentecostale”. Tardini tiene una commemorazione innanzi alla Curia e a Giovanni XXIII a un anno
dalla morte di Pio XII. La ricostruzione del carattere di papa Pacelli è realistica,
lontana dal consueto stile laudativo di tante rievocazioni vaticane di allora.
Pacelli, signorile, ieratico, acuto, talvolta delicatamente ironico, poliglotta, con
un fine accento romano (diceva sempre: “Chièsa”), appariva a taluni troppo fragile
per la tormenta della guerra. Jacques Maritain, ambasciatore francese dal 1945 al
1948, osserva: “Il Papa Pio XII porta in ogni cosa, e fino al minimo dettaglio, una
preoccupazione scrupolosa di fare bene e di fare il bene... Di una delicatezza e di
una sensibilità estreme, desideroso di non ferire nessuno, esitante a lungo nel prendere
una decisione, si tiene molto più fermo a quello che ha una volta deciso e può all’occasione
mostrare un certo rigore”. Sono osservazioni simili a quelle di Tardini. L’ambasciatore
continua il ritratto del papa parlando “dell’intelligenza e della bontà” che emanano
dalla sua persona. Maritain dà però anche un giudizio severo:
Pio XII parrebbe più preoccupato dei risultati pratici da conseguire con le vie della
prudenza politica e della diplomazia e con l’esercizio della carità, che della testimonianza
da dare ponendo atti e facendo sentire parole che scuotono la coscienza dei popoli.
Da qui certe delusioni sentite dal mondo e che senza dubbio affliggono lui stesso
e che il suo costante e incomparabile sforzo di buona volontà non può evitare...
Pio XII aveva la coscienza acuta della sua responsabilità “unica”: “era un capo ed
esercitava il suo ufficio con la autorità di un capo” – osserva lo storico Arturo
Carlo Jemolo, il quale aggiunge che non fece “condanne formali del governo nazista”
per evitare ulteriori persecuzioni e non mettere i cattolici nell’alternativa tra
rifiutare l’autorità papale o subire la repressione. La coscienza del papa, specie in guerra, era inquieta: soppesava le decisioni e
le conseguenze delle scelte. Pio XII confida all’ambasciatore italiano in Vaticano,
Dino Alfieri, in partenza come ambasciatore per la Germania nel 1940, di aver letto
le lettere che Santa Caterina da Siena scrisse a papa Gregorio XI, in cui lo ammoniva
che avrebbe ricevuto da Dio un giudizio molto severo se non avesse reagito al male
e non avesse fatto il suo dovere. Dice al diplomatico di essere “pronto anche ad essere deportato in un campo di concentramento,
ma non a fare alcunché contro coscienza”.
Alfieri, nell’incontro, aveva comunicato al papa la reazione critica degli ambienti
fascisti per i telegrammi da lui inviati ai sovrani degli Stati invasi da Hitler,
il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo. Il papa “si è mostrato molto tranquillo
e sereno, osservando di non avere paura di finire, se sarà il caso, in campo di concentramento
o in mani ostili. ‘Non abbiamo avuto timore, soggiungeva, delle rivoltelle puntate
una prima volta contro di noi, ne avremo tanto meno una seconda’. Il papa in certe
circostanze non può tacere. I governi mettono in primo luogo la considerazione politica
e militare, e... trascurano di proposito la considerazione morale e di diritto; per
il papa invece questa considerazione è la prima”.
Il papa usò parole forti: “Badi, aggiungeva, che al giudizio di Dio saremo soggetti
tutti, tutti; e non valgono i successi terreni a sottrarci a questo tremendo giudizio”.
L’incontro (su cui il papa volle che ci fosse una memoria scritta del Sostituto) fu
uno sfogo di Pio XII: “Come poteva nel caso presente il papa rendersi colpevole d’un’omissione
così grave come quella d’assistere indifferente a fatti di tanta importanza quando
tutto il mondo attende una parola da lui?”. L’Italia voleva limitare la sua libertà?
“Non potrà pretendere il governo italiano che il papa stia silenzioso perché così
piace al governo italiano...” – concludeva, aggiungendo: “E il governo italiano sapeva
che la Germania aveva intenzione d’invadere questi paesi...”.
Alla fine del colloquio, il papa si rasserenò un poco: anche con la Germania cercava
una “pacificazione”, purché rispettosa dei diritti della Chiesa. Alfieri affermò che,
tramite i suoi rapporti con i tedeschi, avrebbe trasmesso un messaggio conciliativo.
Tuttavia, a sera, Pio XII incaricò Montini di telefonare ad Alfieri “di non fare nulla
a proposito del messaggio a Hitler e Ribbentrop. Il Santo Padre vi aveva ripensato;
non sembra il momento opportuno...”: è un esempio dei processi decisionali del papa, complessi, segnati da correzioni
e ripensamenti.
Da parte sua, l’ambasciatore italiano non fu affatto riservato con Berlino, nonostante
il ripensamento del papa. Si legge nel diario di Goebbels, il 16 giugno 1940: “La
sera arriva Alfieri... Si trattiene per alcune ore. Mi parla del papa, con il quale
s’intende ottimamente. Il papa desidera avere rapporti più stretti con noi. Ma ha
ancora qualche riserva. Se aspetterà troppo, sarà troppo tardi. Alfieri è felice dei
nostri successi”. Il messaggio trasmesso al gerarca nazista non è quello che Pio XII voleva. Traspare
il disprezzo di Goebbels, che sente la Germania vincitrice: un atteggiamento tipico
dei nazisti verso la Chiesa (mentre un gerarca fascista come Alfieri, che aveva votato
le leggi razziste, teneva ai buoni rapporti con il Vaticano).
Pio XII era perfettamente consapevole che faceva parte del suo ministero parlare non
solo ai cattolici, ma anche ai popoli. Se i governanti non gli prestavano ascolto,
avrebbe parlato al popolo. Questo è anche il senso dei radiomessaggi durante la guerra.
Il papa lavorava personalmente e con meticolosità a quasi tutti i discorsi sulle questioni
più varie, documentandosi pure su tematiche estranee alla sua formazione. Studiava
lo scenario, dove tenere i discorsi, e ne preparava con cura l’esposizione, spesso
imparandoli a memoria.
Parlava con la prospettiva non solo di edificare la Chiesa, ma anche di essere “profeta”
di un “mondo migliore”, per utilizzare l’espressione del gesuita Riccardo Lombardi,
che interpretò tante intuizioni pacelliane. Anche questo è un aspetto che lo differenzia da Pio XI, i cui discorsi erano spesso
a braccio. Il tono “profetico” di tanti suoi interventi non rientra nella rappresentazione
di Pacelli come diplomatico e si manifesta negli anni della guerra e della ricostruzione.
Il papa viveva una mistica del rapporto con il popolo: si sentì escluso dalla “riorganizzazione
del mondo” e volle “agire sulla coscienza degli uomini” – scrive il suo medico Riccardo
Galeazzi Lisi.
Pio XII è stato un papa molto popolare tra i fedeli, anche grazie a una comunicazione
intensa e crescente con loro. Se, soprattutto con il passare del tempo, si faceva
riservato nell’incontro personale, era sempre molto aperto al contatto con la gente:
quest’uomo solitario – dice Tardini – “fu forse il papa che più si avvicinò alle folle
e da esse fu avvicinato”. Era una personalità cordiale: “gradiva le conversazioni
vivaci, apprezzava le belle frasi letterarie... Da autentico romano amava e gustava
l’arguzia, pronto a cogliere il lato comico, che tanto spesso si nasconde nella inesauribile
varietà delle vicende umane”.
Il papa ha avuto a disposizione la Radio Vaticana, fondata da Pio XI nel 1931 con
preveggenza e rapidità (la prima trasmissione radio italiana è del 1924). Precedentemente
l’opinione del Vaticano si conosceva attraverso “L’Osservatore Romano”, distribuito
a Roma o inviato via posta, considerato dai fascisti un giornale ostile. La stampa
cattolica dei diversi paesi riprendeva alcune notizie della Santa Sede e stralci dei
discorsi del papa, ma spesso si trovava sotto il controllo delle censure statali,
severe in tempo bellico. La radio, invece, diffondeva in varie lingue la parola del
papa. Pio XII ha usato la radio, ma è anche stato il primo papa a comparire alla televisione:
a partire dal 1949, negli Stati Uniti vengono diffuse trasmissioni televisive con
i suoi discorsi. È stato il primo papa della comunicazione di massa, anche se questa condizione si
è verificata dopo la fine del conflitto, durante il quale, invece, la Santa Sede è
rimasta isolata.
Papa-profeta, diplomatico, uomo timido, Eugenio Pacelli si concentrò nel servizio
pontificale in maniera totalizzante con una forte tensione anche mistica, come ho
già detto. Durante la guerra, come attestano i collaboratori, sentì in maniera personale
la tragedia dei popoli coinvolti, quasi volendo “partecipare” alle loro sofferenze.
In questo periodo, non mancano gli interventi del papa perché si preghi per la pace.
Nell’aprile 1939, con lettera a Maglione, indice una “crociata di preghiere” per la
pace nel mese di maggio. L’invito è ripetuto ogni anno: “Mentre il mondo – scrive
–, unicamente fidando sulla forza delle armi e di tutti i più micidiali trovati, procede
il suo cammino, Noi, che l’immane strage tiene in lutto... riponiamo ogni Nostra fiducia
in Dio, e a Lui innalziamo le mani supplichevoli, esortando in pari tempo tutti i
nostri Figli, sparsi nel mondo, ad unire con le nostre le loro preghiere”.
Esortando alla preghiera, il papa indicava ai cattolici la pace come il bene più grande
cui aspirare. La preghiera per la pace è un implicito rifiuto della guerra e l’invocazione
della sua fine. Era già successo nella prima guerra mondiale: mentre taluni cattolici
pregavano per la vittoria della patria, il papa indicava la pace come motivo di preghiera
e aspirazione della Chiesa tutta. La preghiera come “lotta” alla guerra (una “crociata”)
è stata un messaggio per i cattolici e ha avuto un rilievo nella loro vita.
In questa prospettiva si colloca la consacrazione della Chiesa e dell’umanità al cuore
immacolato di Maria nello spirito delle apparizioni di Fatima, che il papa pronuncia
nel radiomessaggio al Portogallo e poi in una liturgia l’8 dicembre 1942 a San Pietro.
Sullo sfondo dell’atto c’è l’“orrenda carneficina” che il mondo sta vivendo: “date
al mondo in guerra la pace che i popoli sospirano” – chiede il papa a Maria. Inoltre
prega per la “protezione agli infedeli” (non credenti): chiede che sia arrestato “il
diluvio dilagante del neopaganesimo” (forse un’allusione al nazismo che dominava in
Europa, ma interpretabile in vario senso). Centrale è l’invocazione per la Russia,
dopo che Hitler aveva attaccato l’URSS nel giugno 1942:
Ai popoli separati per l’errore o la discordia, e segnatamente a coloro che professano
per Voi [Maria] singolare devozione, e presso i quali non c’era casa ove non si tenesse
in onore la vostra veneranda icona (oggi forse occultata e riposta per giorni migliori),
date pace e riconduceteli all’unico ovile di Cristo, sotto l’unico e vero pastore.
Questo aperto riferimento alla devozione dei russi ortodossi per Maria si accompagna
ad un cenno alla persecuzione antireligiosa sovietica. La Russia è nel cuore del messaggio
di Fatima, che chiede la consacrazione di questa terra al cuore immacolato di Maria,
perché si realizzi la pace e la conversione della sua gente. Anzi suor Lúcia, unica
sopravvissuta tra i veggenti di Fatima, l’aveva espressamente richiesta al papa, proprio
dopo l’inizio della guerra. Pio XII era sensibile al messaggio di Fatima e non considerava
un puro caso il fatto che la sua consacrazione episcopale fosse avvenuta il 13 maggio
1917, giorno della prima apparizione mariana in Portogallo. La consacrazione a Maria
durante il conflitto mondiale, quand’esso coinvolge la Russia, è un ulteriore momento
della “lotta” alla guerra sul piano spirituale da parte del papa. Infatti, con l’avanzare
del conflitto, si sviluppa in Pio XII una dimensione quasi mistica, consapevole della
debolezza sua e della Chiesa su un terreno che considera dominato da “forze del male”.
Lo storico Arturo Carlo Jemolo parla di un “misticismo che era nel fondo di Pio XII”.
Il mondo di papa Pacelli
Il papa voleva partecipare alle sofferenze della gente. Così nell’inverno 1943-1944,
particolarmente freddo, dispose che gli stabili vaticani non venissero riscaldati
perché anche in Vaticano si sopportassero le stesse condizioni dei romani. “Sua Santità
– spiegava l’ingegner Bernardino Nogara – non vuole che si scaldi, mentre tanti hanno
freddo...”. Dopo le proteste dei diplomatici, concesse il riscaldamento con l’eccezione
dell’appartamento suo, del segretario di Stato e del Sostituto, nonché degli uffici
della Segreteria di Stato.
La sua fu una “solitudine” istituzionale, motivata dall’unicità del suo ministero,
ma accentuata dalla sua personalità. Alcuni rapporti non furono facili, come per esempio
con il nunzio in Germania, Cesare Orsenigo, che non si sentiva apprezzato dal papa.
Con padre Wodzimierz Ledóchowski, preposito generale dei gesuiti dal 1915 al 1942,
figura di rilievo con Pio XI, ebbe una qualche frattura negli ultimi tempi della vita
del gesuita. Anche con la sua stessa famiglia, eccetto il nipote Carlo Pacelli (che vedeva quasi
tutte le sere con l’ingegnere Enrico Galeazzi), ebbe rapporti non frequenti.
Non aveva un segretario personale, come Giovanni XXIII o Pio XI (che ne aveva due),
ma utilizzò come stretto collaboratore il gesuita Robert Leiber. Questi trascorreva
la giornata nel palazzo apostolico (ma non abitava con il papa) e alla sera prendeva
l’autobus per tornare in Gregoriana, dove viveva. Leiber, con qualche altro gesuita,
aiutava il papa, ma quando iniziò a circolare la notizia che il pontefice si serviva
di un gruppo di gesuiti come collaboratori permanenti il papa fece smentire: “la cosa
è grave, perché possono pensare che il papa è nelle mani dei gesuiti”. I padri Leiber,
Wilhelm Hentrich e Augustin Bea – spiegava Pio XII – “vengono quando possono e debbono.
I primi due pensano alla mia biblioteca personale...”. E aggiungeva: “io non posso
aprire tutte le lettere che arrivano: ci pensano loro. Ma questo non si deve dire
in pubblico”, perché il papa non doveva apparire circondato da gesuiti.
Leiber, fedele esecutore, ha raccontato il rapporto distaccato che il papa intratteneva
con lui. Il gesuita infatti lavorava in una stanzetta sopra l’appartamento papale, non figurava in nessun organigramma, eppure fu un importante tramite per Pio XII.
Questo rapporto illumina la “solitudine” del papa. Leiber, dopo la morte del pontefice,
difese sempre il suo operato sulla questione degli ebrei, anche su “La Civiltà Cattolica”,
affermando che il principio che guidava l’operato del papa era “salvare la vita” alle
persone: “In ogni caso, poi, doveva il papa pesare accuratamente il pro e il contro,
per vedere se non fosse stato meglio tralasciare la protesta per evitare mali maggiori”. Leiber aderisce pienamente alle scelte di Pio XII:
Vi furono molte ragioni in favore di una protesta pubblica. Ma vi furono anche molte
altre ragioni contro tale protesta. Il papa le ha ponderate tutte. Forse un altro
papa (Pio XI, per esempio) avrebbe vibrato una forte accusa... Dubito che una protesta
sarebbe stata in qualche modo utile. Anzi credo fermamente al contrario, che avrebbe,
cioè, causato moltissimo danno. Secondo me, fu opera della Divina Provvidenza che
un papa come Pio XII fosse al governo della Chiesa in quel preciso momento. Nelle
condizioni in cui si trovò egli ha fatto molto per gli ebrei.
A giudizio di Leiber, Hochhuth ha trovato in Pio XII “un capro espiatorio”. Il gesuita,
che curava anche i rapporti con gli ambienti tedeschi durante la guerra (tra cui quelli
della “resistenza” a Hitler), è convinto di questo: Pio XII “faceva il suo dovere
e anche di più. Faticò giorno e notte per la Chiesa ma questo soltanto non fa un santo.
La santità sta ad un altro livello”. Alcuni lati del carattere del papa non lo convincono.
Il suo giudizio non è apologetico: “Pio XII era sempre molto riservato e aveva un
perfetto controllo di sé. Provava una avversione quasi fisica contro ogni eccesso.
Egli fu un monarca solitario. Sì, credo che lui doveva essere così. Egli conosceva
bene la gente della Curia romana e sapeva che anche loro sono degli esseri umani”. Leiber confidò al gesuita Angelo Martini che non era mai entrato in intimità con
il papa: c’era un “mistero dell’anima sua”. Osserva: “a volte, sembrò non mostrare
piena comprensione o riconoscenza per il lavoro compiuto dai suoi collaboratori, anche
più immediati”. E qui trapela la sua esperienza personale.
Leiber ha detto al gesuita Pierre Blet, che l’ha testimoniato al processo di beatificazione
di Pio XII, che il papa era un “sant’uomo”, ma non andava proclamato santo. Era “troppo
suscettibile” ed esigeva dai collaboratori che tutto fosse fatto a perfezione. Leiber
era critico anche sul ruolo di madre Pascalina, la governante del papa: “una donna
non doveva stare in una posizione così rilevante”. Il gesuita non andava d’accordo
con lei, perché lui se ne stava molto appartato, mentre “Madre Pascalina non rimaneva
nell’ombra”.
Suor Pascalina Lehnert è una presenza rilevante nella vita, nella casa e nelle relazioni
del papa. È stata la sua governante fin dalla Germania. Si è presa cura della persona
del papa, fino a cercare di limitarne le udienze, specie negli ultimi tempi. È stata
forse l’unica persona ad avere una qualche confidenza con lui. La sorella di Pio XII,
Elisabetta Rossignani, ne critica l’“invadenza e prepotenza”. La famiglia Pacelli è in genere severa con la suora, considerata autoritaria e descritta
come una persona sopportata da Pio XII. In Curia, taluni causticamente l’avevano soprannominata
con un titolo rivolto alla Vergine Maria nelle litanie: Virgo potens. Talvolta la suora è un tramite per far giungere messaggi al papa, come per Andreotti.
Un esempio del suo modo di fare lo riferisce padre Riccardo Lombardi nei suoi diari:
madre Pascalina si recò nella casa del collegio degli scrittori de “La Civiltà Cattolica”
per parlare con lui di Montini e della necessità di allontanarlo dal suo ruolo. Era di fatto vicina al gruppo curiale conservatore, che ho chiamato il “partito
romano”, di cui Alfredo Ottaviani era una delle maggiori espressioni. La confidenza
con Pio XII risulta anche dal fatto che il papa riportò personalmente a mons. Montini
il dispiacere della suora di non essere stata invitata alla sua ordinazione in San
Pietro come arcivescovo di Milano.
Un ruolo importante svolto da madre Pascalina è la gestione del “magazzino” di aiuti
in Vaticano, durante la guerra e successivamente. Gli aiuti erano preparati da lei
insieme ad altre suore e distribuiti da mons. Ferdinando Baldelli della Pontificia
Opera di Assistenza o dai parroci romani. Furono anche organizzati treni di soccorso
per la Romania e, più tardi, per la Germania. Gli aiuti di madre Pascalina furono un sostegno per gli istituti religiosi di Roma
che, tra il 1943 e il 1944, dettero asilo ai ricercati dai nazisti, ebrei e non ebrei,
che avevano evidenti difficoltà di reperire cibo. Attraverso di lei giungevano a Pio
XII notizie di questa attività clandestina.
Madre Pascalina ha sempre difeso la memoria di Pacelli, insistendo sul fatto che il
papa avrebbe voluto condannare i nazisti, ma fu trattenuto dal timore di aggravare
la situazione degli ebrei e dei perseguitati. Secondo la suora – che nel 1982 ha pubblicato un libro di memorie – Pio XII, dopo aver appreso il progetto della sua deportazione voluta da Hitler,
avrebbe più volte detto: “Io non lascerò mai Roma... se mi vogliono debbono venirmi
a prendere”. La testimonianza della religiosa al processo di beatificazione di Pio XII si è svolta
tra l’ottobre 1968 e il gennaio 1969, dopo che le polemiche su Il Vicario erano già scoppiate.
La religiosa racconta (senza citare la data) che il papa aveva preparato una protesta
per il trattamento degli ebrei, “uno scritto che occupava due grandi pagine e vergato
con calligrafia molto minuta”, da pubblicare su “L’Osservatore Romano”. La notizia
della deportazione degli ebrei olandesi da parte dei nazisti gli fece cambiare idea:
“Se la protesta dei vescovi olandesi ha provocato lo sterminio di 40.000 ebrei, temo
che il mio scritto... potrà avere come conseguenza la morte di 200.000 ebrei”. Bruciò
il documento nella cucina dell’appartamento “data la precarietà della situazione”,
nonostante Pascalina gli chiedesse di conservarlo.
Gli uomini del papa
Pio XII era un conoscitore della macchina vaticana, avendo lavorato in Segreteria
di Stato fino al 1917 e, da segretario di Stato, per nove anni a partire dal 1930.
Nel 1944, alla morte del segretario di Stato card. Maglione, non nominò un successore.
Alcuni diplomatici in Vaticano notarono che il papa voleva essere di fatto il segretario
di Stato di se stesso. Infatti, con decisione inusuale, il ruolo restò vacante fino
alla morte di Pio XII. Maglione, che – da nunzio – aveva allacciato i rapporti diplomatici
con la Svizzera nel primo dopoguerra, e poi era stato nunzio in Francia dal 1926 al
1935, era stato il candidato di Tisserant alla successione a Pio XI. I cardinali francesi,
però, avevano optato per Pacelli, considerandolo meno “italiano” e più internazionale. Durante il periodo francese, Maglione si era molto interessato ai dibattiti in corso
nel cattolicesimo di Francia. Tra le sue carte si trovano libri dedicati da Maritain.
Era fermamente contrario all’Action Française, il movimento nazional-cattolico di
Charles Maurras, simpatizzante per Mussolini, che avrebbe avuto influenza a Vichy.
Così Ciano descrive il cardinale: “È un meridionale pieno d’ingegno che a stento riesce
a frenare con l’educazione clericale gli impulsi del suo temperamento esuberante”.
Maglione auspicava, attraverso la responsabilizzazione della monarchia, un’uscita
dalla situazione in cui l’Italia era precipitata entrando in guerra. Lo ricorda Raffaele
Guariglia, ambasciatore in Vaticano e poi ministro di Badoglio. L’ambasciatore e il
segretario di Stato avevano un rapporto improntato a molta confidenza, anche per la
comune origine campana. Il cardinale aveva confidato al diplomatico che, con l’avanzare
della guerra, sarebbe stata opportuna una transizione dal fascismo ad altra forma
di governo. Questioni interne e internazionali, dovute al conflitto, avrebbero messo
in crisi il regime. Quindi, come prospettava riservatamente a Guariglia, si sarebbe
dovuta rafforzare l’autorità del re, molto diminuita rispetto al duce.
Il direttore de “L’Osservatore Romano”, conte Giuseppe Dalla Torre, amico di Maglione,
racconta che questi era sensibile alla politica democratica e ostile ai regimi autoritari,
di cui vedeva la propensione alla guerra. Osserva inoltre come la visione di Maglione
non fosse del tutto collimante con quella di Pacelli. Il segretario di Stato era favorevole
a una politica meno prudente e probabilmente fu lui a ottenere dal papa i telegrammi
di solidarietà ai sovrani del Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo, che forse avrebbe
voluto più netti. Mons. Antonio Samorè, in Segreteria di Stato negli anni della guerra, osserva: “Col
card. Maglione... [Pio XII] ebbe talvolta una non conformità di pensiero”.
Più che divergenze politiche, ci furono difficoltà di gestione e di carattere tra
il papa e Maglione. Questi, esuberante e meridionale (originario di Casoria e ordinato
prete a Napoli), schietto e diretto, era alle prese con un papa timido e desideroso
di preservarsi dalle influenze altrui. Maglione non seppe trarre le conseguenze del
distacco prodottosi dopo l’elezione dell’amico al pontificato, mantenendo un rapporto
immediato con un papa che governava “non amando discutere”. Peraltro, com’è stato accennato, Pio XII era un carattere sensibile ai conflitti
personali e preferiva creare una certa distanza con i collaboratori. Sua sorella minore,
Elisabetta Rossignani, lo definisce “impressionabilissimo”.
Come abbiamo visto, dopo la morte del cardinale a Casoria nell’agosto 1944, a guerra
non conclusa, Pio XII decise di non nominare un successore. Si servì della collaborazione
dei due dirigenti della Segreteria di Stato, il romano Tardini, alla testa della sezione
per gli Affari Straordinari, e mons. Montini, Sostituto per gli Affari Ordinari. Comunicando
a Tardini la decisione di non rimpiazzare il defunto Maglione, il papa disse: “io
non voglio collaboratori, ma esecutori”. In pratica, assunse direttamente il coordinamento della Segreteria di Stato: “Egli
gradisce – notava l’americano Tittmann – l’opportunità di sovraintendere personalmente
anche ai minuti dettagli dell’amministrazione”.
La Segreteria era il cuore pulsante dell’attività politica e il coordinamento dell’azione
dei dicasteri vaticani, oltre che l’organo di trasmissione di gran parte delle decisioni
del papa. Allocata nel palazzo apostolico, collaborava direttamente con il pontefice,
che ne conosceva uomini e funzionamento.
La prima sezione, gli Affari Ecclesiastici Straordinari, guidata da Tardini, si occupava
soprattutto delle questioni internazionali. Nel 1942 (l’anno che inizia con la conferenza
di Wannsee in cui viene programmata la “soluzione finale” degli ebrei) contava tre
minutanti, nove addetti, cinque ecclesiastici per l’Archivio (tra cui don Agostino
Casaroli, poi segretario di Stato di Giovanni Paolo II, e mons. Edoardo Prettner Cippico
che, nel dopoguerra, sarebbe stato condannato per falso e truffa, nonché sospettato
di contatti con i sovietici). Tardini è personalità chiave della Curia pacelliana,
ed era originale nei suoi punti di vista. Il filosofo Maritain, ambasciatore di Francia
presso la Santa Sede nel dopoguerra, lo definisce “spirito positivo e poco idealista...
non imbarazzato né da idealismo né da generosità”. Lo storico Carlo Felice Casula
parla di “un ruolo-maschera come totus politicus”, mentre don Giuseppe De Luca, che lo conosceva bene, lo considera “intelligente
come pochi... tutto ha versato sempre nel suo costante servizio”.
Faceva parte della prima sezione, come addetto, anche mons. Angelo Dell’Acqua, che
si occupava della “questione relativa agli ebrei” (sulla quale, osserva mons. Samorè,
“posso attestare la continua preoccupazione del Santo Padre”). Su Dell’Acqua sarà necessario ritornare per il suo ruolo nelle vicende degli ebrei.
Fu Sostituto dal 1953 al 1967 ed era amico di Roncalli e Montini (che, da papa, lo
nominò cardinal vicario di Roma, non segretario di Stato, come ci si aspettava).
La sezione aveva un personale esiguo per i suoi compiti. L’ufficio, come si vede anche
dall’ordinamento dell’archivio, continuava una tradizione di contatti politici e negoziati
ed è stata una scuola che ha dato nel Novecento diplomatici di rilievo come lo stesso
papa, Casaroli, Silvestrini e altri. I compiti della sezione di Tardini non erano
esclusivamente diplomatici, ma dipendevano dalla volontà di Pio XII che decideva,
di volta in volta, a quale sezione affidare le questioni.
Nel 1942 le nunziature (senza contare quelle ritiratesi per l’occupazione tedesca
o sovietica) erano diminuite a ventotto: diciassette in America Latina e Caraibi,
dieci in Europa e una in Africa, in Liberia. Ad esse vanno aggiunte le ventidue delegazioni
apostoliche senza carattere diplomatico, come in Gran Bretagna o Turchia. Erano i
canali attraverso cui la Santa Sede tentava di superare le barriere imposte dalla
guerra. I diplomatici vaticani avevano contatti diretti con la prima sezione, ma erano
pure in rapporto con il Sostituto Montini e altri dirigenti della Santa Sede, nel
quadro di competenze articolate.
L’altra sezione, gli Affari Ordinari, guidata da Montini, contava personale più numeroso:
sei minutanti, nove addetti, nove archivisti, sei scrittori. Entrambe le sezioni della
Segreteria (i dati sono del 1942) avevano dunque dimensioni limitate. Niente in paragone
con le diplomazie o i ministeri degli Stati (considerando che la Segreteria si occupava
di molto altro oltre alle questioni internazionali). Durante la guerra Pio XII aveva
voluto anche un “Ufficio Informazioni Vaticano”, chiamato generalmente “Prigionieri
di guerra”, sotto la supervisione del Sostituto Montini, diretto dal vescovo Aleksandr
Evreinov, un nobile russo convertitosi al cattolicesimo a inizio secolo. L’ufficio
accoglieva e inoltrava le richieste d’informazioni sui dispersi, militari e civili.
Un flusso immenso di richieste e notizie passava per i canali vaticani, cercando di
superare le frontiere sigillate dalla guerra, grazie all’internazionalità della Santa
Sede, dei suoi agenti e delle sue istituzioni.
Il vasto fondo dell’Archivio “Prigionieri di guerra” contiene – scrive Sergio Pagano
– “scritti umili e disperati di ogni sorta di classi sociali, ma prevalentemente missive
dimesse di povera gente... spedite al papa con nessuna formalità e con molta fiducia,
dettate dal bisogno, dall’ansia di avere almeno notizie dei propri cari...”. Qualcosa di simile si ritrova in un altro estesissimo fondo, la “Commissione Soccorsi”:
la commissione, nata nella seconda sezione della Segreteria, era un ufficio istituito
per far fronte alle domande, necessità, evenienze (le più diverse) del tempo di guerra
con cui la Santa Sede veniva a contatto o che le erano trasmesse dai suoi agenti o
dalle Chiese locali o da singoli anche non cattolici, come gli ebrei. Nel secondo dopoguerra, di fronte alle masse di rifugiati, è diventato uno strumento
per realizzare il soccorso del papa.
Si trattava di un “ufficio di guerra” che affrontava le problematiche del conflitto
sotto il profilo umanitario (ma ci sono anche le carte dell’invasione nazifascista
degli stabili vaticani a Roma), ed era anch’esso sotto la direzione di mons. Montini.
Egli guidava il gruppo che curava le domande di aiuto provenienti soprattutto dai
polacchi in patria (occupata) e in esilio. La Polonia è il primo caso umanitario su
cui opera l’ufficio con l’inizio della guerra. Il 12 aprile 1941 viene inaugurato
un gruppo di lavoro al quale partecipano esperti diplomatici, tra cui mons. Clemente
Micara, nunzio in Belgio e Lussemburgo (lasciati a seguito dell’occupazione), il nunzio
Filippo Cortesi (che, per lo stesso motivo, aveva lasciato la Polonia) e mons. Giuseppe
Caprio, stretto collaboratore di Montini: sono ecclesiastici che avevano una conoscenza
diretta dei paesi coinvolti in guerra.
Era un organo nuovo, creato per le necessità prodotte dal conflitto. Molto stretto
era il contatto con l’Ufficio informazioni per i prigionieri di guerra, che utilizzava
un servizio radio per comunicare nomi e messaggi. Gli archivi delle due organizzazioni,
di cui esistono gli inventari editi, mostrano un panorama vastissimo di casi umani:
storie diverse, quasi sempre dolorose, puntualmente trattate, anche se non sempre
era possibile risolvere i problemi. Si tratta di un archivio importante, non solo
da un punto di vista storico, ma anche umano, perché mette a contatto con le più diverse
situazioni nate dalla guerra e dalla persecuzione.
Nella Commissione Soccorsi, per fare un esempio, esiste un fascicolo intestato ad
Alberto e Liliana Segre. Un caso tra decine di migliaia: Liliana Segre, arrestata
con il padre Alberto nel dicembre 1943, partita dalla stazione di Milano, al binario
21 (nascosto nei sotterranei), il 30 gennaio 1944 e arrivata ad Auschwitz il 6 febbraio.
La giovane Liliana, a differenza di suo padre, è sopravvissuta al campo di sterminio
e, dopo essere stata trasferita a Malchow, uno dei lager di Ravensbrück, è stata qui
liberata nel maggio 1945. Oscar Foligno, parente dei Segre, internato a Zurigo, si
rivolge alla nunziatura apostolica di Berna perché inoltri una richiesta di notizie
ai parenti, credendo che siano a Katerinstadt in Slovacchia: “tranquillizzatemi vostro
stato di salute indicando se possibile invio pacchi”. La Croce Rossa italiana rifiuta
di inoltrare il messaggio, perché riguarda ebrei. Neanche le autorità italiane della
Repubblica Sociale collaborano a individuare il luogo di detenzione.
Del resto i Segre non erano in Slovacchia. Due mesi dopo, giunge da Roma alla nunziatura
di Berlino un telegramma di Montini in cui domanda notizie della “giovinetta Liliana
Segre”, che si troverebbe nel lager di Greifswald in Pomerania (il che è risultato
poi non vero). La nunziatura si scontra con il rifiuto tedesco di trattare le questioni dei “non
ariani”. Foligno invia pacchi di viveri e un altro toccante messaggio: “pensavi con
tanto affetto/ tranquillizzatemi vostro stato di salute/ indicando se possibile invio
pacchi... Abbiate fede. Vi abbraccio”.
La Commissione Soccorsi e l’Ufficio prigionieri di guerra seguono con sistematicità
casi d’ogni tipo, sollecitando la rete della Santa Sede e delle Chiese locali. Era
un lavoro vasto che riguardava un numero molto alto di prigionieri, deportati, sfollati
e rifugiati, in situazione precaria, persone alla ricerca di parenti. Un mondo di
dolore che trovava un approdo in Vaticano. Tali uffici, sotto la pressione di eventi
drammatici e di travolgente vastità, allargavano le strutture per accogliere il più
possibile le domande e provare a dare risposte a chi era colpito dai bombardamenti
o dai combattimenti, dalle persecuzioni, o costretto agli spostamenti, senza abitazione
o cibo. Ma all’opera d’aiuto si frapponevano le frontiere invalicabili della guerra.
Come comunicare e agire al di là di esse? Ed ecco l’opera ingegnosa della diplomazia
umanitaria: far filtrare notizie, cercare persone o gruppi, far passare aiuti e tanto
altro. Un lavoro che si reggeva sul carattere neutrale, anzi imparziale, del Vaticano,
sostenuto dal suo prestigio morale e coadiuvato dalle comunità cattoliche in loco, se potevano agire. È un volto del papato in guerra, che l’attività diplomatica teneva
a preservare e incrementare.
Molte le operazioni tentate dal Vaticano per scavalcare le frontiere e superare l’incomunicabilità
pur di avere notizie dei prigionieri. Nel 1943, ad esempio, il cappellano militare
bresciano Ottorino Marcolini, amico di Montini, riferisce che l’atteggiamento dei
sovietici verso i prigionieri di guerra italiani è piuttosto positivo perché il loro
comportamento è stato “umano” verso le popolazioni locali. Tardini pensa: “se le cose
stanno così, non si potrebbe, per esempio attraverso mons. Roncalli, far sapere al
governo russo che la S. Sede – per compiere la sua missione di carità – gradirebbe
avere le liste dei prigionieri italiani in Russia?”. In questi casi conta molto il
carattere degli uomini della Santa Sede, la loro capacità di creare rapporti e di
prendere iniziative. Così Tardini propone: “Mons. Roncalli è un pacioccone; è in buoni rapporti con i diplomatici, anche russi; è capace di presentarsi al rappresentante
russo e dirgli, come cosa sua, che sarebbe lietissimo di poter mandare alla S. Sede
la lista dei prigionieri italiani. Egli così farebbe (e potrebbe dichiarare sicuro)
cosa gradita alla S. Sede”.
Il Sostituto Montini sovraintende a questi contatti (in larga parte ne era l’ideatore)
mentre guida la sua sezione, che è quasi un gabinetto pontificio e coordina la vita
curiale. Con lui si ha una dilatazione delle funzioni della seconda sezione della
Segreteria. Egli era dotato di una notevole capacità organizzativa e di lavoro: “una
macchina da lavoro” secondo il card. Ottaviani, che pure era prevenuto nei confronti
del prelato bresciano, considerato una personalità troppo diversa dal “sentire romano”. Il Sostituto – se si vuole usare la terminologia del biografo Fulvio De Giorgi –
era favorevole all’“ammodernamento” nella vita cattolica, interrottosi durante la
crisi modernista. La sua personalità colpiva gli interlocutori per la profondità delle analisi: lo
storico dell’arte Giulio Carlo Argan, in un colloquio nel clima drammatico del 1944,
restò “colpito dall’acutezza dei giudizi dell’allora monsignor Montini”.
La sua fedeltà a Pio XII, l’immedesimazione nel ministero del papa – anche se manteneva
la sua visione – era a tutta prova. La sua posizione politica era antitotalitaria
e antifascista, come la polizia e i servizi fascisti sapevano bene. In un appunto del 9 aprile 1939 egli annotava: “Bisogna che il papa non tema a)
di deplorare apertamente tutto ciò che secondo il Vangelo e la legge naturale lo è,
b) di affermare fortemente i ‘principi’”. Da poco Pio XII era papa. Montini era favorevole all’impegno per i perseguitati
dal nazismo, ma anche per affermare con forza i “principi”. Fu leale collaboratore
di Pio XII.
L’8 giugno 1963 il card. Montini pubblicò una lettera su Pio XII sulla rivista cattolica
inglese “The Tablet”. La data è significativa: il 3 giugno 1963 era morto papa Giovanni
e il 19 giugno cominciava il conclave da cui, due giorni dopo, Montini sarebbe uscito
come Paolo VI. Nella lettera si ribadiva la correttezza delle posizioni di papa Pacelli
e si condannava l’opera (da poco pubblicata) di Hochhuth, definito “giovane commediografo”
malato di “esibizionismo”:
Perché poi Pio XII non abbia assunto una posizione di violento conflitto contro Hitler,
per risparmiare così dalla strage nazista milioni di Ebrei, non è difficile comprendere
a chi non commetta l’errore dello Hochhuth di giudicare le possibilità di un’azione
efficace e responsabile durante quel tremendo periodo di guerra e di prepotenza nazista
alla stregua di ciò che si potrebbe fare in condizioni normali... Se, per ipotesi,
Pio XII avesse fatto ciò che Hochhuth gli rimprovera di non aver fatto, sarebbero
accadute tali rappresaglie e tali rovine...
Questa è la tesi di Montini: comportandosi altrimenti, Pio XII avrebbe aggravato la
situazione delle vittime e dei perseguitati, non tanto quella della Santa Sede. C’è una continuità profonda nelle posizioni di Montini dopo l’elezione al papato.
Nel 1964, durante il viaggio in Terra Santa, riafferma il suo giudizio sulla Santa
Sede durante la guerra, al momento di prendere commiato dalle autorità israeliane.
Dedica parte del suo discorso alla difesa di Pio XII. Vale la pena di citarlo per
esteso:
La Chiesa infatti ama ugualmente tutti. Il nostro grande predecessore lo ha affermato
con forza, e a varie riprese, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, e tutti sanno
quello che ha fatto per la difesa e la salvezza di tutti quelli che erano nella prova,
senza alcuna distinzione. Pertanto sapete che si sono voluti gettare sospetti e anche
accuse contro la memoria di questo grande pontefice. Siamo felici di aver occasione
di affermare in questo giorno e in questo luogo: niente di più ingiusto di questo
attacco a una così venerabile memoria. Quelli che, come noi, hanno conosciuto quest’anima
ammirevole sanno fino a dove poteva arrivare la sua sensibilità, la sua compassione
alle sofferenze umane, la sua delicatezza di cuore. Lo sapevano bene anche quelli
che, all’indomani della guerra, vennero, con le lacrime negli occhi, a ringraziarlo
di aver loro salvato la vita.
Dopo la fine del conflitto, questa era la coscienza di persone come Montini o Tardini,
gli “uomini del papa”. Tanto si è scritto sulla differenza d’impostazione e di carattere
tra i due prelati: Tardini, romano, pragmatico, concreto; Montini, colto, con uno
sguardo alla riforma della Chiesa, amico di Alcide De Gasperi e dei leader democristiani,
un riferimento per l’inquieto cattolicesimo francese. Se Montini è l’uomo della cultura
del progetto, quale si concepiva nel cattolicesimo degli anni Trenta, Tardini è l’uomo
dell’accorto realismo. L’ambasciatore francese d’Ormesson, nel 1949, osservava:
Mons. Tardini può pensare “più a destra”. Mons. Montini può pensare “più a sinistra”.
Alla fine è il Papa – e il Papa solo – che decide. Ascoltandoli, Pio XII si fa così
un’opinione mediana. Si ha spesso l’impressione che la politica di misura e di equilibrio
che caratterizza il pensiero del Pontefice è frutto di un confronto di tesi.
Ma che vuol dire di destra o di sinistra? Montini, figlio di un deputato popolare
bresciano e controllato dalla polizia fascista come elemento pericoloso, era antifascista,
come si è detto. Tardini, lontano dall’antifascismo del Sostituto, aveva maturato
un duro giudizio sul regime, come risulta dai suoi appunti. Dice a Pio XI nel 1938:
“la peste dell’epoca moderna: il nazionalismo”. Ed è convinto che “i pericoli di domani,
la debolezza dei cattolici dipendono, in ultima analisi, dall’esagerato nazionalismo”.
Il gruppo che trattava le questioni internazionali della Santa Sede, in stretto contatto
con il papa, aveva una visione condivisa. Era un gruppo coeso per idealità, devoto
al papato, unito da antiche familiarità maturate negli studi e nel lavoro all’interno
delle istituzioni ecclesiastiche. Erano italiani, parlavano tra loro in italiano e
in questa lingua comunicavano con le nunziature. La devozione al papa era un elemento
di coesione, anche se non mancavano valutazioni diverse, pur coltivate in modo riservato.
Tardini, che aveva a lungo lavorato con Pio XI, notava la differenza tra Pio XII e
un pontefice decisionista come Ratti, ma ne condivideva le scelte.
Il clima di lavoro in Segreteria era intenso, tanto che mons. Roncalli, di passaggio
in Vaticano nel 1945 destinato a Parigi in qualità di nunzio in Francia, scriveva:
“Mi fa qualche pena vedere questi bravi servitori della S. Sede indaffarati, come
all’ergastolo”. Tra l’altro notava che non sempre c’erano idee chiare sui diversi
scacchieri mondiali. Era venuto per ricevere istruzioni sulla missione in Francia,
tutt’altro che un paese secondario per la Chiesa: “Della situazione in Francia, poco
riesco a cogliere. Mi aiuterà il Signore”, annota dopo i colloqui in Vaticano. Il nunzio, inviato per rimediare alla difficile situazione tra l’episcopato francese
(in larga parte vicino a Vichy) e la Francia libera di de Gaulle, non aveva trovato
in Vaticano un giudizio elaborato sulla situazione.
Un’isola nell’Europa nazista
La Curia romana non si riduce alla Segreteria di Stato, ma è composta dai dicasteri
che presiedono all’azione della Santa Sede sotto la guida del papa. Sono concentrati
nella Città del Vaticano, territorio di uno Stato indipendente, o in altri edifici
extraterritoriali nei dintorni del Vaticano o a Roma, venendo a formare un arcipelago
d’istituzioni della Santa Sede nell’Urbe. Il Vaticano è un’enclave a Roma, dipendente
da un punto di vista materiale dai servizi forniti dall’Italia. Lo nota Tardini, con
la consueta chiarezza, nei suoi appunti. Il Vaticano era “uno Stato politicamente
piccolo e debole (quasi più simbolico che reale...)”. Per lavorare serenamente il Vaticano aveva bisogno di un ambiente collaborativo
da parte dell’Italia, che lo circondava territorialmente.
Durante la prima guerra mondiale, l’imparzialità vaticana era stata messa a dura prova
dall’Italia schierata contro gli imperi centrali. Allora, lo spazio vaticano era garantito
solo dalla legge delle guarentigie, peraltro rifiutata dalla Santa Sede perché unilaterale.
I diplomatici dei paesi in guerra contro l’Italia, accreditati presso il papa, avevano
dovuto lasciare Roma. Nella seconda guerra mondiale, i diplomatici degli Stati in
guerra con l’Italia trovarono riparo, con sistemazioni austere, in Vaticano, piuttosto
che restare nella capitale come avrebbero potuto secondo i Patti del Laterano. Myron
Taylor, il rappresentante americano, poté raggiungere il Vaticano nonostante il suo
paese fosse in guerra con l’Italia. I nove mesi dell’occupazione tedesca di Roma,
a partire dall’8 settembre 1943, furono difficili e videro verificarsi varie crisi
tra la Santa Sede e i nazifascisti. In questo periodo, elementi fascisti, appoggiati dai tedeschi, invasero la basilica
di San Paolo fuori le mura, extraterritoriale e appartenente alla Santa Sede, suscitando
le proteste vaticane. Lo stesso fecero con il Seminario Lombardo e il Pontificio Istituto
Orientale, pure essi extraterritoriali. Negli ambienti ecclesiastici si temeva un
attacco all’area extraterritoriale della basilica di San Giovanni in Laterano dove,
oltre agli ebrei, ai renitenti alla leva, a militari italiani (come nelle istituzioni
sopra ricordate), c’erano anche politici del Comitato di Liberazione Nazionale, tra
cui De Gasperi e Nenni.
Il Vaticano e gli ambienti curiali erano infiltrati di spie. Esiste una vasta letteratura
sulle attività spionistiche tedesche, italiane e alleate all’interno delle mura leonine.
Probabilmente gli ambienti della Segreteria di Stato erano i più protetti dalle infiltrazioni.
Nell’agosto 1942 il Sostituto Montini protestò con l’ambasciatore d’Italia Guariglia,
lamentando che la Segreteria era spiata e che si voleva far apparire la Santa Sede
come una realtà partigiana nella guerra. Cesare Catananti ha studiato la difficile vita del Vaticano neutrale – dal settembre
1943 al giugno 1944 – circondato dall’Italia in guerra, anzi accerchiato dalle truppe
naziste al bordo di piazza San Pietro, dove le autorità vaticane avevano tracciato
una linea bianca all’inizio del colonnato per segnalare il confine di Stato. In piazza
prestavano sorveglianza tradizionalmente gli italiani ma, in loro assenza, i tedeschi
si dovevano fermare sul confine.
Il periodo di maggior pressione sulla cittadella vaticana fu l’occupazione nazista
di Roma. Il 10 settembre 1943, Maglione avvisò il decano del corpo diplomatico, l’ambasciatore
del Brasile, perché comunicasse ai colleghi di prendere misure precauzionali sui propri
archivi per il possibile rischio che i tedeschi invadessero il Vaticano. Tittmann
era a conoscenza dell’ira di Hitler per la presenza di diplomatici nemici nel cuore
dell’Europa nazista. Tittmann, Osborne e altri diplomatici, entro il settembre 1943,
bruciarono le carte. I diplomatici decisero che, in caso di prelevamento del papa,
avrebbero provato a seguirlo. Significativamente, la curia generalizia dei gesuiti, un immobile extraterritoriale
vicino al Vaticano, prese la decisione di distruggere lettere e relazioni che trattavano
in particolare dell’Est Europa o di contatti diplomatici a riguardo: “periculo imminente
occupationis Romae a Germania perpetrata, penitus destructa fuere”. Il timore dei gesuiti era forte nonostante l’archivio fosse in una zona extraterritoriale,
in cui non era consentito l’accesso senza permesso vaticano.
La preoccupazione era grande di fronte alla presenza tedesca nella capitale. Come
si sarebbero comportati i nazisti? Dalla caduta di Mussolini alla liberazione di Roma,
il Vaticano si sentì insicuro e temette un’invasione. Il 4 agosto 1943 il segretario
di Stato Maglione convoca i cardinali residenti a Roma per spiegare la difficile situazione
della città e dello stesso Vaticano, che potrebbe essere invaso (secondo fonti italiane):
“ciò non può davvero escludersi date le minacce che da parte tedesca si stanno facendo
da qualche anno...”. Esprime il dispiacere per la situazione della popolazione romana,
mentre non esclude che la tensione potrebbe “sfociare nel comunismo”.
Dopo la caduta di Mussolini, Hitler riteneva ancor più inaccettabile che le mura vaticane
ospitassero e proteggessero diplomatici nemici del Reich, in comunicazione con i propri
paesi. Questo era da sempre un tema sensibile per il Führer, come avvertiva l’ambasciatore
italiano a Berlino. Hitler era convinto che dietro al “tradimento Badoglio” ci fossero state manovre
del Vaticano. Il 26 luglio 1943, quando gli venne chiesto che atteggiamento tenere
con la Santa Sede, si lasciò andare a un attacco d’ira: “Entrerò subito in Vaticano.
Credete che il Vaticano mi metta in soggezione? Noi ce ne impadroniremo subito...
Tutta quella feccia che si trova là. Staneremo quella banda di bastardi... Più tardi
potremo sempre presentare le scuse”. Dopo l’8 settembre, si delineò l’ipotesi di un’invasione.
Karl Wolff, generale delle SS e comandante della polizia e delle SS in Italia, raccontò
di essere stato convocato in Germania nel settembre 1943 per una “missione storica”.
Ricevette da Hitler l’ordine di occupare il Vaticano, di impadronirsi dei tesori d’arte
e di prendere sotto controllo la persona del papa, “perché non possa cadere nelle
mani degli alleati e subire le loro pressioni e l’influenza politica”. Per Hitler,
Pio XII poteva essere portato in Germania o nel neutrale Liechtenstein. Himmler aggiunse
che bisognava impadronirsi dei tesori d’arte e delle “iscrizioni runiche degli antichi
popoli germanici”, conservate in Vaticano.
Wolff prese tempo per eseguire l’incarico affidatogli da Hitler e spiegò successivamente
di non averlo contrastato frontalmente per evitare un inasprimento. In un secondo
incontro, nel dicembre 1943, di fronte all’insistenza del Führer gli illustrò la situazione
italiana, sostenendo che gli italiani erano sostanzialmente ostili al fascismo, ma
che lui in tre mesi era riuscito a ottenere una certa tranquillità grazie ai buoni
rapporti con il clero. Il punto dell’accordo era questo: “Io proteggo le vostre istituzioni
ecclesiastiche, la vostra autorità di fronte al popolo italiano e alle forze tedesche
di occupazione, le vostre proprietà e la vostra vita, e voi agite nel vostro campo
per favorire l’obbedienza verso l’autorità tedesca”. Con questo accordo, nonostante
la limitatezza delle forze tedesche – concluse Wolff –, la situazione era sotto controllo. Hitler desistette dalla decisione di deportare il papa, che peraltro aveva precedenti
nella cattura di Pio VI e Pio VII da parte di Napoleone. Qualcosa trapelò in Vaticano,
dove si ipotizzò qualche sistemazione alternativa per il papa, poi archiviata, perché
Pio XII non intendeva lasciare il Vaticano.
Il 9 settembre 1943 il Sostituto Montini, dopo l’armistizio dell’Italia con gli Alleati,
comunicò su disposizione di Maglione di “dare ordini alla Guardia Svizzera che in
ogni evenienza non faccia uso delle armi da fuoco”. La Segreteria predispose un piano di difesa nell’eventualità d’un ingresso tedesco
in Vaticano e del prelevamento del papa. In caso di “pressione esterna”, gendarmeria
e guardia svizzera dovevano far affluire i residenti nel palazzo apostolico, dimora
del papa. Qui gli accessi andavano chiusi e controllati dai militari con le armi in
dotazione, pronti a farne uso in caso d’ordine. Queste disposizioni sono trasmesse dal card. Maglione al card. Nicola Canali, che
guidava l’amministrazione dell
...