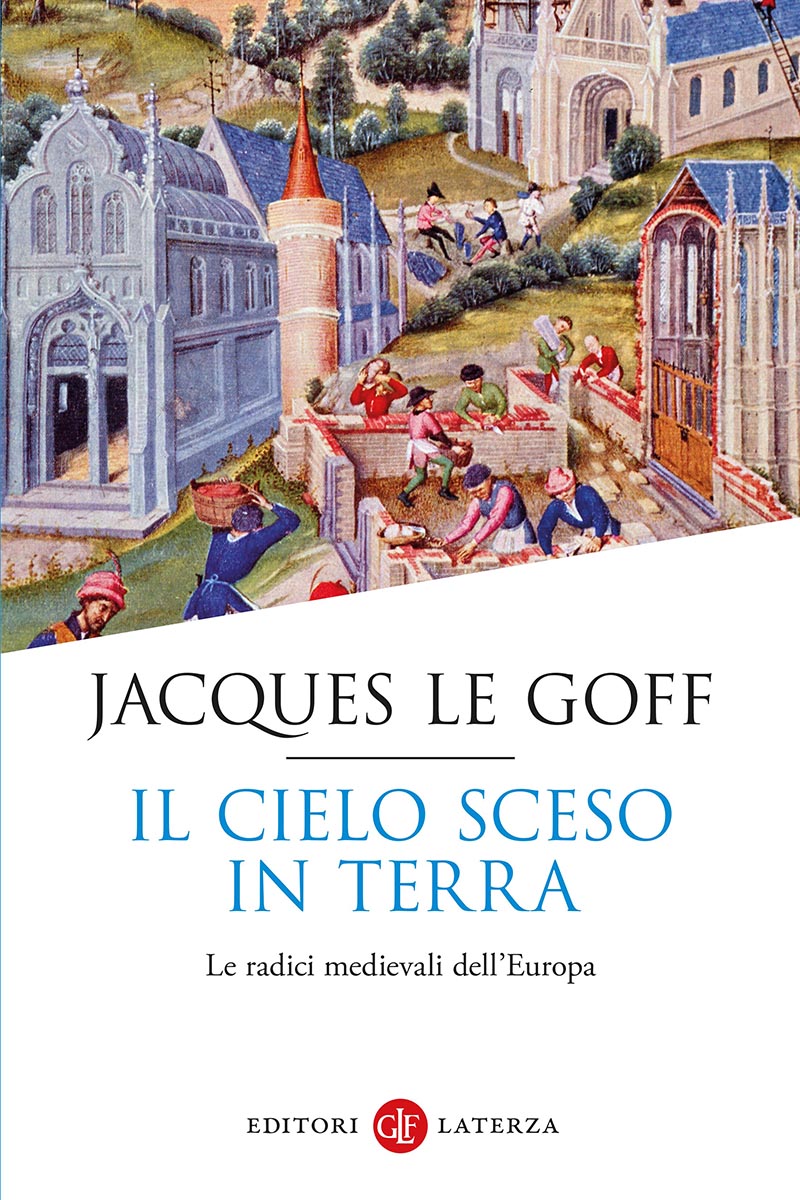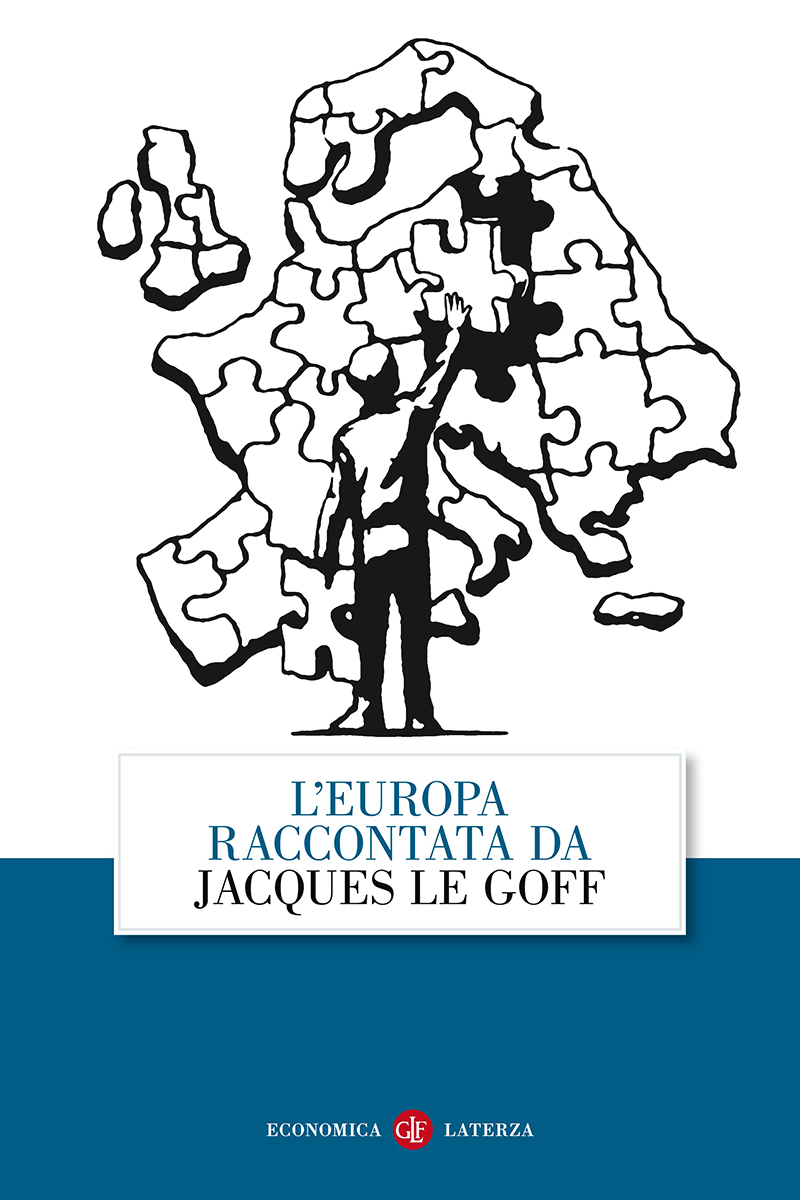Premessa.
Testimoni dell’età dell’oro
Quando Laure Adler e Laurence Bloch mi chiesero, alla fine del 2003, di realizzare
per France Culture delle conversazioni incrociate con Jean-Pierre Vernant e Jacques
Le Goff, mi fecero un doppio regalo. In primo luogo il programma «À voix nue», cui
queste registrazioni erano destinate, doveva ruotare, in teoria, intorno all’incontro
fra un conduttore radiofonico e un personaggio dalla vita ricca e varia. Per la serie
di conversazioni qui riprodotte, andate in onda dal 12 al 16 gennaio 2004, fummo eccezionalmente
in tre e il mio compito si limitò in pratica a tenere i fili della discussione fra
queste due grandi figure.
Ma, soprattutto, l’incarico che mi veniva affidato mi avrebbe permesso di avvicinare
allo stesso tempo due giganti della grande scuola storica francese, i quali hanno
entrambi combinato insieme l’audacia nella ricerca e il successo presso il pubblico,
una congiunzione piuttosto rara in questo inizio del XXI secolo. Dovevo dunque stimolare
a discutere due testimoni di quella che molti uomini dell’accademia di oggi considerano
un’epoca d’oro: gli anni 1950-1980, un arco temporale in cui si realizzò l’impresa
impossibile per le scienze umane di alleare il rigore intellettuale e l’apprezzamento
del pubblico generale al di là della cerchia ristretta degli specialisti.
Da anni, ogni libro pubblicato da Jacques Le Goff era sicuro di trovare, in Francia
e all’estero, un vasto pubblico di lettori. E quanto a Jean-Pierre Vernant, il successo
dei suoi lavori pubblicati con Pierre Vidal-Naquet e Marcel Detienne negli anni Settanta
fu successivamente superato da opere come Entre mythe et politique (1996) o L’Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines (2000) per l’editore Seuil, che lo resero familiare a un pubblico più ampio di quello degli
appassionati di Grecia antica.
Far dialogare i due personaggi significava anche raccontare quasi cinquant’anni di
rinnovamento teorico e di invenzioni concettuali. E dar conto di un’epoca in cui individuare
nuovi territori di ricerca sembrava più facile di oggi. Jean-Pierre Vernant racconta
così in queste conversazioni il modo semplice e diretto con cui l’uomo della Resistenza
che egli era stato fu accolto al Cnrs subito dopo la guerra. Jacques Le Goff rievoca il clima di entusiasmo in cui le sue
prime ricerche furono concepite e il «miracolo» dell’agrégation del 1950, decretata dalla giuria, rivoluzionaria, presieduta da Fernand Braudel.
Entrambi esprimono riconoscenza verso i loro maestri (Ignace Meyerson e Louis Gernet
per Vernant, Maurice Lombard e Fernand Braudel per Le Goff) che li avevano guidati
sulla strada della ricerca.
Ma al di là dello scontato tributo di gratitudine verso quelli che li avevano guidati,
essi disegnano anche il quadro lusinghiero di una ricerca libera. La transdisciplinarità
fu, all’epoca, frutto di una lotta pionieristica. La storia faceva incursioni sui
terreni di altre scienze sociali. L’eliminazione delle barriere disciplinari permise
avanzamenti importanti, anche se non mancarono i contrasti fra le varie discipline.
Lo studioso della Grecia antica e il medievista ricordano, per esempio, la querelle che contrappose Claude Lévi-Strauss a Fernand Braudel sul «tempo lungo» o le discussioni
con Georges Dumézil sulla tripartizione funzionale della società.
La cosa più sorprendente in questo dialogo è sicuramente la naturalezza con cui i
due studiosi riconoscono il loro debito nei confronti del contesto sociale in cui
si formarono: Jacques Le Goff ringrazia le istituzioni ribollenti degli anni Sessanta
e Settanta che gli consentirono di lanciare ipotesi azzardate; Jean-Pierre Vernant
ammette quanto le sue ricerche sulla città greca dovettero alla sua rottura con il
Partito comunista. In questi allievi delle «Annales», economia, scienza e società
si mescolarono per nutrire una ricerca aperta e curiosa.
Ma a parte i loro numerosi punti in comune, i due storici sanno illustrare in parole
semplici quello che i rispettivi campi di indagine hanno di specifico e di diverso
dagli altri: il teatro non ha lo stesso ruolo nell’Atene del V secolo a.C. e nell’Europa
medievale. Il lavoro nemmeno. Dopo una vita di studi, ciascuno dei due ammette di
avere davanti questioni che ancora non hanno risposta. Ma sia l’uno che l’altro confidano
che quanti avrebbero ripreso le piste da loro aperte – i loro gruppi, i loro allievi
– li avrebbero sorpresi con la scoperta di nuovi itinerari attraverso i quali la ricerca
troverà nuove risposte.
Questo ottimismo affermato e caparbio fa bene. A una decina d’anni da queste conversazioni
e quando ormai queste due voci possenti della storia non ci sono più, lo sguardo retrospettivo
sul loro itinerario pone degli interrogativi: per creare nuovi campi, nuovi concetti,
serve una ricerca aperta o una ricerca concentrata sui suoi risultati? Come – in un
contesto di bilanci fortemente ridimensionati – far sì che i giovani ricercatori continuino
ad avere le loro possibilità di sviluppo? Come rimettere la storia al centro del dibattito
pubblico? Quali strumenti possono permettere di riannodare il filo spezzato fra la
ricerca storica rigorosa e il grande pubblico?
In queste conversazioni, Jean-Pierre Vernant e Jacques Le Goff non ci danno una risposta.
Ma la loro fede nel movimento permanente delle idee e degli uomini e la loro fiducia
nel necessario confronto con l’altro, ricercatore di oggi o uomo del passato ritrovato
negli archivi, lasciano credere che «l’età dell’oro» possa essere una promessa e non
un rimpianto.
I maestri
Emmanuel Laurentin Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, voi avete dieci anni di differenza fra di voi
ma, come mi dicevate, siete in un’età in cui questi dieci anni non fanno grande differenza.
So che non vi piace parlare di generazioni di intellettuali, un tema che viene invece
molto spesso evocato nella stampa francese; in ogni caso, voi fate certamente parte
di una generazione intellettuale che si è forgiata prima della guerra.
Jean-Pierre Vernant Io appartengo alla stessa generazione di Jacques Le Goff. Ho mosso i primi passi
dopo la guerra.
Jacques Le Goff Si può dire che apparteniamo entrambi alla generazione della Liberazione. Tu vi appartieni
anche più di me, perché uscivi da una guerra in cui avevi combattuto. Credo sia giusto
dirlo: tu sei stato un eroe della Resistenza.
E.L. Col nome di colonnello Berthier, a Tolosa. Se proprio vogliamo cercare dei collegamenti
fra di voi, Tolosa potrebbe costituire un punto geografico comune. Lei Jean-Pierre
Vernant, era a Tolosa durante la guerra, e Jacques Le Goff evoca Tolosa in una delle
sue opere, in particolare la basilica di Saint-Sernin. Lei racconta che la visita
a Saint-Sernin nel 1939 contribuì alla sua apertura intellettuale al Medioevo.
J.L.G. Non intendo scrivere le mie memorie, non mi considero un soggetto degno d’interesse
per la storia. Ma la famiglia stretta da cui provengo può essere interessante dal
punto di vista storico. I miei genitori erano persone modeste: mio padre era professore
di liceo, mia madre insegnante di piano. Avevano questo d’interessante ed emozionante,
che ha lasciato in me un ricordo grandissimo: erano persone profondamente opposte
sul piano ideologico. Mia madre era di origine italiana, cattolica fervente, praticante.
Mio padre – nel momento in cui il paese stava uscendo dall’affare Dreyfus – rimaneva
un anticlericale scontroso. Per certi versi, nonostante l’ammirazione che ho sempre
nutrito per lui, trovavo che il suo anticlericalismo fosse un po’ esagerato. Prima
della guerra, andammo una volta in vacanza nei Pirenei. Facemmo sosta a Tolosa per
visitare Saint-Sernin; mio padre ci disse: «Andate voi, io non entro in una chiesa».
Ebbi l’audacia di dirgli che era ridicolo, che noi andavamo a vedere l’arte, il Medioevo,
non il dato religioso.
E.L. Lei pure, Jean-Pierre Vernant, proviene da una famiglia anticlericale e dreyfusarda.
J.-P.V. Assolutamente sì. Mio nonno, Adolphe, aveva fondato un giornale che si chiamava
«Le Briard», un giornale di indirizzo repubblicano che aveva dirimpetto «La Brie», un giornale
clericale. Al tempo dell’affaire, si era dichiarato a favore di Dreyfus, e questo gli aveva procurato parecchie difficoltà,
perché alcuni lettori disdissero l’abbonamento. Mio padre, Jean, che gli succedette,
era stato iscritto al partito socialista – si fece poi ammazzare durante la guerra –,
ma condivideva lo stesso orientamento. Ho sempre vissuto in questo ambiente in cui
il clericalismo era considerato il nemico numero uno. Quando arrivai al Quartiere
Latino intorno al 1934, incappai nelle leghe che lì erano molto attive. Aderendo alla
Lega di azione universitaria repubblicana e socialista per poi virare verso le associazioni
giovanili comuniste e il partito comunista, sentivo di restare fedele a una certa
tradizione familiare.
E.L. Nel corso di questi colloqui troveremo altri punti in comune. Possiamo intanto
ricordare, nella vostra carriera universitaria, il passaggio alla sesta sezione dell’École
des hautes études en sciences sociales (Ehess), il fatto che siete stati entrambi insigniti della medaglia d’oro del Cnrs, il fatto che avete lavorato entrambi nel solco delle «Annales». È curioso che, tutto
sommato, non abbiate mai prodotto lavori in comune. Tanto più che lei, Jacques Le
Goff, ha realizzato lavori in collaborazione con uno studioso molto vicino a Jean-Pierre
Vernant, e cioè con Pierre Vidal-Naquet, su Lévi-Strauss.
J.L.G. Ho pubblicato vari lavori in collaborazione con qualcuno, ma non ho mai pubblicato
opere in comune. Ho diretto insieme con Jean-Claude Schmitt Le dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval. Ho pubblicato, per esempio, degli articoli a firma congiunta con Pierre Vidal-Naquet,
il quale peraltro ha scritto libri con Jean-Pierre Vernant. Tutto ciò dimostra che
tutti e tre avevamo obiettivi, interessi che possiamo dire antro
...