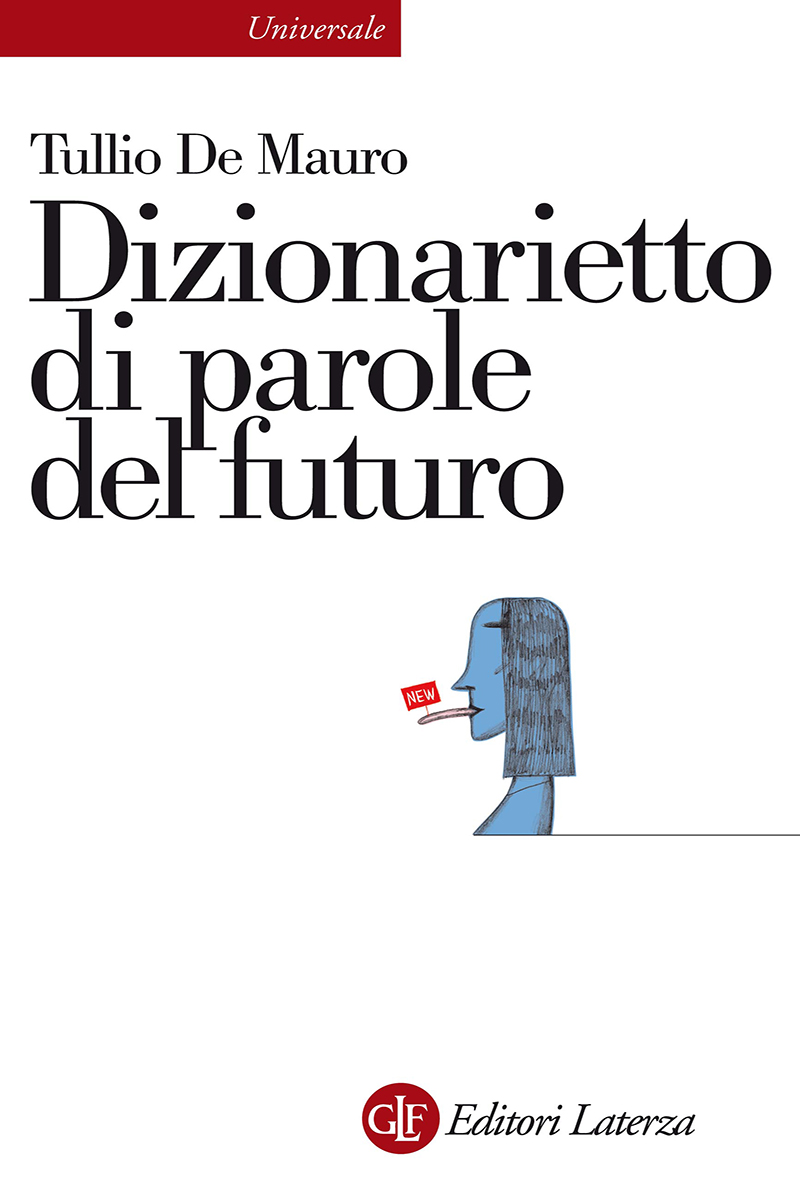CONSTANTER ET NON TREPIDE
Tullio De Mauro (1932-2017), linguista di fama internazionale, ha insegnato Filosofia del linguaggio e Linguistica generale nell’Università Sapienza di Roma, che gli ha conferito il titolo di professore emerito. È stato presidente della Fondazione Bellonci e presidente onorario della Rete italiana di cultura popolare, Accademico della Crusca, socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei e doctor honoris causa in molte università nel mondo. Per UTET ha pubblicato il Grande dizionario italiano dell’uso (8 volumi). Per Laterza è curatore del Corso di linguistica generale di De Saussure e autore, tra l’altro, di Storia linguistica dell’Italia unita, Minisemantica, Capire le parole, Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni e L'educazione linguistica democratica.
Scopri l'autoreIscriviti alla Newsletter Laterza per essere sempre informato sulle novità in uscita e sugli appuntamenti in agenda!

CONSTANTER ET NON TREPIDE
Ogni tanto incontriamo nei giornali, in tv, nei discorsi, una parola che ci pare nuova. Se abbiamo sotto mano un buon dizionario, nella maggior parte dei casi ci accorgiamo che la parola è già là, bella (o brutta) e registrata. Ma altrettanto spesso circolano nell’uso parole non ancora registrate dai dizionari, anche i più accurati e i più ampi. E, sia detto subito, tra le novità bisogna includere anche, se e quando ce ne accorgiamo, i sensi nuovi di parole già esistenti. Questo è stato per esempio il caso di leggerezza, che era parola quasi offensiva se detta di una persona o, peggio, d’un’opera letteraria. Italo Calvino, forse movendo dall’uso che già se ne faceva parlando della danza e di qualche grande pittore, ne ha fatto slittare il senso fino a individuare la più eccelsa delle qualità di uno stile, di un’intelligenza, di un’opera.
Facendo, tra altri, il mestiere di autore di dizionari, di cui uno, in particolare, è assai ampio, da parecchi anni ho dovuto prestare attenzione a parole del genere: parole non ancora registrate nei dizionari eppure meritevoli di entrarvi per la diffusione del loro uso fuori di ambiti strettamente specialistici e per l’autorevolezza di chi le adopera. Sono, come diceva Bruno Migliorini, uno dei maggiori linguisti del Novecento, le parole «d’uso incipiente».
Da un paio d’anni il settimanale «Internazionale» mi ha chiesto di occuparmi di queste parole. Con la redazione ho concordato un secondo o terzo vincolo: non solo parole non ancora presenti nei dizionari (o presenti in un nuovo senso) e non solo parole che circolino fuori di ambiti ristretti, ma parole che nascano e vivano, loro, o le loro strette affini, in diverse lingue del mondo; parole che siano, insomma, «internazionalismi».
Una settimana dopo l’altra, grazie al settimanale, compare una scheda dedicata a qualche parola del genere (tranne un paio d’eccezioni). Ripubblico qui i testi, con la data di prima pubblicazione, non per mera pedanteria, ma perché nel frattempo talune parole potrebbero essere state incluse in qualche dizionario, come lo Zingarelli, assai attento alle novità, o in repertori di neologismi.
I testi sono pubblicati nella forma originale. Rinvii a fonti o dizionari sono spesso assai ellittici. Nell’Appendice a fine volume, in un lavoro presentato a un convegno del 2005 sui neologismi, c’è una discreta bibliografia su dizionari e opere lessicografiche utilizzate nella redazione delle schede. Tuttavia, per comodo di lettrici e lettori esplicito qui i dati bibliografici di alcuni riferimenti più frequenti e meno ovvi fatti qua e là:
Giovanni Adamo, Valeria Della Valle, Neologismi quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio, Lessico Intellettuale Europeo, Olschky, Firenze 2003 (in seguito anche NQ);
Giovanni Adamo, Valeria Della Valle, 2006. Parole nuove. Un dizionario dei neologismi dai giornali, Sperling & Kupfer, Milano 2005 (in seguito 2006 PN);
Francesco De Franchis, Dizionario giuridico. Law Dictionary, 2 voll., Giuffrè, Milano 1984;
Dizionario medico illustrato Dorland, prima edizione italiana a cura di Mauro Bologna et al., Farmitalia Carlo Erba, Stampa Medica, Milano-Roma 1987;
GRADIT. Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro, 7 voll., UTET, Torino 1999-2003, con CD.
Ho accennato alla presenza nell’uso. Era qualcosa che un tempo poteva accertarsi solo con intuito artigianale, come quello, magistrale, di Bruno Migliorini. Oggi potenti aiuti ci vengono sia dalle grandi raccolte, dai corpora o – dice qualcuno anglizzando ad oltranza – dai corpuses di testi consultabili informaticamente, sia dalla congerie immensa di testi eterogenei consultabili on line grazie ai migliori motori di ricerca, come ad esempio Google o Alltheweb. Naturalmente gli aiuti ci vengono solo se usiamo curiosità e intelligenza. Guai ai corpora senza cervello, come la maschera tragica trovata dalla volpe di Fedro: eheu quanta species, sed cerebrum non habet.
Le schede rispondono anche a un quarto vincolo, quello di non superare le circa 1000 battute. La stringatezza (forse non separabile dalla leggerezza di Calvino) è d’obbligo in giornali che siano ben fatti.
Ai redattori e alle redattrici di «Internazionale» vorrei permettermi di dedicare questa raccolta, per il loro lavoro, per la loro bravura, per le speranze che ci accomunano.
Tullio De Mauro
Roma, 2 giugno 2006
Da account «conto, bilancio» in inglese si trasse nel Settecento accountable «soggetto o disponibile a rendere conto» e di qui, più tardi, accountability, una parola fortunata specie in USA. Qui nel 1921 nacque il GAO, General (dal 2004 Government) Accountability Office, ente indipendente per verificare la accountability delle amministrazioni pubbliche. Col crescere del bisogno di pubblico controllo di spese e atti anche di imprese private, dagli anni Novanta sono stati definiti standard internazionali.
La parola, presente in Italia dal 1984 (come nel dizionario giuridico di Francesco De Franchis), s’è diffusa nelle più varie lingue (spagnolo e francese in testa). Il dizionario di neologismi di Adamo e Della Valle propone ben quattro traduzioni: responsabilità, attendibilità, controllo, responsabilizzazione. Altri pensa a rendicontabilità. Potere e dovere rendere puntuale conto del bilancio e, in generale, della correttezza ed efficacia degli atti: cosa difficile, ma concetto chiaro, che però in molte lingue sembra ben reso solo dalla parola inglese.
[23 dicembre 2004]
Nel romanzo di Aldous Huxley Antic Hay (Passo di danza) un personaggio, meditando su autodromo, cinodromo, ippodromo, preso da rigurgiti di grecità si mette a fantasticare sui «dromi» possibili, fino a un teodromo, circuito per stabilire chi è la divinità più veloce.
Carlo Cattaneo, George Orwell, Emanuele Djalma Vitali, perfino Carducci hanno protestato, ma inutilmente, contro il dilagare di tecnicismi grecizzanti in diversi ambiti scientifici iniziato in Francia nel Settecento. Un articolo di «New Scientist», ripreso da «Internazionale» (1 aprile 2005), elenca un po’ di fobie. Ma da ablutofobia a zoofobia nei repertori circolano oltre 110 termini. Sigmund Freud si asteneva da tanta abbondanza e preferiva usare «paura dei cavalli» e non ippofobia o equinofobia ecc.
Alcuni termini, se capiti, fanno ghignare il profano. Male. Secondo gli esperti, nel 37% di popolazione che ha qualche fobia parecchi, per esempio, soffrono di paura patologica dei polli o alectorofobia, alektorophobia in anglo-greco-latino.
[6 maggio 2005]
Nel 1973-75 Donald Johanson e Tim White scoprirono tra Etiopia, Kenya e la depressione di Afar centinaia di reperti di Australopithecus afarensis, tra cui la celebre Lucy, risalenti a poco meno di quattro milioni di anni.
Più tardi Mary Leakey rinvenne resti di Australopithecus anamensis (anam significa «lago» nella lingua dei turkana) e nel 1994 Tim White annunziò con due articoli su «Nature» la scoperta di resti di un nuovo, più antico tipo di progenitore, l’Ardipithecus ramidus, vissuto 4,4 milioni di anni fa, dal nome composito (ardi è il «ground floor» in afar o dancalo e ramid vale «radice») non meno della sua struttura: più scimmiesco del cugino Afarensis, tuttavia già capace di muoversi sul terreno e trovarvi cibo.
Come ha osservato «Nature» (cfr. «Internazionale», 638), il cespuglio delle origini si fa sempre più fitto.
Il latino scientifico internazionale rende omaggio a una lingua nilotica, quella dei turkana, e a una lingua cuscitica, affine al somalo, come l’afar. E questo è un bel segno della complessità che oggi riconosciamo alle nostre radici africane.
[5 maggio 2006]
In olandese se ne parla dal 2002, quando nel Regno Unito gli Anti-Social Behaviour Orders varati dal governo Blair («Internazionale», 606, p. 36) erano solo annunziati, ma non erano ancora in vigore.
Inglese e olandese a parte, in altre lingue asbo stenta a farsi strada tra sigle omonime di tutt’altro significato (in francese, per esempio, un Academicus Sanctae Barbarae Ordo, in italiano l’Archivio di Stato di Bologna). In francese e tedesco all’inizio dell’attuale diffusione c’è un bell’articolo di «Arte. Forum des Européens/der Europäer» (5 marzo 2005), seguito da «Le Monde diplomatique» e, quindi, dalla versione italiana del «manifesto» (aprile 2005). Ancor più lento il cammino in spagnolo.
L’ostilità continentale al «metodo britannico» è marcata, ma problemi di microcriminalità anche giovanile accompagnano tutte le nostre società stralunate dal consumismo. Il problema c’è e di asbo si continuerà a parlare, ma occorre un punto d’equilibrio.
La porcilaia di San Patrignano che è stata usata per recuperare drogati e le campagne giornalistiche per ripristinare il 7 in condotta a scuola rendono sicuri che l’Italia marche à la tête de la civilisation.
[16 settembre 2005]
La parola (attractor in inglese, attracteur in francese) è stata usata dagli anni Sessanta del Novecento in ambito matematico, per indicare il valore cui tende una serie di risultati casuali: per esempio, il valore di un sesto che dopo molti lanci e se il dado non è truccato assumerà la comparsa di ciascuna delle facce di un dado. Di là la parola è migrata verso la fisica del caos, per indicare la linea o lo stato verso cui convergono fenomeni caotici.
Nel 1994 l’israeliano Avishai Dekel ha scoperto che non tutte le galassie si allontanano reciprocamente secondo la legge di espansione enunziata da Edwin Hubble nel 1929. Alcune – la nostra Via Lattea, Andromeda e altre vicine – si discostano dal movimento generale d’espansione e fuga e si dirigono invece verso una massa gigantesca, un muro di galassie, stimata a cento milioni di miliardi di masse solari, in direzione della costellazione del Centauro. A questa immensa muraglia cosmica, di recente oggetto di nuove osservazioni, è stato dato il nome di Grande Attrattore.
Forse merita qualche riga nei dizionari, oltre che in Wikipedia.
[27 gennaio 2006]
Francesco Rutelli usò anni fa noismo per indicare l’atteggiamento di chi dice sempre e solo no a qualunque proposta. La parola ha avuto successo, anche se collide con noismo tratto da noi, egoismo di gruppo, e con noismo da noia, ostentazione di noia. Il noismo colto da Rutelli è la forma più generale del dir no.
Riferito a novità tecnologiche o strutturali, in USA per il noismo antitecnologico circola l’acronimo banana: «Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything» «non costruite niente da nessuna parte vicino a niente». In italiano lo usava già nel 2003 «lavoce.info», deprecando il bananismo. I banana sono la forma estrema di qualcosa che si indicò (negli USA fin dal 1980; in italiano, in forma grafica scorretta, dal «Corsera» del 1999) con un altro acronimo, nimby «Not In My Backyard», non nel cortile di casa mia: bene la piattaforma ecologica o l’alta velocità, ma, per favore, non dalle mie parti.
La parola (assai meno il suo derivato nimbysm o nimbism) sta avendo un’enorme fortuna in testi e siti inglesi, ma anche nelle altre lingue del mondo, come sostantivo e come aggettivo.
[1 settembre 2006]
Qualcuno, male informato, usa questo termine al posto di biografia, come se fosse un parente nobile, scientifico, del vocabolo corrente. Ma è una vera sciocchezza.
Il termine biographème fu coniato negli anni Settanta dal critico e semiologo francese Roland Barthes, mentre si occupava di fotografia e scriveva La chambre claire. La fotografia – diceva – isola e rende esemplare un momento solo della storia personale o pubblica e così nelle biografie, o meglio nelle autobiografie, si isolano soltanto certi eventi, presentati come fondamentali nella storia d’una vita: questo evento messo in esponente, diceva Barthes, è un biografema.
La parola è piaciuta a critici, ad antropologi e sociologi che raccolgono storie di vita, e agli educatori, specie a chi si occupa di educazione degli adulti, che dal gusto di rievocare propri biografemi sono sospinti a riattivare altre capacità che si erano magari atrofizzate.
Partendo dal francese, biographème e i suoi adattamenti hanno avuto diffusione nelle lingue neolatine e slave e in basco. Minore la fortuna in tedesco e in inglese. E sì che, a partire da autobiografie splendide come quella di Charles Darwin o Helen Keller, i biografemi non mancano nel mondo anglosassone.
[18 febbraio 2005]
Nella stampa italiana greggio (o grezzo, usato alternativamente magari nello stesso articolo) batte ancora tre a uno brent, parola spesso usata in modo inesatto, come completo sinonimo di greggio. Il brent è non ogni greggio, ma il greggio estratto nella parte britannica del Mare del Nord e, come spiega l’Enel in un glossario, è «usato in Europa come benchmark di mercato» (negli Stati Uniti il greggio di riferimento è il WTI, West T