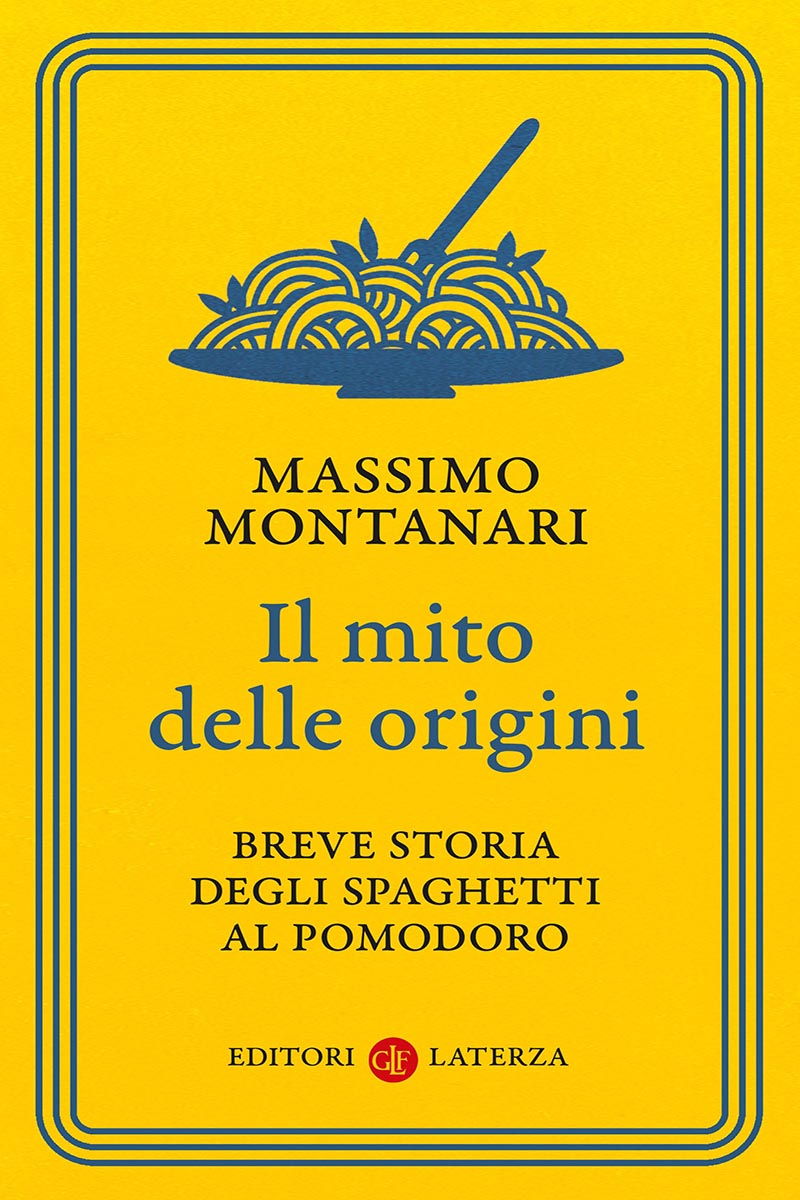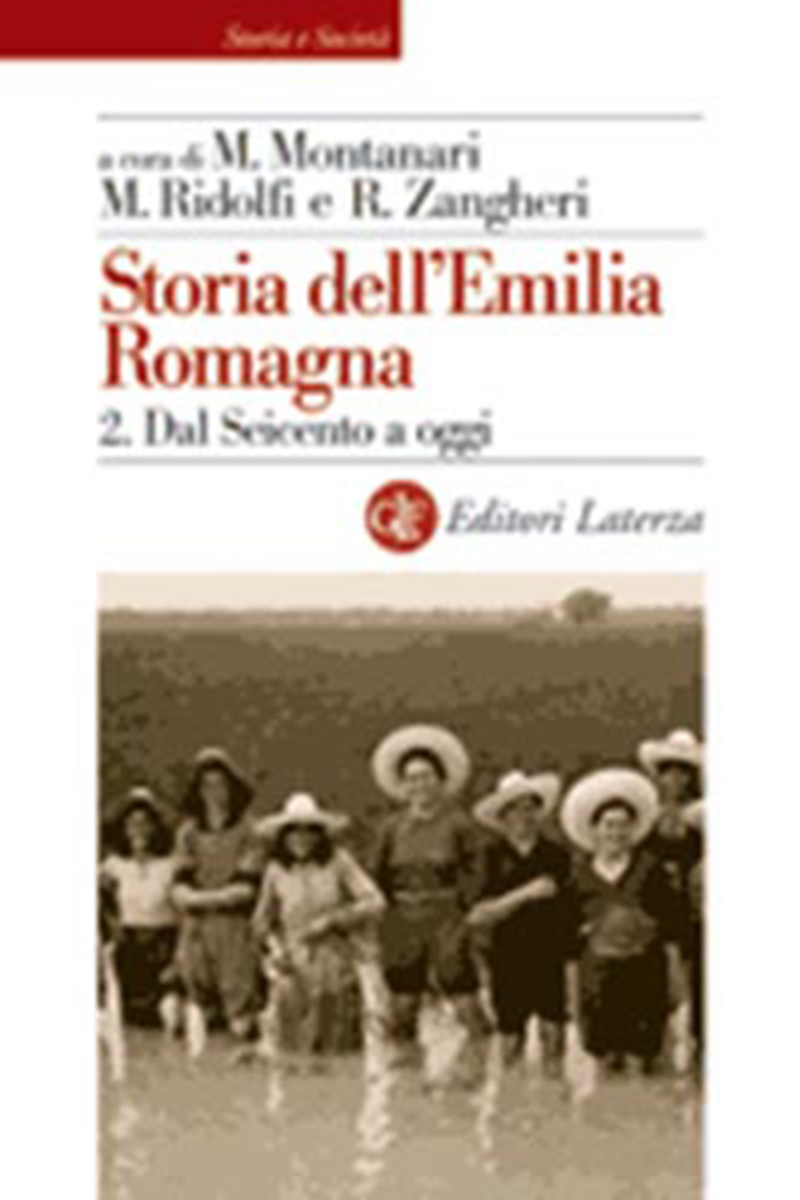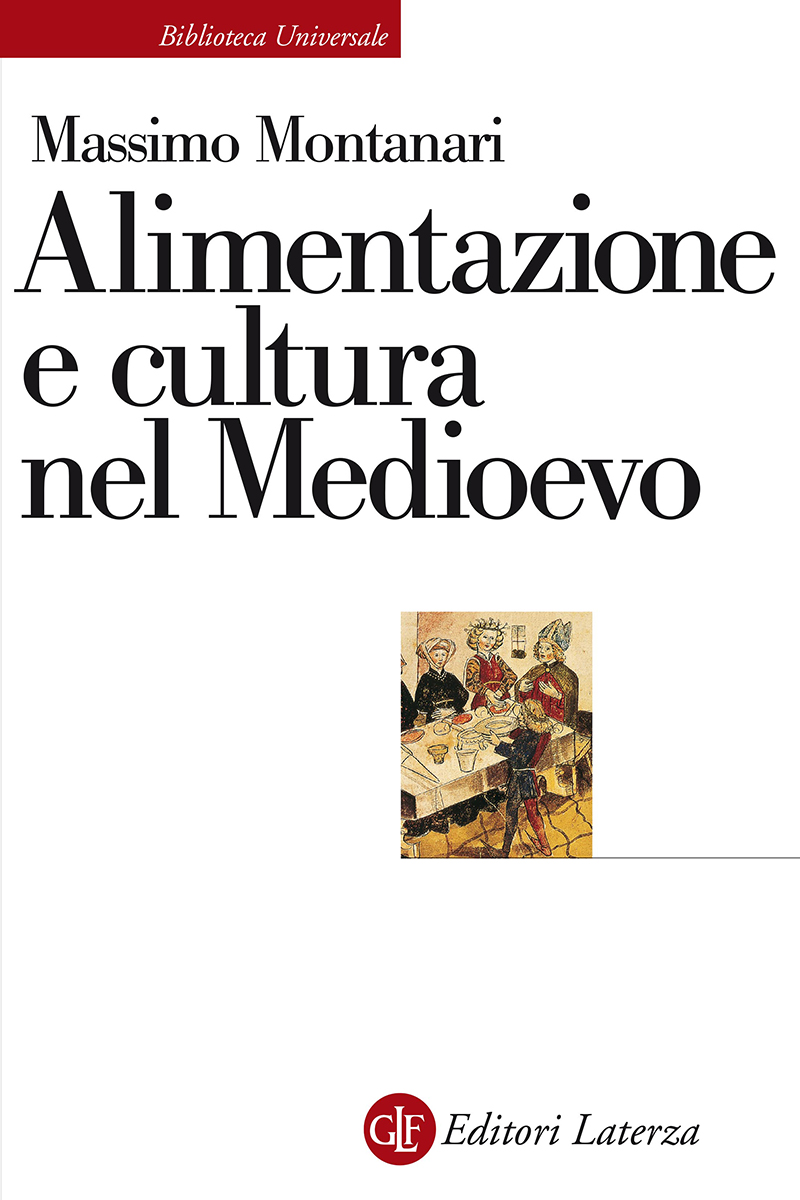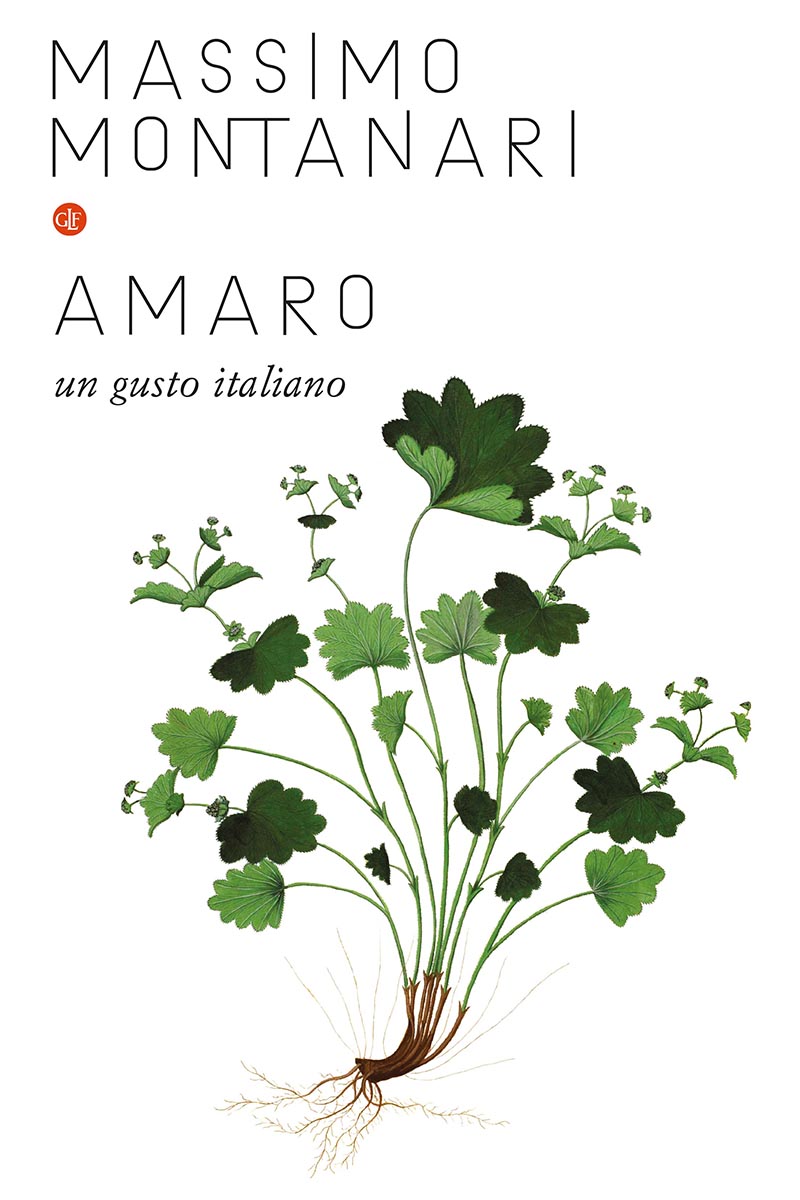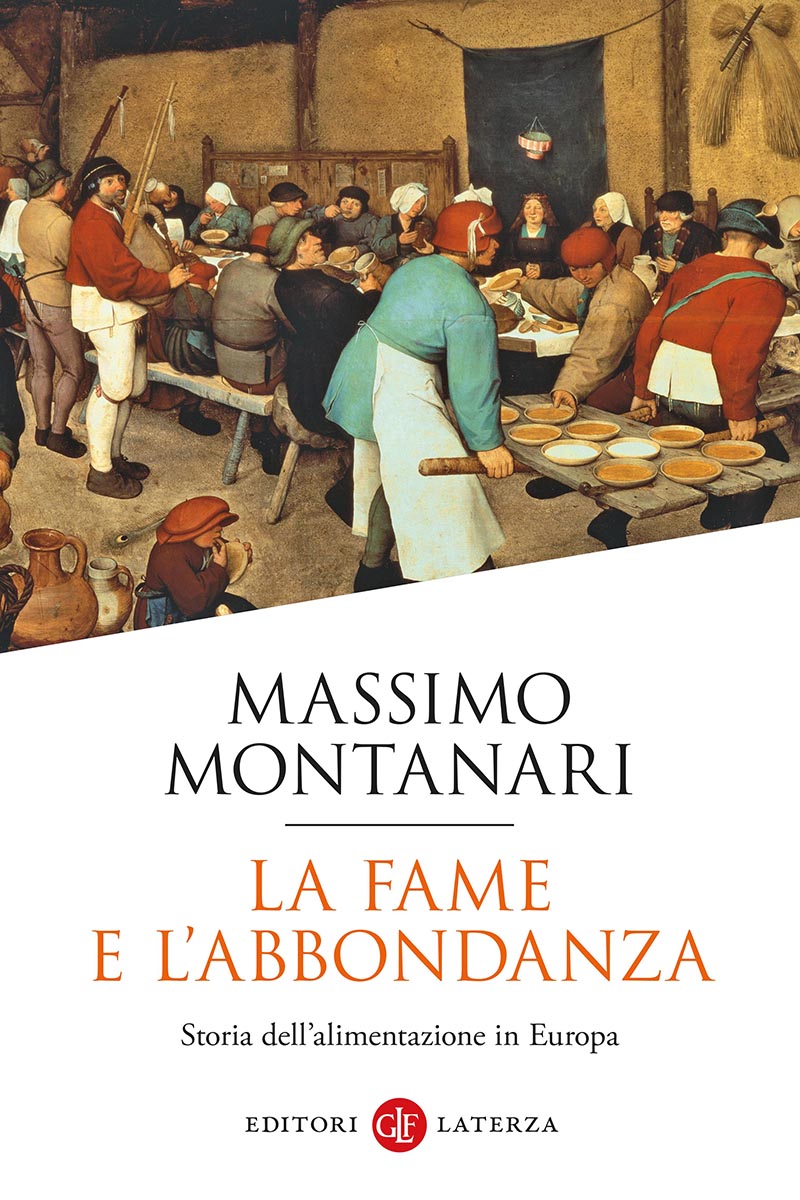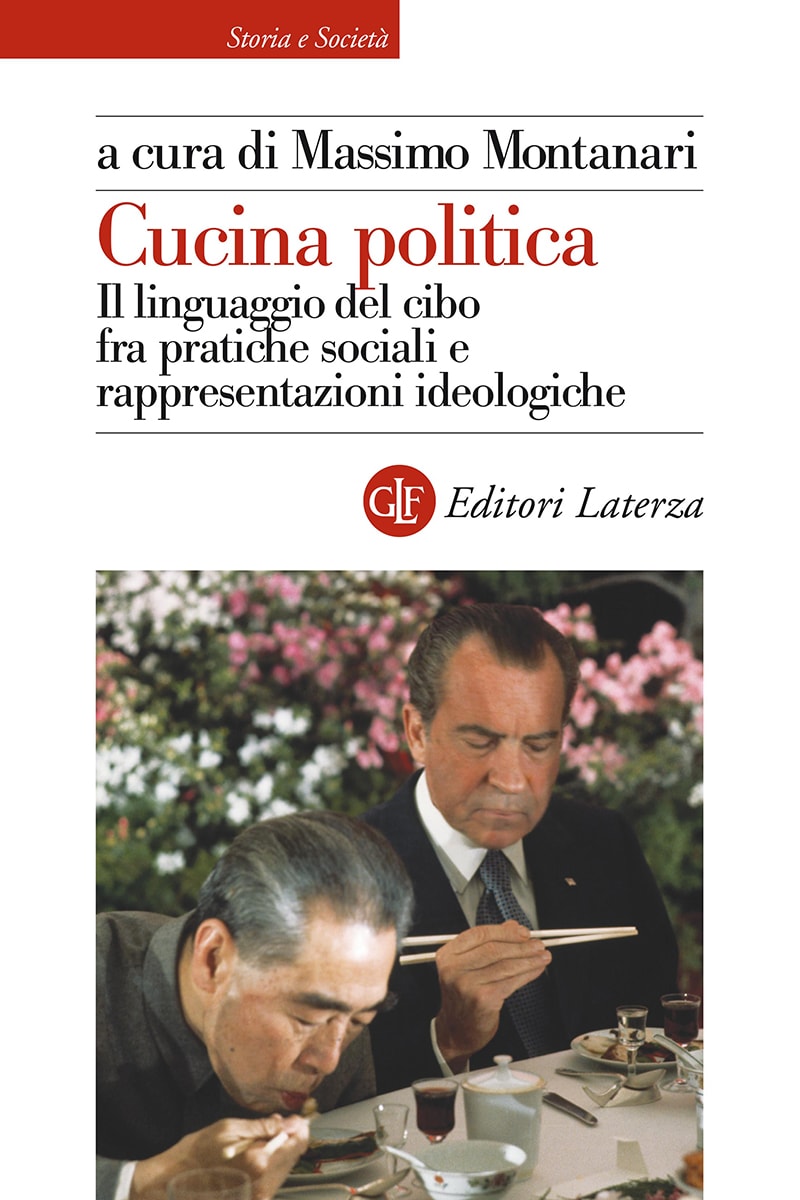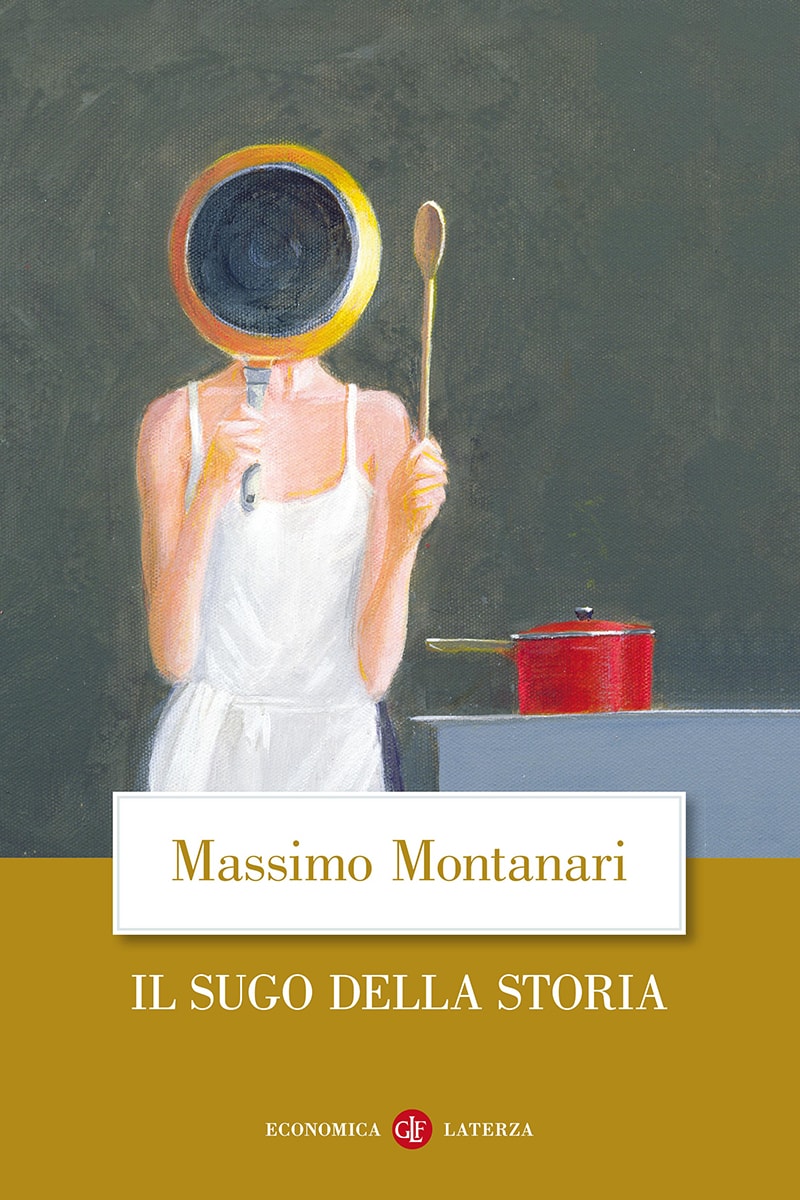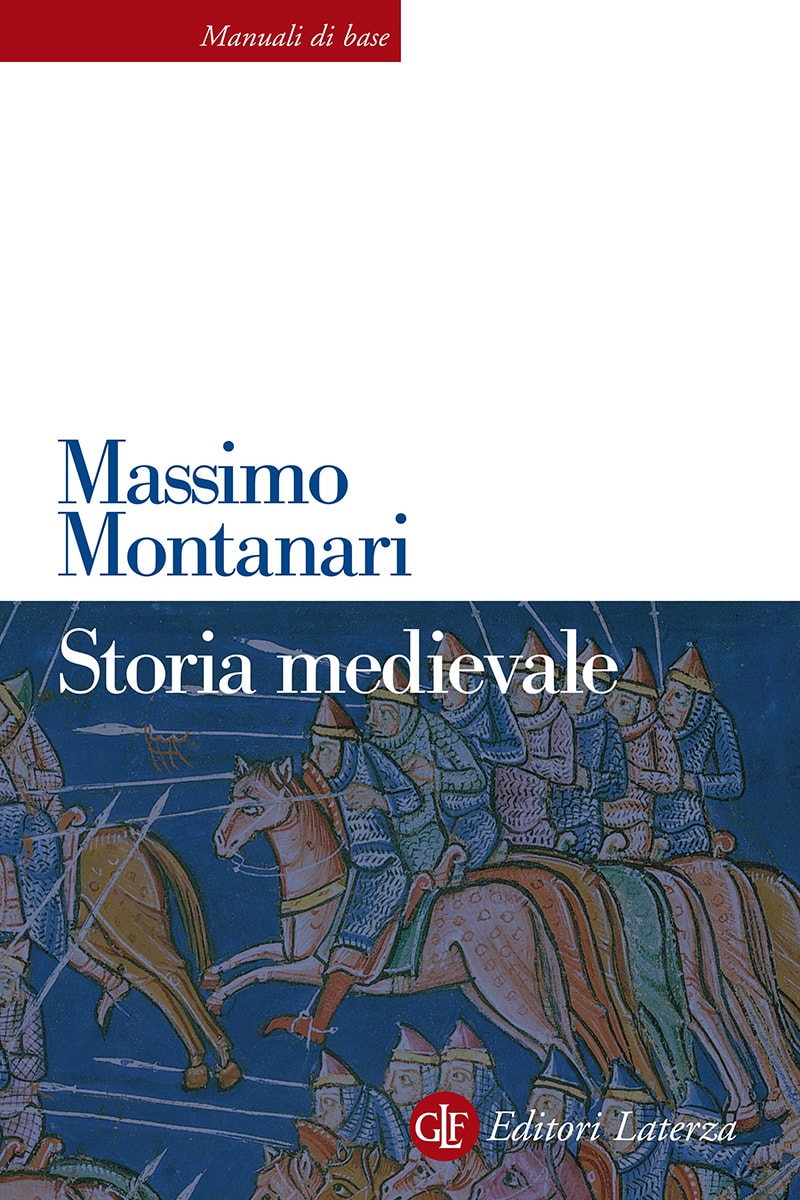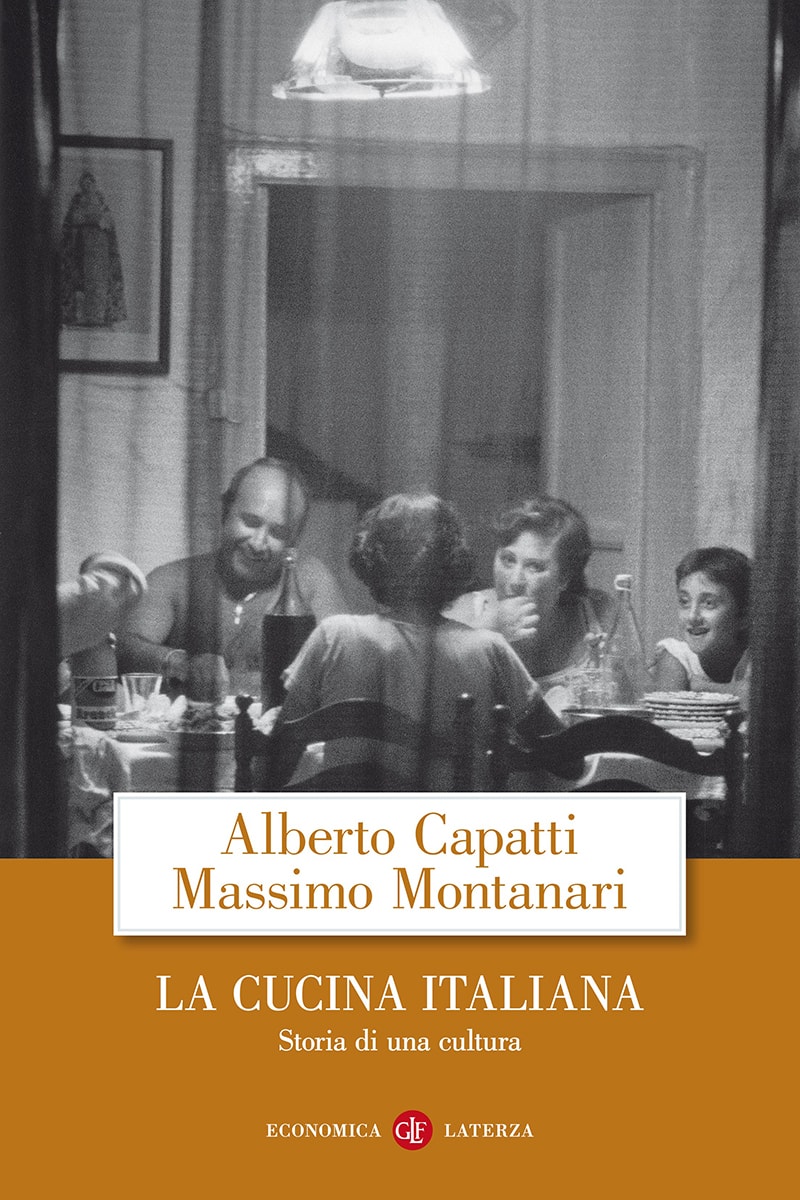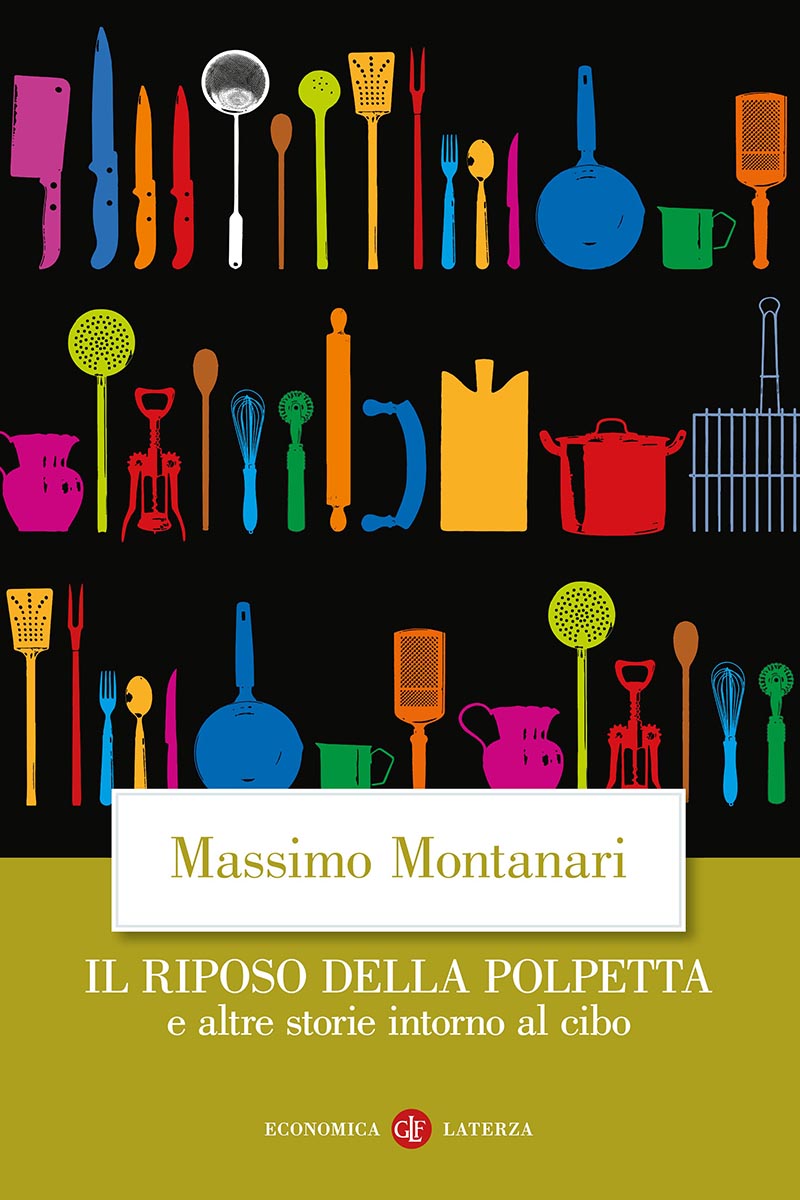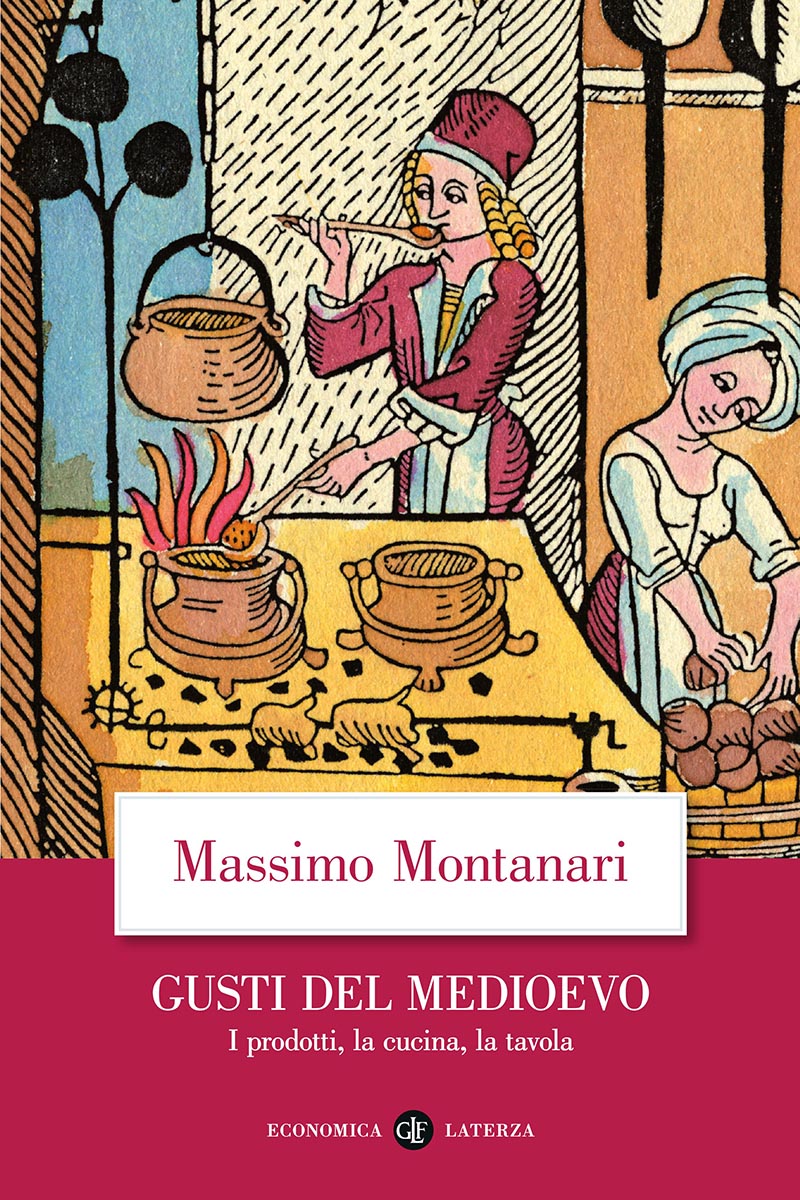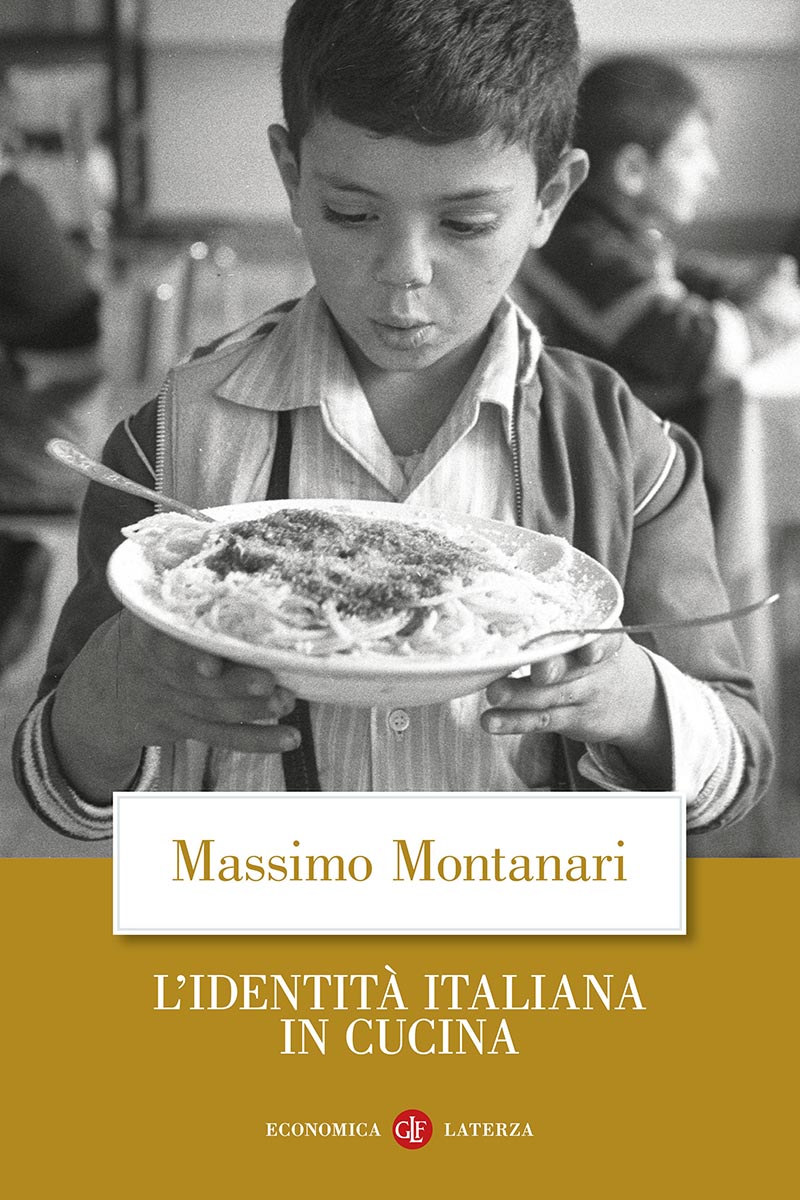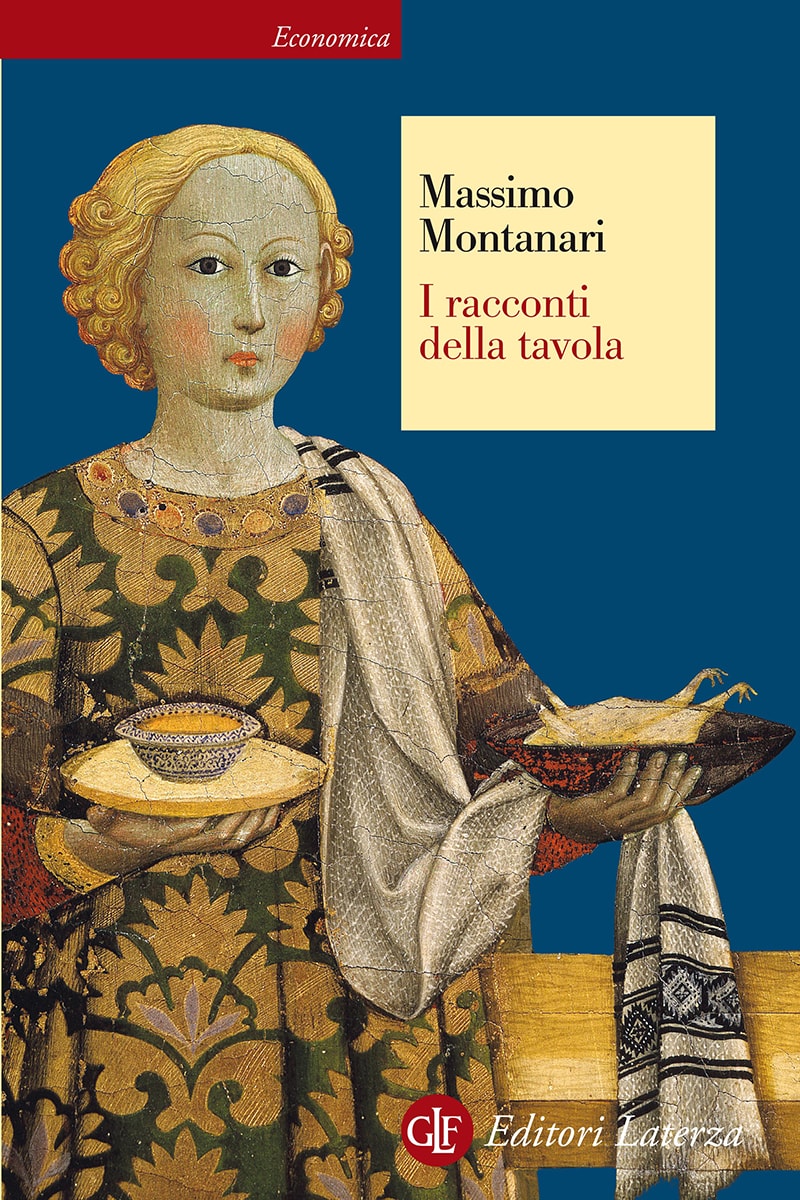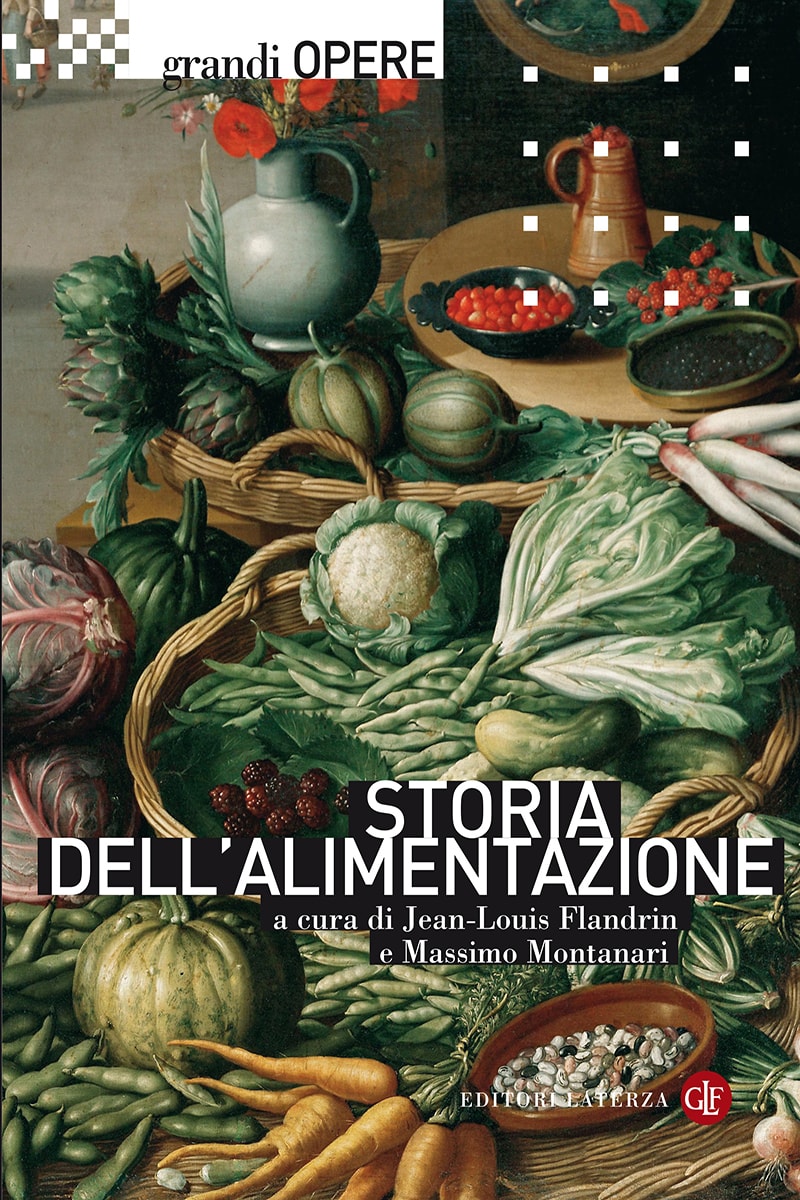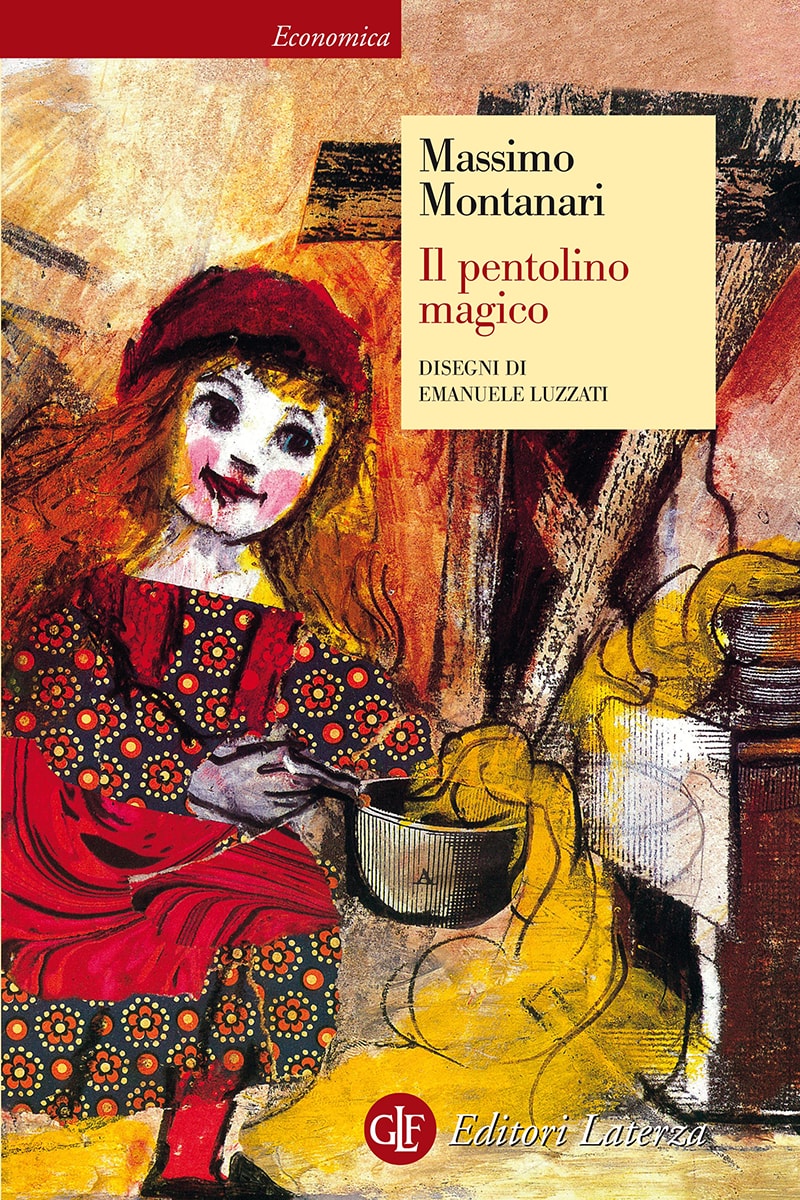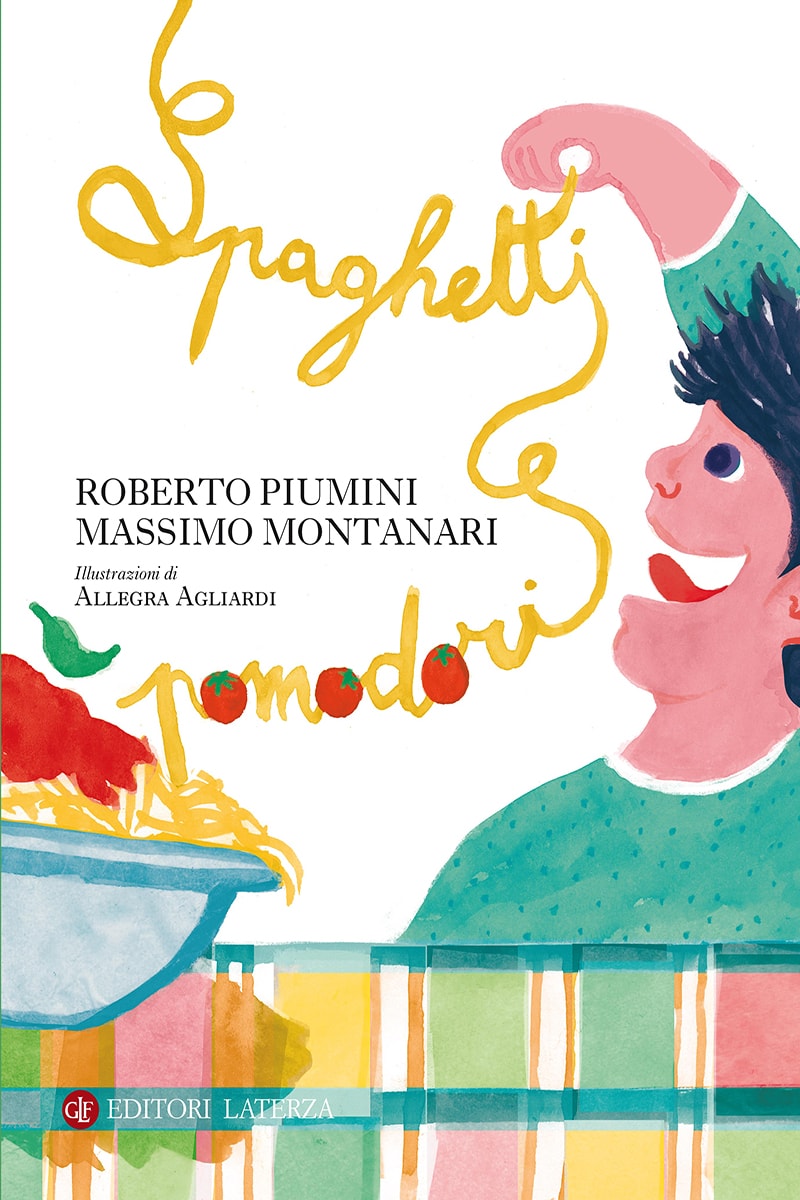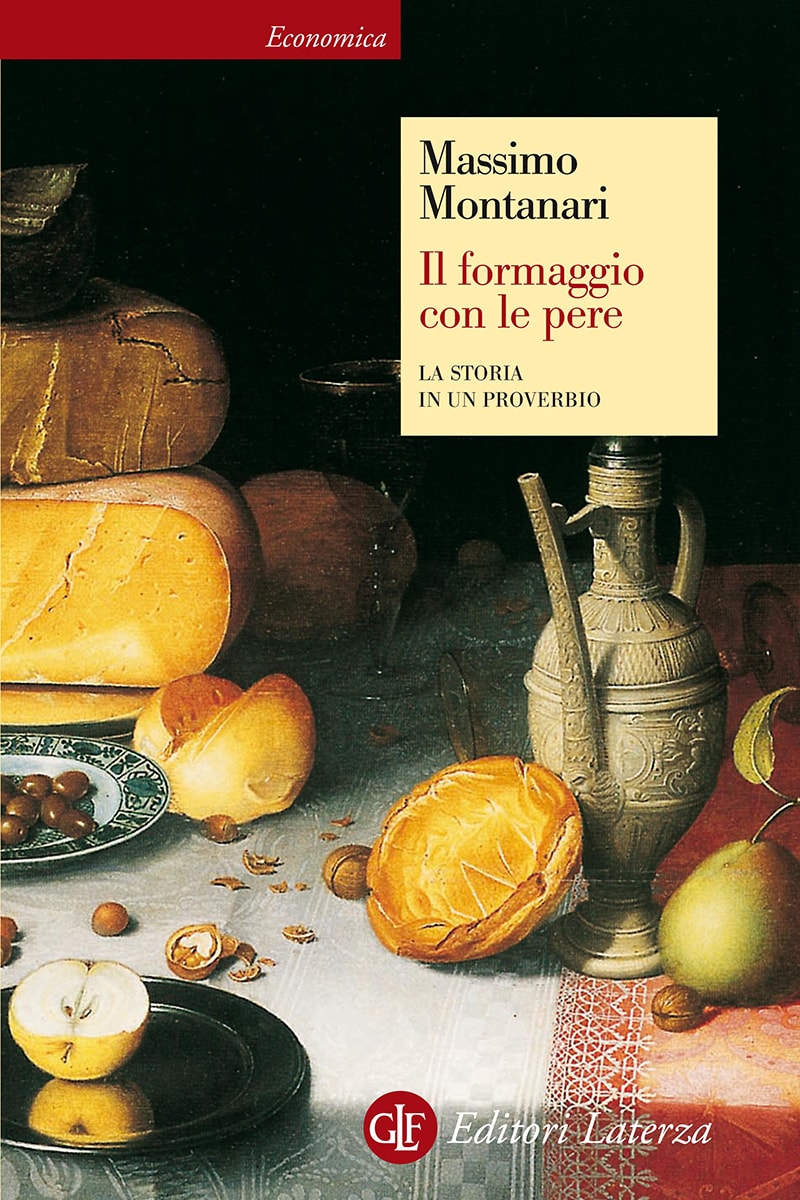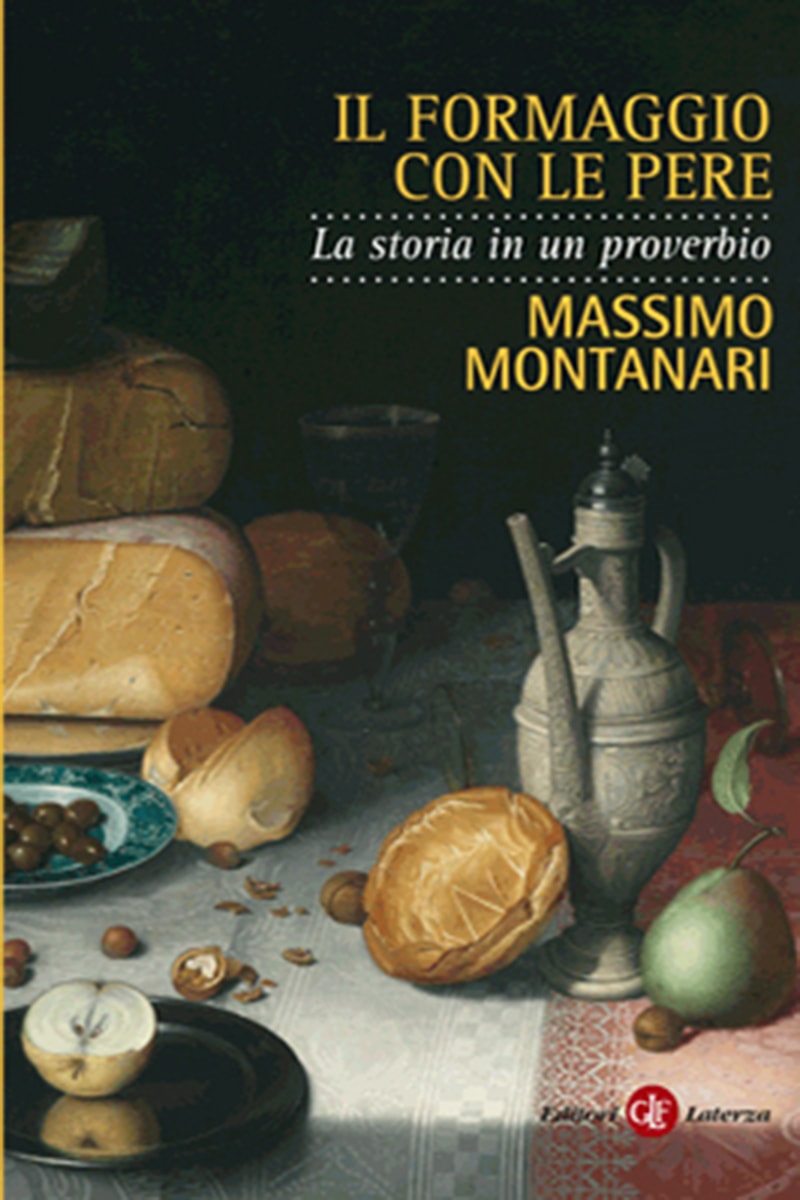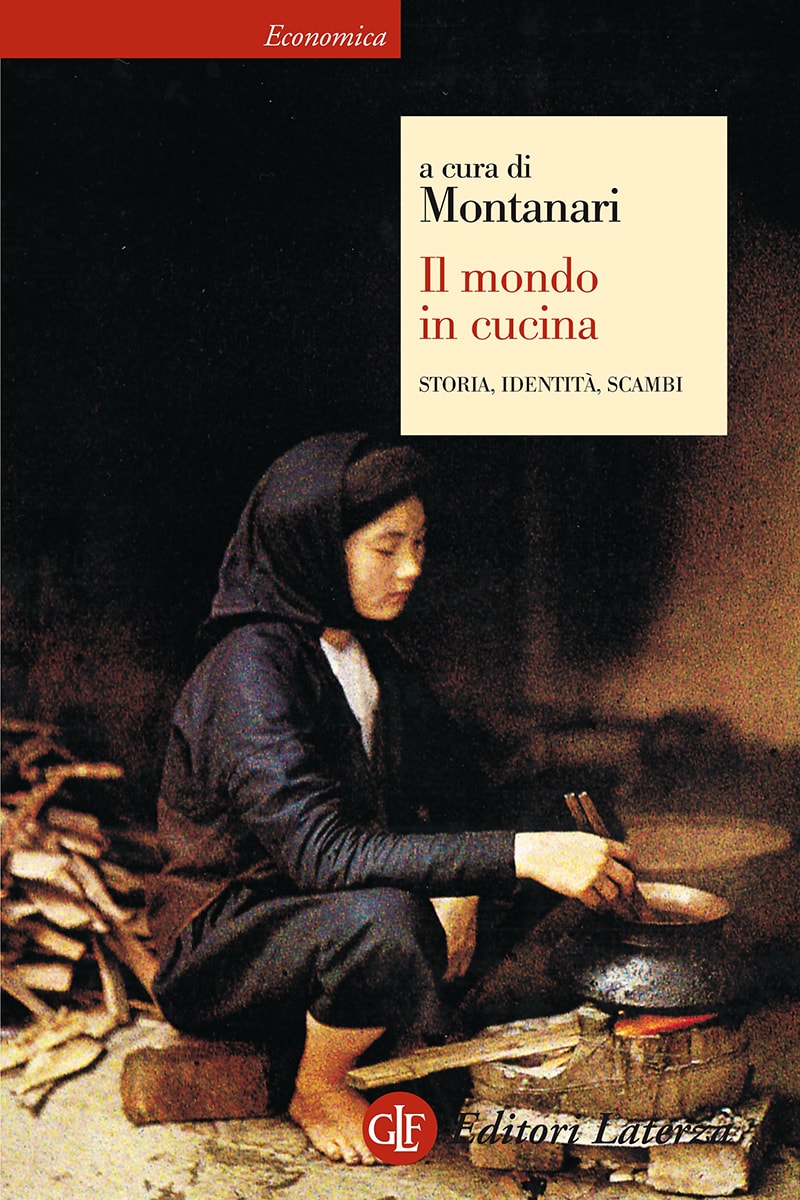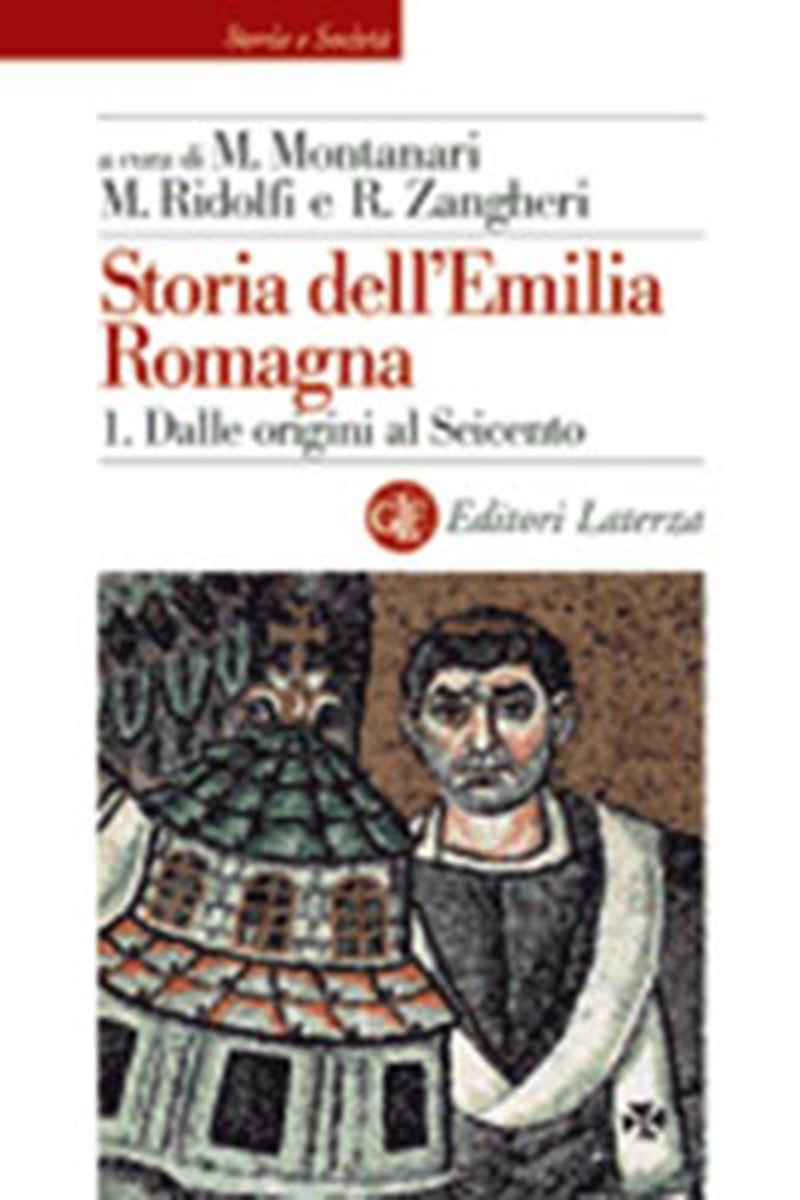Caro dottore, quello che conta è la crescita,
e quella là modestamente ha fatto una crescita...
uuuhhh!
Totò a Parigi, 1958
Parole. Maneggiare con cura
Idolo delle origini lo chiamava Marc Bloch, il più grande storico europeo del Novecento1. Ricercare nel passato ciò che prepara il presente, diceva Bloch, è un’ossessione
tipica di chi si occupa di storia. Essa domina anche l’immaginario collettivo. Niente
di male, in apparenza. Tutto sta a intendersi sul significato di ‘origini’. Semplicemente
‘inizi’? In questo caso, il concetto sarà abbastanza chiaro. O si vorranno intendere
le ‘cause’? In questo caso, saremmo di fronte a un determinismo storico tanto ingenuo
quanto insostenibile, e contraddetto dall’esperienza: dato un punto di partenza x, non esiste un solo punto d’arrivo y ma una molteplicità di direzioni possibili, definite dalle circostanze, dall’interazione
di forze diverse, dal caso, dall’imprevisto.
Il problema è che tra i due significati avviene spesso un salto logico: «nel vocabolario
corrente le ‘origini’ sono un cominciamento che spiega. Peggio ancora: che è sufficiente
a spiegare». Qui sta l’ambiguità, qui il pericolo: confondere una filiazione con una
spiegazione. Perché una ghianda non è una quercia.
La metafora di Bloch è fulminante. «La quercia nasce dalla ghianda. Ma diventa quercia
e tale rimane, solo se incontra condizioni d’ambiente favorevoli, che non dipendono
più dall’embriologia». Ed è questo che veramente interessa lo storico: l’analisi delle
condizioni ambientali, del tessuto economico, sociale, culturale che consente alla
ghianda di diventare quercia. Le origini, a quel punto, importano davvero?
Le origini in realtà non spiegano nulla, perché un seme è necessario a dar vita a
una pianta, ma non sufficiente a generare una radice e, su questa, una pianta. Ecco
che cosa sono le ‘origini’: non una ‘causa’ ma semplicemente un seme che può diventare pianta, a condizione di incontrare un ambiente favorevole. È la parola-chiave:
incontrare. Più numerosi e interessanti saranno stati gli incontri, più ricchi saranno i risultati,
più forte e robusta la pianta. In questo modo essa avrà costruito la propria identità,
che, come ogni prodotto della storia, è viva e mutevole. Viva in quanto mutevole – «il moto è causa d’ogni vita» è il celebre aforisma di Leonardo. Quanto
alle radici che questa identità hanno reso possibile, lanciarsi alla loro ricerca
è un’esperienza che può rivelarsi più avventurosa del previsto, portandoci a visitare
luoghi, società, culture che non sono necessariamente la nostra.
Radici e identità sono parole pericolose, da maneggiare con cura. Frequentemente le si vedono fraintese
e confuse, mentre è importante distinguerle. Le radici abitano il passato: sulla linea
del tempo – se vogliamo raccontare la nascita, la crescita, lo sviluppo di qualsiasi
realtà – stanno all’inizio, e nello spazio si allargano per trarre alimento da ogni
fonte raggiungibile (la metafora botanica, affinché sia utile, va usata fino in fondo).
All’altro capo della linea del tempo stanno le identità, che invece abitano il presente
– un presente mobile, sempre teso a proiettarsi nel futuro diventando esso stesso
passato. In qualsiasi punto della linea cronologica, le identità sono un punto d’arrivo:
spazi mentali e materiali ben delimitati le caratterizzano, ma sempre instabili e
mutevoli, come è proprio di tutto ciò che vive.
Perdere di vista questa vitalità significa precludersi uno sguardo veramente storico attorno al tema delle identità e delle radici da cui esse provengono, ossia le loro
‘origini’. Significa pensarle immutabili rispetto al futuro, preoccupandosi non di tenerle in vita – con gli opportuni adattamenti
– ma di congelarle, codificarle, musealizzarle. Significa pensarle immutate rispetto al passato – un passato che a questo punto diventa puro mito e colossale
mistificazione. È l’idolo delle origini che rispunta, contro ogni evidenza, contro
ogni logica. E si giustificano le scelte radicali di quanti non si limitano a raccomandare
cautela nell’uso di questi concetti e di questi termini, ma li contrastano fino ad
auspicarne l’eliminazione dal vocabolario e dall’immaginario collettivo. Contro le radici ha scritto Maurizio Bettini2, Contro l’identità ha scritto Francesco Remotti3 – giusto per citare due casi esemplari. Contro le origini si sarebbe potuto chiamare questo piccolo saggio. Ma lo storico si illude che il
semplice racconto dei fatti possa aiutare a far luce sul senso delle parole e delle
cose. Soprattutto quando le ‘cose’ sono aspetti della vita con cui ci confrontiamo
quotidianamente. Per esempio il cibo, i prodotti alimentari, le ricette di cucina.
È possibile sedersi a tavola di fronte a un piatto di spaghetti al pomodoro e riflettere
sul senso delle radici, delle identità, delle origini? È quanto ho provato a fare
in queste pagine.
Ricette e prodotti,
ovvero il tempo e lo spazio
Quando si mangia, e quando si parla di cibo, gli equivoci e le mistificazioni sono
all’ordine del giorno, e di forte impatto emotivo. Tutto ciò che riguarda la cucina
e la tavola, infatti, richiama valori e suggestioni profonde, connesse all’identità
della persona. Realtà materiale (i modi di vivere) e realtà mentale (i modi di pensare)
come sempre interagiscono, e in questo caso come in altri – forse più che in altri
– l’immaginario è condizionato da pregiudizi, luoghi comuni, miti, fantasie, idoli. Quello delle ‘origini’ è il più forte e si impone all’attenzione individuale e collettiva,
in una declinazione sia temporale, sia spaziale.
La dimensione tempo è quella delle ricette, di cui spesso ci chiediamo l’origine andando alla ricerca di un episodio preciso,
dell’esatto momento in cui qualcuno per la prima volta ebbe l’idea di realizzarla.
Ossessione antica: Catalogo de gli inventori delle cose che si mangiano e bevono è il titolo semiserio di una curiosa opera dell’erudito milanese Ortensio Lando,
pubblicata nel 1548. Spulciando nella letteratura antica e molto aggiungendo di fantasia,
egli si diverte a raccontare chi per primo «mangiasse fritelle di sambuco e di ramarino»,
o «frigesse il pane nel butiro» o «mangiasse in minestra orgio e avena pesta»4.
Il mito delle origini qui assurge a metodo – sia pure in modo scherzoso – ma tutti
conosciamo storie e storielle che fanno risalire questa o quella ricetta a improbabili
personaggi storici: il cuoco, il signore, il monaco sono i più gettonati, ma non mancano
pastori e contadini, in un mix esplosivo di fortunate coincidenze, invenzioni dettate
dalla fame, casualità e imprevisti. L’importante è fissare un’origine, che rassicura
e acquieta. Non importa se in questo modo la fiction sopravanza la storia: anche se nessuno ci crede veramente, la narrazione è talmente
bella che in ogni caso appaga. Appaga il desiderio di sapere, l’urgenza di riconoscere
un’origine certa a cui appellarsi, perché lì, nell’origine, sta il segreto della storia;
perché, tornando a Bloch, le origini non sono pensate come un semplice inizio, bensì
come un ‘inizio che spiega’. Di tutto il resto (quali meccanismi economici e sociali
abbiano prodotto la ricetta e quali, viceversa, essa abbia messo in moto; come e perché,
e in quale tipo di cultura essa si sia affermata; quale spazio abbia trovato nel sistema
di cucina) possiamo bellamente disinteressarci. Mentre fingevamo di sentire il richiamo
della storia, dalla storia eravamo proprio usciti.
La dimensione spazio è quella dei prodotti. La retorica contemporanea – soprattutto, ma non solo, nel linguaggio del marketing
e nella promozione pubblicitaria – ci ha insegnato a chiamarla territorio, insistendo sulla parola e sul concetto in modo davvero ossessivo. È il territorio
che conferisce ai prodotti il loro marchio identitario, la loro ‘origine’ – intesa
proprio nel modo che Bloch deprecava: non semplicemente il luogo in cui un prodotto
nasce, ma ciò che magicamente gli attribuisce un’identità. Anche qui, le origini diventano
un ‘inizio che spiega’.
Certo, tutti sappiamo che il territorio da solo non basta a ‘spiegare’ un prodotto,
le sue caratteristiche, le sue qualità. Il lavoro dell’uomo, che, interagendo con
l’ambiente e mettendo a frutto le risorse naturali, in larga misura inventa quel prodotto, è almeno altrettanto importante. Di ciò rende conto la nozione francese
di terroir, che tiene insieme la geografia del luogo e le abilità dell’uomo. Di ciò rendono
conto i disciplinari dei consorzi, che fissano norme precise – tecniche, procedure,
metodi – per riconoscere a un determinato prodotto il diritto a fregiarsi di una denominazione
territoriale, marcandolo come ‘tipico’ di un luogo.
L’operazione non è scevra da equivoci, perché se da un lato consente di tutelare e
proteggere un bene comune, sottoponendolo a un rigoroso controllo produttivo e commerciale,
dall’altro di fatto lo espropria, consegnandolo a una gestione privata come è quella
dei consorzi, sia pure pubblicamente riconosciuti. Ma quello su cui mi preme insistere
è la prospettiva idolatrica che in tutto ciò assume la nozione di ‘origine’, che finisce per acquisire un valore
di garanzia – quasi ontologica, per così dire – della natura e della stessa qualità del prodotto. ‘Origine’ diventa
di per sé un valore.
Non voglio dire che l’attenzione al territorio sia esclusiva della modernità e del
mercato globale – giacché individuare qualcosa, o qualcuno, con una denominazione
di origine territoriale comincia ad avere un senso solo nel momento in cui, e nella
misura in cui, quel qualcosa o quel qualcuno escono dal territorio per circolare altrove. Questo è sempre stato vero: i testi antichi
(quelli degli agronomi latini, per esempio) sono ricchi di attribuzioni locali riferite
a prodotti, e la letteratura gastronomica del Medioevo e del Rinascimento trabocca
di denominazioni di origine. L’intento – qui al di fuori di ogni ansia normativa –
è sempre quello di riconoscere, confrontare, valorizzare. Anche l’umanista Platina,
al secolo Bartolomeo Sacchi, quando parla delle galline di Padova o delle carote di
Viterbo, o di tante altre specialità locali5, assegna al luogo un valore di qualità e di garanzia. E lì non ci sono consorzi a
tirare la cordata. Dunque il territorio, la geografia, lo spazio paiono essere una
costante dell’immaginario legato ai piaceri del cibo.
Neppure voglio dire che le origini siano ininfluenti: è l’evidenza a smentirlo. Ma
desidero sottolineare come questa attenzione alle origini, in sé pienamente motivata,
possa assumere declinazioni inquietanti, sposandosi ad atteggiamenti mentali che a
volte profumano di intolleranza e fanatismo. È quando il legittimo pensiero «la mia
cucina è buona» diventa «la mia cucina è buona perché la sua (e mia) origine è buona».
Più della tua, s’intende. Così le origini vengono messe in conflitto fra loro, senza
rendersi conto che la storia – eccola di nuovo, la storia, ecco il tempo che disturba
la tranquillità dello spazio – mostra tutto il contrario, e cioè che, rimestando uomini
e cose e pescando da ‘origini’ diverse, i risultati sono spesso eccellenti e comunque
dinamici, e la vita continua e tutto si fa più interessante.
In realtà, i prodotti (caso esemplare di richiamo alle ‘origini’) non funzionano mai
da soli. La cucina li mescola e li mette in gioco, facendoli interagire. Squisito
il basilico, ma nessuno mangia basilico da solo. Squisito il peperoncino, ma nessuno
mangia peperoncino da solo. Squisita la pasta, ma nessuno mangia pasta senza condirla.
La cucina è fatta di prodotti, certo, ma soprattutto di ricette. ‘Ricette’ dal latino
recipio: prendo (di qua, di là, quello che mi serve) e compongo. Anche le più autoctone delle
ricette, quelle basate su prodotti ‘locali’, non saranno mai così integralmente locali
da escludere apporti di origine diversa.
Ragionando attorno
a un piatto di pasta
È fuori discussione che la pasta sia un segno identitario dell’Italia a tavola, perfetta
immagine di una cultura (non solo gastronomica) che paradossalmente trova nella varietà
delle declinazioni locali la sua cifra unificante e distintiva6. Centinaia di formati e migliaia di ricette, realizzate con prodotti diversi e con
diverse procedure, sono legate a singole città e territori rurali, che in quelle preparazioni
riconoscono storie, tradizioni, gusti diversi, disseminando nel paese in modo capillare
una cultura del cibo che non ha pari al mondo quanto a varietà e imprevedibilità.
Ciascuna forma, ciascuna preparazione ha la sua storia, racconta esperienze e gusti
particolari, legami più o meno forti con le produzioni locali o con le offerte del
mercato. Questa incredibile varietà di forme e di sapori, che l’industria alimentare
tende a restringere – non potendo rappresentarli tutti – ma non ha alcun interesse
a cancellare, si riconduce tuttavia a una parola e a una sostanza, la pasta, divenuta ormai da tempo l’icona della cucina italiana.
Icone nell’icona, alcune ricette e alcuni formati si sono fatti spazio fra gli altri,
imponendosi come simboli primari della cucina nazionale. Gli spaghetti al pomodoro,
possibilmente conditi col formaggio parmigiano, sono il segno identitario per eccellenza.
Così almeno è percepito da fuori – e sappiamo che le identità, prima ancora di diventare
il collante ‘interno’ di una comunità, si nutrono di prospettive esterne, che necessariamente
semplificano e riducono, come quando in una fotografia si passa dallo zoom al grandangolo,
occultando i particolari dell’insieme. «Visto da uno straniero disinformato», hanno
scritto Odile Redon e Bruno Laurioux, il primo piatto italiano «non è che un piatto
di spaghetti con la salsa al pomodoro e il parmigiano grattugiato»7.
Ragioniamo allora su questo piatto, sulle cui origini è ovviamente lecito interrogarsi. La curiosità è il motore di ogni scoperta. Ma altrettanto
lecito è dire, fin da subito e seguendo l’avvertimento di Marc Bloch, che non tanto
ci interessa sapere (se mai fosse possibile) chi per primo ebbe l’idea di prepararlo,
o chi per primo lo assaggiò, quanto interrogarci sulle «condizioni ambientali», i
luoghi, i percorsi che consentirono di ‘allevare’ l’idea portandola a tale fortuna
da diventare, oggi, segno identitario di una cucina e di una cultura.
Lo storico dovrà dunque stabilire rapporti e cronologie, individuare cause ed effetti,
rilevare, fra le opposte idee di destino e di caso, quella ben più efficace della
circostanza e dell’occasione – il kairós dei Greci – ossia la volontà e la capacità di cogliere una circostanza e di metterla
a profitto per costruire qualcosa di utile. Per fare questo dovremo muoverci indietro
e avanti nel tempo. Indietro, per trovare le ‘radici’ che rendono possibile l’esistenza di questo piatto (radici
al plurale, giacché una ricetta è realtà complessa, che richiede l’interazione fra
semi diversi, ghiande di varia provenienza). Avanti, alla ricerca delle ragioni ambientali che a un certo punto giustificano il successo,
l’innesto di questo piatto nella tradizione italiana.
Proporrò dunque una sorta di decostruzione storica del piatto, alla caccia dei suoi elementi costitutivi – gli ingredienti che lo compongono,
le tecniche con cui essi vengono preparati, assemblati, trasformati. Ma non solo.
Oltre ai prodotti-base e ai procedimenti attraverso i quali essi prendono forma saranno
le modalità d’uso a richiamare la nostra attenzione, giacché ogni cucina si configura
come un sistema, all’interno del quale ogni elemento occupa un posto preciso – come una parola in
una frase – e assume un senso specifico. La logica e la ‘grammatica’ del sistema saranno,
quindi, altrettanto importanti da mettere a fuoco, per valutare il ruolo (oltre che
le caratteristiche) del nostro piatto.
Ma innanzitutto, quali elementi scegliere? Giacché la varietà che caratterizza la
cucina italiana – mai, per sua fortuna, codificata o ridotta a modelli omogenei e
conformi – si ritrova in ogni ricetta, suscettibile di infinite varianti negli usi
locali, sociali, generazionali. Quante varianti esisteranno degli spaghetti al pomodoro
che abbiamo deciso di analizzare? Scegliamo dunque un minimo denominatore comune,
uno standard che possa andar bene, se non a tutti, a molti. Elementi base saranno,
come ovvio, gli spaghetti e la salsa di pomodoro. Lo sarà anche il parmigiano grattugiato
– scelta meno ovvia, ma altrettanto importante nella percezione collettiva (Redon
e Laurioux ce lo hanno appena mostrato, e l’analisi storica ce lo confermerà). Aggiungiamo
l’olio d’oliva, chiamandolo semplicemente così, senza l’extra e senza il vergine,
denominazioni che solo oggi hanno acquisito un preciso significato merceologico e
commerciale. Aggiungiamo ancora l’aglio e/o la cipolla (scegliere fra l’uno e l’altra,
o tenerli insieme, sarà solo una questione di gusto). Non ci negheremo una foglia
di basilico, ormai luogo comune dell’italianità. Sale. Qui potremmo fermarci, ma una
manciata di peperoncino è consigliata nella maggior parte delle ricette.
Gli spaghetti di Marco Polo:
come nasce una fake news
Contro Marco Polo fu intitolato nel 1989 un dossier della rivista «Médiévales» dedicato alla storia
comparata della pasta in diverse aree del mondo8. Obiettivo: smontare la leggenda secondo cui Marco Polo, sul finire del XIII secolo,
al ritorno dalla Cina avrebbe fatto conoscere in Italia la pasta – notizia che continua
imperterrita a sollecitare le fantasie e l’immaginazione di molti. Si tratta di un
falso: la notizia è assente da tutti i manoscritti del Milione, dove invece si parla della farina di sago (l’amido estratto da una particolare specie
di palma) che gli abitanti di Sumatra utilizzano per fare «lasagne e altri tipi di
pasta», prodotti che a Marco Polo ricordano analoghe preparazioni a lui ben note,
consumate da tempo in Italia.
L’equivoco nasce due secoli dopo, quando Giovanni Battista Ramusio, pubblicando le
memorie di viaggio del mercante veneziano, fraintende e manipola il testo: trasferisce
l’informazione sulla pasta di sago (di cui Marco Polo, incuriosito, decide di portare
un campione a Venezia) alla pasta in genere, facendo credere al lettore che Marco
ne abbia scoperto in Cina il segreto9.
Siamo nel 1559 e da allora la favola continua a proliferare, rafforzata da strampalate
invenzioni fra cui, particolarmente notevole, quella di un giornalista americano che
nel 1929, sul «Macaroni Journal», organo dell’associazione industriali della pasta,
attribuisce la scoperta a uno dei marinai di Marco Polo, il veneziano Spaghetti (!),
che, sceso dalla nave alla ricerca di acqua, si imbatte in una contadina che sta mescolando
in una ciotola un impasto semiliquido, che si solidifica al clima caldo e asciutto
del Catay. Il marinaio ha un’intuizione: un cibo secco, capace di durare, potrebbe
essere utile nei lunghi viaggi in mare. Si fa dare un po’ di quella pasta – delle
stringhe che si erano agglutinate attorno al bordo – e torna sovreccitato alla nave.
Maneggia e tira l’impasto traendone dei lunghi cordoncini ed ecco, sono nati gli spaghetti,
che dal loro inventore prenderanno il nome. Ora bisognerà cuocerli, e la scelta sarà
di bollirli nell’acqua salata del mare. Tornati in Italia, sarà un trionfo10.
Passiamo alle cose serie, cercando di riassumere i termini di una questione effettivamente
molto complicata – di quelle che non piacciono agli amanti degli aneddoti e delle
storie inventate, che tanto divertono e rassicurano. La storia della pasta, infatti,
rimane oscura in alcuni snodi importanti, anche se è stata molto scandagliata dagli
studiosi, e nelle sue linee essenziali appare abbastanza chiara.
Anzitutto è necessario ribadire l’estraneità della Cina alla storia ‘occidentale’
della pasta. Non perché la Cina non abbia avuto (e non abbia) un ruolo di primo piano
nella storia della pasta: la tradizione cinese ha sviluppato in questo campo abilità
e tecniche straordinarie, testimoniate fin da epoche antichissime. Tuttavia questa
tradizione ha seguito vie proprie, diverse e autonome rispetto agli sviluppi che la
cultura della pasta ha avuto nel mondo occidentale, specialmente in Italia.
Gli studiosi – in particolare Françoise Sabban11 – hanno ampiamente illustrato le diversità sostanziali fra due storie che non si
sono mai incontrate. In Cina la cultura della pasta è rimasta sempre confinata all’utilizzo
del grano tenero e alla preparazione domestica del prodotto, per un uso familiare
immediato; in Italia, accanto a un’analoga tradizione della pasta fresca, si è precocemente
sviluppata – a iniziare dal Medioevo, come vedremo – una vocazione artigianale-industriale
della pasta, basata sull’utilizzo del grano duro e sulla fabbricazione di pasta secca
a lunga conservazione.
In ogni caso, la tradizione cinese non ha avuto alcun rapporto con l’Italia. Nella
vicenda italiana sono confluite altre storie, altre ‘radici’, che evocano altre culture
e altre regioni del mondo. La ricerca delle ‘origini’, in questo caso, ci porta nella
Mezzaluna fertile, le regioni mediorientali a est del Mediterraneo in cui 10-12.000
...